Gli Ittiti sono stati una popolazione di lingua e cultura indoeuropea insediatasi in Anatolia (precisamente nella parte centrale della odierna Turchia) e da lì diffusasi in gran parte del Vicino Oriente nel II millennio a. C., tanto da entrare in lotta con le maggiori potenze dell’epoca (pensiamo solo alla prima battaglia che mobilitò ingenti forze internazionali: quella di Kadesh).
A tutt’oggi la maggior parte dei documenti ittiti è in cuneiforme e, di questi, abbiamo circa 34.000 testi. Moltissimi sono tavolette, le quali sono conservate prevalentemente a Istanbul e ad Ankara. L’80% di tutti i documenti è di natura religiosa.
Già la Bibbia parlava di una popolazione di nome Hittim, della quale però non si sapeva nulla. Nel 1834 Texier ritrovò in Turchia, nella città di Bogazköy le rovine di una grande città remota. Si trattava di immagini allora sconosciute, delle quali nessuno riusciva ad attribuire con precisione la collocazione storica e culturale. Immagini analoghe però erano state descritte già da esploratori antichi nell’ovest dell’Anatolia: da Erodoto (2. 106, 1 ss: che erroneamente pensò alla figura di un faraone) e da Pausania (che pensò a un personaggio di un mito greco). In Siria Burckhardt aveva visto qualcosa di simile, una pietra incisa con geroglifici, eravamo nel 1813, ma non capì a quale civiltà appartenesse il ritrovamento. A partire dal 1870 ritrovamenti simili in geroglifico anatolico in Siria e Asia Minore si moltiplicarono. Nel 1880 Sayce ipotizzò che quei geroglifici appartenessero agli Hittim di cui parlava la Bibbia. Nella metà dell’Ottocento venne ritrovata in Mesopotamia la biblioteca di Assurbanibal: moltissimi testi in accadico e scritti in cuneiforme. In quelle tavolette comparve il nome di Ittiti. Fu spontaneo il collegamento con la civiltà sconosciuta attestata dalla Bibbia. Solo nel 1906 si fece la prima spedizione archeologica nel villaggio ove Texier aveva rinvenuto quelle rovine: era capeggiata da Winckler, il quale ritrovò molte tavolette in cuneiforme. Da questi scavi si capì che sotto il villaggio vi era sepolta Hattusa, la capitale degli Ittiti. In seguito, altri scavi rinvennero veri e propri archivi di testi in cuneiforme. Si capì che, anche se la scrittura era cuneiforme, la lingua non era l’accadico, una lingua semitica già conosciuta. Nel 1906 Knudtzon suggerì che in quella lingua erano presenti elementi indoeuropei. Ma solo nel 1915 Hrozny decifrò la lingua sconosciuta dimostrando che è una lingua indoeuropea.
La maggior parte dei testi ittiti è in ittita cuneiforme (lingua centum), una stringata minoranza è in una variante detta ittita geroglifico (lingua satem). L’ittita è una lingua indoeuropea preclassica.

Prima degli Ittiti nella zona vi erano popolazioni non indoeuropee (Hattici, Gasghei, Hurriti). Queste popolazioni stavano in loco sin dalla preistoria. Le testimonianze su questi popoli le abbiamo soprattutto dai testi ittiti che parlano di loro. Le lingue di queste popolazioni non indoeuropee erano, a seconda delle teorie, di adstrato (continuano dopo l’invasione ittita) o di sostrato (spariscono con l’invasione ittita). Il hattico è stata sicuramente una lingua di adstrato, abbiamo testi in questo idioma e anche molte grammatiche di hattico scritte in ittita. L’hattico era usato ancora per il culto. La concezione della regalità ittita dipende molto da quella hattica. Dei Gasghei non abbiamo nulla di scritto, anche se gli Ittiti parlavano di loro. Degli Hurriti sappiamo pochissimo, ci rimangono pochi documenti scritti nella loro lingua: tra questi assai importante è una bilingue hurrico-ittita ritrovata a Hattusa.
Poi, anche prima degli Ittiti, mercanti assiri viaggiavano stagionalmente in Anatolia per vendere prodotti: e mettevano in piedi colonie stagionali paleo-assire di Cappadocia, dalle quali si spostavano nei territori limitrofi. Si parla di karum, una città da costruire e poi smantellare. Queste popolazioni mesopotamiche parlavano l’accadico. Loro vendevano stoffe pregiate e ottenevano in cambio metalli preziosi, come rame e argento. Nei testi ittiti di Kultepe sono state trovate molte parole ittite e luvie derivanti dall’accadico. c’è una parola ittita, GIShuluganni, “carro leggero” (il determinativo GIS davanti al nome ne determina il materiale: legno) ma che non è né ittita né assira, ma più antica, mutuata dagli Ittiti da questi paleo-assiri della Cappadocia. Ci sono molte altre parole ittite e luvie ma che derivano dall’accadico più antico per via di questi scambi commerciali.
Da questi dati linguistici possiamo desumere che tra il 1950-1750 gli Ittiti e i Luvi già erano arrivati in Anatolia. Se ittita e luvio erano lingue già differenziate in questo periodo, il proto-anatolico era esistente nel III Millennio. Ci sono due tesi. La prima tesi dice che il proto-anatolico si differenziò dall’indoeuropeo prima dell’arrivo degli anatolici (Ittiti e Luvi) in Anatolia, cioè nei Balcani. Secondo un’altra teoria, la differenziazione avvenne proprio in Anatolia.
Da questa differenziazione seguì la seconda: dal proto-anatolico si sviluppò da una parte l’ittita, dall’altra il luvio. Precisamente dal proto-anatolico si sviluppò da una parte l’ittita, dall’altra il lidio e il luvio-palaico. Dal luvio-palaico sorse il palaico e il luvio. Dal luvio nacquero il cario, il licio e il luviano.
Nei siti ittiti ci sono testi in queste lingue:
- Ittita cuneiforme;
- Ittita geroglifico;
- Luvio (considerato da alcuni un dialetto dell’ittita, e che è scritto in geroglifico);
- Palaico;
- Hattico;
- Hurrico;
- Accadico;
- Sumerico.
I primi documenti scritti dagli Ittiti sono in accadico e in cuneiforme accadico. Gli ittiti sconfissero i siriani e si portarono via gli scribi (perché avevano un sistema grafico sofisticato), che scrivevano in accadico e in cuneiforme accadico, che era la lingua e la scrittura internazionale del tempo. Lo sappiamo perché il sillabario ittita è uguale al sillabario della Siria (precisamente della città di Alalah). Solo dopo costrinsero gli scribi siriani a scrivere in cuneiforme anche l’ittita.
I segni cuneiformi nel III millennio erano 800, i Babilonesi li usarono 500, gli Ittiti li ridussero a 200. Il cuneiforme è presente in Anatolia dal III millennio ed era usato dai paleo-assiri di Cappadocia, con la lingua accadica. Ma gli Ittiti, come abbiamo detto, presero la scrittura dalle città stato siriane, che vennero abbattute dagli Ittiti perché esse impedivano i commerci tra Ittiti e Mesopotamia. Dal 1900 al 1600 non c’è traccia in Anatolia di cuneiforme, che ricompare nel 1600 con il cuneiforme ittita.
La lingua ittita presenta queste caratteristiche:
- sistema nominale in nove casi;
- due numeri (singolare e plurale) e tracce di collettivo;
- due generi (animato e inanimato).
Il verbo è caratterizzato da:
- due diatesi (attiva e medio-passiva);
- due numeri (singolare e plurale);
- due modi (indicativo e imperativo);
- forme nominali: due infiniti e supino, participio, sostantivo verbale;
- due tempi dell’indicativo: presente e preterito;
- due forme perifrastiche;
- due tipi di desinenze: in mi e in hi.
La sintassi ha queste caratteristiche:
- particelle affisse al primo elemento della frase;
- avverbi che possono fungere da posposizioni o preverbi;
- congiunzioni coordinanti e subordinanti;
- è una lingua SOV (Soggetto-Oggetto-Verbo);
- presenza di suffissi possessivi che si attaccano ai sostantivi e agli avverbi (particolarità che distingue l’ittita, specie nella fase linguistica antica e media, dalle altre lingue indoeuropee).
Anche se l’impiego di sumerogrammi e accadogrammi in ittita è frequente, specie in parole di uso corrente, la loro lettura da parte di scribi, messaggeri, personale templare o amministratori regi (ovvero la dettatura di testi!) avveniva sempre in ittita. Così bēlu(m) “signore” in accadico, EN in sumerico, poteva essere scritto ricorrendo appunto a un accadogramma o a un sumerogramma, ma veniva molto verosimilmente sempre pensato e letto in ittita (išḫa-) o luvio (sicuramente durante la seconda metà del XIII secolo a.C.).
La frase che permise la decifrazione dell’ittita cuneiforme è questa (KUB 13, 4 ii 70):
nu NINDA-an ez-za-at-te-ni wa-a-tar-ma e-ku-ut-te-ni
{nu NINDA-an ezzatteni wātar=ma ekutteni}.
- NINDA: sumerogramma per “pane, cibo”, già noto dall’assirologia; -an: complemento fonetico, nasale di accusativo, cf. gr. –n, lat. –m, ecc.
- ezzatteni: -tteni desinenza verbale, 2° persona plurale, cf. gr. e lat. –te, ai. thá, ecc.; ezza-: “mangiare”, cf. lat. edere, ted. Essen, ecc.
- watar: “acqua”, gr. húdōr, protoger. *watar; inglese water; ted. Wasser, ecc.; -ma è lo stesso di –an: desinenza dell’accusativo.
- eku-: “bere”, lat. aqua, ecc.
Quindi, dopo questi confronti con le lingue, si giunse a tale traduzione: “mangiate pane, bevete acqua”.
La prima grande stagione dell’ittitologia va dal 1915 al 1945:
- studi di E. Forrer e H. Ehelolf e pubblicazione in copia dei testi ittiti giunti in Germania dalla Turchia.
- primi studi linguistici, grammaticali e storici sui testi, e.g. J. Friedrich, F. Sommer, A. Goetze.
- scoperta dei contatti Egeo-Anatolici e della questione degli Ahhiyawa (da parte di Forrer).
- Prima grammatica: J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch.
- Sistematizzazione del problema dei contatti Egeo-Anatolici (Sommer, Ahhijavāfrage und Sprachwissenschaft).
- K. Bittel assume la direzione dello scavo della capitale ittita. H.G. Güterbock è l’epigrafista.
- In Italia, lavori di P. Meriggi sull’ittito, le iscrizioni in geroglifico anatolico (che erano ancora ritenute essere in lingua ittita) e le lingue dell’Asia minore.
Abbiamo poi il Dopoguerra (fino agli anni Settanta):
- prosegue la grande stagione dell’anatolistica tedesca; primo vocabolario (Friedrich, Hethitisches Wörterbuch).
- scavi di Karatepe (Bossert), bilingue fenicio-luvia permette di decifrare gran parte della scrittura geroglifica anatolica: la lingua si rivela essere certamente il luvio.
- fiorisce l’ittitologia anche in Francia, con E. Laroche (Catalogue des textes hittites, 1971).
- Güterbock a Chicago, H. Otten epigrafista a Hattusha. Dibattito sulla paleografia e sulle datazioni. Sodalizio scientifico di Friedrich e A. Kammenhuber a Monaco.
Gli studi proseguono dalla metà degli anni Settanta in poi:
- Si tratta della grande stagione dei vocabolari: Kammenhuber riavvia il progetto di un vocabolario ampliato rispetto a quello di Friedrich, i lavori iniziano nel 1975 e sono ancora in corso (nel dipanarsi degli anni, tra gli editori anche I. Hoffmann). Negli Stati Uniti, Chicago Hittite Dictionary (1989-), a cura di Güterbock, poi Th. van den Hout, P. Goedegebuure.
- P. Neve subentra a Bittel nella direzione dello scavo di Hattusha.
- Nuovi scavi in altri centri al di fuori della capitale, tra cui: Maşat Höyük (T. Özgüç), Ortaköy (A. Süel e M. Süel), Kuşaklı (A. Müller-Karpe).
- Edizioni di testi, studi sempre più avanzati sulla lingua, la cultura e la storia ittita; integrazione dell’ittita e dell’anatolico nell’albero genealogico dell’Indo-Europeo (tra i nomi di indo-europeisti di questa generazione, oltre ai già citati, ricordiamo N. Oettinger, F. Starke, E. Eichner, E. Neu, G. Neumann, H.C. Melchert, J. Puhvel, J. Tischler).
- Primi dizionari etimologici (J. Puhvel, J. Tischler).
- Sul fronte “geroglifico”, A. Morpurgo Davies, G. Neumann e D. Hawkins definiscono la trascrizione di (quasi) tutto il sillabario; Hawkins pubblica numerose iscrizioni luvio-geroglifiche, Morpurgo-Davies e Melchert danno grande impulso alla linguistica del luvio.
- Nascono scuole importanti anche in Italia (Firenze, Pavia, Roma).
Bibliografia
- Calzoli, La ragione dell’uomo, Lecce 2020;
- Francia, V. Pisaniello, La lingua degli Ittiti. Grammatica, crestomazia e glossario, Milano 2019;
- Renfrew, The Anatolian Origins of Proto-Indo-Europeans, in R. Drews (ed), Greater Anatolia and the Indo-Hittite Language Family, Washington 2001, pp. 36-63;
- T. Van den Hout, The Ductus of the Alalah VII Texts and the Origin of Hittite Cuneiform, in E. Devecchi (ed), Palaeography and Scribal Practices in Syro-Palestine in the Late Bronze Age, Leiden 2009, pp. 147-170.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 50 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.


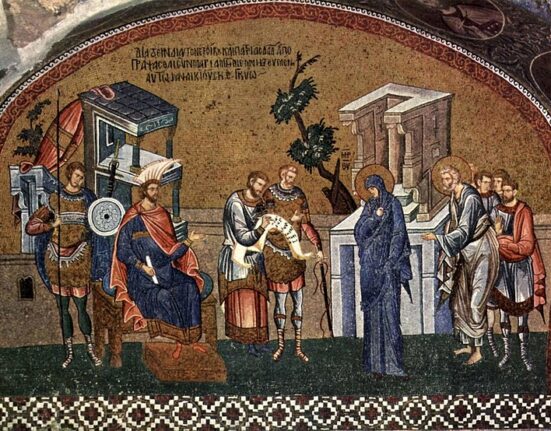
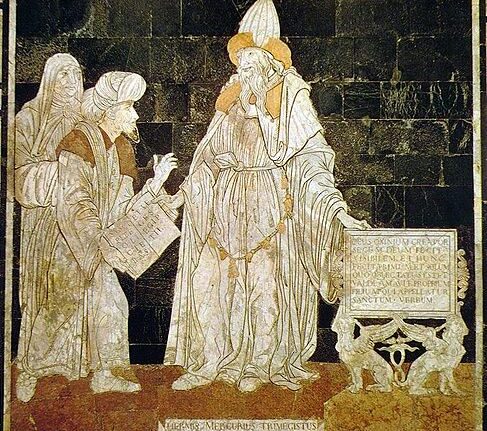

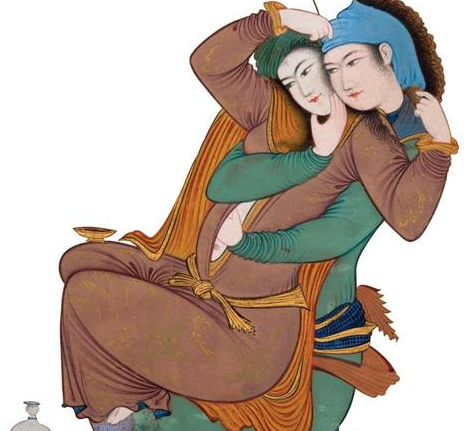
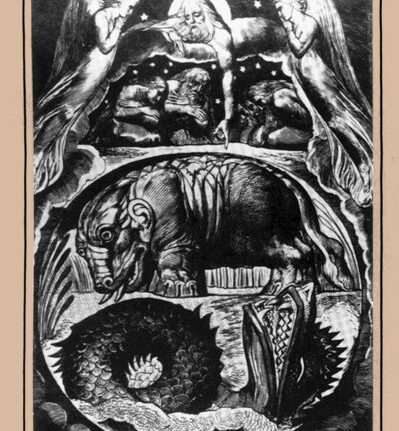

1 Comment