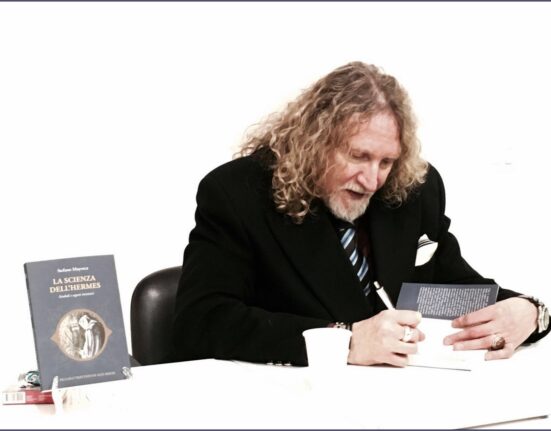Nicola Cusano (Kues 1401-Todi 1464), teologo, matematico, astronomo e giurista, svolse i suoi studi a Heidelberg, poi a Padova; instancabile viaggiatore, ottenne molti uffici ecclesiastici (nel 1448 creato cardinale e vescovo di Bressanone nel 1450, vicario generale a Roma dal 1459, dedicò gli ultimi anni della sua vita a raccogliere le sue numerosissime opere di filosofia e teologia).
I dialoghi dell’idiota, da molti attribuito a Francesco Petrarca (Arezzo 1304-Arquà 1374), fu composto da Cusano nel 1450, dopo la nomina a cardinale e vescovo di Bressanone: il primo dialogo di getto il 15 luglio a Rieti, il secondo in due giorni, 7 e 8 agosto a Fabriano, il terzo nel monastero di Valle Castro presso Fabriano il 23 agosto, il quarto a Fabriano il 13 settembre. Cusano usa il termine idiota secondo l’etimologia greca, come uomo incolto, rozzo, senza conoscenza. Del resto, già nella sua opera De docta ignorantia, Cusano riprende Socrate nell’affermare che bisogna “sapere di non sapere”, e tale è l’unico modo umano possibile per avvicinarsi a Dio. Non si tratta però di semplice ignoranza, ma della più alta sapienza dell’uomo, che riconoscendo la sua totale insipienza può trasformarla in “dotta ignoranza”.
Il primo dialogo di Cusano fu edito con il titolo De vera sapientia tra le opere di Petrarca nelle edizioni del 1473 e del 1485 e nelle edizioni dell’Opera omnia di Basilea (1496, 1554, 1581) e di Venezia (1501, 1503)[1]. L’errore d’attribuzione è giustificato dalla notevole somiglianza del primo dialogo con molti passi del celebre De remediis utriusque fortunæ di Petrarca, al quale probabilmente Cusano s’ispirò nel comporre la sua opera.
LIBRO PRIMO
Un idiota, uomo semplice e povero, incontrò nel Foro romano un oratore ricchissimo e, sorridendogli amichevolmente, così l’interpellò: Mi meraviglio della tua superbia, che tu non sia ancora arrivato all’umiltà, così intento ad affaticarti nell’assidua lettura di innumerevoli libri: e questo, perché la scienza di questo mondo in cui pensi di superare tutti gli altri, e perciò, te ne vanti, è stoltezza presso Dio. La vera scienza, invece, rende umili. A questa scienza mi piacerebbe condurti, perché qui si trova il tesoro della letizia.
Oratore. Che presunzione è mai la tua, o povero idiota, del tutto ignorante, che ti spinge a stimare così poco lo studio delle lettere senza il quale nessuno migliora?
Idiota. Non è la presunzione che non mi permette di tacere, grande oratore, ma la carità. Ti vedo tutto intento a cercare la sapienza con molta fatica inutile, dalla quale vorrei liberarti, se potessi, sì che tu stesso misurassi il tuo errore; saresti ben lieto, penso, di sfuggire a questo logoro laccio. Credere nell’autorità ti ha spinto a essere come un cavallo, libero per natura, ma trattenuto con arte per la cavezza alla mangiatoia dove si ciba solo di ciò che gli viene somministrato. E il tuo intelletto, costretto dall’autorità degli scrittori, si pasce di un cibo non adatto e non naturale.
Oratore. Se il cibo della sapienza non è nei libri dei sapienti, allora dov’è?
Idiota. Non dico che non sia qui, ma dico che qui non si trova il cibo naturale. Quanti per primi si dedicarono a scrivere sulla sapienza non crebbero per il nutrimento dei libri che ancora non c’erano, ma divennero uomini perfetti per un alimento naturale. E questi furono, per sapienza, di gran lunga superiori agli altri che credono di aver fatto tanti progressi con i libri.
Oratore. Anche se possiamo avere qualche conoscenza senza lo studio delle lettere, tuttavia le cose grandi e difficili non si possono conoscere mai, perché le scienze si sono arricchite per aggiunte successive.
Idiota. Questo è quel che dicevo, cioè che ti fai guidare ed ingannare dall’autorità: un uomo ha scritto la parola in cui credi. E io ti dico che la sapienza grida all’aperto nelle piazze e la sua voce risuona perché abita nelle regioni altissime[2].
Oratore. A quel che sento, benché tu sia un semplice profano, pensi di essere sapiente.
Idiota. Questa è forse la differenza tra te e me: tu credi di essere sapiente, benché non lo sia e, perciò, sei superbo. Io invece so di essere un idiota ignorante, perciò sono più umile. Per questo forse sono più sapiente.
Oratore. Come puoi essere arrivato alla scienza della tua ignoranza, se sei profano?
Idiota. Non dai tuoi libri, ma da quelli di Dio.
Oratore. Quali libri?
Idiota. Quelli che egli scrisse con il suo dito.
Oratore. Dove si trovano?
Idiota. Dappertutto.
Oratore. Anche nel Foro dunque?
Idiota. Certamente. Ho già detto che la sapienza grida nelle piazze.
Oratore. Mi piacerebbe sentire in che modo.
Idiota. Se vedessi che sei disposto a indagare senza smaniosità, ti rivelerei grandi cose.
Oratore. Puoi in breve tempo fare in modo che io possa gustare quello che tu vuoi?
Idiota. Sì.
Oratore. Ripariamoci, allora, in questa vicina bottega di barbiere, prego, affinché seduti si possa parlare più tranquillamente.
Questo piacque all’idiota. Ed entrando nella bottega con lo sguardo rivolto al Foro, così cominciò a parlare:
Idiota. Poiché ti ho detto che la sapienza grida nelle piazze e il suo clamore rivela che essa abita nelle regioni altissime, mi sforzerò di fartelo vedere. E prima vorrei che mi dicessi: che cosa vedi fare qui nel Foro?
Oratore. Vedo che qui si conta il denaro; da un’altra parte si pesano le merci; dalla parte opposta si pesa l’olio e altri prodotti.
Idiota. Queste sono le operazioni proprie di quella ragione per la quale gli uomini sono superiori alle bestie. I bruti non sono capaci di numerare, pesare e misurare. Considera ora con che cosa, in che cosa e da che cosa questo si fa, e dimmelo.
Oratore. Con la distinzione.
Idiota. Precisamente. E con che cosa si fa la distinzione? Non si numera forse con l’uno?
Oratore. Come?
Idiota. L’uno non è l’uno una volta, e il due non è l’uno due volte, e il tre non è l’uno tre volte e così via?
Oratore. Sì.
Idiota. Ogni numero non si fa, dunque, con l’uno?
Oratore. Sembra che sia così.
Idiota. Dunque come l’uno è il principio del numero, così il peso minimo è il principio del pesare e la misura minima è il principio del misurare. Si chiami “oncia” questo peso “piccolo”[3] quella misura. Allo stesso modo che si numera con l’uno, così non si pesa, forse, con l’oncia, e non si misura con il “piccolo”? Così la numerazione è dall’uno, il pesare dall’oncia e la misurazione dal “piccolo”. Pertanto la numerazione è nell’uno, il pesare è nell’oncia, la misurazione è nel “piccolo”. Non è così?
Oratore. Certo.
Idiota. Con che cosa si coglie l’unità, con che cosa si coglie l’oncia e il “piccolo”?
Oratore. Non lo so. So tuttavia che l’unità non è colta col numero, perché il numero è dopo l’uno; e così neppure l’oncia è colta col peso, né il “piccolo” con la misura.
Idiota. Benissimo, oratore. Come il semplice è per natura prima del composto, così per natura il composto viene dopo. Pertanto il composto non può misurare il semplice, ma viceversa. Ne deriva che ciò, con il quale, dal quale e nel quale ogni cosa misurabile viene misurata, non è attingibile dal numero. E ciò con cui, da cui e in cui si pesa ogni cosa che si può pesare, non è attingibile dal peso. Allo stesso modo anche ciò con cui, da cui e in cui viene misurato ogni misurabile, non è attingibile dalla misura.
Oratore. Lo vedo chiaramente.
Idiota. Nella regione altissima, là dove abita la sapienza, trasferisci il suo clamore che risuona nelle piazze; e troverai cose molto più dilettevoli di quelle che trovi in tutti i tuoi elegantissimi volumi.
Oratore. Non capisco se non spieghi quel che vuoi dire.
Idiota. Se non lo desideri sinceramente, ho il divieto di farlo: i segreti della sapienza non sono svelabili a tutti dovunque.
Oratore. Desidero moltissimo ascoltarti e sono già infiammato da queste poche parole. Quelle che hai ora detto preannunciano qualcosa di grande. Ti prego, dunque, di proseguire il tuo discorso.
Idiota. Non so se sia permesso rivelare segreti così grandi e se sia facile svelare profondità così alte. Non mi riesce tuttavia, di trattenermi dal compiacerti. Ecco, fratello, la somma sapienza è questa: sapere in che modo si attinge, in maniera inattingibile, l’inattingibile nell’immagine di cui si è già accennato.
Oratore. Dici cose ben strane e in contrasto.
Idiota. È questa la causa per cui le verità occulte non devono essere comunicate a tutti: perché quando sono rivelate sembrano loro strane. Ti meravigli che parli di verità che si contraddicono tra di loro. Ora ascolterai e gusterai la verità.
Quel che ho già detto prima dell’unità, dell’oncia e del “piccolo”, affermo ora che dobbiamo dirlo di tutte le cose rispetto al loro principio. Infatti il principio di tutto è ciò con il quale, nel quale e dal quale, ogni principiabile ha principio e non è, ciononostante, attingibile da nessun principiato. Questo è ciò con il quale, nel quale e dal quale, è compreso ogni intelligibile e, tuttavia, non è attingibile con l’intelletto. È anche ciò con cui, in cui e da cui, ogni cosa esprimibile è espressa e, tuttavia, non è attingibile con le parole. E anche ciò con cui, in cui e da cui, ogni cosa limitabile è limitata e ogni cosa finibile è finita, senza che esso sia limitabile da un termine, e finibile da un limite. Potrai formulare innumerevoli proposizioni, piene di verità analoghe a queste e riempirne tutti i volumi di oratoria e aggiungerne innumerevoli altre, sì da vedere come la sapienza abiti nelle regioni altissime.
Altissimo è ciò che non può essere più alto. L’infinità sola è quest’altezza. Perciò, della sapienza a cui tutti gli uomini aspirano con grande slancio della mente (in quanto il desiderio di sapere è per natura) sappiamo solo che è la più alta d’ogni scienza, è inconoscibile, non è esprimibile da nessun discorso, non è intelligibile da nessun intelletto, non è misurabile da nessuna misura, non è limitabile da nessun limite, non è terminabile da nessun termine, non è proporzionabile con nessuna proporzione, non è comparabile con nessuna comparazione, non figurabile da nessuna figura e non formabile da nessuna formazione, immobile in ogni movimento; ancora non è immaginabile da nessuna immaginazione, non sensibile in nessuna sensazione, non attraibile da nessuna attrazione, non gustabile da nessun gusto, non udibile da nessun udito, non visibile da nessuna vista, non apprendibile da nessun apprendimento, non affermabile in ogni affermazione; in ogni negazione non negabile, in ogni dubbio indubitabile, in ogni opinione inopinabile. E poiché non si può esprimere con nessun discorso, non si può pensare la fine di questi discorsi; e, in quanto per essa, in essa, e da essa sono tutte le cose, essa è impensabile in ogni pensiero.
Oratore. Sono parole queste, certo più alte di quelle che credevo udire da te. Non smettere, prego, di condurmi là dove potrò gustare insieme a te, in modo dolce e soave, qualcuna di queste altissime teorie. Vedo che non ti sazi mai di parlare di questa sapienza. Penso che sia la dolcezza massima, che produca questo: essa non ti attirerebbe, se non la gustassi con un gusto interiore.
Idiota. È la sapienza che ha sapore; e niente è più dolce di essa all’intelletto. Né sono da stimare sapienti coloro che parlano soltanto con la parola e non con il gusto. Parlano con gusto della sapienza coloro che per essa sanno tutto in modo da non sapere niente di tutto. Ogni assaporamento interiore è grazie a essa, da essa e in essa. E siccome abita le cime più alte, non è gustabile con nessun sapore. Essa è gustata senza gusto, perché è superiore a ogni cosa gustabile, sensibile, razionale e intellettuale. Consiste nel gustare senza gusto e a distanza come fosse un odore: quasi una pregustazione che non si può gustare. Come l’odore diffuso da una cosa che odora in un’altra, quando è avvertito, ci spinge a muoverci dietro l’odore dell’unguento per arrivare all’unguento, così la sapienza eterna e infinita che risplende in tutto, ci spinge per una certa pregustazione degli effetti a portarci a lei con mirabile desiderio.
Poiché essa è la vita spirituale dell’intelletto che ha connaturata in sé una certa pregustazione grazie alla quale esso cerca con applicazione grandissima la sorgente della sua vita che, senza pregustazione non cercherebbe e, se la trovasse, non saprebbe di averla trovata, – per questo [l’intelletto] si muove verso la sapienza come verso la propria vita. E dolce è per ogni spirito ascendere senza fine al principio della vita anche se inaccessibile. E quando, alla ricerca della propria vita, l’intelletto è condotto là dove vede quella vita infinita, tanto più gode quanto più vede che la sua vita è immortale. Così avviene che l’inaccessibilità o l’incomprensibilità dell’infinità della sua vita, è la comprensione che egli desidera, come se qualcuno possedesse il tesoro della propria vita e arrivasse al punto di sapere che questo suo tesoro non è numerabile, non è ponderabile e non è misurabile. Questa conoscenza dell’incomprensibilità è comprensione gioiosa e oltremodo desiderata, non per chi comprende, ma in relazione al tesoro amatissimo della vita, allo stesso modo che, se uno ama qualcosa perché amabile, gode di trovare nell’oggetto d’amore cause infinite e inesprimibili d’amore. E questa è la comprensione gioiosissima dell’amante quando comprende l’amabilità incomprensibile dell’amato. Egli non gode tanto perché ama l’amato secondo qualcosa di comprensibile, quanto invece perché sa che l’amabilità dell’amato non è misurabile, né finibile, né terminabile, né comprensibile.
Questa è la comprensibilità gioiosissima dell’incomprensibilità, ed è l’amata dotta ignoranza, allorché essa sa a suo modo e, tuttavia, non sa con precisione.
Oratore. Forse ho capito; giudicherai tu. Mi sembra che il tuo pensiero sia questo: il nostro principio per il quale, nel quale e dal quale, siamo e siamo mossi, è da noi gustato come principio, mezzo e fine, quando la sua soavità vitale è assaporata senza gusto con l’affetto ed è compresa in modo incomprensibile con l’intelletto; e chi si sforza di gustare questo principio con il gusto e di comprenderlo in modo comprensibile, è completamente senza gusto e senza intelletto.
Idiota. Hai capito perfettamente, oratore. Perciò quanti credono che la sapienza è ciò che essi possono comprendere con l’intelletto e che la felicità è solo quella che essi possono raggiungere, sono ben lontani dalla vera sapienza eterna e infinita: anzi tendono a una quiete che ha fine, dove credono che si trovi la letizia della vita; e, invece, non c’è. Quindi, sapendosi ingannati, si tormentano, perché, dove pensavano che si trovasse la felicità alla quale si erano volti con ogni sforzo, là trovano invece tormenti e morte. La sapienza infinita è cibo incorruttibile di vita, di cui vive eternamente il nostro spirito che non può amare altro che la sapienza e la verità. Ogni intelletto desidera essere; il suo essere è vivere; il suo vivere è intendere; il suo intendere è pascersi della sapienza e della verità. Perciò l’intelletto che non gusta la sapienza splendente è come l’occhio nelle tenebre. È occhio; ma non vede, perché non è nella luce. E, poiché è privo della vita che lo allieta, che consiste nel vedere, è in grande pena e affanno: questa è morte piuttosto che vita. Così, l’intelletto rivolto verso un cibo diverso da quello dell’eterna sapienza, si troverà fuori della vita, avvolto, per così dire, nelle tenebre dell’ignoranza, più morto che vivo. Ed è tormento senza fine: avere un essere intellettuale e non intendere mai. Solo la sapienza eterna è, infatti, quella nella quale ogni intelletto può intendere.
Oratore. Dici cose belle e inconsuete. E ora ti domando come posso elevarmi a un certo gusto della sapienza eterna.
Idiota. La sapienza eterna si gusta in ogni cosa gustabile. Essa è diletto in ogni cosa dilettevole, è bellezza in ogni cosa bella. È appetibilità in ogni cosa appetibile. Così, dì pure di tutte le altre cose desiderabili. Allora, come può non essere gustata? La vita, quando è secondo il tuo desiderio, non è gioiosa per te?
Oratore. Niente è più gioioso.
Idiota. Poiché questo tuo desiderio c’è solo grazie alla sapienza eterna dalla quale e nella quale esso è, e poiché questa vita felice che desideri non è che per questa stessa sapienza eterna in cui essa è e al di fuori della quale non può essere, per questo, in ogni desiderio della vita intellettuale tu desideri solo la sapienza eterna che è il compimento del tuo desiderio, il principio, il mezzo e il fine. Se ti è dolce questo desiderio di vita immortale, [ossia] di vivere felicemente in eterno, tu provi entro di te una certa pregustazione della sapienza eterna.
Non si desidera niente che sia completamente ignoto. Ci sono alcuni frutti presso gli Indi che noi non desideriamo solo perché non li abbiamo mai gustati. Tuttavia siccome non possiamo vivere senza nutrirci, desideriamo il nutrimento. E abbiamo una certa pregustazione del nutrimento per vivere sensibilmente. Il bambino ha, nella propria natura, una certa pregustazione del latte, per cui, quando ha fame, tende al latte. Di ciò di cui siamo, noi ci nutriamo. L’intelletto ha la sua vita dalla sapienza eterna e di questa ha una certa pregustazione. Pertanto in ogni pascolo che è necessario per vivere, l’intelletto non si muove se non per nutrirsi di ciò da cui ha questo essere intellettuale. Se, dunque, in ogni desiderio di vita intellettuale, tu badassi a ciò da cui è [il tuo] intelletto, per chi e verso chi si muove, scopriresti in te che la dolcezza della sapienza eterna è quella che rende il tuo desiderio così dolce e dilettevole, sì da essere tratto da indicibile affetto alla comprensione di essa quasi fosse l’immortalità della tua vita – allo stesso modo in cui tu vedi che il ferro è attratto dal magnete. Il ferro ha nel magnete un principio d’attrazione, per così dire; e quando il magnete, per la presenza di questo, eccita il ferro che è grave e pesante, il ferro, con desiderio degno di meraviglia, viene attirato al di sopra del suo movimento naturale (per il quale dovrebbe tendere al basso secondo la gravità) e così si muove verso l’alto unendosi al suo principio. Se nel ferro non ci fosse per natura una pregustazione del magnete, non si muoverebbe verso il magnete più che verso un’altra pietra. E, se nella pietra non ci fosse maggiore inclinazione al ferro che al rame, non ci sarebbe quest’attrazione.
Il nostro spirito intellettuale ha, dunque, dalla sapienza eterna il principio d’essere in modo intellettuale, sicché esso è più conforme alla sapienza di un altro essere non intellettuale. Perciò l’irradiazione o l’immissione della sapienza nell’anima santa è il moto d’aspirazione a elevarsi in alto. Colui che con moto intellettuale cerca la sapienza, toccato interiormente, dimentico di sé, viene rapito nel corpo, quasi fuori dal corpo verso la dolcezza pregustata. Il peso di tutte le cose sensibili non può trattenerlo dall’unirsi alla sapienza che lo attira; spogliatosi dei sensi, rende l’anima folle d’ammirazione stupefatta sicché nulla apprezza tranne la sapienza. A costui sarebbe dolce poter lasciare questo mondo e questa vita per essere trasportato più rapidamente alla sapienza dell’immortalità. Questa pregustazione rende abominevole ai santi ogni cosa che appare dilettevole e fa loro sopportare con animo fermissimo tutti i tormenti corporei per poter più rapidamente conseguire la sapienza.
Essa c’insegna che questo nostro spirito, a lei rivolto, non può mai venir meno. Anche se il corpo, con tutti i suoi legami sensibili non può impedire che il nostro spirito sia attirato con ardore alla sapienza, abbandonando tutte le operazioni corporee, mai lo spirito viene meno, anche se vien meno il corpo. Quest’assimilazione che è inerente al nostro spirito per sua natura, per cui esso s’acquieta solo nella sapienza, è per così dire l’immagine viva di essa. Infatti l’immagine non si placa se non in ciò di cui è immagine, da cui ha principio, mezzo e fine. L’immagine, viva grazie alla vita, trae da sé il moto verso l’esemplare nel quale, soltanto, s’acquieta. La vita dell’immagine non può riposare in se stessa in quanto è vita della vita della verità, e non vita propria. Perciò si muove verso l’esemplare come verso la verità del suo essere. Se l’esemplare è eterno e l’immagine ha una vita nella quale pregusta il suo esemplare e a lui si muove con desiderio, poiché quel movimento vitale non può riposare se non nella vita infinita che è la sapienza eterna, questo moto dello spirito, che mai attinge infinitamente la vita infinita, non può mai cessare; lo spirito si muove sempre con gioiosissimo desiderio per attingere ciò di cui, provatone diletto, mai si sente sazio. La sapienza è, infatti, cibo saporosissimo, il quale, saziando, non fa diminuire il desiderio di prenderne ancora sì da non cessare mai di dilettare in una mensa eterna.
Oratore. Credo senza alcun dubbio che tu abbia parlato molto bene. Tuttavia, vedo che c’è molta differenza tra il gusto della sapienza e i discorsi che si possono fare su di esso.
Idiota. Dici bene e mi fa piacere sentirtelo dire. Ogni sapienza del gusto di una cosa mai gustata, è vana e sterile fino a che il senso non ne ha il gusto; così accade di questa sapienza che nessuno gusta per sentito dire: solamente chi la riceve in un gusto interiore, offre la testimonianza non di ciò che ha sentito dire, ma di ciò che ha gustato in sé stesso per esperienza. Sapere le molteplici descrizioni dell’amore che i santi ci hanno lasciato, senza aver gustato l’amore, è cosa vana. Pertanto, a chi cerca la sapienza eterna non basta sapere le cose che si leggono di essa, ma deve farla sua dopo aver ritrovato con l’intelletto dov’è: allo stesso modo di chi, trovato un campo in cui è sepolto un tesoro, non può godere di questo tesoro in un campo che non è suo, ma di altri; e, allora, vende tutto e compra quel campo per possedere il tesoro nel suo campo. Per questo bisogna vendere e dare tutte le proprie ricchezze.
La sapienza eterna non vuole essere posseduta se non là dove chi la possiede non ha più nulla di suo per poterla avere. Ciò che abbiamo di nostro, è vizio. Ciò che abbiamo dall’eterna sapienza, invece, è solo bene. Perciò, lo spirito della sapienza non abita nel corpo sottomesso al peccato, né nell’anima malevola, ma nel suo puro campo e nell’immagine monda della sapienza come nel suo tempio santo. Dove, infatti, abita la sapienza eterna, qui è il campo del Signore che dà frutti immortali. Esso è il campo delle virtù che la sapienza coltiva, da cui nascono i frutti dello spirito che sono la giustizia, la pace, la fortezza, la temperanza, la castità, la pazienza e gli altri frutti simili.
Oratore. Hai spiegato ampiamente questo argomento. Ma ora dimmi: non è Dio il principio di tutto?
Idiota. Chi ne dubita?
Oratore. La sapienza eterna è qualcosa di diverso da Dio?
Idiota. No, è Dio.
Oratore. E Dio non ha formato tutte le cose mediante il Verbo?
Idiota. Sì.
Oratore. E il Verbo è Dio?
Idiota. Sì.
Oratore. E così è anche la sapienza?
Idiota. Dire che Dio ha fatto tutte le cose nella sapienza non è altro che dire che Dio ha creato tutte le cose mediante il Verbo. Osserva come tutto ciò che è, è potuto essere ed è potuto essere così com’è. Dio che dà a sé 1’attualità dell’essere, è presso colui che è l’onnipotenza per la quale una cosa può essere prodotta dal non essere all’essere. Ed è Dio Padre che può essere chiamato unità o entità, perché necessita l’essere che era nulla, dalla sua onnipotenza. Dio si dà anche un essere tale, si da esser questo, per es. cielo e non altro, né di più né di meno. Per questo, Dio è Verbo, sapienza o Figlio del Padre e può essere chiamato uguaglianza dell’unità o dell’entità. È, quindi, l’essere e l’essere unito in modo tale da essere, e ha questa unione da Dio che è connessione che connette tutto ed è Dio Spirito Santo. Lo spirito unisce e connette tutte le cose in noi e nell’universo. Perciò come niente genera l’unità, ma essa è il primo principio mai principiato, così niente genera il Padre che è eterno. L’uguaglianza procede dall’unità, come il Figlio procede dal Padre. E il nesso procede dall’unità e dalla sua uguaglianza. Perciò ogni cosa per avere l’essere e quel tale essere in cui è, ha bisogno di un principio unitrino, di Dio trino e uno, di cui si potrebbe parlare più a lungo se il tempo lo permettesse.
La sapienza, dunque, che è la stessa uguaglianza dell’essere, è il verbo o la ragione delle cose. Essa è, per così dire, la forma intellettuale infinita; la forma dà alla cosa l’essere formato. Pertanto la forma infinita è l’attualità di tutte le forme formabili e l’uguaglianza precisissima di tutte. Come il cerchio infinito, se ci fosse, sarebbe l’esemplare vero di tutte le figure raffigurabili e l’uguaglianza d’essere di qualunque figura – sarebbe infatti triangolo, esagono, decagono e così via, e sarebbe di tutte misura adeguatissima, anche se è figura semplicissima – così la sapienza infinita è la semplicità che complica tutte le forme ed è la misura adeguatissima di tutte; ad esempio, nell’idea perfettissima dell’arte onnipotente ogni cosa formabile dall’arte, è l’arte stessa come forma semplicissima, così che se guardi la forma umana, trovi che la forma dell’arte divina [è] il suo esemplare precisissimo, come se essa non fosse nient’altro che l’esemplare della forma umana. Se guardi la forma del cielo e ti volgi alla forma dell’arte divina, non potrai affatto concepirla diversamente dall’esemplare di quella forma del cielo; e così [si dica] di tutte le forme formate o formabili, di modo che l’arte o la sapienza di Dio Padre è la forma semplicissima e, tuttavia, l’esemplare unico e assolutamente uguale delle infinite forme formabili per quanto varie esse siano.
Quanto ammirabile è quella forma, la cui infinità semplicissima non possono esplicare tutte le forme formabili! Solo chi s’eleva con sommo intelletto al di sopra d’ogni opposizione, riesce a intuire questa verità profondissima. E, se uno considerasse la forza naturale che è nell’unità, vedrebbe quella forza, se la concepisse in atto, come qualcosa di formale, visibile da lontano al solo intelletto. E poiché sarebbe la forza semplicissima dell’unità, sarebbe un’infinità semplicissima. Quindi, se questi considerasse la forma dei numeri, considerando la dualità o la decina, e tornasse, quindi, a considerare la forza attuale dell’unità, vedrebbe in questa forma, che si è ammesso essere la forza attuale dell’unità, l’esemplare precisissimo della dualità, della decina e d’ogni altro numero numerabile. Questo farebbe l’infinità della forma di ciò che abbiamo chiamato forza dell’unità: cioè che, mentre guardi la dualità, questa forma non può essere né maggiore né minore della forma della dualità di cui è l’esemplare precisissimo. Così vedi che la sapienza unica e semplicissima di Dio, in quanto infinita, è l’esemplare verissimo di tutte le forme formabili.
E questo è il suo modo di cogliere tutte le cose: per cui le attinge, le delimita e le ordina. È, infatti, in tutte le forme come la verità è nell’immagine, l’esemplare nell’esemplato, la forma nella figura e la precisione nell’assimilazione. E, sebbene [la sapienza] si comunichi a tutti con somma liberalità, essendo infinitamente buona, tuttavia, da nessuno può essere compresa come essa è. L’identità infinita non può essere ricevuta in altro, perché in altro sarebbe ricevuta secondo l’alterità. E benché non possa essere ricevuta in uno se non con alterità, essa è tuttavia ricevuta nel miglior modo possibile; ma l’infinità immoltiplicabile si esplica meglio nell’esser ricevuta in modo vario: la grande diversità, infatti, esprime meglio l’immoltiplicabilità. Ne consegue che la sapienza, ricevuta in modo diverso nelle diverse forme, fa sì che una forma qualunque chiamata all’identità nel modo che le è possibile, partecipi della sapienza, sicché alcune la partecipano in uno spirito molto distante dalla forma prima, il quale dà a esse a mala pena l’essere elementare; un’altra forma la partecipa in uno spirito più formato e le dà l’essere del minerale; un’altra in un grado ancor più nobile e le dà la vita vegetativa; un’altra in un grado ancor più alto e le dà la vita sensibile; e, quindi, vi sono le forme che [ricevono] la vita immaginativa; poi quelle che [ricevono] la vita razionale e, infine, quelle che hanno quella intellettuale.
Questo è il grado più alto: l’immagine più vicina della sapienza. Ed esso solo è il grado che ha l’attitudine a elevarsi al gusto della sapienza, perché nelle nature intellettuali l’immagine della sapienza è viva di vita intellettuale; la forza di questa vita sta nell’esprimere da sé il moto vitale che consiste nel tendere all’oggetto proprio che è la verità assoluta che è la sapienza eterna, grazie all’intendere. Questo tendere, essendo intendere, è anche gustare intellettualmente: apprendere con l’intelletto è cogliere la quiddità nel modo migliore con una degustazione graditissima. Come, infatti, con il gusto sensibile che non coglie la quiddità della cosa, si percepisce sensibilmente una gradevole soavità negli aspetti esterni della quiddità, così con l’intelletto si gusta nella quiddità una soavità intellettuale che è l’immagine della soavità della sapienza eterna che è la quiddità delle quiddità. E il paragone tra la soavità dell’una e dell’altra non è possibile.
Data la brevità di tempo, ti basti quanto abbiamo già detto, per sapere che la sapienza non sta nell’arte oratoria, né nei grandi volumi, bensì nel separarsi da queste cose sensibili, nel rivolgersi alla forma semplicissima e infinita, nel riceverla nel tempio puro da ogni vizio, nell’aderire a essa con amore ardente, al punto di poterla gustare e vedere quanto soave sia, essa che è ogni soavità. Quando l’avrai gustata, disprezzerai tutto quello che ora ti sembra grande e diventerai umile, in modo che nessuna traccia di superbia rimanga in te, né nessun altro vizio, perché con cuore castissimo e purissimo aderirai in modo indissolubile alla sapienza una volta che l’avrai gustata, preferendo abbandonare questo mondo e tutte le cose che non sono la sapienza, piuttosto che la sapienza stessa. Con indicibile letizia vivrai, morirai e riposerai in eterno, oltre alla morte, in essa, in un amorosissimo abbraccio; il che conceda a te e a me la sapienza sempre benedetta di Dio, Così sia.
[*] La sapienza dell’idiota, Libro primo. Cfr. I dialoghi dell’idiota, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2003.
[1] Cfr. R. Klibansky, De dialogis De vera sapientia Francisco Petrarcae addictis,Opera omnia V, Idiota, Meiner, Hamburg 1983, pp. xxi-xxiv, dissertazione che sviluppa la tesi secondo cui i Dialoghi De vera sapientia di Petrarca erano spuri (in J. Ubinger,Die angeblichen Dialoga Petrarcas iiber die Wahre Weisheit, Vierteljahrschrift fiir Kultur und Litteratur der Renaissance, II, 1887, pp. 57-70). Così per quattro secoli i posteri lessero Cusano pensando di leggere Petrarca!
[2] Proverbi, I, 20.
[3] Il termine petitum deriva da una radice celtica che significa piccolo, donde il francese petit. Anche oggi, talora, si usa l’espressione “un piccolo” di birra, di vino.
Ringraziamo Lettera e Spirito per la disponibilità