Di Michele Ruzzai
Nell’articolo precedente (“La fine dell’età primordiale e la Caduta dell’Uomo”) avevamo cercato di inquadrare il particolare momento preistorico che vide il passaggio dalla fase paradisiaca a quella post-edenica della nostra umanità, traendo in larga misura spunto da quanto hanno avuto modo di scrivere gli autori inseribili nel filone culturale del cosiddetto “Tradizionalismo integrale” come Julius Evola e Renè Guenon, ma anche nomi quali Ananda Kentish Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Titus Burckhardt, in parte Mircea Eliade ed altri ancora.
La prospettiva qualificante di questa corrente di pensiero – è utile ricordarlo – assume come essenziale punto di partenza il fatto che ai primordi si sia manifestato un retaggio conoscitivo, appunto una “Tradizione Primordiale”, di origine essenzialmente non umana, che i nostri avi non hanno inventato o “costruito”, ma essenzialmente “ricevuto” da forze e realtà “divine” a loro trascendenti. Se il sapere e le fonti più profonde delle verità metafisiche e cosmologiche non rappresentano quindi nulla di umanamente accumulato, è facile comprendere come un altro degli elementi più caratterizzanti del pensiero tradizionalista sia il deciso rigetto della visuale evoluzionista, biologica e culturale assieme, almeno nella sua accezione più comune, ovvero quella di un processo generale che da un “meno” conduce verso un “più” (contrariamente al vero significato etimologico del termine che viene dal latino “volvere”, cioè srotolare, svolgere e che quindi dovrebbe piuttosto esprimere il dispiegarsi delle possibilità di esistenza che sono già tutte contenute – senza procedere, passo dopo passo, l’una dall’altra – nella totalità dell’Essere).
E’, questa, una prospettiva che ci invita a considerate l’Uomo sotto una luce radicalmente diversa rispetto a quella post-darwiniana, con delle riflessioni che possono coinvolgere più livelli.
Ad esempio, anche rimanendo sul piano strettamente biologico, è di notevole interesse il lavoro del prof. Sermonti, che sottolinea come la gran parte dei caratteri dell’uomo attuale siano da considerarsi “primari”, cioè vicini alle conformazioni tipiche dell’ordine, presenti nei più antichi primati fossili e collocandolo, contrariamente a quanto dovrebbe attendersi secondo la teoria evoluzionista, in una posizione filogenetica compatibile con quella di un mammifero della più elevata antichità, tra tutti forse il meno lontano da un ipotetico “prototipo”. Quella umana sembrerebbe cioè la forma primigenia tra quelle dei mammiferi in quanto evidenzierebbe una specializzazione molto meno marcata rispetto a tutte le altre; ciò non solo nei confronti, ad esempio, delle scimmie attuali, ma anche in rapporto a quelli che si vorrebbe fossero i nostri ipotetici precursori, ovvero le Australopitecine, gli Homo Erectus e gli Habilis. Al contrario, tali specie parrebbero denotare caratteri molto più specializzati ed adattati a delle precise “nicchie” ecologiche rispetto ad altre forme, necessariamente coeve e nettamente più simili a quelle umane attuali. Da queste ultime, infatti, gli ominidi africani avrebbero mantenuto la stazione eretta, che dunque presenta una grandissima antichità, ma ciò stando ad indicare piuttosto una loro derivazione da un tronco più originario e “centrale”, esistente già da tempi molto più aurorali di quanto si supponga.
Se poi consideriamo gli animali attualmente esistenti e ritenuti meno distanti da noi, va ricordato che fino ad ora la paleontologia non ci ha consegnato fossili antichi somiglianti a scimpanzé, gorilla od orango, conseguendone da ciò il fatto che, contrariamente a quanto si creda, questi organismi sono molto più recenti della forma umana e quindi certamente non possano costituire (loro, o altre tipologie più o meno simili) quegli “snodi” evolutivi annoverabili tra i nostri ascendenti biologici.
Utili indicazioni, inoltre, possono essere tratte dalla conformazione del feto umano. E’ stato infatti osservato come questo manifesti in modo ancora più evidente i caratteri generali dell’ordine a cui la specie appartiene, ed è per questo motivo che si presenta in maniera morfologicamente molto simile in tutti i rappresentanti dello stesso (ad esempio, il feto di uno scimpanzé o di un gorilla sono quasi identici a quello umano) perché ancora libero da caratteri “secondari”; una specie poco specializzata, com’è quella umana, evidenzia in effetti questa sua “primarietà” proprio nella somiglianza che, nell’adulto, si mantiene con lo stadio di feto e di neonato, cosa invece non osservabile in altre specie considerate a noi vicine, che ben presto, con la crescita dell’individuo, si rivestono delle “sovrastrutture” organiche loro proprie. E’ questa eterna fanciullezza che ha spinto diversi autori a considerare la nostra come una specie a forte tendenza “neotenica”, caratterizzata cioè dalla conservazione anche in età adulta di certe importanti caratteristiche infantili.
Se quindi l’uomo non sembra essersi “evoluto” da forme ancestrali animalesche, sono semmai queste ultime che rappresentano delle linee laterali, derivate e senili di sviluppo: i caratteri primordiali, invece di essere di tipo bestiale, sono quelli fetali, quelli della incontaminata giovinezza. E’ piuttosto l’animale ad essere il prodotto di una “involuzione” a partire dall’uomo – quasi una sua “malattia” – come ipotizzava anche lo stesso Platone che, ad esempio, vedeva nelle scimmie gli umani di un remoto passato, decaduti per aver perso la “scintilla sacra”.
Ma, precisamente, a partire da quale tipo di Uomo sarebbe iniziata tale serie di linee discendenti? Questa domanda ci porta da un’antropologia basata su elementi di carattere più fisico-biologico ad un’altra che si apre verso il Mito.
Per il filosofo Edgard Dacquè, in effetti, le specie animali discendono involutivamente da un’umanità che non è tout court identificabile a quella attuale, ma che corrisponde ad un ceppo primordiale e non del tutto corporeizzato – la definisce “Urmensch” – dal quale l’uomo materializzato, pur distinguendosene, tuttavia ne costituisce l’erede più diretto; antropoidi, primati ed animali vari rappresenterebbero linee di caduta via via più laterali e periferiche rispetto a questa direzione “centrale”.
Una sorta di impulso antropogenetico che si rinnova e si manifesta all’inizio di ogni nuovo ciclo umano, testimone vivente di quella Tradizione Primordiale di cui sopra.
Dunque l’uomo odierno, con le sue facoltà biologiche e razionali, rappresenterebbe la “precipitazione” più approssimata e vicina di quest’Uomo originario, che anche Platone ebbe a sottolineare come dotato di una natura profondamente diversa da quella attuale. Una forma quindi esemplare che avrebbe svolto una funzione “archetipica”, creata direttamente “ad immagine di Dio”, ed in rapporto alla quale noi non saremmo che dei decaduti, una sorta di “immagine secondaria” di livello ancora più basso rispetto alla primaria figura divina che informò e plasmò tale Essere.
Forma Umana, primordiale ed unitaria, che almeno in un paio di occasioni anche Julius Evola significativamente riconosce (pur animato da una prospettiva che definiremmo piuttosto “polifiletica”, tanto da non fargli utilizzare mai, a quanto ci risulta, il concetto di Manvantara quale “cornice” generale di un completo e conchiuso ciclo umano); infatti, anche il pensatore romano accenna a quella primordiale razza unitaria Hamsa, menzionata nel mito indù, che ricorda come “anteriore ad ogni successiva differenziazione umana”, mentre in un altro passaggio segnala – in termini analoghi – che, pur nella latente dualità, vi è una chiara unità di fondo del principio generatore che nutrì i due gemelli Romolo e Remo, così opposti (il primo votato alle divinità maschili, celesti e solari, il secondo a quelle femminili, ctonie e lunari), ma pur sempre nati dalla medesima Lupa e da Evola ricordati come chiave interpretativa delle stesse “origini umane”. Più ancora di Evola, Guenon ebbe a sottolineare come non possa esservi alcuna irriducibilità assoluta neppure tra la prima di tutte le dualità, cioè quella che, passando su scala cosmologica, polarizza l’Essere Universale in “Essenza” e “Sostanza”, benché sia proprio a seguito di questo primo atto che trae inizio quella molteplicità tendente sempre più a porre in risalto gli aspetti soprattutto separativi ed “eterogeneizzanti” della manifestazione. Essenza e Sostanza come concetti analoghi a Cielo e Terra, la cui separazione, sul piano ora antropologico, corrisponde chiaramente al polarizzarsi dell’Androgino platonico (sul quale avremo modo di tornare) nei due soggetti separati – maschio e femmina – che la tradizione biblica identifica in Adamo ed Eva.
Ciò costituisce il primo passo verso la diversificazione umana, che implica il manifestarsi delle varie modalità di esistenza le quali, partendo da una radice unica, troverà la sua estrinsecazione attraverso la nascita delle varie razze della nostra specie.
Ma, come già ricordavamo, il metafisico francese rafforza questa impostazione, tendenzialmente più “monofiletica” di quella evoliana, anche attraverso il concetto di Manvantara; ciò, oltretutto, rimarcando chiaramente la totale scomparsa, da questo livello di esistenza, di tutte le umanità vissute nei Manvantara precedenti al nostro. Secondo Guenon, infatti, tutto ciò che riguarda la manifestazione corporea relativa ad uno specifico ciclo, al suo termine letteralmente si volatilizza ed abbandona il piano materiale; nella sua particolare interpretazione, il ricordo degli “antichi re di Edom”, rappresenterebbe appunto le umanità dei precedenti cicli, trascorsi i quali sarebbero finite in una modalità, però solamente extracorporea, del Manvantara presente. Per il francese, quindi, ogni singola umanità nel suo tempo partirebbe da una sorta di “tabula rasa”, con la sua propria Età dell’Oro, dell’Argento e via seguendo le altre, e non esisterebbero popolazioni “residuali” (come invece potrebbe sembrare nella lettura evoliana, ad esempio, dell’origine dei “selvaggi” australi) in grado di superare i limiti fisico-temporali del proprio Manvantara per accedere a quello successivo; almeno non sul piano della manifestazione materiale. O, in alternativa, forse anche sì – interpretando in tal senso il summenzionato passo platonico sulle scimmie – ma solo al durissimo prezzo di una animalizzazione completa e senza ritorno.
Comunque, nell’una come nell’altra ipotesi, parrebbe da escludere il mantenimento delle caratteristiche “Sapiens”, probabilmente già possedute anche nei cicli precedenti, analoghe a quelle della nuova umanità nascente.
Sotto quest’ottica, quindi, è evidente che ogni ritrovamento anteriore al limite temporale dei 65.000 anni andrebbe considerato come attinente a Manvantara precedenti al nostro, e quindi relativo ad un altro ceppo umano, separato dal nostro da una cesura netta.
Se ora diamo uno sguardo generale alle datazioni dei ritrovamenti riferibili a Homo Sapiens nel mondo, emerge a nostro avviso anche un altro importante elemento di riflessione: l’assenza, in pratica, di reperti invece collocabili nel lasso di tempo posto tra 65.000 e 52.000 anni fa, ovvero nella primissima fase del nostro Manvantara.
Questo intervallo dovrebbe in effetti corrispondere al momento veramente primordiale della presente umanità e riteniamo non casuale che tale assenza di siti archeologici copra un periodo di circa 13.000 anni, ovvero quello che nelle varie tradizioni è stato definito come “Grande Anno”; questo, corrisponde alla metà della durata del ciclo precessionale terrestre e, come Guenon ricorda, nelle varie mitologie tradizionali assume spesso un’importanza particolarmente significativa, in misura anche maggiore del ciclo processionale completo di 26.000 anni. Il “Grande Anno”, segnalato anche da Gaston Georgel nel suo importante “Le quattro età dell’Umanità”, rappresenta una fondamentale modalità di suddivisione del Manvantara, in quanto costituisce precisamente un quinto della sua durata totale.
L’assenza, totale o quasi, di reperti databili tra 52.000 e 65.000 anni fa, quindi si sovrappone perfettamente al 1° Grande Anno del nostro ciclo (come da schema presentato nel nostro precedente articolo), ovvero la prima metà esatta del Satya Yuga, e riteniamo che potrebbe essere spiegata proprio con l’esistenza di quella “Urmensh” – la forma primordiale umana, sulla quale torneremo ancora – praticamente impossibile da rinvenire sotto forma fossile proprio in quanto non ancora fisicizzata secondo i canoni odierni: evento che si sarebbe verificato solo più tardi, anche se – va sottolineato – ben addentro alla stessa età edenico-paradisiaca.
E’ ovvio che quest’ultimo assunto presupponga un’idea più articolata e dinamica dell’età primordiale rispetto a quanto, nella letteratura di riferimento, sembra darsi quasi sempre per scontato più o meno implicitamente, e cioè l’aver rappresentato, questa, un momento statico, una parentesi senza storia.
Qualche breve e preliminare nota di ordine più generale a questo punto ci sembra utile per fornire una cornice introduttiva ed accompagnare le considerazioni che, più in là, cercheremo di svolgere in merito alla genesi umana.
In effetti, come ci ricorda Renè Guenon e come proveniente da alcune interpretazioni dei Purana indù, il Satya Yuga si sarebbe protratto per circa 26.000 anni, una durata molto lunga per la quale, a ben vedere, sembra difficilmente sostenibile una totale assenza di discontinuità interna; d’altronde, non è un caso se il metafisico francese in varie occasioni ebbe modo di sottolineare come, in ciascuna delle varie età del Manvantara, vi sia la possibilità di operare ulteriori significative suddivisioni interne, a partire da quella, basilare, nelle due relative metà.
Il Satya Yuga, quindi, non sfugge a questa regola ed anzi è rimarchevole il fatto che risulti composto esattamente da due “Grandi Anni” di quasi 13.000 anni ciascuno.
Oltretutto, è stato rilevato come il transito da un Grande Anno a quello successivo sia sempre contraddistinto da un violento cataclisma che quindi, per l’età edenica, deve per forza aver avuto luogo in corrispondenza della sua metà, attorno a 52.000 anni fa. Anche da considerazioni legate al “ciclo avatarico” di Vishnu (ciclo che suddivide il Manvantara totale in dieci parti uguali di 6.500 anni, ciascuna collegata ad una particolare “discesa” sulla terra del Principio per il ristabilimento della legge divina) lo stesso evento traumatico viene ricordato nel preciso momento del passaggio dal secondo Avatara (Kurma), al terzo (Varahi), quando dovettero verificarsi importanti modificazioni della geografia boreale, uno spostamenti di Centro dal polo artico verso una zona più nord-orientale (la terra di Beringia?) e, come ipotizza anche Gaston Georgel, una primissima ondata migratoria verso aree meno settentrionali del pianeta.
Ciò che ne seguì, originò quella che Guenon ritiene la sede del centro spirituale primordiale di questo Manvantara, la citata Varahi o “Terra del Cinghiale”, dalle marcate caratteristiche solari: il fatto però che risulti collegata non al primo ma al terzo Avatara di Vishnu, ci fa supporre sia più corretto collocare Varahi non nella fase aurorale ed indistinta, veramente iniziale, del nostro ciclo umano, ma invece nel secondo Grande Anno, ovvero tra 52.000 e 39.000 anni fa.





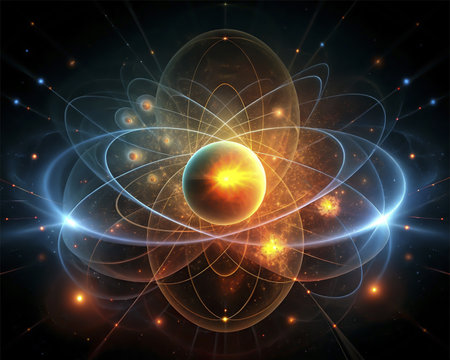


2 Comments