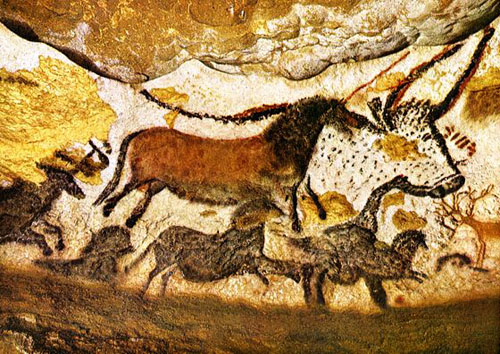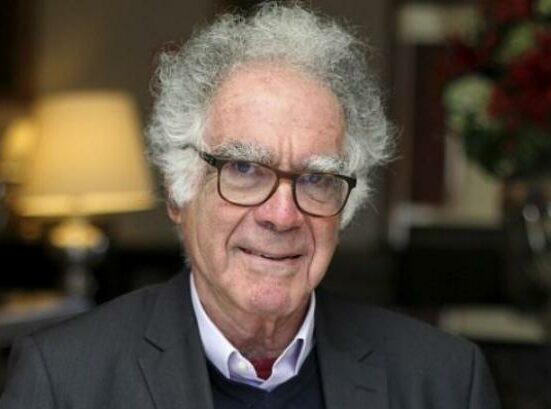SECONDA PARTE
Lo zoo delle “donne giraffa” tailandesi:
quando un’antica etnia viene trasformata in merce turistica
Un reportage di Martino Nicoletti
Le “donne giraffa”: da discendenti della mitica dragonessa divina a paccottiglia vivente in mostra
Dal mito che racconta delle origini divine dei Kayan, della dragonessa primordiale e dell’unione tra uomini e dei, torniamo al presente, al quadro reale. Il presente di ora, quello del nord della Tailandia; quello ovvero dei Kayan, popolo di profughi che sopravvive oggi come merce in mostra per il piacere di turisti di passaggio. Qui, nessuna parvenza esiste più della nobile discendenza dalla dragonessa divina; nessun mito, bensì unicamente delle misere “donne giraffa” vendute agli sguardi di golosi villeggianti in cerca di “etnicità” allo stato virtualmente puro.
Chiunque abbia avuto la ventura di viaggiare nel nord della Tailandia, sa come, uscendo dalla cittadina di Mae Hong Son, nel giro di poche ore di auto, si possono raggiungere con facilità gli odierni “villaggi” Kayan ad uso turistico, pubblicizzati dalle numerose agenzie locali come anche in quelle della stessa Bangkok. Alle strade diritte e asfaltate che vi conducono, si susseguono sentieri polverosi, battuti su e giù da autobus e pick-up farciti di turisti. Qua e là, sporadiche, persone chine che lavorano nei campi. Più oltre, moderne e acuminate chiese cristiane che spuntano tra la folta giungla e, di tanto in tanto, cartelli gialli, inchiodati agli alti tronchi degli alberi, con lapidarie scritte in lingua thai e che dicono: “Dio osserva i tuoi peccati!”. Un monito disseminato, come mine sparse, un po’ ovunque. Una rudimentale, quanto efficace, forma di controllo sociale messa in atto dai missionari protestanti che qui imperversano ovunque, facendo abbondanti messi umane.
Continuando a viaggiare, in breve, iniziano ad apparire anche degli sbiaditi cartelli stradali di colore grigio, con frecce indicatorie: Karen village. Sono il segno che gli insediamenti dei Kayan – qui designati con il nome della vasta koinè etnica, i Karen, di cui sono parte – non sono ormai distanti. Si avanza ancora un po’ quando, dopo un’ennesima curva, un arco trionfale in bambù, con tanto di scritta “Welcome” e immagine dipinta di una “donna collo lungo”, dice che si è infine giunti a destinazione.
Arrivati all’ingresso del “villaggio”, pagando un modesto biglietto d’ingresso di 250 Bath (qualcosa più di cinque euro), si ha modo di accedere al regno delle “donne giraffa”. Duecento cinquanta Bath per essere invitati all’assurdo spettacolo di etnici detenuti in invisibili gabbie. E lo spettacolo è davvero assurdo. Sì, perché un villaggio artificiale, creato ed organizzato unicamente perché mandrie di turisti possano facilmente ed efficacemente visitarlo, mantiene un retrogusto di dolore e di desolazione che è difficile da dire. È questo un luogo privo di radici; sospeso; fluttuante in un liquido amniotico privo di vita. 
Passeggiando, ecco le prime immagini di vita: donne intente a fare la loro vita come se nulla fosse, come se nessun visitatore fosse qui. E il lavoro quotidianamente svolto dai Kayan è infatti unicamente questo: mostrare ciò che si è; vivere sotto i riflettori del sole tropicale; mangiare, passeggiare, accudire la prole, sonnecchiare, in piena e totale esposizione. In completa vetrina. Da dietro delle bancarelle, altre donne sono invece all’opera vendendo souvenir etnici: chincaglieria che, in maniera ossessiva, ripete lo stesso identico leitmotiv declinato in tutte le salse possibili: “colli lunghi, colli lunghi, colli lunghi”… E allora ecco le cartoline ingiallite con bimbe e donne sorridenti con i loro colli lunghi. Statuine in legno intagliato, di tutte le fogge e dimensioni, che ritraggono esili e stereotipate donne con il collo lungo. Bamboline sintetiche con colli lunghi. Anelli in ottone, destinati a rendere i colli lunghi, che attendono solo che un collo occidentale le acquisti come souvenir. T-shirt collo lungo, CD musicali collo lungo… “collo lungo, collo lungo, collo lungo”… Un intero, artificiale, villaggio edificato attorno e in funzione di interminabili file di bancarelle.
Qua e là, in assetto sparso, si trovano i turisti, appena defluiti dai loro bus con aria condizionata, e ora intenti a far foto, a far shopping, a compiere il loro mini-safari pedestre tra le indigene dell’etnia Kayan. Turisti in movimento, qui a frugare con lo sguardo nelle verande delle capanne, o a sbirciare con gli obbiettivi, attraverso le porte aperte, nell’intimità ombrosa delle abitazioni. Altri sono invece indaffarati a “comporre” le proprie modelle “collo lungo” secondo il loro piacimento. Ecco dunque chi domanda foto di gruppo; chi depone i propri figli qualche secondo in grembo a una “donna giraffa” per poterli ritrarre insieme; chi osa un selfie in accoppiata con una giovanissima “fanciulla-giraffa”, o chi ancora che domanda di poter scattare una fotografia della propria moglie mentre indossa per qualche secondo un vistoso fac simile del fardello metallico che ha reso note le tribali.
Dal canto loro le donne Kayan rispondono assecondando ogni possibile richiesta. È il regno del surreale. E lo è anche perché una “indigena” con il collo lungo, così mansueta sotto i colpi d’infiniti scatti fotografici, così docile e cedevole ad assumere qualsiasi posa plastica gli venga richiesta pur di accontentare i gusti del visitatore, non è più una persona. Questa è piuttosto una mezza bestia, sfinita e sfibrata da una detenzione prolungata. Irreale è questo show, anche perché un popolo di antichi cacciatori e di agricoltori, ridotto a guadagnarsi il proprio vivere da dietro bancarelle ricoperte di paccottiglia, è ormai un popolo sfibrato, finito, senza più una identità né una dignità accettabili.
Sebbene sembrino “sigillate” nel loro silenzio la donne giraffa restano tuttavia donne, restano persone, dotate di vita, di sentimenti e di memoria. Basta sollevare il velo, fare una domanda diretta, che lo sguardo cambia e che la voglia di parlare, di dire si fa strada da sola. Durante una delle mie visite, conosco Muthé, una donna Kayan di mezza età che vive qui assieme a sua figlia. Le chiedo come sia arrivata in Tailandia, quale la sua storia, dove si trovi la sua famiglia.
Senza attardarsi, Muthé inizia allora a raccontarmi di come sia fuggita dalla Birmania assieme a suo marito. Di come la sua famiglia si sia spaccata in due. Una parte che, corrompendo le guardie di frontiera, riuscì a suo tempo a scappare e un’altra rimasta invece per sempre in Birmania. Di loro poche notizie. Telegrafiche. Gli annunci dei nuovi scontri tra gli indipendentisti Kayan e l’esercito. Notizie di matrimoni che avvengono oltre confine, di nascite, di morti. Nulla di più, pare. Mentre Muthé racconta, sua figlia appare portando un vassoio di plastica con un bicchiere pieno d’acqua. Da turista, divento di colpo un ospite. Dopo avermi servito, la ragazza, silenziosamente, si mette a sedere vicino alla madre. Tira su con il naso. Muthé mi dice che, qualche volta, soprattutto di notte, da lontano, si sentono i rumori di spari e i boati di scoppi. È il segno che i combattimenti sono ricominciati. È la conferma che, nonostante tutto, lei e la sua famiglia sono degli scampati. Degli eterni sopravvissuti, si direbbe anche.
Di contorno a questo spettacolo della desolazione, gli impassibili e inossidabili turisti continuano ad affluire. Non uno o dieci. Molti. Moltissimi. E tutti sorridenti e indifferenti, appagati con un paio di cartoline e con qualche fotografia. L’occhio avido e prensile del turista di massa – specchio fedele dell’“uomo massa” dell’“essere amorfo” che costituisce il tipo umano oggigiorno prevalente su scala globale – si coniuga qui con la sua consueta, basica, bulimia da shopping: comprare, comprare e gettar dentro il proprio zaino. Comprare, comprare e gettar dentro la propria borsa. E tutto qui si concentra: comprare! Che tutto il resto sarebbe solo un domandar troppo, francamente non esigibile da chi si vuole solo godere una vacanza di qualche giorno ai tropici.
Si avanza senza posa e si consuma. Poi, come si girerebbero le spalle ad una donna cannone o ad una signora barbuta non appena dopo averla vista e osservata da vicino, i turisti, terminato il loro breve giro, con aria vaga, si avviano nuovamente verso l’ingresso dove l’autista li stava ad attendere. È passata poco più di mezz’ora. Eppure in questa breve mezz’ora si condensa una vera e propria erosione umana e culturale che agisce senza posa, per otto ore al giorno e per 365 giorni all’anno. Un rullo compressore fatto di 10.000 turisti ogni anno.
I turisti arrivano, passano, comprano, escono, dimenticano alla prima curva. Le “donne collo lungo” restano invece dentro. Questo per loro, in effetti, non è il vecchio villaggio del Myanmar da cui si è scappati pagando sottobanco ai militari della frontiera. È il villaggio a cui si è state un tempo destinate e da cui non si può uscire né guardare fuori. Uno zoo in cui degli esseri umani pagano per vedere altri esseri umani, creduti diversi. Non donne: “giraffe”.
Per saperne di più:
Nicoletti M., Lo zoo delle donne giraffa: un viaggio tra i Kayan nella Tailandia del nord, Roma, Exòrma, 2011
Video:
Giovanni Lindo Ferretti in un cortometraggio dedicato alle “donne giraffa”: https://www.youtube.com/watch?v=9xHLPRBIwAk
Martino Nicoletti (Dottorato di ricerca in Antropologia e PhD in Multimedia Arts): antropologo, scrittore e viaggiatore, si occupa da oltre venticinque anni di etnografia e storia delle religioni dell’Asia meridionale. È autore di numerosi saggi dedicati alla spiritualità dell’Himalaya, opere letterarie, volumi multimediali e fotografici pubblicati in più lingue. Sul tema dell’articolo, è autore del volume: Nicoletti M., Lo zoo delle donne giraffa: un viaggio tra i Kayan nella Tailandia del nord, Roma, Exòrma, 2011
Vive in Francia. www.martinonicoletti.com