Ho spiegato in vari miei saggi come nella Tradizione Misterica Eleusina l’umanità venga considerata figlia degli antichi Dei Titani, sconfitti dai nuovi Dei Olimpici in un’epica guerra, la Titanomachia, narrataci da Esiodo nella sua Teogonia, ma la cui memoria e la cui profonda eco è sempre stata presente in tutte le tradizioni dei popoli antichi, dal Mediterraneo al Vicino Oriente, dall’Asia alle Americhe. Tale Tradizione, infatti, attribuisce la creazione di questa attuale umanità ai quattro figli del Dio Titano Hyaphethos (Giapeto, Ιαπετός): Atlante (Ἄτλας), Menezio (Μενοίτιος o Μενοίτης), Prometeo (Προμηθεύς) ed Epimeteo (Ἐπιμηθεύς), i quali crearono l’uomo e la donna a loro immagine e somiglianza.
In seguito alla Titanomachia e al rovesciamento religioso che ne conseguì con la vittoria dei nuovi Dei Olimpici e con l’instaurazione, sia sul piano religioso che su quello sociale, del regime del patriarcato, gli Antichi Dei Titani, per quanto sconfitti, esiliati e in parte imprigionati nel Tartaro, non abbandonarono mai gli esseri umani loro figli. La Tradizione Misterica ci insegna, infatti, che furono condotti dai Titani due tentativi per redimere l’umanità e per salvarla dall’ottenebramento del culto dei nuovi Dei.
Il secondo ed il più noto di questi tentativi fu quello compiuto dalla Dea Demetra, con la nascita di Kore.
Il primo, meno noto e spesso travisato dai mitologi e dagli storici delle religioni, doveva prevedere la nascita di un Salvatore, una Divinità redentrice che avrebbe condotto l’umanità alla Salvezza e a un ritorno di essa alla piena auto-coscienza; una Divinità che avrebbe dovuto essere generata dalla Dea Leto (Λητώ), conosciuta nella classicità anche come Lada o Latona, la più dolce fra le Divinità Titaniche, la «Signora della Notte Tenebra dal Bruno Manto»[1].
Leto, o Letho, il cui nome, secondo Guido Maria St. Mariani di Costa Sancti Severi[2], deriva da Αανθαναω (Aanthànao, cioè “star nascosta”), è una Dea Titana. Secondo la Hyerogonia degli Eleusini Madre e le più antiche ed arcaiche tradizioni egeo-mediterranee, fu generata, insieme a sua sorella Asteria (Ἀστερία), dal Titano Keys (Κοῖος, Ceòs, Coiòs), e dalla Titana Febe (Φοίϐη, Phoibe). Ciò viene confermato nella Teogonia di Esiodo ai versi 404-410.
Keys è il Titano della luce albina (bianca, diurna) ed Egli, come il Suo Regno, rappresenta il Polo Celeste della nostra galassia. Cioè viene identificato con la costellazione del Draco (Dragone), la cui stella più famosa è Thuban Giogo del Cielo, ossia Alpha 11 Draconis, che fu l’antica Stella Polare. Febe è invece la Titana del chiarore delle Tenebre. Fra i Suoi appellativi vi sono quelli di “Argentea”, “Luminosa”, “Risplendente”, “Notturna”.
La sorella di Leto, la Titana Asteria (da Ασθρ = Asthr, Aster, cioè “astro”, “stella”), è la Dea «della Notte Stellata dal peplo azzurro»[3], detta anche “Honorata”, a cui il Dio Ennosigeo-Poseidon donò, secondo la Tradizione, un’isoletta vagante sul mare, che ancorò sul fondo marino. Questa isoletta, una delle Cicladi, inizialmente portò lo stesso nome della Dea Titana, ossia Asteria,e in seguito cambiò nome in Delos.
Paredro di Leto fu il Titano Kreys (Κριως, Kriôs, “ariete”, o Κρειος, Kreios, “maestro”, “signore”), chiamato anche Megamede (“Grande Signore”).
Come sottolinea sempre Mariani di Costa Sacti Severi[4], sappiamo bene che nel periodo ellenico classico (e forse ancor prima nel periodo miceneo), si insiste nel voler attribuire a Zeus la paternità dei figli di Letho. Ma così non era nei periodi arcaici egeo-minoico, pelasgico, lelegico-cicladico e lelegico-anatolico. Gli autori ellenici operarono tale stravolgimento sia per chiari motivi di orgoglio di stirpe che con intenti politico-religiosi, in maniera del tutto funzionale al controllo politico, militare e culturale che esercitava la nuova cultura “greca”, con la sua religiosità “olimpica”, sulle popolazioni pelasgiche e lelegiche autoctone della Grecia continentale e delle isole dell’Egeo. Questa operazione di sostituzione “sincretica” venne anche agevolata dal fatto che sia Kreys che Zeus venivano rappresentati, nella più arcaica iconografia, con la testa di un ariete su un corpo umano.
In Egitto Leto fu conosciuta come la Dea Uadjet (nome poi grecizzato in Uto, Utit o Buto), ossia la Dea-Cobra, equivalente al concetto delle “Tenebre”, similmente all’Ureo portato sulle corone dei faraoni. Considerata erroneamente in origine come una Divinità locale della città di Per-Uadjet, sorta sul delta del Nilo, circa venti chilometri a Nord di Sais (detta, in seguito, Βοῦτος in età tolemaica, l’odierna Tell El Farain), divenne, al momento dell’unificazione dei regni predinastici, la Dea protettrice del Faraone e la personificazione del Basso Egitto, come la Dea-Avvoltoio Nekheb lo era dell’Alto Egitto.
La Tradizione Misterica degli Eleusini Madre ci insegna che la Dea, per adempiere alla sua missione di redenzione dell’umanità, discese dal Polo Celeste (la stella Thuban), arrivando al Polo Nord della Terra dei caduchi umani. Ivi assunse la forma esteriore di una lupa dal manto niveo e discese dal Nord, percorrendo la vasta Europa, fino a giungere alle coste mediterranee, dove avrebbe dovuto partorire il Redentore, il potente figlio divino concepito con il Titano Kreys.
Zeus e la Dea Hera vennero avvertiti da alcuni loro messaggeri e, messi al corrente di ciò che stava per accadere, erano spaventati ed atterriti, al pari di tutti gli altri Dei dell’Olimpo. Erano infatti consapevoli dell’esistenza di una antica profezia, che recitava: «Se la Titania Letho genererà un solo nato, il regno di Zeus sarà travolto, annientato, e ricoperto dalla terra»[5].
Fu così che Hera e Zeus, per evitare il temuto ritorno degli Dei Titani, proibirono a chiunque (Dei, Semidei e mortali loro succubi) di dare asilo alla Dea.
Arrivata sulle coste egee, da Lupa ch’era ivi giunta, la Titania Leto assunse, a completamento della Sua Missione, una forma esteriore umana. Ma tutte le “porte” del mondo mediterraneo le si chiudevano in faccia e ovunque veniva respinta e scacciata. Non le rimase che dirigersi alle isole Cicladi, ma anche là incontrò rifiuti, poiché ognuno dei mortali temeva la collera di Zeus. Solo sullo scoglio di Delos, in aperta sfida a Zeus e Hera, venne accolta e protetta da sua sorella Asteria.
Ben nove notti durò il suo travaglio (simbolicamente il numero 9 rappresenta un “piccolo ciclo”), distesa alle verdi falde del piccolo monte Kynthos. Nel frattempo gli Dei Olimpici operarono con magie per spezzare la forza generatrice di Leto, e per dividerla in due parti: infatti, se avesse generato più di un nato, la profezia sarebbe stata vanificata. Solo la decima notte, narra sempre la Tradizione, la Dea riuscì a partorire con dolore, afferrando con le mani i ciuffi d’erba delle falde del Kynthòs, ove era distesa, mentre i suoi occhi guardavano il cielo da cui era discesa. Ma si trattò di un parto gemellare: Zeus aveva in parte vinto. Fu così che la Dea generò, dal Titano Kreys, due gemelli divini: Kynthia Artemi (Ἄρτεμις, Artemide) e Kynthios Febo (Φοίβος).
Tutte le fonti sono però concordi nel riportare che, incurante dell’ordine di Zeus e Hera, giunse, dalla città cretese di Amnisos, in soccorso della Titania Leto, la Dea della vita, la Grande Levatrice Eileithyia (Εἰλείθυια). Questa antichissima tradizione, di origine cicladica ed egea, era molto diffusa sia presso i Pelasgi che fra i Lelegi. Questi ultimi, il cui emblema totemico era il lupo, veneravano la stessa Dea Leto nel suo aspetto di lupa. E i gemelli divini da Ella partoriti assunsero nomi egeo-cicladici-lelegici derivati dal sito che aveva dato loro i natali, ossia Delia e Delios (i gemini delici) e Kynthia e Kynthios (da monte Kynthòs).

di Diana Scultori Ghisi (1547-1612)
Secondo una diversa versione, Kynthia Artemi sarebbe nata pochissime ore prima di Kynthios Febo, non a Delos, ma su una isoletta vicina, al tempo chiamata Ortyx (quest’isola si chiamò poi Rhenaia, mentre oggi è conosciuta come Rhenia), e avrebbe aiutato la Divina Madre a far nascere il fratello.
L’Inno Omerico ad Apollo, nei versi 45-65, ci narra in maniera esemplare il girovagare della Dea.
Come evidenzia Guido Maria St. Mariani di Costa Sancti Severi, «Appena nato, Kynthios già aveva con Sé il Grande Arco d’Argento e la faretra piena di dardi, al par d’appendici sussidiarie di Sé! Istantaneamente salì a passo svelto sin sulla vetta del Kynthòs, in piena notte fonda. Il Grande Arco splendeva, spandendo tutto all’intorno un chiarore argenteo, di una luce fredda, che illuminò la notte. Con quest’atto Kynthòs automaticamente divenne Febo l’Illuminatore, il Grande Arciere, il Hekatebolos (“lungi saettante”), il Hekaergos (“che colpisce lontano”), l’Argyrotoxos (“dall’arco d’argento”), il Lycos (Lupo dei Lelegi), il Guanokaites “dalle chiome cerulee” (in tal modo sono descritte le sue chiome, come le chiome della stirpe Pelasgica)»[6].
Solo posteriormente i Dori-Greci attribuirono a questo Dio le chiome bionde, mutando infatti i suoi simbolismi in quelli di un Febo solare e cancellando la sua natura stellare, dato che “Deità Stellari” significava una sola cosa: Titani, parola greca derivata dal termine lelegico-cretese Tan. A questo Febo solare dimenticarono però di cambiargli l’arco con uno d’oro, che invece rimase d’argento. Inizialmente la cultura greca lo identificò con i raggi solari, poi in seguito, scansando il Dio Titano Helios, identificarono Febo medesimo con il Sole. Ovviamente i successivi autori romani mantennero, nelle loro opere che tanto attingevano dalla cultura ellenica, questa interpretazione, nonostante fosse evidente che si trattava di una Divinità notturna (Kynthios Febo era nato la decima notte del travaglio della Dea).
Le classi sacerdotali zeutiche inoltre tentarono, come abbiamo visto, riuscendovi in pieno, di assimilare la figura di Kynthios Febo a quella di una loro Divinità di origine nordica, un semplice Dio pastore e niente di più, Apollo (Ἀπόλλων), che certo niente poteva collegare al Sole, né tantomeno a Delòs. Da qui si evince come buona parte dell’interpretazione che della cosiddetta “mitologia classica” ci hanno dato i moderni mitologi e gli storici delle religioni sia fondamentalmente errata e da riscrivere.
Abbiamo visto, sin qui, come il primo tentativo di redenzione dell’umanità da parte degli Dei Titani non sia andato a buon fine a causa delle trame degli Dei Olimpici, e come la Dea Leto, anziché generare il Dio che tutti attendevano, partorì sull’isola di Delo due Gemelli Divini: Artemide e Febo. Per quanto queste due Divinità si dimostrarono importanti per l’umanità, non riuscirono però ad adempiere alla missione che sarebbe toccata al Fanciullo Divino. La forza e la potenza che avrebbe dovuto avere quest’ultimo, infatti, risultò essere scissa nelle due nuove Divinità e non fu possibile portare avanti la missione di redenzione auspicata.
Gli Dei Olimpici avevano così sventato quella per loro terribile profezia che, se si fosse avverata, avrebbe decretato la fine del loro dominio. Ma vedremo come questa loro temporanea vittoria abbia generato una nuova profezia, ancora più terribile della prima.

Leto, a memoria d’uomo, fu la prima Divinità a incarnarsi nell’aspetto umano, con tutte le limitazioni che un fragile corpo mortale può comportare. E in tale corpo peregrinò per le terre dei mortali, soffrì la fame e la sete, il caldo e il freddo, venne ostacolata, offesa e umiliata e riuscì infine a mettere al mondo i suoi figli. Fu seguita, diversi secoli dopo, dall’incarnazione di Demetra e di Kore-Persefone, in quello che viene considerato, in ambito eleusino, come il secondo tentativo di redenzione dell’umanità da parte degli Dei Titani.
Esiodo, in un passo della Teogonia molto probabilmente frutto di interpolazioni successive, definisce Apollo e Artemide come Dei Olimpici “di seconda generazione” e queste due Divinità vengono spesso menzionate dalla letteratura ellenica addirittura come schierate dalla parte di Zeus nella Titanomachia. La Tradizione “ellenica”, infatti, attribuisce ai due figli gemelli della Dea Titana Leto la paternità di Zeus, ma abbiamo sottolineato più volte come l’autentico paredro di Leto e legittimo padre di Artemide e Febo sia il Dio Titano Krios (chiamato anche Kreys), che già abbiamo menzionato in relazione al suo legame con il simbolismo dell’ariete.
Semmai lo “zampino” di Zeus c’è stato, ma solo in relazione al fatto che, al posto dell’unico potente Dio Titano che sarebbe dovuto nascere, e che nelle intenzioni di Leto e Krios avrebbe dovuto rovesciare il Sovrano dell’Olimpo e affrancare l’umanità dal suo regno di oppressione, siano stati generati due gemelli, entrambi certamente forti e potenti, ma singolarmente senza la forza necessaria per assolvere alla loro missione. Fu infatti proprio Zeus, che, consapevole della minaccia rappresentata da questo Redentore che sarebbe dovuto nascere, perseguitò e fece perseguitare in ogni dove dai suoi seguaci la povera Leto, agendo anche sul piano “sottile” ed energetico, fino a che Ella, scacciata da tutte le terre dei mortali, generò infine sull’isola di Delos, suo estremo rifugio, Febo e Artemide, i cui veri nomi furono Kynthios Febo (Φοίβος) e Kynthia Artemis (Ἄρτεμις).
Forti di questa forzata – benché spudoratamente falsa e tendenziosa – attribuzione della paternità zeutica a queste due Divinità, i tessitori della trama hanno avuto gioco facile nell’arruolarle entrambe in questa sorta di “Armata Brancaleone” senza arte né parte che sembra divenire il consesso degli Olimpici. Ma, come nel caso di Demetra e Poseidone, hanno decisamente giocato col fuoco. Un conto, infatti, sarebbe stato servirsi per i propri scopi “teologici” o “teogenici” e per i propri disegni “pantheongenici” di Divinità Titaniche di prima e seconda generazione che si trovano imprigionate nel Tartaro, e che quindi hanno perso giocoforza la loro diretta influenza sui fatti e sulle vicende di questo mondo, oppure ricorrere (come nel caso di Hera, Afrodite, o, come vedremo, di Ares o Efesto) a Divinità sostanzialmente innocue, “ripescate”, riplasmate o totalmente costruite. Altro conto è invece servirsi per detti scopi di Divinità Titaniche – come nel caso di Demetra, Poseidone, Leto, Artemide e Febo – che non sono mai state confinate in catene nelle tartaree dimore e che hanno pertanto sempre avuto una certa libertà di azione nell’influenzare le vicende di questo mondo, sia su un piano fisico che su quello sottile. Senza scendere troppo in particolari (cosa che non mi sarebbe consentita, in quanto stiamo letteralmente camminando su un terreno minato), posso tranquillamente affermare che tali improvvide scelte, negli ultimi tre millenni, si sono ritorte contro più di una volta a certi tessitori della trama, con conseguenze decisamente pesanti, se non addirittura catastrofiche.
Ma il clero zeutico ha comunque preso le sue precauzioni, “addomesticando” e riplasmando, ricorrendo anche alla privazione di alcuni attributi fondamentali, quella figura (o forse sarebbe più consono dire “controfigura”) di Artemide che ha inserito nel proprio teatrino. E con Febo si sono spinti anche oltre, sostituendo di fatto la sua figura, le sue prerogative e le sue caratteristiche originarie con quella di Apollo, originariamente un Dio tribale e pastorale di origini nordiche e iperboree, racchiudente in sé anche tratti sia indo-europei che anatolici. Ne è emersa così, come vedremo meglio fra poco, una Divinità completamente diversa, sicuramente più funzionale con il disegno zeutico, ma al contempo anche una Divinità dai tratti ambigui ed oscuri e potenzialmente imprevedibile per la stessa causa “zeutica”.
Ma chi è dunque Apollo? O, comunque, chi è l’Apollo che ci viene presentato dalla Tradizione ellenica e dalla relativa poetica e letteratura?
Appare evidente che l’Apollo menzionato da Esiodo e dai poemi omerici e che viene fatto figurare nel novero degli Dei Olimpici sia una figura composita, decisamente in parte “costruita”, ma comunque reale e capace di una propria forte autonomia. Una figura sicuramente scelta dal clero zeutico per sostituire, non solo nella persona ma anche nel nome, quella scomoda e ingombrante di Febo, ma comunque molto interessante da sondare e approfondire.
Da Febo Apollo eredita molte delle caratteristiche, tanto da essere spesso con Lui identificato e assimilato (anche se dobbiamo sempre tener presente che si tratta di due Divinità ben distinte), e questo lo possiamo vedere innanzitutto dagli epiteti. Fra i molti epiteti attribuiti ad Apollo, infatti, quasi tutti derivano direttamente da quelli tradizionalmente attribuiti a Febo, come ad esempio Aphetoros (il “Dio dell’Arco”) e Argyrotoxos (il “Dio dall’Arco d’Argento”), in quanto Febo viene descritto dalle Tradizioni Misteriche come armato, sin dalla nascita, di un favoloso arco d’argento, e la trasposizione di questi epiteti sulla figura di Apollo ne fece nella Tradizione ellenica il patrono degli arceri, così come anche nella Tradizione romana, in cui veniva definito Articenes, “Colui che porta l’arco”. Mentre Febo, però, come tutti i Titani, è una Divinità stellare ed eredita da suo padre, il Titano Krios, un particolare legame con la luce stellare albina, biancheggiante (e anche Leto ha fra i suoi appellativi quelli di “Argentea”, “Luminosa”, “Risplendente” e “Notturna”), l’Apollo della Tradizione ellenica è una Divinità solare e con capigliatura bionda. I Greci si “dimenticano” però di sostituire ad Apollo l’arco d’argento di Febo (d’argento perché appunto legato alla luce bianco-argentea delle stelle) con un arco d’oro, che sarebbe quantomeno risultato più consono alla sua figura. Per rimediare alla “dimenticanza” gli danno però contemporaneamente una spada d’oro (da qui il suo appellativo di Khrysáoros, che significa, appunto,”dalla spada d’oro”).

(Cleveland, Cleveland Museum of Art)
Altri epiteti attribuiti ad Apollo ma derivanti dalla figura di Febo furono Lykeios, o Lykegenes, come Febo era chiamato dai popoli pelasgici della Licia, che lo identificavano con una loro antica Divinità totemica, il Lupo Solare Lykeios (essi veneravano infatti la Dea Leto nella sua forma di lupa bianca); Akesios o Iatros, dal comune significato di “guaritore, in riferimento al suo ruolo di protettore delle Arti Mediche, tanto da essere tradizionalmente ritenuto il padre di Asclepio, appellativi direttamente connessi con quelli di Alexikakos e Apotropaeos, entrambi significanti “colui che scaccia – o tiene lontano – il male”. Un significato analogo a quello dell’appellativo di Averruncus che diedero i Romani ad Apollo, in riferimento al suo potere di scatenare o di tenere al contempo lontane le malattie e le pestilenze.
La figura e il nome di Apollo risultano assenti nei testi micenei in Lineare B, tanto che si ritiene che la sua scelta da parte del clero zeutico per sostituire la scomoda figura di Febo e la sua collocazione nella cerchia dei dodici Olimpici sia riconducibile cronologicamente agli inizi dell’Età del Ferro (già probabilmente all’XI° o al X° secolo a.C.). Nei testi micenei vi è però una figura in un certo qual modo a Lui assimilabile, menzionata dalle tavolette in Lineare B – alcune delle quali rinvenute a Cnosso – come Paiawon (o come Pa-ja-wo-ne) e dai testi greci più arcaici come Paion (Παιών), un nome divenuto in seguito uno degli epiteti di Apollo e riconducibile al significato di “guaritore”. Molti storici delle religioni ritengono che potesse trattarsi di una Divinità minore dei Micenei, il cui culto sarebbe stato da questi esportato a Creta, o più semplicemente dell’epiteto con la quale Essa era invocata per la tutela della salute dei suoi fedeli, ma in ambito Eleusino si è sempre sostenuto che Paion fosse un antico Dio pastorale, della magia, del canto magico-profetico (da cui deriverebbe infatti il peana, un’antica forma di canto corale dedicato agli Dei), e della medicina, tanto da essere considerabile non certo un Dio “minore”, la cui figura è stata di fatto poi assorbita, durante il Medio Evo Ellenico, da quella di Apollo.
Come Dio della cura Paion (o Paean) compare anche nell’Iliade, dove, significativamente, non risulta ancora sovrapposto con la figura di Apollo. E l’assenza di Apollo dai testi micenei (precedenti alla Guerra di Troia) si riconnette direttamente al fatto che Omero, nell’Iliade, colloca Apollo al fianco dei Troiani, anche per il fatto che il Dio – a detta di Omero – era infuriato con gli Achei, in particolare con il loro Wanax Agamennone, per il rapimento da questi perpetrato ai danni di Criseide, la giovane figlia del Sacerdote di Apollo Criso (in realtà Sacerdote di Febo). Narra infatti il poeta che, per vendicare l’affronto il Dio decimò le schiere degli Achei con le sue terribili frecce, fino a che Agamennone non acconsentì di rilasciare la prigioniera, pretendendo però in cambio Briseide, una schiava di Achille. Ebbene, qui Omero fa, sì, il nome di Apollo, ma si riferisce di fatto a Febo, il cui parteggiare per i Troiani era una cosa del resto scontata, perché legata anche a un discorso di “stirpe” (tutti i Titani presero le parti di Troia, che rappresentava uno degli ultimi baluardi del loro culto); cosa che invece risulterebbe quantomeno anomala per una Divinità “Olimpica”.
Il Dio, infatti, continuò a parteggiare per i Troiani per tutta la durata della guerra, mettendoci decisamente la faccia e intervenendo più volte in prima persona. In un’occasione salvò la vita a Enea, nel corso di un duello fra questi e Diomede, e si rivelò determinante l’aiuto che prestò a Ettore e a Euforbo nel combattimento che li vedeva impegnati con Patroclo, amico “intimissimo” di Achille. Il Dio, infatti, oltre ad aver stordito Patroclo, che i Troiani avevano scambiato per il sovrano mirmidone per via dell’armatura che indossava, lo privò di quest’ultima, sciogliendola come neve al sole. Distrusse inoltre la punta della lancia con cui Patroclo stava mietendo numerose vittime fra le file troiane, e fu sempre Lui a guidare quella freccia, scoccata da Paride, che uccise Achille colpendolo al suo unico punto debole, il tallone.
Intorno al luogo di nascita di Apollo erano molte le città dell’Ellade, soprattutto se sedi di Santuari a Lui dedicati, che pretendevano di avergli dato i natali, ma tutte queste tradizioni di carattere locale vennero poi messe in ombra, per via dell’assimilazione Apollo-Febo, da quella relativa a Delos, rafforzata anche dall’autorità di cui godeva, fra gli Inni Omerici, quello dedicato al Dio. Ma, appurato che la figura di Apollo non debba assolutamente essere confusa o assimilata con quella di Febo, possiamo quindi scartare, in relazione alle origini di questo Dio, tutte le versioni del mito e le fonti che lo indicano, al pari di Artemide, come figlio della Dea Titana Leto, e di conseguenza anche tutte quelle che ne indicano la nascita sull’isola di Delos, incluso lo stesso Inno Omerico. Torniamo quindi a quanto abbiamo detto poc’anzi, ovvero che Apollo possa essere stato in origine un Dio tribale e pastorale di provenienza nordica e iperborea, ma racchiudente in sé anche evidenti tratti sia indo-europei che anatolici.
Sono state suggerite molte probabili origini etimologiche per il nome Ἀπόλλων (nella sua forma attica, ionica e greco-omerica) e per le sue varianti Ἀπέλλων (nella sua forma dorica), Ἀπείλων (nella sua forma arcadocipriota) e Ἄπλουν (nella sia forma eolica). Fra queste, la forma dorica Ἀπέλλων viene ritenuta dai filologi come la più arcaica, ma è essa è probabilmente derivante da una forma ancora precedente, Ἀπέλjων, che avrebbe la stessa origine del nome del mese dorico Apellaios (Ἀπελλαῖος) e delle offerte sacrificali dette Apellaia (Ἀπελλαῖα), che avevano luogo in concomitanza con le Iniziazioni dei giovani durante una festività detta Apellai (Ἀπέλλαι). Sempre secondo i filologi, tutti questi termini trarrebbero origine dal sostantivo dorico apella (ἀπέλλα), che in epoca arcaica aveva il significato di “muro”, “parete”, “steccato” o “recinto per gli animali”, e che successivamente indicò l’assemblea popolare di Sparta.
Altre interpretazioni etimologiche ci giungono dagli stessi autori della classicità, molti dei quali misero il nome di Apollo in associazione con il verbo greco ἀπόλλυμι (“distruggere”). Platone invece, nel Cratilo, metteva in connessione il nome del Dio con i termini ἀπόλυσις (“redenzione”), ἀπόλουσις (“purificazione”) e ἁπλοῦν (“semplice”), con particolare riferimento alla forma tessalica del nome di Apollo (Ἄπλουν).
Ma più ci addentriamo nella figura di questa Divinità, e più essa ci appare come manifestamente composita, al pari della sua personalità, tanto da rendere difficile qualsiasi tentativo di isolare elementi che permettano di stabilire con certezza un suo carattere originario.
A prescindere dai tratti indo-europei e anatolico-asiatici che questa Divinità racchiude (e che fra poco prenderemo in esame), non dobbiamo assolutamente trascurare i suoi elementi “nordici” o ario-nordici, a cominciare dalla capigliatura bionda attribuitagli, in netto contrasto con quelle nero-corvine delle antiche Divinità pelasgiche e pre-greche. Fra i suoi appellativi, infatti, come ci ricorda il grande mitologo Giacomo Prampolini, vi erano quelli di Xanthόs (“biondo”, sia che l’aggettivo alluda alla luce dorata o che indichi effettivamente il colore dei capelli) e Khrysokόmes (“dagli aurei capelli”). Interessante inoltre l’affinità del suo nome con la parola che significa “mela” in molte lingue nord-europee (ad esempio, apfel in Tedesco, apple in Inglese, abal in Celtico). C’è anche chi, fra gli storici delle religioni, ha visto un suo collegamento con la mitica isola di Avallon, o chi vi ha visto addirittura una trasposizione del Dio arabo-semitico Hobal. In ogni modo, la provenienza “nordica” del Dio viene sottolineata ancora dalla tradizione delfica, che ci narra come Apollo, per giungere al Santuario (che di fatto usurpò), sia disceso proprio da Settentrione, passando per la tessalica valle di Tempe. E, sempre secondo tale Tradizione, durante l’inverno il Dio si ritirava nella fredda Iperborea, da cui evidentemente era provenuto.

All’ipotesi della provenienza anatolica ci riconnette la documentata esistenza di un importante Dio anatolico noto come Aplu, la cui forma hittita Apaliunas è attestata da alcune tavolette, fra cui quella contenente la Lettera di Manapa-Tarhunta[7], risalente al 1295 a.C. circa. Aplu/Apaliunas, che nel nome ricalca pienamente la forma etrusca Aplu, da molti storici delle religioni è stato classificato come un terribile Dio delle pestilenze e delle malattie (ma, di riflesso, anche delle guarigioni), e come un potente arciere, un Signore e protettore degli animali selvatici dai marcati caratteri indo-europei, riconducibile in buona misura alla figura del Dio vedico Rudra. Venerato anche dagli Accadi e dagli Hurriti, era dai primi chiamato “Il Figlio di Enlil”, un epiteto che era proprio del Dio mesopotamico Nergal.
A differenza di altre Divinità del mondo ellenico, Apollo non aveva un “equivalente” romano diretto, e il suo culto si diffuse a Roma e nei territori da essa conquistati attraverso la mediazione etrusca e il relativo culto di Aplu, chiamato talvolta anche Apulu (interessante anche la sua assonanza con Apulia, l’antico nome della Puglia). Il suo culto venne ufficialmente introdotto nell’Urbe nel 421 a.C., ma varie fonti ci riferiscono che fosse già presente in epoca regia. Trovò poi nuovo impulso al tempo di Ottaviano Augusto, che dichiarava di essere un protetto del Dio (che avrebbe anche lanciato un fulmine nell’atrio della sua casa come presagio fausto per la sua lotta contro Marco Antonio) e che fece pertanto di Apollo una delle Divinità più influenti a Roma. Dopo la battaglia di Azio, la cui vittoria attribuiva proprio a Apollo, Augusto fece restaurare e ingrandire l’antico Tempio di Apollo Sosiano, istituì dei giochi quinquennali in onore del Dio e finanziò la costruzione del nuovo Tempio di Apollo Palatino, sull’omonimo colle, dove furono trasportati anche i Libri Sibillini. Affidò inoltre al poeta Orazio la composizione, in onore del Dio, del Carmen Saeculare, che fu cantato il 3 Giugno del 17 a.C. sul Palatino e sul Campidoglio da un coro di giovani fanciulle durante i Ludi Seaculares, voluti dall’imperatore per celebrare la venuta della nuova Età dell’Oro preannunciata dalla IV° Ecloga di Virgilio.
In epoca classica venne accentuato ulteriormente il carattere di Divinità solare attribuito ad Apollo quale “portatore di luce” e auriga del Carro Solare, tanto che venne tentata un’operazione per sostituire con la sua figura quella ingombrante e scomoda (per il clero zeutico) del Dio Titano Helios. Operazione non del tutto però riuscita, perché, nonostante numerosi tentativi di assimilazione, Apollo e Helios rimasero sostanzialmente due Divinità distinte e separate, sia agli occhi dei fedeli che nella letteratura.
Non staremo qui ad elencare le numerose imprese attribuite ad Apollo, né tantomeno gli altrettanto numerosi amori attribuiti a questo Dio, sia con Dee che con donne mortali, spesso frutto delle varie sovrapposizioni sincretistiche di cui questa Divinità multiforme fu oggetto le complesse vicende mitologiche ad essi correlate. Occorre però ricordare come il Dio, sfruttando probabilmente uno dei suoi più arcaici attributi di cantore pastorale, venne messo in connessione con Orfeo e con le Muse. Tale connessione è attestata già nell’Inno Omerico, che racconta fra le altre cose dell’incontro fra il Dio e il giovane Hermes (del quale ci occuperemo più avanti), ritenuto dalla Tradizione “Olimpica” figlio di Zeus e della Pleiade Maia. Narra l’Inno che Hermes, appena nato, sfuggì alla custodia della madre Maia, e iniziò a vagabondare per la Tessaglia, fino a imbattersi nel gregge del pastore Admeto, sacro ad Apollo. Il giovane e irrequieto Dio riuscì con uno stratagemma a rubare gli animali e, dopo averli nascosti in una grotta, usò gli intestini di alcuni di essi per realizzare le corde di una lira. Quando Apollo, infuriato, riuscì a rintracciare Hermes e a pretendere, con l’appoggio di Zeus, la restituzione del gregge, non poté fare a meno di innamorarsi dello strumento realizzato dal giovane Dio e del suo suono melodioso. Accettò così di lasciare a Hermes il maltolto in cambio della lira, che da allora divenne uno dei suoi simboli sacri. Secondo altre tradizioni avrebbe poi donato la lira a Orfeo e, alla morte di questi, decise di trasformarla nell’omonima costellazione.

Dietro questa apparente favoletta si cela il duplice chiaro intento, da parte del clero zeutico, di mettere il cappello, attraverso il personaggio Apollo, da un lato sull’odiata e temuta figura di Orfeo (che mai però riuscirono a controllare, né da vivo né tantomeno da morto, nonostante lo abbiano barbaramente ucciso), e dall’altro sulle stesse Muse, da sempre nel mirino di Zeus e dei suoi sodali.
Altra operazione strategica, da parte di coloro che amo chiamare i “tessitori della trama” (ma che i fratelli Wachowski chiamerebbero di buon grado i “Guardiani della Matrix”) è stata quella che viene ricordata dalla Tradizione mitologica ellenica e dalla relativa letteratura come la principale – nonché la prima – impresa di Apollo: l’uccisione del serpente-drago Python e l’usurpazione del Santuario di Delfi. Tale operazione rientra nel quadro di un piano stabilito, da parte del clero zeutico, per affermare il totale e definitivo controllo sui principali Santuari oracolari del mondo greco. Abbiamo già visto, parlando di Zeus, come tali gerarchie sacerdotali avessero già messo in “sicurezza” sotto il loro definitivo controllo l’antichissimo Santuario oracolare pelasgico di Dodona, in Epiro, estromettendone di fatto la potente Dea Titana Dione. Restava, a questo punto, da espugnare un altro grande Santuario oracolare, anch’esso di fondazione pelasgica, che ancora sfuggiva al loro controllo, quello di Delfi.
Abbiamo già detto, nelle scorse pagine, che anticamente il nome originale di tale Santuario, che sorgeva nella Focide, su un contrafforte alle pendici del Monte Parnaso, circa 130 chilometri a Nord-Ovest di Atene, era Python, e che esso fosse, fin da epoche remote, sotto il controllo di un’altra potente Dea Titana, Themis, la Dea della Giustizia Siderale. Themis vi presiedeva, associata nel culto da Python, un’arcaica Divinità serpentiforme da sempre venerata dai Pelasgi, e la Sacerdotessa che emetteva gli oracoli, agendo così da tramite nella comunicazione fra gli Dei Titani e i mortali, era chiamata Pizia (Πυϑία), appellativo derivante proprio da Python. Nei tempi più antichi il suo ufficio si svolgeva periodicamente, una sola volta all’anno, il settimo giorno del mese delfico di Bysios (Febbraio), l’unico momento in cui si potevano richiedere responsi all’oracolo. Più tardi, già durante il Medio Evo Ellenico, dato il numero sempre crescente di pellegrini interroganti, la Pizia dovette rimanere in funzione costantemente, e si ebbero talora anche due e perfino tre Pizie che officiavano a turno.
Secondo la Tradizione e le numerose fonti antiche pervenuteci, gli interroganti, incoronati d’alloro, presentavano al Προϕήτης (Sacerdote a capo del Santuario) le loro richieste, e la Pizia, dopo essersi purificata con l’acqua della fonte Castalia e avere indossata la lunga veste rituale, penetrava nell’adyton del Tempio, beveva un sorso d’acqua della corrente Cassotis, che scorreva sotto di esso, e, dopo aver masticate delle foglie d’alloro, andava a prender posto sul seggio ad ella destinato, il quale era collocato sopra un disco adattato nel bacino stesso dell’aureo tripode dell’adyton. Il tripode si trovava situato al di sopra di una voragine da cui salivano vapori ed esalazioni che si ritiene avessero la virtù di mettere in stato d’estasi chi li aspirava. Entrata in estasi, la Pizia pronunciava parole spesso oscure e sibilline, che il Profetes parafrasava in versi (anticamente solo in esametri, più tardi anche in altro metro), o talvolta anche in prosa, e consegnava ai richiedenti.

(Adelaide, Art Gallery of South Australia)
Abbiamo già inoltre accennato al fatto che, virtualmente, la Dea Titana Themis fosse stata già da tempo “espropriata” del suo Santuario da parte del Dio Delphinios, una Divinità di origine cretese che risultò determinante per la ridenominazione del luogo in Dephi. Ma si trattò, a mio parere, vista anche la non ostilità o incompatibilità fra queste due Forze Divine, di un’operazione “politica” pacifica e di avvicendamento, attuata dalle gerarchie sacerdotali del Santuario, probabilmente con la direzione di un particolare genos di origine cretese, forse diretto erede per linea di sangue dell’aristocrazia o della casta sacerdotale dell’ormai tramontata civiltà Minoica, ed è quindi plausibile che Themis fosse rimasta, da un punto di vista “energetico”, intimamente legata a quel luogo sacro che era considerato non a caso l’ombelico del mondo. In mancanza di documentazione scritta, non mi è possibile provare con certezza questa mia ipotesi, anche se non mancano gli indizi che possono avvalorarla. Fra questi, in primis, un passo delle Eumenidi, tragedia in cui l’Eleusino Eschilo ci narra che Apollo “ricevette” il Santuario non da Delphinios, ma direttamente da Gea, Febe e dalla stessa Themis[8]. Inoltre, vi sono elementi a sufficienza per provare l’origine minoica del culto oracolare di Delfi, i cui Sacerdoti, ancora in tempi storici, venivano comunemente chiamati Labrydaen (“gli uomini con la Labrys”), e la Labrys era uno dei simboli per eccellenza dell’antica religione Minoica, fondata sul culto degli Dei Titani, da cui derivò l’Eleusinità.
Se dobbiamo qui fare una sintesi delle varie fonti che ci narrano la cosiddetta “impresa” di Apollo a Delfi (Plutarco, Eliano, Diodoro Siculo, altre minori, fino ad arrivare all’Inno Omerico), vediamo che il Dio, appena quattro giorni dopo la sua nascita, già fornito del “dono della profezia” e armato delle frecce di Efesto, si reca alle pendici del Parnaso e si dirige verso il Santuario. Trova però sulla sua strada Python, custode e difensore di quel sacro luogo. Interessante rilevare come, per giustificare quello che avviene dopo, ovvero il ferimento e la sacrilega uccisione di Python, è stata inserita nella storia la “notizia” che il drago-serpente sarebbe stato colpevole di aver tentato di fare violenza alla Dea Leto quando Ella era incinta del Dio e di sua “sorella” Artemide. Ma abbiamo già detto che dobbiamo rigettare con decisione l’arbitraria identificazione di Apollo con il figlio di Leto Febo, e non possiamo neanche non rilevare che, nella vicenda di Leto narrataci dalla Tradizione Misterica, non vi è alcuna traccia di questo ipotetico tentativo di violenza da parte di Python ai danni della Dea. Questo inserimento, quindi, appare quindi del tutto giustificatorio, e possiamo trovarlo in testi tardi come le Fabulae di Igino[9], in cui viene fatta figurare Hera come “mandante” dei presunti tentativi di violenza di Python ai danni di Leto per via della sua gelosia. L’inserimento acquisisce così, in Igino, una duplice funzione: quella giustificatoria, da un lato, appunto per “giustificare” la sacrilega uccisione di Python da parte di Apollo, e quella confermatoria, dall’altro, tesa ad affermare la sacrilega versione di un’unione fra Leto e Zeus.
Sta di fatto che Apollo ferisce gravemente Python con le sue frecce e poi lo insegue fin dentro l’Area Sacra, profanandola, dove poi lo uccide in prossimità della voragine che connetteva il Santuario con il mondo sotterraneo, proprio vicino alla roccia dove sedeva la Pizia sul suo tripode d’oro.
Particolarmente interessante risulta anche la versione di Porfirio, che, nella sua Vita di Pitagora, ci riferisce che il Divino Filosofo, durante una sua visita a Delfi, si soffermò sulla tomba di Apollo, dove iscrisse un distico per mezzo del quale rivelava che il Dio era in realtà figlio di Sileno, che era stato ucciso da Phyton e che era stato poi sepolto sotto il Tripode. Una notizia, questa, a dir poco eclatante, perché non solo ribalta tutte le versioni precedenti in merito all’esito del combattimento fra il Dio e il Drago-Serpente, ma rivelerebbe soprattutto che anche l’Apollo della Tradizione Ellenica, al pari di Zeus, sarebbe stato un mortale e che, come Zeus, sarebbe stato ucciso e sepolto.
Porfirio era notoriamente un grande Iniziato Eleusino e le rivelazioni che ci concede nella sua biografia pitagorica, inspiegabilmente e clamorosamente ignorate dagli storici delle religioni, ci confermano quelle che, in ambito iniziatico, sono sempre state considerate delle palesi verità.
Károly Kerényi[10], dal canto suo, osservava che, nelle versioni più arcaiche del mito, fra cui quella dell’Inno Omerico, figurano due serpenti-dragoni, uno di sesso femminile, menzionato come Delphine, e uno di sesso maschile, menzionato come Typhon, lasciando intendere che il narratore tendeva a identificare il drago-serpente ucciso da Apollo con il Typhon, protagonista della Tifonomachia, ultima risorsa di Gaia per la lotta contro Zeus e gli Olimpici narrataci da Esiodo nella Teogonia. Non vi sono però elementi, né misterici né dottrinali, per confermare un’identificazione o un’assimilazione delle due figure, ed è quindi probabile che si tratti di un’interpretazione popolare del mito alla luce degli echi, tutt’altro che sopiti della Titanomachia e dei suoi strascichi.

Interessanti anche le interpretazioni del mitologo Robert Graves, che ravvisava nella vicenda narrata dalle fonti il ricordo di turbolenze politiche e sociali che portarono alla conquista – violenta, sacrilega e profana – da parte degli Elleni di un importante luogo sacro pre-ellenico [11]. E, sostanzialmente, proprio questo avvenne a Delfi, dove, al di là del materiale, reale ed effettivo intervento di Apollo (che comunque la Tradizione Misterica non nega e non mette in discussione), il Santuario fu senza dubbio oggetto di una conquista violenta. Una conquista che determinò sicuramente la cacciata (se non l’uccisione), oltre che del drago-serpente Python, anche dell’antico genos sacerdotale di origine minoica che da sempre ne deteneva il controllo e l’amministrazione, e il passaggio dei poteri a tutto vantaggio del clero zeutico, che da quel momento in poi vi impose la figura di Apollo (“provvidenzialmente” divenuto a tal scopo un Dio oracolare).
Questa drammatica conquista del Santuario da parte del clero zeutico e di Apollo dovette incontrare, come rilevava sempre Graves, una forte opposizione da parte delle masse popolari dei fedeli, e molto probabilmente dette origine a tutta una serie di rivolte. Tanto che, come ci narrano le fonti, Apollo fu costretto, per espiare il suo gesto sacrilego, a compiere per volontà dello stesso Zeus un percorso purificatorio che lo portò ad auto-esiliarsi per otto anni (si noti qui la valenza simbolica, poiché l’otto è sempre stato il numero sacro per eccellenza della religione Minoica e della Tradizione Misterica Eleusina da essa derivata) nella Valle di Tempe, da cui poi tornò a Delfi trionfalmente. Ma neanche l’esilio espiatorio del Dio a Tempe si dimostrò a quanto pare sufficiente, perché ci riferiscono sempre le fonti che Apollo fu costretto a salpare per Creta, dove si recò da un Sacerdote di nome Carmanore per compiere ulteriori riti espiatori.
Ma, ancora una volta, tutte queste espiazioni non si rivelarono sufficienti o risolutive per lavare la colpa del Dio, perché si rese necessaria anche l’istituzione delle purificatorie feste Septeria (o della Venerazione), che, nella forma più solenne si celebravano ogni nove anni, e dei Giochi Pitici, in onore di Python, che Apollo fu per punizione costretto a presiedere.
Precursori dei Giochi Olimpici, quelli Pitici divennero col tempo uno dei quattro Giochi Panellenici, e si disputavano ogni quattro anni proprio presso il Santuario di Delfi. Si svolsero ininterrottamente dal 582 a.C. fino al 384 d.C., quando furono aboliti dai Cristiani. A differenza dei Giochi Olimpici, non prevedevano solo gare atletiche e sportive, ma anche competizioni per musicisti e poeti, e i vincitori ricevevano una corona di alloro donata dalla città di Tempe, in Tessaglia, la stessa che più volte abbiamo menzionato per il suo legame con Apollo. Secondo una tradizione riportata da Pausania, infatti, il culto di Apollo sarebbe giunto a Delfi proprio da Tempe, al centro di una regione di antica tradizione oracolare[12].
Il nome del luogo, Δελφοί, oltre ad essere connesso con il Dio cretese Delphinios e con il drago-serpente femmina Delphine, trova connessione anche con δελϕύς (“utero”), e Delfi non a caso era ritenuta l’ombelico del mondo, il centro della Terra dal quale tutto ha avuto origine e dove tutto è destinato a rinascere; nello stesso modo in cui, secondo le credenze dell’antichità, il feto si sviluppa nel grembo materno crescendo attorno all’ombelico, nucleo vitale del futuro essere umano. Ben le si addiceva, quindi, il carattere di località germinale primordiale, abitata dal serpente-utero, un luogo quindi per eccellenza preposto per il contatto con il Divino. E a Delfi l’Omphalos, la celebre pietra il cui nome significa proprio “ombelico”, indicava a tutti coloro che vi giungevano che si trovavano proprio al centro del mondo.
Il significato e il ruolo dell’Omphalos, in relazione a Delfi, è stato esemplarmente esposto anche da Mircea Eliade, che scriveva: «È a partire dal centro (ombelico) che prende il via la creazione del mondo e, imitando in modo solenne questo modello esemplare, ogni costruzione e ogni “fabbricazione” deve essere fatta a partire da un centro»[13].
Anche la celebre filologa classica Belga Marie Delcourt (1891-1979) ha dedicato anni di studi e ricerche al rapporto Delfi-Omphalos, concentrando in particolare la sua attenzione sul significato dell’Agrenon, quel complesso reticolo, che si riteneva fatto di bende o fili di lana, presente su tutte le diverse raffigurazioni conosciute degli Omphalos di area ellenica. In un suo importante saggio del 1955, la Delcourt scriveva: «L’antico feticcio, che era considerato la pietra espulsa da Kronos, era quotidianamente unto d’olio e ornato con un nastro di lana grezza nei giorni di festa. Si è tentati di vedere, semplicemente, nell’Agrenon, un ornamento di questo tipo, ma allora si spiega male il fatto che la rete sia presente, scolpita in altorilievo, sull’Omphalos di marmo che ha lo scopo di rappresentare il primo alla devozione dei fedeli, e che sia riprodotto su quasi tutte le immagini della pietra sacra»[14].
E, sempre alla Delcourt, dobbiamo delle importanti osservazioni sul significato simbolico dell’Omphalos e della sua forma: «Nessuno, credo, si è mai stupito di vedere i Greci chiamare omphalos una sporgenza conica in una superficie piana, quando l’ombelico dell’uomo adulto è una cicatrice schiacciata. L’omphalos bombato si ricollega a due realtà concrete: l’ombelico della donna gravida alla fine della sua gravidanza e quello del neonato, che si appiattisce solo dopo diversi giorni. Un simbolismo di fecondità, di nascita»[15].
È proprio questo il punto: l’Omphalos, nelle conclusioni della Delcourt, rappresenta l’ombelico di una donna gravida, o, se preferiamo, quello della stessa Gea. E René Guénon metteva in correlazione il simbolismo dell’Omphalos con quello dell’uovo, che a sua volta è in relazione simbolica con il cuore: «La somiglianza di forma fra il cuore e l’uovo (…) può avere un significato vero e proprio solo se esistono delle relazioni più profonde. Ora, il fatto che l’omphalos e il betilo, che sono incontestabilmente simboli del centro, siano spesso di forma ovoidale, come era l’omphalos di Delfi, ne è una riprova (…). L’Uovo del Mondo è la rappresentazione non del “cosmo” nel suo stato di completa manifestazione, ma di ciò a partire da cui si effettuerà il suo sviluppo. E se tale sviluppo è rappresentato come un’espansione che si compie in tutte le direzioni a partire dal suo punto d’inizio, è evidente che questo punto coinciderà necessariamente con il centro stesso»[16].
Jean Richer, nel suo mirabile saggio sulla Geografia Sacra[17], riteneva che la rappresentazione grafica di questa espansione che si effettua contemporaneamente in tutte le direzioni fosse proprio da ravvisare nell’Agrenon, in quella rete scolpita su tutte le principali raffigurazioni dell’Omphalos delfico e che rappresenta chiaramente ed esattamente quelle complesse suddivisioni geometriche sacre e quegli allineamenti che egli aveva individuato sulla carta della Grecia. L’Agrenon, quindi, secondo Richer, può essere in relazione diretta con il ruolo di centro generatore assunto da Delfi.
Con la conquista – anzi, potremmo dire l’usurpazione – di questo grande Santuario oracolare, il clero zeutico e i “tessitori della trama”, che già si erano accaparrati non molti secoli prima il Santuario di Dodona, ottennero un fondamentale risultato strategico. Avevano infatti provveduto a mettere “in sicurezza” sotto il loro totale controllo già due importanti varchi di contatto diretto fra gli Dei Titani e i mortali (Dodona e Delfi) e a estromettere le grandi Dee Titane che ne esercitavano il controllo, Dione e Themis. Il controllo dei grandi Santuari oracolari rappresentava, infatti, per il clero zeutico, un’assoluta priorità, sia per la gestione delle potenti energie telluriche e sotterranee che essi celavano, sia soprattutto perché tali Santuari, se fossero rimasti sotto il controllo e la gestione da un clero legato alla religione Titanica, avrebbero rappresentato per i “tessitori della trama” una seria minaccia, proprio per la loro capacità di mettere in contatto Microcosmo e Macrocosmo, gli uomini mortali e gli Dei Titani loro creatori. Queste “porte” di contatto diretto e di comunicazione fra gli Dei Titani e l’umanità, esistenti soltanto in pochi posti nel mondo, nelle intenzioni del clero zeutico e dei suoi superiori incogniti andavano a tutti i costi chiuse.

Ma l’operazione intrapresa da parte dei “Controllori della Matrix” non era ancora conclusa. Essa venne in seguito completata con l’usurpazione dell’ultimo grande Santuario oracolare che ancora non era caduto sotto il loro controllo: quello di Dydyma, sulla costa egea dell’Anatolia.
L’antica Dydyma sorgeva presso l’odierna città turca di Didim, che ne ha ereditato il nome, nel distretto di Söke, nella provincia caria di Aydın. Divenne celebre in epoca classica come sede del più importante Santuario oracolare dell’area dell’Egeo, il Dydymaion, anch’esso usurpato da Apollo. In realtà il Santuario esisteva già da epoca piuttosto remota, ed era presieduto da Cibele Dyndymena, il cui culto era originario della Frigia. Sia Erodoto che Pausania ci attestano l’antichità del Santuario e del suo oracolo, confermandoci che la sua esistenza era da far risalire ad un’epoca di gran lunga antecedente alla colonizzazione degli Ioni, che occuparono Dydyma attorno al VI° secolo a.C. E, in effetti, le ricerche archeologiche hanno dimostrato una presenza cultuale nel sito già nel II° millennio a.C.
In Greco dydyma significa “gemello”, ma gli Ioni che invasero e occuparono le coste anatoliche interpretarono il toponimo a loro uso e consumo, storpiando la sua forma originale Dyndyma sulla base di una sua assonanza con dydyma, ignorando l’etimo esatto che, in lingua Caria e in altri dialetti di quell’area costiera, indicava ed incarnava un epiteto della Dea Cibele, indicante la sua natura “montanara” e la sua provenienza dal Monte Dyn-dymo, una montagna della Frigia.
Cibele viene tradizionalmente associata o identificata con la Dea Titana Rea, paredra di Kronos e madre di Demetra e Poseidone. In realtà fra le due figure divine esistono non poche differenze, a cominciare dal fatto che Cibele è una Grande Madre e, come Divinità prettamente anatolica, è una De-a delle vette, mentre Rea, benché come tutti i Titani sia una Divinità stellare, è sempre stata associata alle pianure. Ma, al di là di queste disquisizioni meramente “geografiche” e delle dispute teologiche da esse derivate, e al di là degli attributi “umani” conferiti a queste Dee dalle antiche popolazioni che le veneravano, non è mai stata rilevata alcuna rilevante incompatibilità fra le due figure.
A differenza di quanto avvenuto per Delfi, sono andate purtroppo perdute tutte le fonti e le eventuali testimonianze relative alla conquista ellenica del Santuario, sia quelle di parte caria, sia quelle degli occupanti Ioni. Qui, la sostituzione nel culto fra la Cibele Dyndymena e la figura di un Apollo ormai divenuto “pizico” e “oracolare” non è stata enfatizzata, al pari di quella di Delfi, nella poetica e nella letteratura, e non si ha memoria dell’uccisione di alcun drago-serpente o altro custode sacrale del luogo. Ma questo non significa che tale conquista e avvicendamento nel culto, avvenuti plausibilmente attorno alla metà del VI° secolo a.C., siano stati indolori e non abbiano provocato disordini o rivolte. E il fatto stesso che alla figura di un Apollo Didymeus sia stato necessario associare nel culto del Santuario quella di uno Zeus Didymeus, scomodando così direttamente l’usurpatore sommo in prima persona, avvalora l’ipotesi che tale conquista sia stata per gli Ioni tutt’altro che una passeggiata di salute.
L’operazione risultava comunque già senz’altro completata quando, nel 494 a.C., sia la città che il Santuario vennero distrutti da un’incursione persiana guidata da Dario I° in persona, nel corso della quale venne trafugata per essere trasportata a Ectabana una statua bronzea di Apollo, opera di Canaco di Sicione. E si ha notizia che, fino a questa distruzione da parte dei Persiani, sia la città che il Santuario fossero amministrati dal genos sacerdotale apollineo dei Branchidi, sedicenti discendenti del leggendario Brancos, giovane mortale amato dal Dio.
Nel 334 a.C., con la conquista della regione da parte di Alessandro Magno, il Santuario venne restaurato e riconsacrato, sempre ad Apollo, ed amministrativamente passò sotto il controllo della vicina città di Mileto. Pochi anni più tardi, nel 330 a.C., Seleuco I°, a cui era toccata la parte dell’Impero di Alessandro comprendente l’Anatolia, fece riportare nel Santuario dalla Persia alcuni dei tesori trafugati da Dario, fra cui la statua di bronzo del Dio, e, successivamente, l’amministrazione di Mileto dette inizio ad una imponente opera di ristrutturazione e riedificazione dell’intera area sacra, con la costruzione di un maestoso Tempio che venne ritenuto il più grande dell’intero mondo greco.
Il Santuario, seguendo la sorte toccata a migliaia di altri luoghi sacri, venne infine chiuso definitivamente dal Prefetto Materno Cinergio, su ordine delle intolleranti autorità cristiane, tra il 384 e il 388 d.C.
NOTE
[1] Da un papiro segreto Eleusino Madre.
[2] Guido Maria St. Mariani di Costa Sancti Severi: La Titania Letho, Dea Eleusina Madre. Da Aesyr n. 3 (Settembre-Ottobre 2012).
[3] Da un papiro segreto Eleusino Madre.
[4] Guido Maria St. Mariani di Costa Sancti Severi: articolo citato.
[5] Ibidem.
[6] Guido Maria St. Mariani di Costa Sancti severi: articolo citato.
[7] La Lettera di Manapa-Tarhunta (CTH 191; KUB 19.5 + KBo 19.79), rinvenuta negli anni ’80, è stata scritta attorno al 1295 a.C. da un Re vassallo, chiamato appunto Manapa-Tarhunta, al Sovrano di Hattusa.
[8] Eschilo: Eumenidi, 1-19.
[9] Igino: Fabulae, 140.
[10] Károly Kerényi: The Gods of the Greeks. Ed. Grove Press, New York 1960.
[11] Robert Graves: The Greek Myths. Ed. Penguin, London 1955.
[12] Pausania: Periegesi della Grecia, IX°, 30.
[13] Mircea Eliade: Arti del metallo e Alchimia. Ed. Boringhieri, Torino 1980.
[14] Marie Delcourt: L’Oracle de Delphes. Ed. Payot, Paris 1955.
[15] Ibidem.
[16] René Guénon: Le coeur et l’oeuf du monde. Articolo su Etudes Traditionelles n. 218, Febbraio 1938.
[17] Jean Richer: Geografia Sacra del mondo greco. Ed. Rusconi, Milano 1989.







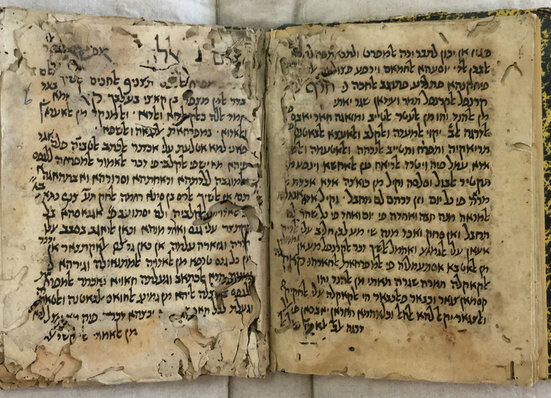
1 Comment