In questo saggio parlerò dell’insieme delle forze sociali – le considererò nei loro rapporti – che hanno caratterizzato il medioevo a partire dal periodo del feudalesimo carolingio, fase storica in cui, secondo Henri Pirenne, il pieno avvento dell’epoca medievale (la sua fase nascente) si realizza, si svolge, definitivamente.Tale stadio iniziale del medioevo ha come sua premessa, ha come suo immediato antecedente, la progressiva corrosione dei domini imperiali romani ad opera dei barbari, i quali, quantomeno, tendevano tutti al dominio della florida, prosperosa, Europa mediterranea. Ma in epoca carolingia i ricchi traffici del Mediterraneo sono già egemonizzati dagli Arabi. Il feudalesimo dei tempi di Carlo Magno era espressione di una società prevalentemente agraria e i mercati, all’interno del suo impero, ebbero un peso pressoché insignificante. Ebbene, la rinascita delle città e la seguente affermazione crescente dei ceti cittadini, la si ebbe forse già a partire dal periodo che seguì immediatamente la morte di Carlo Magno. Corrispose agli albori di un feudalesimo acefalo (il titolo imperiale da allora valse assai poco, ma, ovviamente, soltanto all’interno dell’intero, detto, periodo di anarchia feudale). Tale fenomeno storico, gradualmente, giungerà a compimento (vi è da ritenerlo) – protraendosi fra l’altro oltre se stesso – con la concessione dell’ereditarietà dei feudi minori (precedentemente essa era valsa per i feudi maggiori). Ma ciò coincide con la fine del feudalesimo stesso (e delle sue successive propaggini), ovvero – di fatto – con il possesso privato di un feudo da parte di un nobile, feudo che cessa, perciò stesso, di esser tale: i re, o addirittura delle dinastie regali, erano nel frattanto già scelti dalle piccole e, più che altro, dalle grandi aristocrazie. Sarebbe dunque in fase di anarchia feudale che sorgerebbero le prime corporazioni, da intendersi però quali associazioni presso le quali gli avventurosi mercanti che le componevano erano protetti, non solo nelle loro attività, ma addirittura nelle loro stesse vite. Ebbene, lo sfaldamento progressivo del corporativismo medievale (vedremo in quale ulteriore senso esso andrà inteso), segnerà l’inizio dell’età moderna.
In questo saggio faccio riferimento a tre testi. Uno di essi è dunque Le città del medioevo del summenzionato storico belga (cfr. H. Pirenne, Le città del medioevo, Newton & Compton, Roma 1997.). Faccio poi riferimento al celebre L’Autunno del Medioevo (cfr. J. Huizinga, L’Autunno del Medioevo, Newton & Compton, Roma 1992). Infine, ad un libro curato da Jacques Le Goff, intitolato L’uomo medievale (cfr. AA. VV., L’uomo medievale, Laterza, Bari 1988). Se tutto ciò che, dunque, di materia storica si è detto fino ad ora lo si può confrontare con quanto è contenuto nella succitata opera di Pirenne, il lettore potrà raffrontare l’ultima affermazione da me svolta (attinente ovviamente a detta materia), e tutto ciò che dirò in seguito, anche con il libro summenzionato di Huizinga.  Esso si concentra ad esaminare i secoli quattordicesimo e quindicesimo (riferendosi inoltre, soprattutto, agli eventi che caratterizzarono la Borgogna e i suoi domini), considerandoli come i secoli di un medioevo ormai al tramonto. Mi sembra infatti che, leggendo L’Autunno del Medioevo, in detti secoli i valori più tipicamente medievali vadano perdendo di credibilità, essendo man mano oggetto di una corrosiva dissacrazione. Nel cinquecento svaniranno definitivamente, il che segnerebbe per lo storico olandese l’avvento del Rinascimento e della modernità: il mondo classico greco-romano verrà recuperato (perlomeno in parte) e rivalutato; più in generale, il disaccordo tra uomo e mondo, tra la sua umanità, la sua nobiltà, persino la sua santità, e un mondo considerato come basso, abbietto e meschino, verrà meno. L’uomo ritroverà se stesso, considerandosi adesso come più simile al mondo rispetto a come egli si era immaginato (rispetto a quanto aveva fantasticato di se stesso) durante il medioevo. Ma ciò, a mio parere, corrisponde ad una riabilitazione del suo egoismo (si pensi – ad esempio e in primo luogo – al ruolo giocato dalla riscoperta di quest’ultimo nella nascita della scienza moderna, nonché alla graduale affermazione del disincantato punto di vista di quest’ultima in ogni settore della conoscenza umana). Detto egoismo andrà, a mio parere, man mano a corrodere l’ingenua oggettività, sia valoriale che più propriamente conoscitiva, che caratterizzò i cosiddetti ‘secoli bui’, fino al raggiungimento dei tempi più attuali (con riferimento all’odierno modello sociale, politico ed economico, di matrice occidentale). L’ultimo dei tre libri dell’assai essenziale bibliografia di riferimento di questo saggio, esamina varie figure che furono protagoniste dell’età di mezzo. Se, come ho già detto, anch’io analizzerò le varie tipologie umane in gioco nello scacchiere medievale, il lettore potrà confrontare quanto da me asserito circa esse con quanto emerge nel suddetto libro (in cui ogni capitolo è fra l’altro scritto da un affermato storico dei tempi più recenti). Ma un analogo confronto andrà fatto con quanto è contenuto nel libro di Pirenne e in quello di Huizinga, in quanto il mio punto di vista non converge mai del tutto con quanto è espresso nei tre riferimenti bibliografici di questo saggio. A questo punto è necessario parlare della scientificità di quest’ultimo.
Esso si concentra ad esaminare i secoli quattordicesimo e quindicesimo (riferendosi inoltre, soprattutto, agli eventi che caratterizzarono la Borgogna e i suoi domini), considerandoli come i secoli di un medioevo ormai al tramonto. Mi sembra infatti che, leggendo L’Autunno del Medioevo, in detti secoli i valori più tipicamente medievali vadano perdendo di credibilità, essendo man mano oggetto di una corrosiva dissacrazione. Nel cinquecento svaniranno definitivamente, il che segnerebbe per lo storico olandese l’avvento del Rinascimento e della modernità: il mondo classico greco-romano verrà recuperato (perlomeno in parte) e rivalutato; più in generale, il disaccordo tra uomo e mondo, tra la sua umanità, la sua nobiltà, persino la sua santità, e un mondo considerato come basso, abbietto e meschino, verrà meno. L’uomo ritroverà se stesso, considerandosi adesso come più simile al mondo rispetto a come egli si era immaginato (rispetto a quanto aveva fantasticato di se stesso) durante il medioevo. Ma ciò, a mio parere, corrisponde ad una riabilitazione del suo egoismo (si pensi – ad esempio e in primo luogo – al ruolo giocato dalla riscoperta di quest’ultimo nella nascita della scienza moderna, nonché alla graduale affermazione del disincantato punto di vista di quest’ultima in ogni settore della conoscenza umana). Detto egoismo andrà, a mio parere, man mano a corrodere l’ingenua oggettività, sia valoriale che più propriamente conoscitiva, che caratterizzò i cosiddetti ‘secoli bui’, fino al raggiungimento dei tempi più attuali (con riferimento all’odierno modello sociale, politico ed economico, di matrice occidentale). L’ultimo dei tre libri dell’assai essenziale bibliografia di riferimento di questo saggio, esamina varie figure che furono protagoniste dell’età di mezzo. Se, come ho già detto, anch’io analizzerò le varie tipologie umane in gioco nello scacchiere medievale, il lettore potrà confrontare quanto da me asserito circa esse con quanto emerge nel suddetto libro (in cui ogni capitolo è fra l’altro scritto da un affermato storico dei tempi più recenti). Ma un analogo confronto andrà fatto con quanto è contenuto nel libro di Pirenne e in quello di Huizinga, in quanto il mio punto di vista non converge mai del tutto con quanto è espresso nei tre riferimenti bibliografici di questo saggio. A questo punto è necessario parlare della scientificità di quest’ultimo.
Ponendola anticipatamente a confronto con i criteri utilizzati dallo storico olandese per portare acqua al mulino delle sue tesi, essi sono per lo più di tipo documentale: argomenta a favore del suo punto di vista di storico esponendo una fitta documentazione che, a dire il vero, non appare sempre convincente (perlomeno a mio parere). Ma, del resto, la svariata mole di documenti cui ci si potrebbe riferire per ricostruire l’età di mezzo, appare per lo più viziata: può essere faziosa, quando non addirittura falsata, infine ermeneuticamente scorretta. E questo è il motivo per il quale interpretare un’epoca relativamente recente come quella medievale risulta, ancora oggi, un compito difficoltoso da realizzare. Del resto, credo che l’intera storia, persino quella più recente, non sia poi così facile da comprendere. Faccio un esempio (a mio parere molto significativo, anche se è accaduto in tempi non recentissimi): gli studiosi sono addirittura in disaccordo per quel che riguarda l’individuazione delle cause che condussero alla Grande Depressione statunitense (personalmente ritengo sia stata causata da un liberismo incontrollato, da un laissez-faire che avrebbe dovuto condurre all’equilibrio economico, e che invece condusse alla ‘crisi del ventinove’. Non fu dunque caratterizzata da uno stallo economico dovuto alla saturazione del mercato. Se così fosse, del resto, l’applicazione delle misure keynesiane del New Deal per porre rimedio alla crisi non avrebbe avuto alcun senso. Inoltre credo che la spartizione aconcorrenziale dei mercati da parte di una pluralità di imprese sia un fenomeno economico molto recente, nonché ancora oggi vigente). Ma veniamo a parlare del criterio da me utilizzato per la ricostruzione dei fenomeni storici, a partire ovviamente da una fase dell’alto medioevo abbastanza inoltrata. Credo di aver individuato delle figure archetipiche (o quasi archetipiche, o magari aprioristiche, o quasi), i cui caratteri le pongono in un rapporto dialettico, conflittuale, con altre figure, oppure in una relazione di alleanza con ulteriori forze storiche. Dopo aver individuato i caratteri di ognuna di esse sarà possibile porle in rivalità, in contesa, quando non in armonia, con le restanti. Sono esse tutte i motori dei mutamenti storici. Talvolta esse verranno descritte nella loro astratta purezza. Ma con ciò, il discorso che ne seguirà – e che le concernerà – non potrà che risultare schematico. Tuttavia la conoscenza in generale è sempre schematica. Potrà dunque capitare di accostare due diversi contesti nazionali i quali, in una medesima fase storica, hanno presentato una configurazione politica assai affine. Ebbene, per chi voglia procedere ulteriormente in direzione della conoscenza, al fine di cogliere anche le differenze tra i due anzidetti, ipotetici, contesti, in modo tale da avere una conoscenza più particolareggiata di entrambi, lo potrà fare consultando dei buoni libri riguardanti la storia sia dell’una che dell’altra (dunque non specificata) nazione.
Svolto ogni necessario preambolo, passiamo ora ad individuare, a determinare, una certa tipologia umana: parliamo dunque dell’aristocrazia, facendo rientrare in tale categoria di uomini sia la piccola che la grande nobiltà, nonché la regalità stessa. L’uomo aristocratico non ha una mentalità imprenditoriale e ottimizzatrice (né, tantomeno, più semplicemente ‘lavoratrice’): non è infatti ‘uomo di conoscenza’, ma d’azione. Lo sfruttamento dei suoi poderi è interamente lasciata nelle mani dei suoi contadini, i quali, per via della loro proverbiale ignoranza, non prenderanno, a loro volta, alcuna iniziativa affinché i suoli che coltivano riescano a rendere il massimo: le loro conoscenze dell’agricoltura sono basilari. Quando dunque i suoi terreni divengono improduttivi, l’aristocratico li abbandona, andando in cerca di nuovi terreni fertili di cui impossessarsi con la forza, rapinandoli (dopodiché, per così dire, il gioco ricomincia daccapo). In epoca di regalità feudale il dominio del re coincide con il pubblico demanio, il quale coincide del tutto con un’intera nazione, oppure con un impero. C’è da fare una guerra di razzia: il re (che diverrà magari il futuro imperatore, per via della grande mole di possedimenti che conquisterà) assolda degli aristocratici cui prometterà in cambio terre di cui usufruire semplicemente. Questi ultimi (i vassalli del re), a loro volta, recluteranno ulteriori aristocratici (i loro futuri vassalli, detti ‘valvassori’) cui cederanno parte delle loro conquiste, le quali diverranno i feudi di questi ultimi. In una gerarchia feudale, ogni suo membro (il ‘signore’), assicura protezione a chi è immediatamente (socialmente) più in basso di lui (il suo servitore), oltre ad avergli assegnato un possedimento di cui usufruire. Ogni ‘signore’ vuole in cambio dal suo sottoposto aiuto militare in caso di guerra, pretende il versamento di tributi da parte di quest’ultimo (più in natura che in denaro, nel caso in cui l’ipotetica società feudale cui ci si sta riferendo sia più agraria che industriale). Inoltre gode di privilegi giudiziari-polizieschi da far valere nel caso in cui il suo più immediato sottoposto lo tradisca in una qualsiasi maniera, venendo in tal modo meno ad uno dei suoi obblighi di fedeltà. Il valvassore (il ‘vassallo di un vassallo’ del monarca dunque) ingaggia a sua volta un ‘valvassino’, ovvero un non-nobile, un semplice fattore, ma che avrà alle sue dipendenze dei ‘servi della gleba’ (così come ogni ‘signore’ e ‘signorotto’ della gerarchia feudale, capo – vertice – compreso). Ma per quale necessità nasce la figura del ‘valvassino’ in una società agraria-feudale? Il motivo è pragmatico. Da fattore che è, gode di una sufficiente agiatezza materiale. Assieme ai valvassori và a costituire il ceto medio di detta società; il valvassore è di ceto medio-alto, il valvassino di ceto medio-piccolo: entrambe le classi costituiscono la parte più consistente della società feudale. I ‘servi della gleba’ sono meno consistenti numericamente, anche se numerosi. Ebbene, il monarca sa che una società può tenersi in piedi solo e soltanto se il suo ceto medio (il quale, come si è detto, è il più consistente) non se la passa male. E in una società siffatta ci si può consentire ogni abuso di potere nei confronti dei ‘servi della gleba’, i quali, anche se insorgessero, sarebbero troppo pochi (costituiscono infatti pur sempre una minoranza) per prendere il potere, oppure, più semplicemente, per ottenere una qualche (anche piccola) concessione.
In una gerarchia feudale piramidale l’ingordigia tributaria del re può spingere i suoi immediati sottoposti a rivalersi (a loro volta), a ‘rifarsi’, sui loro immediati sottoposti, aumentando le loro imposte, per cui si giunge a penalizzare i fattori stessi, che conferiranno beni ancora più scarsi ai loro servi della gleba, ai contadini alle dipendenze dell’azienda agricola di ciascuno di essi. Ma ogni membro della piramide può riscuotere più del dovuto facendo da scaricabarile con chi lo sovrasta (sia immediatamente che non). Vedremo come, a tentare di tener compatta un’intera società feudale in tali casi, intervenga la Chiesa, la quale potrebbe addirittura farla traballare a suo favore. Ma prima parlerò della tendenza centrifuga e disgregatrice dello stato, caratterizzante ogni aristocratico, sia piccolo che grande, sottoposto ad un monarca di tipo feudale. Un’embrionale e grezza forma di federalismo, di decentramento politico, caratterizza dunque una società monarchico-feudale. Ogni vassallo piccolo e grande del re gode infatti di poteri giudiziari, polizieschi, fiscali, che farà valere su ogni suo sottoposto. Se vuole tuttavia personalmente (ovvero di propria iniziativa) intraprendere una guerra contro qualcuno, poiché magari ha sfruttato al massimo ogni risorsa da lui posseduta, non lo può fare. Deve proporre ciò al monarca, il quale valuterà se sarà il caso di intraprenderla. Ebbene, in un contesto di anarchia feudale, gli aristocratici possono spezzare anche l’anzidetto vincolo che li lega al sovrano, agendo a proprio piacimento anche dunque (per così dire) in ‘politica estera’. Lo stato feudale è disgregato del tutto (viene meno): la nobiltà da feudale (da ‘servitrice’ del re) diviene baronale (nel caso però dell’alta aristocrazia). Ovvero, quanto il re aveva elargito loro, diviene finalmente di loro esclusiva proprietà (magari – perlomeno in un primo momento – ‘di fatto’ ma non formalmente).  Abbiamo dunque individuato due tipi di forze storiche tra loro in (ora latente, ora aperto) contrasto, in permanente dissidio: le aristocrazie (grandi e piccole) e il re (o l’imperatore), il quale, al contrario di esse, è politicamente accentratore. Tuttavia l’anarchia feudale prodottasi finisce per scontentare tutti: si è infatti ritornati ad un selvaggio, animalesco ed egoistico ‘stato di natura’. I baroni si fanno guerra tra loro per accrescere i propri, rispettivi, domini, i conti (la piccola nobiltà) tendono a svincolarsi con la forza dai baroni e, nel frattanto, la vita dei fattori diviene invivibile per via del continuo stato di tensione guerresca cui sono sottoposti (non riescono più a mandare avanti le rispettive aziende): i loro signori non riescono ad assicurargli la dovuta protezione. È in tale contesto che sorgono probabilmente le forme originarie di corporazioni mercantili in cui (lo si è accennato) imprenditori, artigiani e mercanti, organizzano la loro resistenza ad un simile stato di cose. Insomma, la situazione diviene invivibile per tutti: si invoca l’intervento di qualcuno che – con rettitudine – ponga fine a detto stato di anarchia, dirimendo ogni tipo di controversia, creando ordine. Risorgono le monarchie elettive (o anche la scelta di intere dinastie regnanti da parte dei nobili), le quali hanno per scopo la difesa della proprietà privata di ogni singolo nobile (grande o piccolo che sia). Storicamente (in occidente) ciò corrisponde (ad esempio) alla nascita del domino regale dei Capetingi in Francia e – soprattutto – al dominio degli Ottoni in Germania (i quali godranno anche della nomina imperiale). Ma nulla è davvero e definitivamente risolto, in quanto ogni figura storica, ogni espressione di forze politico-sociali, continua a tendere allo sfaldamento dell’ordine che si è ora (apparentemente, o quantomeno poco) realizzato. Ogni forza tende a prevalere sulle restanti. Quelle accentratrici sono costituite dal re (o dall’imperatore) e (in certo qual senso) dalla Chiesa (con la sua tendenza universalistica, ‘cattolica’). Quelle centrifughe sono rappresentate soprattutto dall’alta aristocrazia e dai ceti cittadini più dinamici.
Abbiamo dunque individuato due tipi di forze storiche tra loro in (ora latente, ora aperto) contrasto, in permanente dissidio: le aristocrazie (grandi e piccole) e il re (o l’imperatore), il quale, al contrario di esse, è politicamente accentratore. Tuttavia l’anarchia feudale prodottasi finisce per scontentare tutti: si è infatti ritornati ad un selvaggio, animalesco ed egoistico ‘stato di natura’. I baroni si fanno guerra tra loro per accrescere i propri, rispettivi, domini, i conti (la piccola nobiltà) tendono a svincolarsi con la forza dai baroni e, nel frattanto, la vita dei fattori diviene invivibile per via del continuo stato di tensione guerresca cui sono sottoposti (non riescono più a mandare avanti le rispettive aziende): i loro signori non riescono ad assicurargli la dovuta protezione. È in tale contesto che sorgono probabilmente le forme originarie di corporazioni mercantili in cui (lo si è accennato) imprenditori, artigiani e mercanti, organizzano la loro resistenza ad un simile stato di cose. Insomma, la situazione diviene invivibile per tutti: si invoca l’intervento di qualcuno che – con rettitudine – ponga fine a detto stato di anarchia, dirimendo ogni tipo di controversia, creando ordine. Risorgono le monarchie elettive (o anche la scelta di intere dinastie regnanti da parte dei nobili), le quali hanno per scopo la difesa della proprietà privata di ogni singolo nobile (grande o piccolo che sia). Storicamente (in occidente) ciò corrisponde (ad esempio) alla nascita del domino regale dei Capetingi in Francia e – soprattutto – al dominio degli Ottoni in Germania (i quali godranno anche della nomina imperiale). Ma nulla è davvero e definitivamente risolto, in quanto ogni figura storica, ogni espressione di forze politico-sociali, continua a tendere allo sfaldamento dell’ordine che si è ora (apparentemente, o quantomeno poco) realizzato. Ogni forza tende a prevalere sulle restanti. Quelle accentratrici sono costituite dal re (o dall’imperatore) e (in certo qual senso) dalla Chiesa (con la sua tendenza universalistica, ‘cattolica’). Quelle centrifughe sono rappresentate soprattutto dall’alta aristocrazia e dai ceti cittadini più dinamici.
Le aspirazioni centrifughe della borghesia più inetta e della piccola nobiltà risultano invece frustrate per via della loro scarsa potenza politico-economica, per cui devono accontentarsi di ricevere protezione da qualcuno che è socialmente più in alto di loro. La frustrazione e il disagio, sia esistenziale che più propriamente materiale, è apicale presso i servi della gleba (i futuri, liberi, braccianti) e i garzoni di bottega. Innanzitutto i re mostrano poca rettitudine e imparzialità, non essendo dunque troppo degni della nomina che rivestono, che ricoprono. I grandi aristocratici (i ‘duchi’ in ambito germanico) sono soddisfatti per via del mantenimento della loro personale proprietà, ma lo sono meno per via della tassazione (alta o non) che gli impone il monarca (esercitando il potere legislativo, oltreché quello esecutivo e quello giudiziario) allo scopo di difendere i loro possedimenti. Inoltre non controllano più la piccola nobiltà (o finiscono per perdere il controllo su quest’ultima). Il re, con le tasse che riscuote, và anche a potenziare il suo personale esercito, al fine di tenere testa all’alta aristocrazia, per via del loro scontento nel caso in cui raggiunga livelli tali da farla contrapporre apertamente alla politica del monarca. Il re gode dell’appoggio della piccola nobiltà, in quanto ne difende la proprietà, proteggendola da eventuali ambizioni di possesso di essa da parte dei ‘grandi’ (o da ingerenze di vario tipo che questi ultimi vorrebbero esercitare sulla proprietà comitale, sui ‘contadi’). Ma l’alta nobiltà è tenuta un po’ a freno nelle sue ambizioni centrifughe anche per via di un ulteriore motivo: la borghesia è sottoposta a una rigida legislazione che le impedisce di crescere ad un punto tale da andare a minare il potere politico, sociale ed economico ducale (o baronale), nonché il potere regale stesso. Nelle città sorgono allora nuovi tipi di corporazioni (in quanto imposte dallo stato, dall’ ‘alto’), in cui si fanno valere essenzialmente tre principi: la dottrina del giusto prezzo (delle merci da vendere), quella del giusto salario (per gli artigiani alle dipendenze di un mastro bottegaio), infine la concessione di un numero limitato di licenze commerciali, in modo tale da limitare una concorrenzialità che avrebbe prodotto un abbassamento eccessivo del livello dei prezzi (a discapito di quegli imprenditori-artigiani che erano in possesso di regolare licenza). Due figure di pubblici funzionari (regali o imperiali, a seconda del contesto) sono particolarmente attive in un comune: il notaio, che redige ogni possibile documento riguardante la vita comunale, conferendogli legittimità; il balivo, dotato di incarichi giudiziari, polizieschi, di riscossione tributaria, nonché della prerogativa dello svolgimento di mansioni amministrative (provvede, ad esempio, alla costruzione – disponendo di fondi pubblici – di tutto ciò che è utile per il ceto cittadino, borghese). Ma, ovviamente, la borghesia più ambiziosa e intraprendente mal sopporta di essere imbrigliata all’interno di una corporazione: ciò (l’irrequietezza di essa dunque) costituisce un ulteriore elemento di instabilità all’interno di uno stato medievale.
Vari sono dunque gli elementi che rendono precaria o traballante la situazione politica di nazioni e imperi nel corso del medioevo: ma tale precarietà non è altro che un propulsore storico. Ma vi è una anche forza ordinatrice nel medioevo (sia pure ‘a suo modo’): la Chiesa. Costituisce la classe (gramscianamente) egemone, ovvero è essa ad essere (quantomeno) la principale depositaria della cultura. Ma essa mira all’imposizione universale dei suoi dettami, e non solo in contrapposizione all’impero, ma anche ad ogni regno. Eredita molto dal druidismo dell’età antica, sebbene quest’ultimo sia stato più barbaro del cattolicesimo in ogni suo aspetto. L’esonero dal servizio militare, l’esenzione fiscale, l’ingiudicabilità dei sacerdoti che ne compongono l’apparato da parte dei tribunali statali (essi sono sottoposti esclusivamente a tribunali ecclesiastici), rendono analoghi i fenomeni del druidismo e del cattolicesimo. Inoltre, al pari della classe dei druidi, i sacerdoti non appartengono (quantomeno nella maggior parte dei casi) alla stirpe dominante, al popolo dei dominatori, cui cercano di imporre (nonostante quindi la loro subalternità) i propri dettami: nel caso dei Franchi (sia merovingi che carolingii), essi sono soprattutto gallo-romani e romani (o perlomeno lo sono i più importanti esponenti ecclesiastici). Carlo Magno in particolare, seguì molto fedelmente i precetti della Chiesa (o, per meglio dire, la sua volontà), anche perché essa faceva molto presa sul ceto medio-piccolo di cui sopra si è parlato. Fu soprattutto la Chiesa a tener coeso il suo impero: se infatti l’imperatore inaspriva (facendo un esempio quantomeno verosimile) la tassazione, anche magari per scopi esclusivamente personali, costringendo – in certo qual modo – i suoi vassalli – a loro volta – a pretendere maggiormente dai loro subalterni (e così via), il disagio dei fattori poteva venire incanalato in maniera tale da non andare a insidiare la solidità dello stato franco. Pretestuosamente il sacerdote poteva infatti raccontare ad essi che la causa del loro disagio non era nel loro ‘buon sovrano’, bensì nei suoi ingordi servitori. Ma in tal modo gli eventuali tumulti che sarebbero potuti sorgere venivano localmente circoscritti (quali isolati focolai di sovversione): il popolo andava cioè a colpire esclusivamente il loro più immediato superiore. La Chiesa era caratterizzata, grosso modo, da due anime: l’una paolina (con riferimento naturalmente all’ ‘apostolo delle genti’), l’altra platonico-aristotelica. La filosofia scolastica più in linea con l’ideologia ecclesiastica dominante, preminente, quindi maggiormente ortodossa, canonica, poteva essere sia platonica che aristotelica. Le differenze tra l’uno e l’altro tipo di filosofia erano difatti, presumibilmente, di natura prettamente metafisica: le conseguenze morali derivanti dall’uno e dall’altro pensiero (considerati dunque da un punto di vista puramente teoretico) erano, ciò nonostante, pressoché identiche. Se infatti l’aristotelismo era assai probabilmente nominalista, negando l’esistenza di ogni universale che non corrispondesse alle categorie, il platonismo negava, viceversa, l’esistenza delle divine e trascendenti categorie, ammettendo esclusivamente l’esistenza di ogni altro universale (le Idee); l’insieme delle Idee, o (in alternativa) le categorie, corrispondevano all’intelletto divino, a Dio nella sua trascendenza rispetto al mondo sensibile dell’esperienza comune (giudicato come reale, concreto), ovvero alla ‘creazione’. Ma la morale sia platonica che aristotelica, si è detto, coincidevano: il buonsenso comune era il comun denominatore, la nota comune, di entrambe. Un’esperienza giudicata come negativa (come costantemente disagiata) era tuttavia a condizione della possibilità di ogni forma di empatia (simpatia, commozione ecc.); la dolce luce delle cose che compongono l’esperienza, che può ferire, anche dolcemente, lo sguardo degli uomini (a voler usare un’immagine, una suggestione, dantesca), esprime molto adeguatamente l’idea che l’uomo medievale aveva del mondo nella sua concretezza. La sua anima era avveduta, accorta, non solo per se stesso, ma anche per gli altri, per i quali, in alcuni casi, era richiesto di agire persino eroicamente (subordinandosi, posponendosi, a loro, e, in alcuni casi, persino sacrificandosi fino all’estremo per loro).
Vediamo ora come Aristotele considerava alcuni dei suoi predecessori. Molti tra i presocratici (non però Aristotele) credevano nell’esistenza di un’originaria età dell’oro, differente tuttavia da come l’aveva immaginata Esiodo (anche Platone la concepiva – anche se approssimativamente – come i suddetti presocratici). Se l’età aurea esiodea era caratterizzata da una natura benigna per l’uomo (da soli animali mansueti, da frutti unicamente commestibili ecc.), quest’ultimo apprendeva forse empiricamente il suo benevolo ordinamento. Per molti presocratici invece (ma anche per Platone) – ciò è una mia plausibile ipotesi – l’uomo delle origini era dotato di cognizioni innate, quindi a lui congenite, grazie alle quali poteva ben orientarsi all’interno di una natura non solo, per egli, positivamente caratterizzata. Ebbene, scopo di molta filosofia presocratica era forse quello di tornare all’età dell’oro tramite il progresso della conoscenza. Ora, la società greca, anche al tempo dei primi presocratici, e fino al cosiddetto ‘V secolo’, era, a mio parere, culturalmente tellurica, dionisiaca, mercantile e affaristica. 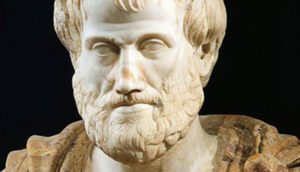 E così, ad esempio, Talete e Anassimene anticiperebbero la più spregiudicata, moderna, mentalità scientifica, essendo il loro pensiero orientato a conoscere, fin nei minimi dettagli, ogni aspetto della Natura allo scopo di dominarla interamente, ignorando ogni problematica concernente i danni derivanti da uno ‘sviluppo insostenibile’ per l’uomo. Ebbene, il punto di vista scientifico aristotelico è ben più cauto. Sebbene lo stagirita abbia aspirato con zelo e tenacia (cosa che non tutti sanno) ad anticipare (pur, ovviamente, non riuscendovi) la nascita della fisica classica (al pari di un esponente della scolastica piuttosto isolato quanto al suo punto di vista filosofico, quale è stato Ruggero Bacone), la mentalità prevalente fra gli scolastici medievali (e anche presso quelli successivi) fu decisamente conservatrice, ossia avversa ad uno sviluppo della conoscenza che risultasse troppo audace. Anzi, loro non facevano altro che ribadire, nei loro scritti e nei loro insegnamenti, il punto di vista aristotelico senza accrescerlo minimamente, attenendosi rigorosamente a conservare (senza – lo ribadisco – ampliarlo) il bagaglio di conoscenze raggiunto da Aristotele. La Chiesa è stata forse l’erede spirituale (una loro propaggine culturale) delle più antiche società mediterranee. Sebbene la credenza biblica dell’Eden cozzasse contro la visione aristotelica del mondo e dell’uomo delle origini, la Chiesa riteneva magari che la fuoriuscita dell’uomo dal paradiso terrestre fosse coincisa con il ritrovarsi di costui all’interno di una natura primordiale suppergiù aristotelicamente concepita. Ebbene, i punti di contatto tra tale condizione e uno ‘stato di natura’ caratterizzato nel modo in cui Rousseau lo concepì, risulterebbero, se non altro, vari. Se non è forse vero, come sostiene il ginevrino, che un’animale carnivoro diviene feroce solo se sospinto dalla fame, è pur vero che, perlomeno in tempi primordiali, nelle pianure l’uomo trovava riparo dai vari pericoli delle selve. L’assenza di grandi assembramenti umani riduceva notevolmente la possibilità di contrarre malattie (è raro infatti che un animale selvatico muoia per un qualche morbo, decedendo soprattutto per vecchiaia). Quelli che ho appena svolti sono solo pochi esempi dei vantaggi che la vita primordiale dell’uomo gli assicurava lungo il corso della sua esistenza. Eppure, lo si è accennato, non bisogna far coincidere interamente il pensiero rousseauiano con quello dello stagirita o della scolastica che fu più in voga nel medioevo e successivamente.
E così, ad esempio, Talete e Anassimene anticiperebbero la più spregiudicata, moderna, mentalità scientifica, essendo il loro pensiero orientato a conoscere, fin nei minimi dettagli, ogni aspetto della Natura allo scopo di dominarla interamente, ignorando ogni problematica concernente i danni derivanti da uno ‘sviluppo insostenibile’ per l’uomo. Ebbene, il punto di vista scientifico aristotelico è ben più cauto. Sebbene lo stagirita abbia aspirato con zelo e tenacia (cosa che non tutti sanno) ad anticipare (pur, ovviamente, non riuscendovi) la nascita della fisica classica (al pari di un esponente della scolastica piuttosto isolato quanto al suo punto di vista filosofico, quale è stato Ruggero Bacone), la mentalità prevalente fra gli scolastici medievali (e anche presso quelli successivi) fu decisamente conservatrice, ossia avversa ad uno sviluppo della conoscenza che risultasse troppo audace. Anzi, loro non facevano altro che ribadire, nei loro scritti e nei loro insegnamenti, il punto di vista aristotelico senza accrescerlo minimamente, attenendosi rigorosamente a conservare (senza – lo ribadisco – ampliarlo) il bagaglio di conoscenze raggiunto da Aristotele. La Chiesa è stata forse l’erede spirituale (una loro propaggine culturale) delle più antiche società mediterranee. Sebbene la credenza biblica dell’Eden cozzasse contro la visione aristotelica del mondo e dell’uomo delle origini, la Chiesa riteneva magari che la fuoriuscita dell’uomo dal paradiso terrestre fosse coincisa con il ritrovarsi di costui all’interno di una natura primordiale suppergiù aristotelicamente concepita. Ebbene, i punti di contatto tra tale condizione e uno ‘stato di natura’ caratterizzato nel modo in cui Rousseau lo concepì, risulterebbero, se non altro, vari. Se non è forse vero, come sostiene il ginevrino, che un’animale carnivoro diviene feroce solo se sospinto dalla fame, è pur vero che, perlomeno in tempi primordiali, nelle pianure l’uomo trovava riparo dai vari pericoli delle selve. L’assenza di grandi assembramenti umani riduceva notevolmente la possibilità di contrarre malattie (è raro infatti che un animale selvatico muoia per un qualche morbo, decedendo soprattutto per vecchiaia). Quelli che ho appena svolti sono solo pochi esempi dei vantaggi che la vita primordiale dell’uomo gli assicurava lungo il corso della sua esistenza. Eppure, lo si è accennato, non bisogna far coincidere interamente il pensiero rousseauiano con quello dello stagirita o della scolastica che fu più in voga nel medioevo e successivamente.
Per Aristotele infatti la Natura è anche popolata dal male, da quanto è cioè avverso all’uomo e ad altre creature, mentre per Rousseau, nonostante tutto, la Natura è un unico grande organismo in cui ogni suo ente, animato e inanimato, tende (quantomeno – ovvero pur senza riuscirvi in tutti i casi – e ciò per necessità, ovvero per ‘cause di forza maggiore’) ad armonizzarsi con ogni altro ente (sia animato che inanimato). Inoltre l’uomo concepito da Aristotele presenta caratteri molto diversi rispetto a quelli del ‘buon selvaggio’. È infatti capace di agire disinteressatamente, e per via – forse – della sua ‘differenza qualitativa’ rispetto ad ogni altra creatura animata e inanimata, diversità effettiva legata alla sua anima, capace, rispetto a quella delle restanti creature, di gesti della più genuina generosità. Per Aristotele, infine, il mondo non è una rappresentazione come per Rousseau, ma è reale, concreto, e dunque animistico (Aristotele sarebbe un animista, mentre il pensatore svizzero non lo è). Assai probabilmente, per lo stagirita, le piante stesse avrebbero un’interiorità, un sensorio. Ma non solo. Forse gli stessi enti inanimati lo avrebbero: l’ ‘orrore del vuoto’ non sarebbe altro che l’egoistico, intimo, disagio provato, ad esempio, da un grave nel momento in cui venga a sperimentare l’assenza di altre cose che non lo vengano più a circondare ermeticamente da ogni parte (e ciò corrisponderebbe alla volontà simultanea di ogni ente – impropriamente dunque – ‘inanimato’, motivo per cui, in Natura, il vuoto non può assolutamente esistere per Aristotele). C’è tuttavia, nel mondo semitico, qualcosa di identico all’animismo aristotelico? Credo fermamente che la tradizione popolare ebraica addirittura pre-biblica (quella cioè più originaria) abbia avuto una concezione dell’uomo e della restante Natura coincidente con le vedute (relative all’uno e all’altra) propugnate da Aristotele. La Bibbia è infatti una produzione maggiormente erudita (lo è anche la Cabala, che è fra l’altro molto più recente di essa). Cosa sono infatti gli ‘angeli’, in origine, se non quanto un Dio assolutamente trascendente ‘annunzia’ circa l’ordine della Natura, rivelandolo, comunicandolo, in tal modo all’uomo, e per benevolenza nei confronti di quest’ultimo?
Dunque, ricapitolando; la Natura concepita (in particolare) dagli scolastici (più ortodossi) è composta sia da entità benevole che malevole (demoniache). Ogni cosa infatti è in possesso di un’anima trascendente l’empirico (persino, come si è detto, un mero ‘grave’, un masso), ed è essa ad essere demoniaca oppure umana (l’uomo è infatti l’unico essere empirico capace del più autentico altruismo, di vera e sincera abnegazione). Se l’uomo gerarchicamente si colloca ‘più in alto’ di ogni restante ‘creatura’, ognuna di esse, agendo egoisticamente, avrà un’anima demonica; tuttavia, nel momento in cui Dio ci offre amorevolmente la possibilità di conoscere la volontà di ognuna di esse, quest’ultime sono al contempo ‘entità angeliche’ (sempre, ovviamente, su di un piano trascendente, ovvero laddove è collocata la loro anima, sempre ‘inferiore’ – dunque – rispetto a quella umana). Concludendo, la Natura, per Aristotele, è anche tale da contrariare l’uomo (quale suo componente). Tuttavia, grazie all’esperienza, l’uomo ne apprende man mano le immodificabili leggi: e così, una volta che si è scottato con il fuoco (magari dopo aver ripetuto tale esperienza), si terrà alla larga da esso. Allo stesso modo, una volta che ha conosciuto l’indole feroce di una fiera, si terrà ben al riparo da essa. Fu forse la Chiesa ad imporre (o a proporre) ai Franchi la costituzione di una società di tipo feudale, caratterizzata praticamente da una ‘chiusura delle caste’ e da una conseguente immobilità sociale. Inoltre essa vedeva di buon occhio che la società franca fosse una società prevalentemente agricola. Presso tutti gli altri popoli germanici (o quasi tutti) vigeva invece il criterio dell’elezione monarchica da parte di duchi (si pensi ai Longobardi), ovvero del ‘popolo in armi’ socialmente preminente. In età antica furono in particolare i Celti ad adottare un sistema politico di tipo monarchico-feudale (anche se non furono gli unici ad accoglierlo). Il severo, rigido, ordine gerarchico feudale era infatti tale da riflettere il più possibile la condizione dell’uomo primordiale. Se la Chiesa non potette impedire ai Germani di riversarsi nell’intera Europa, riuscì, sia pure in una certa misura, ad ingentilirne, a mitigarne, i costumi. Dovette dunque rassegnarsi al fatto che quei predoni, alcuni dei quali praticamente senza Dio (anche da convertiti all’arianesimo) e quindi senza rispetto per alcunché al di fuori di se stessi, fossero divenuti i nuovi padroni d’Europa. Tuttavia, la graduale conversione al cattolicesimo di gran parte di costoro (con il trascorrere del tempo), perlomeno parzialmente, li affratellò. Assunsero quindi un costume, un’etica, di tipo se non altro cavalleresco, da non far valere unicamente in battaglia (quando cioè si scontravano tra loro), ma anche nella vita quotidiana (trattando con una certa umanità persino i loro servi della gleba).
Sempre in età antica, questa era stata l’abitudine di popoli che si riconoscevano quali appartenenti di una medesima stirpe (ciò valse non solo per i Celti, ma anche, ad esempio, per le popolazioni italiche umbro-sabelliche, le quali condividevano tutte la cavalleresca ‘legge feziale’, la quale, fra l’altro, valse anche in certi periodi della storia della Roma monarchica). La Chiesa, in epoca franca, propugnò e sostenne dunque il modello politico feudale, poiché a suo parere offriva tali vantaggi: vedeva innanzitutto di buon’occhio che all’interno di esso i mercanti avessero scarso (se non scarsissimo) peso; l’egoismo dei borghesi fu (e a mio parere a ragion veduta) tra i principali nemici di essa (se non il principale nemico). Il borghese tende infatti allo sfaldamento dell’oggettività – reale, e dunque anche valoriale – in nome di una soggettività che tende (e tenderà) a dissolvere ogni argine vincolante l’umana condotta (si pensi all’epoca attuale), eccezion fatta per il proprio egoismo, per la propria pelle, per la propria persona (giudicata la sola cosa che ha valore al mondo da parte del ‘più puro spirito borghese’). Con la fine del feudalesimo, la Chiesa vide con favore l’imposizione dall’alto di un’economia mercantile di tipo corporativistico (la dottrina del giusto prezzo di età comunale è tomistica). Ma la Chiesa, al contempo, ha anche da sempre temuto che la classe più indigente (i non-specializzati, liberi e salariati, garzoni di bottega e i servi della gleba) potesse prendere il potere. Il servo della gleba, considerato nella sua purezza quasi archetipica, non è portato all’apprendimento di alcunché (non avendone voglia), da cui la sua incapacità a fare qualsiasi cosa che richieda almeno un po’ di conoscenza (di un qualsiasi ambito). In età feudale sceglieva dunque liberamente di porsi al servizio di un fattore, o di un nobile, da cui ricevere protezione e sostentamento, in cambio di quelle semplicissime mansioni (per giunta quasi esclusivamente manuali) che era in grado di svolgere. Ma la sua libera scelta, una volta intrapresala, ne condizionava ‘a vita’ l’esistenza, e anche l’esistenza dei suoi congiunti (la sua prole avrebbe fatto in futuro, necessariamente, il mestiere paterno).
Sebbene la Chiesa esortasse i padroni a comportarsi il più possibile umanamente con i loro servi contadini (cosa che – vi è da ritenerlo – solo in rari casi si verificava), incitava, al contempo, questi ultimi a sopportare le eventuali vessazioni e gli eventuali soprusi che ricevevano dai loro datori di lavoro, dai loro superiori: l’ideologia paolina, con il concetto di santità che ne deriva, fu uno strumento culturale finalizzato a tanto (di ciò ne parleremo in seguito in modo sufficientemente approfondito). Ma cosa temevano i prelati dal popolo minuto più indigente e meno importante di una società? Che insorgessero compatti dando luogo, eventualmente, ad una realtà politica estremamente caotica per via della loro ignoranza e della loro inettitudine (per via della loro generalizzata incompetenza). Ora, il mito di un uomo primordiale, originario, estremamente mansueto e – persino, magari – non carnivoro, può anche non essere fantasia (così come vi sono, del resto, animali dal temperamento aggressivo, carattere pressoché necessariamente condizionato dalla loro genetica e, dunque, dalla loro fisiologia). Ritengo tuttavia che sia stato al contempo un essere relativistico e nichilistico (in quanto al mondo non esisterebbe nulla nel modo più assoluto: Dio, anime, cose, Idee e conseguenti limiti, categorie): per cui le sue successive trasformazioni (in bene o in male) andrebbero – perlomeno sul piano teorico – tutte accettate, in quanto (perlomeno – ancora una volta – sul piano teorico) tutte egualmente legittime. Ognuno ha poi, certamente, le sue opinioni (le mie emergeranno nel corso del saggio), per cui alcune di tali trasformazioni può accettarle, altre respingerle. Ebbene, non solo il punto di vista ecclesiastico medievale appare legittimo, ma è anche (se è tuttavia lecito esprimere tale idea) ‘in buona fede’ (in certo qual modo, dunque). Specie (o ancora) al tempo dei Franchi la Chiesa aspirava sinceramente (in una certa qual maniera – vi è da ribadirlo) a dare ordine al mondo, credendo nella giustizia e tentando di realizzarla universalmente; la Chiesa aspirava insomma, piuttosto genuinamente, a fare da paciere mondiale, da pacificatrice ‘universale’. Quali furono, allora, i suoi limiti (anche al tempo del dominio franco)? Nell’uso di strumenti inefficaci al raggiungimento dello scopo che si era prefissa. Ciò da un lato. D’altro lato non poteva che scontrarsi con tutti quegli elementi che ne limitavano il potere, contrastando tale potere. Come vedremo, la storia della Chiesa (la considererò tuttavia soltanto fino ad un certo momento storico) è altalenante, è fatta di ‘alti’ e ‘bassi’, di momenti di volontà moralizzatrice e di momenti di degenerazione (che si ripresentano dunque – entrambi, ovviamente – in modo ciclico).
In cosa consisterebbe, quindi, un’agire mondialmente pacificatore che sia, che risulti, efficace? Semplificando, è necessario che vi sia un leader davvero ‘umano’ (dotato di ‘Humanitas’), oltreché politicamente intelligente, che accentri nelle sue mani, non solo i tre poteri dello Stato, ma anche e soprattutto (imprescindibilmente) il ‘quarto potere’ (ovvero il controllo di ogni possibile strumento propagandistico), facendo in modo che l’ ‘umanismo’ sia la cultura quantomeno prevalente, predominante, all’interno di una collettività. Tale leader, imponendo ‘dall’alto’ i suoi dettami politici, assicurerebbe, da un lato dignitose condizioni di esistenza, sia materiali che morali, al ceto subalterno, dall’altro verrebbe a coercire fermamente chiunque incarni una mentalità di tipo borghese. L’applicazione poi delle conoscenze scientifiche (ovvero la ‘tecnica’) sono sempre tali da produrre degli imprevedibili contraccolpi negativi: ma dal momento che tali conseguenze non risulterebbero poi così gravi, e dal momento che i vantaggi che la tecnica apporta sono sempre e comunque maggiori rispetto ai danni (dunque piuttosto lievi) che arreca, essa non và a mio parere respinta ‘tout court’: ma solo a patto, tuttavia, che non degeneri in un fattore di sviluppo cieco e disumano (dovrebbe in altre parole venire applicata sempre – quantomeno il più che ci è possibile – oculatamente, in modo tale da non provocare uno sviluppo per noi uomini insostenibile). Prima di parlare, per sommi capi, a grandi linee, della restante storia della Chiesa, stabiliamo quali siano state le forze in campo nello scacchiere medievale, nel loro gioco di alleanze e contrapposizioni. L’alta aristocrazia, specie nelle fasi iniziali di detta, rimanente, storia, fu dalla parte della Chiesa, in quanto entrambe erano in naturale contrasto con il centralismo autocratico cui (quantomeno) tendevano re e imperatori. Culturalmente i grandi aristocratici (ceto piuttosto erudito) propugnavano abbastanza fedelmente il suddetto punto di vista della scolastica, in quanto (come vedremo meglio in seguito) tale prospettiva si scontrava con l’ideologia monarchico-imperiale (l’alta nobiltà provava antipatia nei confronti di re e imperatori, nei confronti della loro mentalità, di cui dunque molto più avanti discuterò). La piccola nobiltà, grazie al progressivo svincolarsi da ogni soggezione cui era sottoposta ad opera della grande feudalità (fino a quando non ottennero la piena proprietà dei loro piccoli domini, proprietà garantita dalle leggi dello stato, monarchico o imperiale che sia stato), stava quindi dalla parte dei sovrani europei e dell’impero. Questi ultimi, inoltre, appoggiando la piccola nobiltà, privavano la grande nobiltà di potere e privilegi.  La borghesia più dinamica e intraprendente, agli inizi dell’età comunale, mal sopportava papi e sovrani, in quanto entrambi erano del pari fautori di uno strangolante (ovviamente per essa) corporativismo. Il ceto, per così dire, ‘neutrale’ (il più consistente delle società medievali) era costituito dalla piccola imprenditoria artigianale (nonché dagli artigiani alle dipendenze di un datore di lavoro) e dalla piccola proprietà terriera (alla quale venne concesso il pieno possesso delle loro aziende ancor prima che i piccoli feudi nobiliari ottenessero un analogo riconoscimento). Se la piccola proprietà terriera era ben vista da papi e sovrani, in quanto non avrebbe potuto intaccare (al contrario della borghesia) il potere di entrambi, i borghesi più incapaci (e, proprio per questo, meno pericolosi), ben si trovavano all’interno di un sistema politico-economico di tipo corporativo, in quanto quest’ultimo proteggeva e sostentava sufficientemente costoro per tutto il corso della loro vita. Il corporativismo era perciò ben visto sia dai papi che dai sovrani.
La borghesia più dinamica e intraprendente, agli inizi dell’età comunale, mal sopportava papi e sovrani, in quanto entrambi erano del pari fautori di uno strangolante (ovviamente per essa) corporativismo. Il ceto, per così dire, ‘neutrale’ (il più consistente delle società medievali) era costituito dalla piccola imprenditoria artigianale (nonché dagli artigiani alle dipendenze di un datore di lavoro) e dalla piccola proprietà terriera (alla quale venne concesso il pieno possesso delle loro aziende ancor prima che i piccoli feudi nobiliari ottenessero un analogo riconoscimento). Se la piccola proprietà terriera era ben vista da papi e sovrani, in quanto non avrebbe potuto intaccare (al contrario della borghesia) il potere di entrambi, i borghesi più incapaci (e, proprio per questo, meno pericolosi), ben si trovavano all’interno di un sistema politico-economico di tipo corporativo, in quanto quest’ultimo proteggeva e sostentava sufficientemente costoro per tutto il corso della loro vita. Il corporativismo era perciò ben visto sia dai papi che dai sovrani.
Infine, mendicanti, garzoni e braccianti, erano degli emarginati condannati ad una vita miserabile da parte di ogni tipo di potere, statale o ecclesiastico che sia stato. È per via – forse – del loro scarso (se non scarsissimo) livello culturale, educativo, che il suddetto corpo intermedio neutrale delle società medievali provava dentro di sé, in luogo di raffinati e profondi sentimenti, delle più naturali, nonché più semplici, emozioni sentimentalistiche. Specialmente all’interno delle chiese poteva allora ammirare (e apprezzare, accogliere, comprendere, recepire) un tipo d’arte semplice, stilizzata (e persino un po’ grezza), quale poteva essere quella realizzata da pittori come Giotto e Simone Martini (vissuti tuttavia entrambi in una fase avanzata dell’età comunale). Se il primo dei due artisti appena menzionati, con uno stile disadorno, sobrio, poneva sulla tela in special modo episodi tratti dalla Bibbia e dai Vangeli, il secondo, con colori smaglianti, sgargianti, quali l’oro (simbolo di sacralità) e il rosso porpora (simbolo di regalità), rappresentava figure divine, sante, oppure politicamente o anche religiosamente eminenti, con lo scopo di investirle di un’aura di intoccabile, d’inattaccabile, maestosa, venerabilità: le anzidette figure dovevano essere inviolabili (sacrilego, empio, sarebbe stato il non rispettarle e il non riverirle). Ma entrambi gli artisti aspiravano a uno stesso scopo, ossia quello di far accettare pienamente lo status quo ai fruitori della loro arte (anche se Giotto invitava gli spettatori dei suoi quadri ad imitare una pacifistica vita di tipo evangelico). Ma anche le persone più ai margini della società coglievano delle loro opere un identico significato. Tuttavia, se dette persone avrebbero dovuto sempre, in ogni circostanza, rispettare lo status quo, senza dunque mai insorgere (sopportando pazientemente ogni ingiustizia perpetrata nei loro riguardi), il suddetto ‘corpo intermedio’ poteva – in alcuni casi – venire addirittura incitato, da parte dei preti, quantomeno ad appoggiare, a sostenere, coloro che insorgevano contro il sovrano (in una certa fase – dunque non troppo avanzata – dell’intera storia ecclesiastica, il grosso del ceto medio poteva, quindi, anche esprimere consenso nei confronti dell’operato rivoltoso dell’alta aristocrazia). Ciò che si è appena concluso di dire, si poteva verificare nel caso in cui la condotta di un sovrano deviasse eccessivamente dai principi religiosi cattolici.
Ancora nella fase conclusiva dell’alto medioevo, la cultura ecclesiastica si era mantenuta quindi, tutto sommato, l’ideologia quantomeno prevalente. Tutta la forza della Chiesa era risieduta in questo suo esser stata ‘classe egemone’: le sue ‘parole’, le sue dottrine e le sue prediche, erano, tutto sommato, l’unica arma di cui disponeva (o comunque la più importante), arma però di non poco peso sociale (arma non priva della capacità di incidere massicciamente nelle società – in particolar modo dunque – medievali). E così, all’interno di un’impresa artigianale, non era raro che tra capo e dipendenti vigesse un rapporto di reciproca benevolenza, e – forse, per giunta – anche di ‘parità’: il datore di lavoro, umilmente, non faceva vanto del suo essere gerarchicamente (e dunque socialmente ed economicamente) più importante degli artigiani alle sue dipendenze. Ma un analogo rapporto poteva sussistere anche tra ‘signori’ di differente rango gerarchico (anche se casi di questo genere erano, a mio parere, più rari); vedremo, inoltre (molto più avanti), originariamente, in cosa sia consistita la ‘fedeltà’ di un nobile al suo superiore.
(continua…)
Umberto Petrongari







