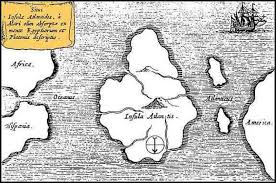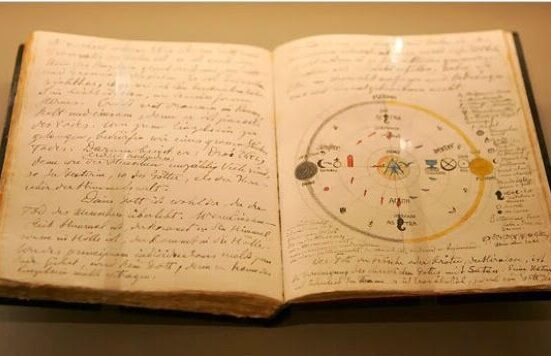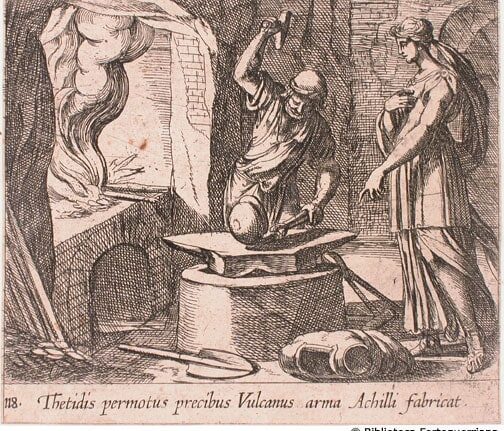“Ma questa è un’epoca in cui ciascuno viene giudicato così aspramente attraverso la lente delle politiche dell’identità che se ti opponi al minaccioso gruppone dell’«ideologia progressista», la quale proclama l’inclusione universale tranne per coloro che osano porre una qualche domanda, in un modo o nell’altro sei spacciato. Tutti devono essere uguali e avere le stesse reazioni di fronte a qualunque opera d’arte, movimento o idea, e se uno si rifiuta di unirsi al coro di approvazione verrà accusato di essere un razzista o un misogino. Questo è ciò che accade a una cultura quando non gliene frega più niente dell’arte”.
– Bret Easton Ellis, Bianco
In un periodo che anticipava di poco l’esasperata e ormai perpetua stagione delle grandi chiusure, dei barricamenti casalinghi e delle false “ripartenze”, ebbi occasione di partecipare a un incontro (presso il Circolo dei Lettori di Torino) con il romanziere Bret Easton Ellis – ex ragazzo prodigio di ‘Meno di Zero’, celebrato autore di ‘American Psycho’, nonché ultimo grande cantore del postmodernismo con l’intrigante ‘Lunar Park’ -, chiamato a presentare la sua ultima fatica non-fiction a titolo ‘Bianco’. Quella sera il pubblico, composto prevalentemente da millennial e perbenisti afferenti a una certa élite salottiera, non parve gradire troppo le lucide sferzate di un divertito Ellis verso l’ipocrisia annessa al politicamente corretto, alla costante, malsana preoccupazione dei giudizi altrui e più in generale verso il clima “antitutto” sviluppatosi nel solco dell’alienazione social che l’affacciarsi della pandemenza, se ci è concesso fare uso di un tale nuovo costrutto, non avrebbe fatto altro che accentuare. Non c’è soluzione, si può solo peggiorare; il futuro sarà sempre più greve, sentenziò l’autore.
‘Bianco’ non è soltanto un romanzo autobiografico, ma è anche ed in particolar modo una critica affilata, feroce e insieme spassosa di alcune delle piaghe che oltre a quelle di tipo sanitario continuano imperterrite ad affliggere il secolo corrente: la simulazione elevata a galateo, il moralismo in sostituzione del giudizio estetico, la censura rispetto alla volontà di esprimere un’opinione poiché, quando ciò avviene, spiega Ellis, si rischia di finire impallinati dai “giustizieri” dei social:
“A un certo punto, nel corso degli ultimissimi anni, un vago eppure quasi opprimente e irrazionale fastidio ha preso a straziarmi fino a una decina di volte al giorno. Questo fastidio riguardava cose all’apparenza secondarie, lontane dai miei consueti interessi, ed ero sorpreso dallo sforzo che dovevo fare per liberarmi dal disgusto e dalla frustrazione provocati dalla stupidità altrui: adulti, semplici conoscenti ed estranei che sui social condividevano pareri e giudizi avventati, stupide preoccupazioni, sempre con l’incrollabile certezza di avere ragione“.

Molto prima dell’avvento di internet, Ellis sperimentò di persona il problema della censura, tematica con la quale egli afferra saldamente, oggi, lo spirito del tempo e di cui fu in particolar modo oggetto quello che si sarebbe trasformato nel suo romanzo di maggior successo, ‘American Psycho’ (1991), storia di uno yuppie ventisettenne ossessionato da un ingombrante feticismo per lo sfarzo e per la cura del sé (a suggellare la di lui natura più occulta, quella del killer-maniaco seriale). Il testo ebbe problemi ancora prima di essere pubblicato e la reputazione dello scrittore fu presa di mira dal “pensiero-gruppo” nel momento in cui la casa madre proprietaria dell’editore per cui Ellis pubblicava decise di non gradire affatto i contenuti di quel romanzo, e di conseguenza rifiutò di pubblicarlo adducendo specifiche motivazioni di “gusto”. Si trattò, sottolinea Ellis, di un momento spaventoso per le arti – anche se poi un episodio di tale portata ha cominciato a sembrare normale: quello che stava di fatto accadendo era che un grande gruppo editoriale decideva che cos’era permesso e cosa no, che cosa si poteva o non si poteva leggere, cos’era lecito dire e cosa no. La differenza tra allora e oggi, precisa però l’autore, sta nel fatto che all’epoca ci furono vibranti proteste e argomentazioni da entrambi i lati di quella contesa; le persone avevano opinioni divergenti eppure ne discutevano razionalmente, guidate dalla passione e dalla logica. A quell’epoca, infatti, l’idea che una grande corporation si concedesse la libertà di applicare una proibizione non era così ammissibile. Non si poteva sostenere, ad esempio, che un determinato spettacolo della HBO non andasse scritto, aggrappandosi al suo presunto razzismo. Non esisteva, ancora, una cosa come lo psicoreato – accusa che oggi sembra del tutto normale. Le persone inoltre erano inclini ad ascoltarsi, ed era quello un periodo in cui potevi essere fieramente convinto delle tue opinioni e apertamente critico senza essere considerato un troll e un hater se le tue idee erano diverse da quelle della maggioranza.
Ellis, oggi cinquantaseienne, cita poi un emblematico episodio della cinica e umoristica serie a cartoni animati South Park, molto popolare anche in Italia, al fine di evidenziare un altro spaventoso problema che affligge l’odierna società della digitazione compulsiva, quello del culto dell’inclusione. Nell’episodio, un personaggio di nome Cartman e altri suoi concittadini, incantati da Yelp, fantomatica applicazione che consente ai clienti di valutare e recensire i ristoranti, minacciano maître e camerieri di conferire loro solamente una stella su cinque qualora la qualità dei piatti non soddisfi i loro palati. Il risultato di ciò è che i ristoratori, presi da rabbia e frustazione, capiscono di non avere altra scelta se non quella di adeguarsi, permettendo agli “Yelper” di sfruttare il loro potere per garantirsi portate gratuite. Il succo di questa storia di finzione, molto vicina alla realtà, è che i clienti possono illudersi di rivestire il ruolo di critici professionisti, ma l’episodio non è che un disarmante resoconto di quella cosa che oggi va sotto il nome di “economia della reputazione”.
“Che siano i servizi oggi a giudicare noi a loro volta solleva la questione di come ci presentiamo online e sui social, e di come gli individui possano sia brandizzare se stessi sia venire brandizzati. Quando tutti pretendono di passare per specialisti e di avere una voce che ha diritto di essere ascoltata”, afferma Ellis, “ciò in realtà rende la voce di ciascuno meno significativa. Tutto quello che abbiamo ottenuto in effetti è di ritrovarci incasellati – per essere venduti, brandizzati, usati come target pubblicitari o fonti di dati. Ma questa non è che la logica conclusione della democratizzazione della cultura e del temibile culto dell’inclusione, in cui è promossa l’idea che tutti debbano vivere sotto lo stesso sistema di regole e regolamenti: un mandato in cui si pretenderebbe di dettare a chiunque come ci si dovrebbe esprimere o comportarsi. Molte persone di una certa fascia di età, probabilmente, hanno notato qualcosa di simile quando si sono iscritte al loro primissimo social creato e gestito da una corporation. Facebook incoraggiava gli utenti a usare i «mi piace», e trattandosi della piattaforma nella quale le persone per la prima volta si autobrandizzavano sul Web, il loro impulso naturale fu presentare un ritratto idealizzato di se stesse – in modo da apparire più carine, più amichevoli, più melense. […] Per essere accettati, bisognava seguire un codice morale positivo e chiunque avesse opinioni negative o impopolari che non fossero inclusive – in altre parole, fosse portatore di un semplice «non mi piace» – sarebbe stato escluso dalla conversazione e spietatamente umiliato”.
In sostanza, nella nuova era digitale post-Impero ci siamo abituati a recensire gli spettacoli televisivi, i ristoranti, i videogame, i libri e perfino i medici, e in generale garantiamo giudizi positivi perché nessuno desidera farsi etichettare come hater. E anche se di fatto non lo sei, dice Ellis, è così che vieni giudicato se ti allontani dal gregge. Allo stesso tempo, però, e in misura sempre maggiore, sono anche le corporation a recensire noi. L’autore tira in ballo alcune famose aziende della sharing economy quali Uber o Airbnb, le quali conferiscono valutazioni ai loro clienti. E dal momento che oggigiorno le opinioni personali e i riscontri critici viaggiano di pari passo, la gente ha iniziato a preoccuparsi freneticamente di risultare sempre all’altezza della situazione:
“Per un breve istante sono stato intrigato dalla possibilità che l’economia della reputazione potesse stimolare la cultura della gogna – rendendoci più onesti e più critici che mai – ma l’insipida idea propria della cultura aziendale, consistente nel farsi piacere tutto per proteggere se stessi e di risultare falsamente positivi così da non venire esclusi dal gruppo, si è solo fatta più forte e più pervasiva. Ciascuno continua a postare giudizi positivi nella speranza di ottenerne a sua volta. Anziché abbracciare l’autentica natura contraddittoria di noi esseri umani, con tutti i nostri difetti e mancanze e imperfezioni, continuiamo a trasformare noi stessi in robot virtuosi. Questo di conseguenza ci ha portati alla pessima idea – e al florido business – dei reputation manager, soggetti retribuiti per coadiuvare la creazione di una identità più piacevole e relazionabile. Destinata a manipolare il sistema, questa nuova pratica è una forma di inganno, un tentativo di cancellare (curiosamente) sia la soggettività sia l’oggettività, di valutare qualsiasi cosa attraverso l’opinione di massa“.
Per Ellis l’economia della reputazione non è che un esempio di come la nostra cultura venga resa insipida, anche se l’imposizione del pensiero di gruppo attraverso i social ha solo accresciuto l’ansia e la paranoia, dato che coloro che approvano entusiasticamente l’economia della reputazione sono anche, va da sé, i più spaventati. Cosa succederebbe, infatti, se a questi gruppi dovesse sfuggire di mano quello che è di fatto il loro più grande patrimonio?
“Ciò che persone sembrano dimenticare tra questi miasmi di narcisismo fasullo e nella nostra nuova cultura dell’ostentazione, è che l’autoaffermazione non deriva dal mettere un «mi piace» a questo o a quello, ma dall’essere fedele al tuo io, che è contraddittorio per natura. Esistono limiti nel mettere in mostra le proprie qualità più lusinghiere perché, per quanto genuini e autentici possiamo pensare di essere, stiamo sempre e solo fabbricando un concetto per i social, al di là di quanto davvero sia o appaia accurato. […] Chi di noi rileva difetti e incoerenze o dà voce a idee impopolari, improvvisamente terrorizza coloro i quali si trovano impigliati nel mondo del conformismo e della censura sociale attuata dalle corporation”.
Perché in fondo il crimine più grande commesso in questo nuovo mondo, conclude l’autore, è proprio quello di stroncare la passione e ridurre al silenzio l’individuo, rendendolo il più possibile acritico.
Elementi bibliografici:
Bret Easton Ellis, Bianco (Einaudi, Torino, 2019)
Simöne Gall, American Psycho, Vent’anni Dopo (nocturno.it)
Simöne Gall