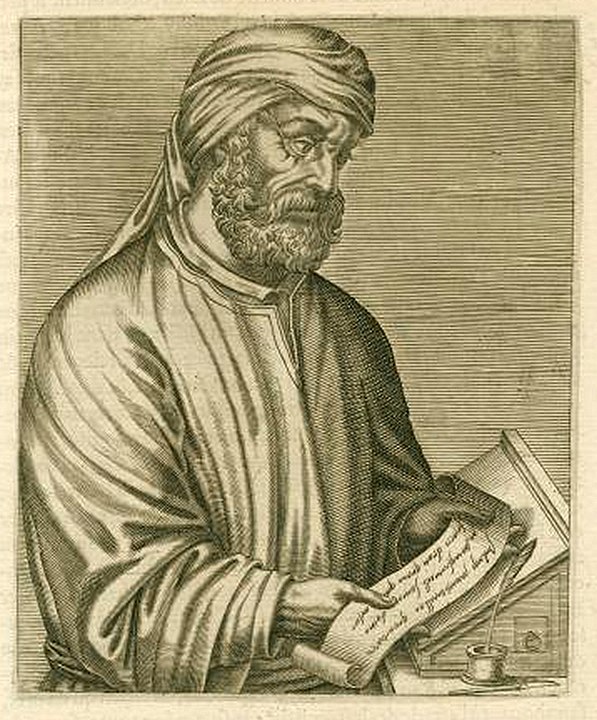In Occidente spesso siamo abituati a pensare all’Oriente in termini astratti, che poco hanno a che vedere con la realtà. Molto probabilmente non esiste un Oriente in generale, ma tante popolazioni e culture tra di loro diversissime, che quasi nulla hanno in comune, se non stereotipi occidentali.
Lo stesso concetto di sacro, di religioni, di culto divino è spessissimo molto diverso da quello occidentale e oltretutto diverso da cultura a cultura. C’è sicuramente nel fondo dell’anima delle persone appartenenti alle varie nazioni della terra una unica idea di Dio e un rapporto identico con questo Grande Essere, ma in base ad altri aspetti ci sono anche innumerevoli differenze da popolazione a popolazione. L’Unico Dio si declina storicamente e culturalmente in forme assai diverse. Poi il sacro si colora di angeli, spiriti, santi e defunti, numi tutelari, maghi e iniziati, streghe e stregoni. Il variegato caleidoscopio delle culture rende un’unica idea di Dio molto diversificata.
Emblematico è lo shintoismo, la più antica religione di Stato giapponese. La parola Shin-tō è formata da due caratteri giapponesi: il primo indica il sacro (può essere pronunciato anche kami), il secondo indica il Tao, la Via. Quindi lo shintoismo è la Via del divino, cioè la Via dei kami. Il termine giapponese kami è intraducibile. Indica non solo le divinità, ma anche le divinità intermedie (angeli?), gli spiriti e il sacro in generale. Si tratta di un concetto grossomodo vicino a quelli di shen cinese oppure di mana austronesiano oppure di tri hita karana indonesiano oppure di nagual amerindo oppure di me sumerico oppure di numinosum italico oppure di Brahman induista oppure di kesunyataan giavese oppure di ntr skm egiziano oppure di sé africano oppure di ciuringa degli aborigeni australiani.
La prima definizione di kami completa è quella di Motoori Norinaga. In generale, kami si riferisce innanzitutto ai molteplici kami del cielo e della terra che vediamo negli antichi classici, e agli spiriti (mitama) nei santuari ad essi consacrati. E si riferisce inoltre a tutti gli altri cose impressionanti: le persone ovviamente, ma anche uccelli, animali, erba e alberi, persino l’oceano e montagne, che possiedono un potere superlativo che normalmente non si trova in questo mondo. “Superlativo” significa non solo superlativo in nobiltà, bontà o virilità, dal momento che anche le cose che sono malvagie e strane, se ispirano uno stupore insolito, sono anche chiamati kami.
È in pratica impossibile definire lo shintoismo in quanto la nostra idea di religione è profondamente differente da quella giapponese. Kuroda Toshio: “La visione dell’uomo comune dello Shintō include in genere le seguenti ipotesi: lo Shintō reca le caratteristiche inconfondibili di una religione primitiva, compreso il culto della natura e il tabù contro il kegare (impurità), ma non ha un sistema di dottrina; esiste in diverse forme come credenza popolare ma allo stesso tempo possiede alcune caratteristiche della religione organizzata, ad esempio rituali e istituzioni come i santuari; inoltre svolge un ruolo importante nell’antica mitologia giapponese e fornisce una base per la venerazione degli antenati e degli imperatori. In breve, lo Shintō è visto come la religione indigena del Giappone, che continua in una linea ininterrotta dalla preistoria fino ad oggi”.
Ono Sokyō: “Lo Shintō è la fede indigena dei giapponesi. Fin dall’antichità i giapponesi hanno creduto e venerato i kami come un’espressione della loro fede razziale nativa che sorse nei giorni mistici dell’antichità. In realtà, lo Shintō ha subito influenze straniere evidenti e la fede nei kami non può essere compresa completamente senza fare riferimento anche ad esse. Ciononostante, esso è tanto indigeno quanto le persone che hanno portato la nazione giapponese a nascere e a inaugurare la sua civilizzazione”.
Da tempo immemore i giapponesi hanno creduto ai kami come espressione della loro identità. Questo è un modo di pensare che l’Occidente ha perso da quando delle religioni più “alte” lo hanno dominato. L’Oriente perciò è descritto da un punto di vista occidentale che non è corretto.
Non si può definire semplicemente religione, ma è qualcosa di più profondo, è un’indole culturale (in linea con la Costituzione Meiji) e assume sia la natura della filosofia e che quella della religione. Anche se uno shintoismo secolare non esiste: rientra pur sempre nella religione, o meglio nella ampia sfera del sacro.
C’è chi discute di uno shintoismo immutabile nei secoli nei suoi elementi essenziali, altri invece parlano espressamente di shintoismo come di una costruzione ideologica legata al periodo storico preso in esame. Lo Shintō puro sarebbe un’invenzione Meiji, ma certi elementi sono stati portati avanti sempre nella storia del Giappone.
Inoue invece elimina la credenza che lo Shintō sarebbe solo un fenomeno giapponese, analizza le credenze dell’Asia orientale considerando non solo lo sviluppo dello Shintō, ma anche la sua relazione nei sistemi religiosi in varie epoche. È difficile tuttavia individuare quali credenze, rituali e credo abbiano caratterizzato lo Shintō nei secoli.
Gli studiosi lo dividono in Shintō dei templi, settario, secolare, imperiale, di stato e popolare, tuttavia queste non sono divisioni chiare e non è chiara la relazione tra esse. “Indigeno” significa che non è fondato da un personaggio storico, ma originato da una cultura indigena, “Popolare” significa che non è direttamente controllato da un tempio o una chiesa, è impossibile quindi dividere lo Shintō popolare dallo “Shintō puro”.
Il buddhismo arriva in Giappone a metà del VI secolo dai monaci coreani. Ci sono 4 fasi della influenza del buddhismo sullo shintoismo autoctono, che non sono successive le une alle altre ma sono modi diversi di legare i kami al pensiero buddhista.
Innanzitutto le divinità buddhiste sono venerate come kami stranieri. Quelli giapponesi quindi diventano autoctoni. I kami buddhisti erano percepiti come simili agli autoctoni. Già nel VII secolo però ci sono conflitti legati all’uso di materiali legati ai kami per la costruzione di strutture buddhiste. Il buddhismo è percepito come strumento per pacificare i kami giapponesi.
Il secondo momento lo abbiamo a partire dal VII secolo: la corte apprezza il buddhismo per la sua capacità di controllo e pacificazione dei kami. Sono costruiti dei jingūji, templi allestiti accanto ai santuari shintoisti. Qui i monaci si dedicano a conversione tra kami e rituali buddhisti. Conversione attraverso recitazione di sutra ed esecuzioni di vari rituali buddhisti. Era un oracolo dello stesso kami che richiedeva la costruzione del jingūji per un kami che doveva essere salvato per espiare le colpe commesse nei suoi cicli karmici. Il karma positivo così prodotto dai jingūji serviva a salvare il kami. Ci furono però resistenze a queste diffuse conversioni. La costruzione del jingūji a Ise fu seguita da alcune catastrofi che furono interpretate come reazioni negative dei kami. Il luogo sacro fu poi distrutto come conseguenza dell’incidente Dokyo, che vide l’imperatrice Shotoku molto vicina a lasciare il trono ad un monaco buddhista. Tale monaco fu esiliato alla morte della sovrana, il jingikan cercò di evitare il ripetersi di questa storia vietando gli elementi buddisti nei riti di corte, inoltre proibì ai monaci e monache buddiste di partecipare ai riti di corte per i kami. Qualsiasi parola legata al buddhismo è vietata a Ise, come l’ingresso dei monaci.
La terza fase: kami percepiti come protettori del Dharma buddhista. Abbiamo poi l’ultima fase di amalgamazione di kami e buddhismo: kami percepiti come emanazioni della divinità buddhista con tracce dell’originale. Honji suijaku è il nome della teoria. Honji: l’originale, sujaku: le sue tracce. Gli originali buddhisti prendono temporaneamente l’aspetto di kami per salvare più persone. Le figure buddhiste legate ai benefici per gli umani sono identificati come forma originaria del kami. Yakushi, Kannon, Amida soprattutto. Nella teoria, c’è la pratica di rappresentare i kami nel loro originale buddhista, soprattutto nel kamakura. Per esempio, Kakebotoke: Buddha e Bodhisattva realizzate sul retro degli specchi dei santuari. Alcuni santuari vengono percepiti come mandala. Tutto questo avvenne perché si percepiva l’arrivo del mappo, fine della legge del Dharma, in cui i Buddha, per salvare la maggior quantità di persone avrebbero assunto la forma di kami. Kami e Buddha sono diversi ma per altri aspetti in parte assimilabili.
Il periodo Heian della storia giapponese (794-1185) è considerato quello classico della letteratura (pensiamo solo al celebre Pillow Book), dell’architettura e quello che ha posto le basi con importanti risvolti nel tempo, della fusione tra buddhismo e shintoismo, pensiamo solo alla scuola buddhista Tendai.
La stabilità del primo periodo Tokugawa (XVII secolo fino alla sua fine) è garantita da uno speciale controllo della gerarchia sociale. Nel 1637 è bandito il cristianesimo, visto come sovversivo. Nel 1639 ci fu l’espulsione di tutti gli stranieri dal Paese. Tutte le famiglie si devono iscrivere ai registri dei templi. Il buddhismo è usato come controllo sociale. Sono messi in secondo piano i jinja. Il sistema che vede il buddhismo come forma utile per il controllo verrà ribaltata nel Meiji. Il regime Tokugawa necessitava di principi razionali per regolare la società, e li trova nel confucianesimo. Alcuni confuciani trovarono collegamenti con lo Shintō e si identificarono con questo affermando che se l’unione tra Shintō e buddhismo porta alla distorsione del primo, ciò non accadrebbe col confucianesimo, perché Shintō e confucianesimo sarebbero una cosa sola. Lo Shintō venne anche spiegato in termini confuciani. I kami equivalgono al ri, fondamento della realtà. È mantenuta la prospettiva per cui le buone azioni portano il bene e la non obbedienza al kami al male. Hayashi parlava anche dei tesori imperiali che rappresenterebbero delle virtù confuciane: lo specchio la saggezza, il gioiello la generosità e la spada il coraggio. Amaterasu li donò come strumento di governo, di conseguenza il sovrano deve incarnare quelle virtù per guidare il popolo. Hayashi usava spesso il termine Shintō e una terminologia shintoista per rendere più chiari dei concetti confuciani. Ci furono anche pensatori shintoisti che adottarono una terminologia confuciana per spiegare lo Shintō in modo più razionale, tra cui le famiglie Watarai e Yoshida.
Nel periodo Meiji (1868-1912) lo shintoismo si fonde con lo Stato e si stacca dal buddhismo. Non è corretto parlare di Shintō prima di questo periodo: come esperienza spirituale unitaria è una costruzione del governo Meiji. È da lì che si piantano le basi per il concetto moderno di Shintō. A differenza dei vari costrutti che precedono questa data, lo Shintō Meiji è un costrutto unitario, rielaborato e ricostruito per soddisfare le esigenze del governo stesso. In precedenza, il termine non era mai stato usato universalmente per descrivere ciò che oggi chiamiamo Shintō, ma c’erano espressioni diverse che in vari contesti hanno significato elementi eterogenei. La prima volta che il termine Shintō viene utilizzato è presso Yoshida Kanetomo (1435-1511), tuttavia il suo concetto di Shintō è unico e ha caratteristiche esclusive.
Il santuario oggi conosciuto come Yasukuni (1979) nasce nel 1869 con il nome di Tokyo Shoukonsha per richiamare gli spiriti (shōkon). Lo shōkon si basa sull’idea che dopo la morte, quando lo spirito si stacca dal corpo, è necessario presentarvi offerte. Il sacerdote richiama gli spiriti in luoghi precisi dove fa le offerte. Siccome gli spiriti di morti in modo violento sono impuri, non si possono richiamare direttamente in un santuario. Nel Tokyo Shoukonsha era presente un edificio per la purificazione degli spiriti richiamati e per le offerte. Nel santuario erano venerati gli spiriti di coloro che erano morti per l’imperatore nel bakumatsu, in tutto 3588 spiriti. Per superare il problema dell’impurità della morte si è sviluppato un sistema particolare. I ministeri della Marina e dell’Esercito trasmettevano inizialmente la lista dei nomi degli spiriti da venerare ai sacerdoti, i nomi erano messi in una lista che l’imperatore doveva approvare. Durante il rituale per la purificazione di questi spiriti in un edificio del santuario, i sacerdoti trasformavano ritualmente gli spiriti in kami e li fondevano all’interno di una spada. La spada era un dono della famiglia imperiale insieme allo specchio e al registro degli spiriti trasformati. Allora lo spirito diventava un kami parte della collettività dei kami. Per questo tuttora nel santuario non sono venerati singoli kami o anime di defunti, ma una collettività di spiriti dei soldati caduti. Nel 1875, lo status del santuario è elevato ed al suo interno si racchiudono anche gli spiriti di soldati di altri santuari; il numero di questa collettività crebbe a 10.880. Nel 1882, il santuario è posto sotto l’amministrazione del ministero dell’Esercito e della Marina, e non più dal ministero degli Affari Interni. Si continuano a deizzare i soldati caduti, che arrivano a 2 milioni e mezzo. Aumentano anche le visite degli imperatori. L’imperatore Meiji ci venne 7 volte, lo Showa 20. Le visite dei vari ministri del santuario furono sempre fonte di tensioni anche con gli stati confinanti come la Cina. Tra il 1868 e il 1945 sono costruiti molti nuovi santuari, questo per dare sostanza all’idea della nazione come centrata sulla figura dell’imperatore. I kami che sono venerati includono infatti imperatori del passato come Jinmu e figure di spicco in ambito militare che servirono nella Restaurazione.
Nel Giappone odierno lo Shintō ha un’identità distinta. Lo Shintō è la religione dei jinja, santuari distinti dai templi buddhisti per la loro architettura caratteristica. Questi santuari sono gestiti da circa 20.000 sacerdoti shintoisti. I santuari ospitano una moltitudine di divinità, i kami, differenti dai Buddha e Bodhisattva del buddhismo.
Per quanto i contorni dello Shintō moderno possano essere precisi, ancora rimane estremamente difficile da classificare. In base alle statistiche ufficiali, lo Shintō è la religione più diffusa in Giappone, ma solo una piccola parte della popolazione si considera shintoista. Questo riflette il fatto che sebbene molti giapponesi partecipino agli eventi dei santuari e facciano uso dei servizi rituali offerti, solo pochi vedono lo Shintō come la loro identità religiosa. Lo Shintō rimane quindi un concetto alquanto vago. La distinzione tra santuari e templi è di valore ridotto per coloro che fanno uso dei loro servizi.
Il fatto che lo Shintō funzioni raramente come identità religiosa non vuol dire che i santuari siano considerati poco importanti. In base alla Costituzione moderna, i santuari non possono essere sostenuti da fondi pubblici, dipendendo dalla generosità dei fedeli. Quando un santuario smette di essere rilevante alla comunità da cui dipende, scompare quasi istantaneamente.
I santuari possono avere un sacerdote fisso o meno; i santuari più piccoli sono gestiti dalle persone del quartiere o condividono un sacerdote con altri santuari. In media si ha un sacerdote ogni cinque santuari. Ciò varia molto anche dalla grandezza e importanza del santuario.
I santuari sono i luoghi in cui si crede risiedano i kami. Il punto focale dei santuari è lo shinden, solitamente un piccolo edificio in stile tradizionale in cui si dice le divinità risiedano. Di fronte allo shinden si ha lo haiden, la sala di preghiera. Solo i sacerdoti possono avvicinarsi allo shinden, entrandoci raramente a loro volta. L’area attorno a queste due sale è solitamente simile a un parco. L’accesso al santuario avviene attraverso il portale torii. I visitatori attraversano il torii e si lavano bocca e mani a un lavabo prima di procedere per lo haiden. Nei santuari più grandi, passeranno presso l’ufficio del santuario, detto shamusho, dove possono chiedere a un sacerdote di svolgere un rituale o comprare amuleti, cartoline e tavolette dedicate ai kami. Molti invece passeranno oltre, lanciando una moneta nel saisebako, batteranno le mani e chineranno il capo per una preghiera prima di lasciare nuovamente il santuario. Il periodo in cui ciò avviene più spesso è per il nuovo anno.
I santuari tengono tre tipi di rituali. Il primo tipo è costituito da questi riti. Importante è la preghiera personale per individui o famiglie. Dopo lo hatsumode, la pratica svolta in occasione del nuovo anno, le pratiche più popolari sono hatsu miyamairi, la prima visita a un santuario da parte di un neonato, e shichi go san, una visita al tempio per festeggiare il terzo, quinto o settimo compleanno di un bambino. Questi riti sono seguiti da circa la metà del popolo giapponese. In queste occasioni, un sacerdote reciterà un norito e le miko danzeranno davanti all’altare. I partecipanti offriranno un dono simbolico, ovvero un ramo di sasaki, bevendo un sorso del vino sacro miki, simboleggiando così una promessa tra il kami e il fedele. Altri riti popolari sono quelli di purificazione per luoghi di costruzione e macchine, matrimoni, preghiere per allontanare la sfortuna e per il successo in esami.
La seconda categoria di rituali riguarda quelli di natura imperiale, venendo svolti simultaneamente presso i santuari più importanti. I rituali più importanti sono il kinen-sai (17 febbraio) e niiname-sai (23 novembre.) Entrambi sono cerimonie di corte tradizionali in cui l’imperatore prega e ringrazia per il raccolto dell’anno. Questi rituali sono entrati nel calendario shintoista solo nel tardo XIX secolo. Altri rituali nazionali hanno un tema imperiale simile: kigensetsu (11 febbraio) celebra la fondazione della nazione da parte del primo imperatore Jinmu nel 660 a.C.; Meijisetsui (3 novembre) è il compleanno dell’imperatore Meiji; tenchosetsu (23 dicembre) è il compleanno dell’attuale imperatore. Questi rituali simboleggiano il legame dello Shintō con la famiglia imperiale.
La terza e ultima categoria di rituali è legata ai matsuri. Oltre il nuovo anno, i matsuri riflettono le tradizioni locali e sono sparsi attraverso l’anno. I matsuri più importanti durano diversi giorni e danno un’identità culturale a città intere. I matsuri minori sono eventi più privati e intimi. A caratterizzare i matsuri sono le parate, quando il kami viene trasferito dallo shiden a una portantina chiamata mikoshi. Viene trasportato attraverso il quartiere e posto temporaneamente in vari punti dove il kami viene intrattenuto con danze, spettacoli teatrali, competizioni eccetera. I matsuri sono generalmente organizzati dalla comunità locale, mentre i sacerdoti intervengono solo in occasione dei rituali o di compiti liturgici.
Per i sacerdoti shintoisti, questi tre tipi di rituali sono tutti parte di una singola tradizione, ma per molti partecipanti la differenza tra la tradizione Shintō e quella buddhista è minima, dove gli eventi vanno a formare un unico ciclo di festività stagionali.
Oggi lo shintoismo si fonde con la New Age. I powerspot sono dei luoghi o degli elementi naturali come alberi e pietre che si ritiene posseggano un’energia in grado di rilasciare a chi si avvicina. Il fenomeno dei powerspot non è unicamente giapponese ma caratterizza vari movimenti della Nuova spiritualità. Si inizia a parlare di powerspot negli anni Ottanta. Nel mondo si perde generalmente interesse negli anni Novanta, ma è proprio in quegli anni che il Giappone si interessa sempre di più. Questo concetto di powerspot si lega alla visione della terra come un organismo vivente. Si crede che sulla terra ci siano flussi di energia che scorrono formando un reticolo enorme. Quest’energia si manifesterebbe poi in determinati luoghi, che secondo i credenti, sarebbero stati segnalati dall’antichità con i megaliti. Si crede che anticamente gli uomini avessero riconosciuto questa energia riconoscendo anche come veicolarla per guarire le persone. Nel 1987 si svolge una conferenza, la Harmonic Convergence, proprio in coincidenza con un raro allineamento degli astri. In tutto il mondo i partecipanti sono invitati a meditare nello stesso momento in luoghi ricchi di energia. Il monte Fuji è uno di questi, ci sono anche Yakushima, Kumano, Ise e Kurama. Quest’ultimo è luogo di nascita del reiki, una pratica di guarigione e autoguarigione attraverso l’imposizione delle mani, con le quali si può veicolare l’energia verso sé stessi o verso altri.

Alcuni movimenti New Age arrivano anche in Giappone dove prendono il nome dei Seishin sekai, ovvero mondo spirituale. Questo termine è usato la prima volta nel 1978 da una libreria di Tokyo per etichettare libri su temi spirituali ma diversi da quelli delle religioni istituzionalizzate. Nello stesso periodo nascono anche riviste che trattano dei temi New Age parlando di alieni, cristalloterapia e divinazione, e vedono la luce anche negozi che vendono articoli utili per le pratiche del Seishin sekai. Si diffondono altresì seminari per la crescita personale. L’interesse è largamente diffuso anche dalla stampa e dalla televisione, ad esempio sono popolari le predizioni di Nostradamus, trasposte perfino in manga per ragazzi. Il focus è posto sul processo di guarigione. L’obiettivo è congruente a quello statunitense ed è quello di creare un nuovo mondo attraverso la combinazione di sistemi religiosi tradizionali e la scienza moderna, e soprattutto attraverso la trasformazione personale. A differenza della New Age, tra gli interessati al Seishin sekai non si manifesta una reazione nei confronti delle strutture dominanti, le altre espressioni religiose, come lo shintoismo. Si adotta però una visione olistica cercando di dissolvere la visione dualistica fra corpo e spirito utilizzando diverse pratiche di guarigione. La guarigione che viene ricercata è utile pure per ricostruire i rapporti interpersonali e ha effetti anche sull’ambiente.
Secondo gli orientamenti interpretativi contemporanei, ci sono queste affermazioni piuttosto sbagliate sullo shintoismo:
- “Darne una definizione è difficile perché è cambiato nel tempo”. Questo è in parte vero, ma se ci si riferisce a una data epoca è possibile ricostruire storicamente e culturalmente quel tipo di shintoismo. La chiave allora sta nella contestualizzazione. È lo stesso discorso del cristianesimo, che si è evoluto nel tempo ed è radicalmente cambiato nel corso dei secoli: ma in una data epoca è possibile ricostruirlo e darne una definizione;
- “E’ impossibile definirlo in senso organizzato”. Secondo alcuni anche questa espressione è sbagliata, in quanto lo shintoismo ha una struttura ben precisa e una filosofia ma tutto questo non combacia con le nostre categorie occidentali. Un giapponese capisce benissimo cosa sia lo shintoismo, ma un occidentale, legato ad altra mentalità, non può penetralo appieno;
- “Lo shintoismo non è una religione”. Anche questa affermazione è parziale. Innanzitutto non esiste una definizione univoca di religione né un tipo di religione uguale in tutto il mondo. Lo shintoismo non è una religione come il cristianesimo, né si identifica con un modo sociale di essere occidentale. Ma può rientrare in un tipo di definizione di religione, in quanto nello shintoismo ci sono riti, entità non umane, un clero (sacerdoti shintoisti), strutture (santuari). Oltretutto bisogna contestualizzare, perché nel periodo Meiji lo shintoismo non è una religione;
- “Lo shintoismo combacia con la identità giapponese”. Solo nel periodo Meiji, nel quale si fece dello shintoismo la religione dello Stato e si giocò molto per imporla ai giapponesi come la loro più vera identità;
- “Lo shintoismo è la religione autoctona del Giappone, legata al culto dei kami e della natura”. Questa definizione si adatta allo shintoismo della contemporaneità, dove è percepito come autoctono (è nato nell’arcipelago giapponese ma ha al suo interno elementi di influenza continentale). Anche se segato alla natura e al culto dei kami dipende dal momento storico. Nel periodo Meiji non è una religione e neanche legato alla natura.
Anche l’induismo non è una religione in senso occidentale: è difficile per noi immaginare una religione senza dogmi come l’induismo, che poi nemmeno esiste come entità unitaria, essendo formato da vari culti (visnuismo, shivaismo, shaktismo, e così via). Chi pratica un culto riconosce però l’esistenza delle altre divinità. Lo stesso concetto di divinità è differente dal politeismo greco-romano: in quest’ultimo gli dei hanno esistenza propria, invece nei culti induisti le divinità sono espressioni molteplici di un unico principio metafisico, chiamato Brahman. Si parla spesso del vedismo come contrapposto all’induismo (posteriore): il primo, facente capo totalmente ai Veda, sarebbe per i più un monoteismo. Quando si usa la parola vedica deva, “dei”, al plurale, in realtà la si usa in senso etimologico, “brillare”, per indicare una sola entità divina luminosa. Non solo, ma nei culti induisti non esiste un “sacrificio” come quello ebraico e cristiano, connotato dal dolore: la parola sanscrita yajña è più estesa di “sacrificio”, ed indica semplicemente una azione rituale per scopo benefico.
Facendo un enorme salto passiamo al Vicino Oriente antico.
Quelle culture (mesopotamica, eblaita, mariotica, ittita, ugaritica, aramaica, ebraica, cananaica, fenicia, e così via) sono molto diverse tra di loro, quindi, nonostante ci siano tratti comuni nella religione vicino orientale, ogni popolazione ha espresso un fenomeno religioso sui generis e sotto alcuni aspetti unico. È significativo che due lingue indoeuropee anatoliche, l’ittita e il luvio, come notato da Hutter, hanno avuto termini diversi per definire la nozione di divino: “dio” in ittita è šiu (ni), invece in luvio è maššana. Gli hurriti, stanziati anche in Anatolia, chiamavano la divinità ēni, al plurale ēnna. Ogni religione vicino orientale ha delle caratteristiche peculiari, per esempio in quella di Ugarit si poneva molto rilievo alla venerazione degli antenati, i Rapiuma. Lo studio della religione di tutti i popoli vicino orientali deve muovere dalla valutazione delle caratteristiche dell’organizzazione sociale e politica di ciascuna cultura, alla quale organizzazione fanno capo tutte le attività. Infatti, non c’era ancora la differenziazione tra politico e religioso, laico e sacrale. Per esempio ad Ebla i re stranieri che si alleavano con il re di Ebla andavano a fare giuramento nel tempio principale, quello del dio Kura. La religione è una componente fondamentale dell’assetto di una cultura ed è tanto più viva quanto più allargata, oltre la stretta ufficialità, a quei riti quotidiani presenti nella più ampia fascia della popolazione, da forme divinatore fatte da un agricoltore per sapere come andrà il raccolto a esorcismi contro qualche demone officiati da una persona sconosciuta in qualche villaggio.
Andando nelle varie religioni pensiamo anche a quella egiziana. L’Egitto fa parte geograficamente del Vicino Oriente, ma la sua cultura, arte e lingua fondono sempre elementi orientali con elementi africani.
In antico egiziano “dio” è detto neter, rappresentato da un geroglifico che Champollion credeva essere un’ascia. Ma si tratta di bende avvolte attorno a un bastone: quindi sarebbe un feticcio avvolto in un telo oppure una bandiera del tempio. Le statue possono essere abitate dalla divinità, come gli animali: allora il bastone sarebbe il simbolo di qualche cosa (un feticcio) abitata da un dio. Secondo una teoria le divinità egiziane erano indicate prima in senso astratto (come mediante il segno del bastone), poi come animali e infine come uomini. Ma il segno del bastone resistette nell’immaginario e divenne quello per indicare il dio in generale. Il segno assume la forma canonica durante la IV Dinastia. L’espressione kr-neter significa “sotto la necropoli”; questo segno geroglifico indica anche le bende delle mummie. Nel Papiro di Tanis, che contiene una specie di sillabario, il segno viene interpretato come “egli è seppellito”.
Nella Stele di Rosetta l’egiziano neter è tradotto in greco con theòs, “dio”, e in demotico al singolare con noyote (forma per indicare il dio cristiano) e al plurale con enthp (per indicare i demoni). In egiziano antico quando si usa neter al singolare, si usa anche il dimostrativo “questo”: può indicare un dio particolare. Neter è usato anche al plurale. Il plurale baw, “anime”, può indicare anche gli dei o la collera divina (keper baw). Molte cose sono definite netery, “divine”: in questa lista di cose manca l’uomo comune, ma c’è il re (i defunti sono detti Osiride).
Un altro termine egiziano per dio è skm, “forza”, rappresentato dal bastone del comando. Nel Nuovo Regno skm indica anche la immagine del dio. Essa può essere trasposta nel defunto, che così diventa a sua volta divino.
Quindi, già da queste brevi note di filologia egiziana, si evince che il concetto egiziano di dio sia molto più ampio rispetto al Dio personale cristiano diffuso in Occidente. Il saggio di Hornung, ormai un classico dell’egittologia, rileva con molti dati linguistici e archeologici che la religione egiziana era assai differente da quella nostra. In tutta la letteratura egiziana non si trova niente che sembra più sicuro di questo: gli egiziani dipendevano dalle parole e dai comandi del dio. E nessun egiziano metteva in dubbio questo dato. Pertanto è plausibile sospettare che gli antichi egiziani intendevano per “dio” qualcosa di diverso da quello che intendiamo noi oggi. Secondo la teologia sistematica del Nuovo Regno, la divinità è in cielo per illuminare il mondo, il suo corpo rimane nell’oltretomba e, sulla terra, tra gli uomini, le immagini della divinità comunicano la sua presenza. Anche queste immagini sono il corpo del dio. Il corpo principale del dio dovrebbe essere d’oro e cosparso di gemme preziose. Probabilmente questa deificazione delle immagini si spiega con il fatto che il dio non è un’entità personale, come quello cristiano, ma più che altro una forza di cui noi moderni non possiamo dire granché perché dall’antico Egitto si è interrotta la tradizione. È significativo che gli animali sacri sono per gli egiziani i portavoce del dio, cioè segni della sua manifestazione, come immagini viventi della sua divinità. Ancora per Celso, alla fine del periodo pagano egiziano, essi sono segni sacri della divinità, aenigmata. Anche gli uomini sono ritenuti immagine del dio. Alcune prove dimostrano che questo è vero per tutti gli esseri umani. Nei racconti del Pap. Westcar persino un criminale condannato a morte viene considerato “un animale sacro” di dio! Bisogna considerare altresì un fenomeno tipico della teologia egiziana e per noi difficilmente spiegabile, come il sincretismo fra dei, del quale si è occupato Bonnet: quando per esempio si dice che Ra è in Amon.
In qualche modo possiamo estendere il nostro discorso della diversità delle concezioni orientali sul divino, anche al dogma della Trinità entro il cattolicesimo. Esso deriva dai concili e dai teologi della chiesa orientale, che così hanno interpretato alcuni dati della Bibbia. Solo nel cristianesimo esiste il concetto di Trinità, nelle altre religioni ci sono triadi divine (come la Trimurti induista) che solo all’apparenza sono analoghe. Secondo il dogma della Trinità, esiste un solo Dio ma in tre Persone (Padre, Figlio e Spirito Santo). Le tre Persone non sono tre Dei ma un solo Dio in tre Persone.
La Trinità resta un mistero inconcepibile per la ragione umana. Non si può capire ma si deve accettare per fede. È impossibile dire razionalmente che qualcosa è uno e trino allo stesso tempo. Quindi nei primi secoli della chiesa ci furono feroci lotte per stabilire l’esatto concetto della Trinità, espresso da Gesù stesso quando dice di battezzare nel nome (e non nei nomi!) del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La questione nei primi secoli era anche terminologica. Come chiamare il Padre, il Figlio e lo Spirito? I teologi greci (cioè orientali) usavano il termine greco prosopon, “persona”. In greco la parola significa anche “maschera” teatrale (come pure la parola latina persona), che gli attori indossavano per apparire come i personaggi del mito e ampliare il suono della voce (donde il latino per-sona, “per- suonare”). Ma usando questa terminologia sia presso i teologi greci sia presso i teologi latini si correva il rischio di far credere ai fedeli che Padre, Figlio e Spirito fossero tre modi di manifestarsi dello stesso Dio (conformemente all’eresia detta modalismo), invece la schietta fede cattolica dice che Padre, Figlio e Spirito sono lo stesso identico Dio e non tre suoi modi di apparire.
Allora Origene propose la parola greca upostasis, ipostasi. Questo termine andava bene per i greci (presso i quali vuol dire sia persona sia sostanza), ma non per i latini, che lo traducevano solo con substantia, “sostanza” (e non persona), quindi poteva insinuare nei fedeli il dubbio che Padre e Figlio fossero:
- Tre sostanze uguali, cioè tre dei, a danno del monoteismo;
- Tre sostanze diverse, cedendo alla eresia ariana, per cui Padre e Figlio non hanno la stessa sostanza, cioè non sono lo stesso Dio, ma il Figlio è subordinato al Padre, ha ovvero una sostanza inferiore.
La eresia degli ariani era più semplice da capire rispetto al mistero proclamato dalla chiesa, e quindi il popolo ignorante andava dietro alle tesi di Ario. Allora il Concilio di Nicea (325) ribadì che Padre e Figlio hanno la stessa sostanza, usando l’aggettivo greco omoousios, “consustanziale”.
Gli ariani quindi si divisero tra quelli più strettamente legati ad Ario e quelli più concilianti con la chiesa, che erano di tre tipi:
- Alcuni dicevano che il Figlio è “dissimile” (anomoios) al Padre;
- Alcuni che il Padre e il Figlio hanno una “sostanza simile” (in greco omoiousios, con uno iota in più rispetto all’aggettivo omoousios usato dal Concilio di Nicea);
- Altri ancora che il Figlio è “simile” (omoios) al Padre.
Tutte queste aspre discussioni (fino al sangue) dei primi secoli della chiesa trovarono la soluzione tra il 360 e il 380 con alcuni teologi greci detti Padri Cappadoci. Essi dissero che lo Spirito Santo è consustanziale al Padre e al Figlio (estendendo anche allo Spirito l’aggettivo omoousios usato dal Concilio di Nicea).
Dissero inoltre che bisogna fare distinzione tra:
- Ousia (sostanza o essenza o natura), che è ciò che è comune tra gli individui della medesima specie;
- Upostasis (ipostasi, che poi verrà chiamata Persona): ciò che appartiene ai singoli individui.
Matteo, Marco e Luca hanno in comune una sostanza (umanità), ma sono tre ipostasi differenti, cioè tre persone con caratteristiche individuali diverse le une dalle altre. Quindi Padre, Figlio e Spirito hanno la stessa ousia, cioè sostanza (la divinità, vale a dire che sono l’Unico Dio) ma in tre ipostasi differenti. Ma tutto ciò è sempre un mistero in Dio, in quanto in Matteo, Marco e Luca l’umanità si moltiplica in tre uomini, invece nelle tre Persone divine (Padre, Figlio e Spirito) la sola divinità non porta alla esistenza di tre dei: Dio resta Uno.
Pertanto si può dire che il Padre è l’Unico Dio, il Figlio è l’Unico Dio e lo Spirito è l’Unico Dio, ma Padre, Figlio e Spirito sono misteriosamente tre Persone distinte. Possiamo pensare, però sempre imperfettamente, a un triangolo equilatero: ognuno dei tre angoli (A, B, C) esprime la stessa superficie del triangolo, tuttavia A è diverso da B e da C.
In cosa Padre, Figlio e Spirito sono distinti? I Padri Cappadoci diedero questa definizione:
- Il Padre è Colui che Genera in Principio;
- Il Figlio Colui che è Generato;
- Lo Spirito Colui che Procede (in seguito si chiarirà che procede dal Padre e dal Figlio).
Secondo una interpretazione, non condivisa però dai cristiani, la Trinità trarrebbe origine della tendenza di introdurre tra il Dio supremo e il mondo una serie di “divinità intermedie” o “mediatori celesti”. Questa tendenza va cercata in una lettura mistica di Platone che nel mondo ebraico si veniva delineando con menti speculative come Filone di Alessandria. A lui si deve la grande sintesi tra sapienza ebraica e cultura greca.
Secondo la mentalità greca, qualsiasi contatto del Dio supremo col mondo materiale lo avrebbe degradato a livello metafisico, costringendolo ad un abbassamento indegno della perfezione della sua essenza. Fu così che alcune del medioplatonismo, come Numenio di Apamea, Filone di Larissa e Filodemo di Gadara, introdussero una serie di Mediatori divini tra il Dio supremo e il mondo. A questi filosofi fece ricorso non solo la tarda filosofia dell’età ellenistica, ma anche quella giudaica, quando si trovò a dovere affrontare il problema di come conciliare in Dio l’unità e la molteplicità delle sue manifestazioni o potenze sul piano sensibile. Nacque così, nella tarda teologia giudaico – ellenistica, tutta una serie di Ipostasi, o astrazioni personificate, composte da funzioni o attribuiti divini o che alla divinità si riferivano.
Questo processo si sposava bene con un’altra tendenza della tarda età greco- romana, assetata di magico e di misterico, cioè quella di vedere alcuni individui dotati di un carisma particolare come “incarnazioni ” o “manifestazioni ” di alcuni attributi divini: Potenza, Sapienza, Bellezza, Santità, Perfezione, Sublimità, e così via. È il processo che ha generato le Sephiroth della Cabala e gli Eoni dello Gnosticismo. Simone il Mago, strano e controverso santone di cui parlano perfino il Nuovo Testamento, venne adorato in Oriente e finanche a Roma, alla corte di Nerone, come Incarnazione della Virtù di Dio detta “La Grande”. Un altro taumaturgo eccezionale, Menandro, era specializzato in guarigioni miracolose e riuscì a farsi adorare alla corte di Claudio come un dio. Stesso processo di divinizzazione subì il filosofo, taumaturgo e mistico neopitagorico Apollonio di Tiana, che gli stessi Padri della chiesa chiamarono “il Cristo pagano”.
Nacque così, nel tentativo neopitagorizzante di conciliare in Dio l’Uno e il Multiplo, la figura del theios aner, dell’uomo divino, irradiazione vivente di forze soprannaturali. L’impresa di Alessandro in India e la commistione con elementi dell’Estremo Oriente fece il resto, introducendo elementi orientali di molteplicità nel concetto ebraico di Dio unico.
Pertanto il filosofo ellenistico Plotino contemplava tre ipostasi: Uno, Intelletto e Anima. Queste si ritroverebbe nella Trinità cristiana quali Padre, Figlio (detto anche Logos, che significa Parola o Ragione o Intelletto) e Spirito Santo (“spirito” in greco è pneuma, che vuol dire anche “soffio vitale” o “anima”). Nella divinizzazione ipostatica dell’uomo di Nazareth, Gesù, considerato nella sua natura divina quale Figlio, si immetterebbe nella Trinità l’altra tendenza ellenistica del theios aner, l’uomo divino.
I cristiani sono quasi del tutto ostili a questa interpretazione e sin dal Medioevo rintracciano prefigurazioni della Trinità cristiana già nelle Scritture ebraiche di millenni prima.
Bibliografia
- L. Bienati, La letteratura giapponese, 2 voll., Torino 2005;
- L. Bienati, A. Boscaro, La narrativa giapponese classica, 2 voll., Firenze 2010;
- M. G. Biga, A. M. G. Capomacchia, Il politeismo vicino-orientale, Roma 2008;
- J. Breen, M. Teeuwen, A New History of Shinto, London 2010;
- E. Hornung, Gli dei dell’antico Egitto, Roma 1992;
- K. Kasahara, A History of Japanese Religion, Tokyo 2001;
- S. D. B. Picken, Essentials of Shinto, Atlanta 1994;
- M. Raveri, Il pensiero giapponese classico, Torino 2014;
- P. Zanotti, Introduzione alla storia della poesia giapponese, 2 voll., Milano 2012.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha dato alle stampe 36 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli.
Fonte immagini:Web