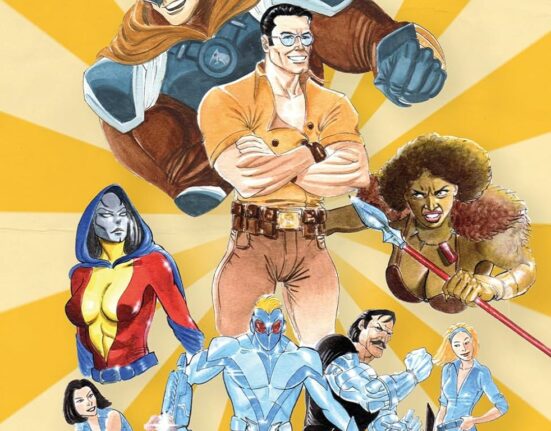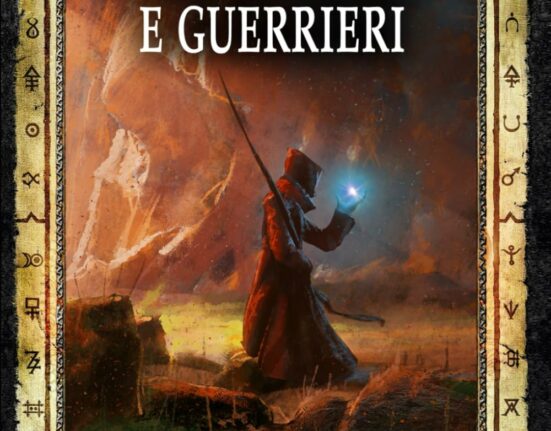A questo punto del nostro discorso, la rilettura politica della narrativa fantastica deve farsi più politica che mai. Come avrete senz’alto presente ma per sicurezza sarà meglio riepilogare, in questa parte della nostra trattazione mi sono prefisso di dimostrarvi che la preminenza di cui godono oggi gli autori di lingua anglosassone nel campo del fantastico, non è dovuta a una particolare eccellenza di americani e inglesi in questa materia, ma unicamente al prevalere dell’inglese come lingua a livello mondiale, a sua volta dovuto al prevalere degli Stati Uniti come potenza planetaria, e che altre letterature non anglofone avrebbero avuto non minori e forse anche maggiori potenzialità.
In un primo momento ho posto sotto analisi la Germania, o meglio il mondo di lingua tedesca, e, a partire dall’articolo precedente a questo, la venticinquesima parte, ho esteso l’analisi al mondo di lingua latina, cominciando ovviamente dalla nostra Italia, anche se mi riprometto più avanti di parlarvi del fantastico francofono e poi di quello iberico e latino-americano.
La storia della fantascienza italiana comincia ufficialmente nel 1952 con l’uscita di “Urania” dell’editore Mondadori, nata in un primo tempo come rivista, e poi trasformatasi in collana libraria, forma che mantiene tuttora, “ufficialmente”, perché in realtà è stata preceduta da altre iniziative editoriali simili destinate a minor fortuna, di cui non si può fare a meno di nominare almeno “Scienza fantastica”.
Probabilmente se ne parlerà molto nei prossimi tempi, visto che siamo giunti proprio al traguardo dei settant’anni.
Anche in Italia come altrove, la fantascienza è stata accompagnata dal fenomeno del fandom (dall’inglese “fan domain”, ambiente di appassionati), gruppi di appassionati che davano vita a club, manifestazioni, pubblicazioni amatoriali, fanzine (dall’ inglese “fan magazine”) spesso spartanamente ciclostilate o addirittura dattiloscritte una copia alla volta.
Sono stati proprio il fandom e le fanzine a permettere la nascita di un vivaio di autori di fantascienza nazionali in un momento in cui l’ambiente dell’editoria professionale offriva loro ben pochi sbocchi.
Dopo il pionieristico “primo fandom” dal 1952 al 1968, si situa temporalmente il “buco nero” (o “gli anni bui”, come ho definito questo periodo in un articolo pubblicato anni fa sulla rivista on line “Continuum”), con la sparizione di tutte le iniziative. Restava “Urania”, sorretta dal colosso Mondadori, ma attorno c’era il deserto.
Probabilmente è stata proprio la contestazione sessantottesca ad ammazzare il “primo fandom”. Molti si saranno detti che era inutile continuare a sognare il futuro quando lo si poteva costruire, non è stata la sola illusione di un parco di illusioni che ha devastato una generazione e i cui strascichi, si può dire, perdurano ancora oggi.
Nel 1978 un momento importante della ripresa è stato rappresentato dall’antologia Universo e dintorni a cura di Inisero Cremaschi, pubblicata dalla Garzanti, un’antologia che affiancava sullo stesso piano nomi affermati dell’ambiente fantascientifico, come Roberto Vacca, l’autore de Il medioevo prossimo venturo, a esordienti, e se si vanno a vedere i loro nomi, si scopre che sono gran parte di coloro che sarebbero poi stati protagonisti della fantascienza italiana negli anni successivi (forse non dovrei dirlo, ma ci sono anch’io).
Tuttavia il motivo principale per cui ne parliamo ora, è proprio l’introduzione all’antologia stesa da Inisero Cremaschi.
Molti, troppi, hanno visto nella nostra fantascienza un fenomeno imitativo di quella americana, sminuendo sistematicamente l’originalità, la qualità e le capacità letterarie dei nostri autori, fra questi, innanzi tutto il “malefico duo” Fruttero e Lucentini, succeduto a Mario Monicelli alla direzione di “Urania” e che, finché l’ha gestita ha tenuto le porte della pubblicazione rigidamente sbarrate agli autori nazionali (anche se Fruttero si autopubblicava sotto lo pseudonimo di Obstbaum – in tedesco “albero da frutta”).
Questo atteggiamento trovava un preciso parallelo nel disprezzo nutrito per la fantascienza, di qualunque nazionalità fosse, dagli esponenti spocchiosi e paludati della letteratura cosiddetta “alta”. Ce ne diede un chiaro esempio Alberto Moravia all’Italcon (congresso italiano di fantascienza) di Montepulciano del 1986.
Era accaduto quell’anno che una scrittrice del circolo moraviano, Luce D’Eramo avesse scritto un romanzo di fantascienza, Partiranno, a cui fu assegnato il Premio Italia di fantascienza per la categoria romanzi, e gli organizzatori pensarono di invitare Moravia a conferire il premio alla sua pupilla.
All’atto della consegna, Moravia tenne alla D’Eramo un discorsetto velenoso, in sostanza chiedendole come mai si fosse abbassata a scrivere un romanzo di fantascienza, dopo di che, senza aggiungere una parola, abbandonò la sala con ostentato disdegno, lasciando di stucco i partecipanti in attesa di ricevere gli altri premi, e tutti i presenti. Per protesta contro il suo atteggiamento, Vittorio Catani rifiutò di ricevere il premio che gli era stato assegnato.
Il “grande” Alberto Moravia si rivelò un perfetto cafone. Se la fantascienza non gli piaceva, nessuno l’aveva obbligato con il fucile puntato a venire a Montepulciano, ma non si va in casa d’altri per insultarli!
Cremaschi era di avviso esattamente opposto a quanti hanno voluto vedere nella fantascienza italiana null’altro che un fenomeno imitativo di quella americana, e nella sua introduzione ha minimizzato il ruolo che l’influenza di oltreoceano può aver avuto sulla nascita di quella nostrana, dando spazio alla tradizione italiana nel campo del fantastico, e a quelli che possiamo chiamare gli autori di paleo-fantascienza dell’ottocento.
Bisogna dire che Cremaschi era un vecchio comunista, un comunista vecchia maniera, e detestava cordialmente gli Stati Uniti e tutto ciò che fosse statunitense.
Nell’ultimo trentennio la sinistra ha abbandonato gran parte del proprio retaggio storico-culturale, e fra le cose che ha archiviato c’è indubbiamente l’anti-americanismo, che era una delle poche cose positive di questo retaggio, passando addirittura a un atteggiamento opposto, di servilismo verso il colosso a stelle e strisce, e oggi lo vediamo bene in fatti anche recentissimi, come la guerra in Ucraina.
Non si è solo trattato del fatto che “ha buttato via il bambino assieme all’acqua sporca” (anche perché di acqua sporca gliene rimane parecchia), ma del fatto che questo anti-americanismo era, in ultima analisi, superficiale, espressione del fiancheggiamento del dissolto impero sovietico, e non c’era alcuna reale comprensione del fatto che l’importazione di modelli e stili di vita americani sta progressivamente dissolvendo la cultura europea, un tempo indiscutibilmente superiore alla paccottiglia che ci arriva d’oltre Atlantico.
Tutto ciò premesso, l’introduzione di Inisero Cremaschi a Universo e dintorni rimane una ricerca importante su aspetti poco noti del nostro fantastico e sui precursori della nostra fantascienza.
Sui lontani ascendenti del fantastico italiano, Cremaschi non si sofferma molto: c’è ovviamente Ludovico Ariosto (oggi la materia dell’Orlando furioso potrebbe essere la tematica di un eccellente romanzo di fantasia eroica), c’è Tommaso Campanella con il romanzo utopico La città del sole, e non molto altro, non manca tuttavia qualche sorpresa con riferimento ad autori di cui difficilmente parlano le storie della letteratura, a testimonianza del fatto che questa introduzione deve essere costata all’autore un ampio lavoro di scavo e documentazione, ad esempio Bernardo Zamagna che ben nel lontano 1785 (per intenderci, siamo a prima della rivoluzione francese), pubblicò un romanzo, Navis aerea, dove descrive quella che potremmo considerare un’astronave.
Il maggior interesse di Cremaschi si concentra piuttosto sui precursori ottocenteschi, su quella che possiamo considerare la paleo-fantascienza del XIX secolo, e qui possiamo distinguere fra i “grandi” della nostra letteratura che hanno un risvolto fantascientifico spesso ignorato, e i “minori” che sebbene non manchino d’interesse, le storie della letteratura, ben di rado si degnano di nominare.
Sarà una sorpresa per molti, ma il primo di essi, di cui Cremaschi parla con ampiezza, è Giacomo Leopardi, che nelle Operette Morali avrebbe mostrato una preveggenza davvero sorprendente.
Trascrivo dall’introduzione di Universo e dintorni:
“Leopardi ipotizza fra l’altro la cultura di massa, il peso della stampa quotidiana sull’opinione pubblica, l’esplosione demografica, il volo umano, le aberrazioni del consumismo, gli studi statistici, le stragi di cui verranno ricoperte l’Europa e l’America, il dominio dei mercati come causa di conflitti armati, l’alienazione.
L’ispirazione socio-utopica di Leopardi, determinabile negli embrioni di un’affilatissima preveggenza negativa è lampante anche nella Proposta di premi fatta all’Accademia dei Sillografi, un’operetta morale scritta nel 1824 e nella quale, sicuramente per la prima volta, viene usata l’espressione “età delle macchine”, geniale anticipazione dell’odierna “civiltà delle macchine”. Nella Proposta, Leopardi suggerisce la costruzione di tre tipi di automi, che chiama “automati”, affinché sostituiscano l’uomo nelle sue abituali occupazioni”.
Nostradamus – verrebbe da dire – fatti da parte!
Sempre a proposito di Giacomo Leopardi, e peccato che Cremaschi non menzioni questo fatto, varrebbe la pena di ricordare che la citatissima frase sulle “Magnifiche sorti, e progressive” è una sua espressione, e che pochi si degnano di menzionare il fatto che già allora Leopardi la citava in senso ironico, poiché mentre divinava in modo sorprendente il progresso scientifico a venire, nel contempo non si faceva alcuna illusione su di esso nel portare la condizione umana alla felicità.
Tra i “grandi” della letteratura ottocentesca, possiamo ancora ricordare Emilio Salgari con il romanzo di anticipazione Le meraviglie del duemila, ma anche lui, come tutti gli altri autori di paleo-fantascienza citati da Cremaschi, è difficile che trovi spazio nelle storie della letteratura.
L’ottocento è stato il secolo del positivismo, un’epoca di entusiasmo per i miracoli della scienza e della tecnica, e non deve stupire lo sviluppo che ha avuto a quel tempo il “romanzo scientifico”, grazie anche, bisogna ammetterlo, al modello rappresentato da Jules Verne.
Fra gli autori ottocenteschi di paleo-fantascienza, Cremaschi cita Guglielmo Folliero De Luna, autore di un romanzo fantapolitico prudentemente ambientato sul nostro satellite, I misteri politici della luna del 1863. Gli fa eco nel 1880 Carlo Dossi con una Utopia, una delle tante che hanno ricalcato le orme di Thomas More.
Di maggiore interesse e più vicino allo spirito della fantascienza moderna è probabilmente Il corpo del 1870 di Camillo Boito (da non confondersi con Arrigo), dove si prospetta per la prima volta l’idea della creazione della vita in laboratorio, un romanzo, ci avverte Cremaschi, che riflette molto lo spirito materialistico del tempo, dove tutte le funzioni vitali e intellettive sono interpretate in termini di movimento di atomi, nonché l’entusiasmo positivistico del tempo per il progresso scientifico. Tuttavia Boito ci dà anche un inquietante avvertimento:
“Chi può dire alla scienza: questo è il limite?”
Una domanda che oggi, dopo la creazione delle armi nucleari e di distruzione di massa, certo ci poniamo con più angoscia.
L’autore probabilmente più rappresentativo di questo periodo e certamente quello che andò incontro a maggiore fortuna presso il pubblico, però, è Enrico Novelli che firmava con lo pseudonimo di Yambo, autore di mirabolanti avventure tra il salgariano e il verniano, para-scientifiche, le definisce Cremaschi, fra cui La guerra nel XX secolo pubblicato nel 1899.
Il periodo che va dagli inizi del XX secolo al 1952 con la nascita “ufficiale” della fantascienza in Italia (nascita che invece negli Stati Uniti è datata al 1926 con la creazione della rivista “Amazing Stories” di Hugo Gernsback), un cinquantennio abbondante, comprendente eventi terribili come le due guerre mondiali e l’impiego dell’arma nucleare, dove si è visto l’enorme potere del progresso scientifico nell’incrementare la distruttività umana, rappresenta, per così dire il neolitico della lunga preistoria fantascientifica, che ci ha consegnato fin dagli inizi una fantascienza più matura e meno dipendente dai modelli anglosassoni di quel che si potrebbe supporre.
A questo riguardo, Cremaschi ci presenta una lista davvero notevole di opere e di autori oggi dimenticati, ma ricordiamo che il suo scritto non aveva un intento principalmente storico, ma era un’introduzione alla meritoria antologia da lui curata.
Fra questi, ricordiamo L’invenzione dei tricupi di Maurizio Basso del 1902, i romanzi di Luigi Motta L’onda turbinosa del 1910 e Il vascello aereo del 1914, La fine del secolo XX di Giustino Ferri, poi ancora i romanzi di Antonio Beltramelli Gli uomini rossi del 1923 e Il cavaliere Mostardo del 1927, quindi I ciechi e le stelle, una raccolta di novelle del 1931. Come vi ho raccontato la volta scorsa, chiude questa lista Il paese senza sole di Giorgio Scerbanenco, pubblicato nel 1938, e comparso come altri romanzi di questo autore, a puntate su di un periodico.
Devo dire la verità: da triestino, mi sarebbe piaciuto trovare inserito in questo elenco anche La coscienza di Zeno di Italo Svevo, con il suo finale apocalittico e prettamente fantascientifico in cui il protagonista sembra preconizzare l’arma atomica e la distruzione nucleare del nostro pianeta.
Tuttavia, per quanto scarno, questo elenco è sufficiente a farci vedere in controluce un ambiente intellettualmente molto più vivo di quanto avremmo immaginato, e le potenzialità italiane nei campi fantastico e fantascientifico.
Nelle prossime parti di questa serie, come vi ho anticipato, vedremo di estendere la nostra analisi al resto del fantastico di lingua neolatina.
NOTA: Nell’illustrazione, un altro panorama fantascientifico