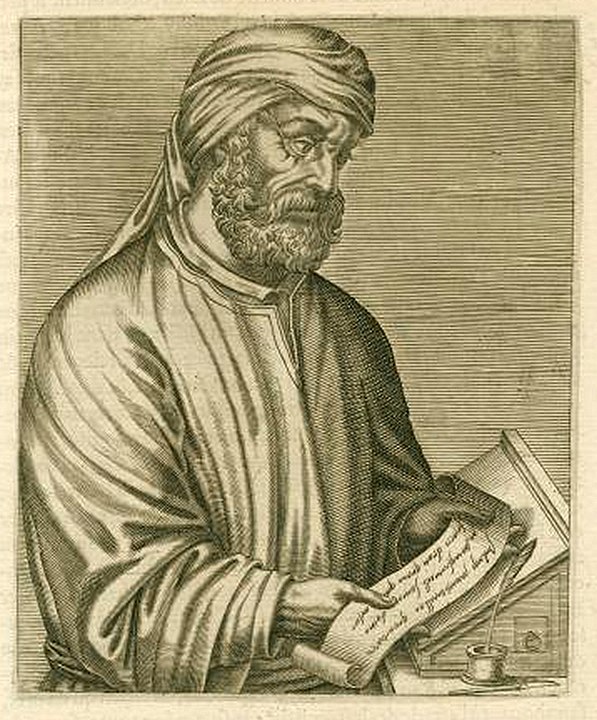L’italiano è una lingua indoeuropea, per quanto riguarda la famiglia, e una lingua neolatina o romanza, per quanto riguarda il gruppo. L’italiano è una delle varietà italo-romanze.
Facciamo ordine partendo da uno scenario più generale. La classificazione genealogica delle lingue nasce in un contesto tedesco primo ottocentesco. Questo tipo di classificazione portò a quelli che saranno noti come indoeuropeisti, a riconoscere delle parentele tra le antiche lingue indiane e persiane, il greco e il latino. Franz Bopp, nel 1816, scrive “Sul sistema di coniugazione della lingua sanscrita” il sanscrito è l’antico indiano, che resiste come lingua di culto. Nel continente europeo, prima dell’arrivo degli indoeuropei, c’erano altre lingue di cui si sa pochissimo, delle quali è rimasto pochissimo. In Italia non ci sono testimonianze in merito. Il basco è una di queste. Poi in Europa ci sono lingue che non sono indo-europee, per esempio l’ungherese. Tutte le altre lingue europee sono di origine indoeuropea.

Quando parliamo delle lingue neolatine, più che dire che provengono dal latino sarebbe più opportuno dire che “continuano” il latino. Si tratta, infatti, di una prosecuzione. Le lingue neolatine sono: francese, spagnolo, portoghese, rumeno, provenzale, catalano. Per quanto riguarda l’area dell’italiano, possiamo individuare varietà italo-romanze. Quello che noi chiamiamo italiano è una lingua fondata sulla morfologia del fiorentino letterario trecentesco. Ci sono tuttavia molte altre varietà italo-romanze (dialetti e lingue di minoranza). Alcune varietà che potremmo considerare dei dialetti sono (anche se non esiste una differenza sostanziale tra lingua e dialetto, si tratta solo di una questione di riconoscimento) il ladino dolomitico e il friulano, oltre che il romancio che non è in territorio italiano (la loro parentela con l’italiano fu uno dei più importanti conseguimenti della lingua italiana da parte del glottologo Isaia Ascoli, figura cruciale dell’Ottocento italiano).
Casa in sardo si dice sa domu, questo vuol dire che dal latino alle varietà italo-romanze normalmente il lessico tende a provenire dal sostrato colloquiale. Le parole elevate difficilmente sono passate alle lingue italo-romanze. Per esempio domus non è passata, ma si dice casa per dire domus, che in realtà significa capanna, casa umile. Testa si diceva caput, ma è passata la parola testa che in latino significava vaso d’argilla, come metafora “testa vuota”. Cavallo era equus, ma è passato caballus che voleva dire cavallo da tiro e non si trova assolutamente nei testi latini. Insomma, sono state tramandate le parole più umili. Un altro esempio è l’aggettivo bello, che si diceva pulcher, formosus, bellus, quest’ultimo però significa carino (l’equivalente di nice in inglese) e difficilmente si trova nei testi. Bellum che significa invece guerra, non è passato, infatti la parola guerra arriva da *werra, forma tedesca. Pulcher: parola latina di registro alto che si trova nelle poesie, non compare però nell’italiano, a meno che non andiamo a cercare nei testi teatrali che imitano il latino. Nelle altre lingue neolatine non esiste, come in italiano.
Con l’esempio di “bello” vediamo proprio che più si va verso la lingua latina bassa più emergono esiti nelle lingue romanze. Nel sardo, a differenza delle altre lingue romanze, rimane il vocalismo timbrico del latino. Nell’articolo c’è una differenza rispetto a tutte le altre lingue romanze. L’articolo italiano viene dal dimostrativo (IL)LU(M) in latino, che diventa l’articolo determinativo LO. L’articolo femminile viene da (IL)LA(M). L’articolo sardo viene da ISPUM, quindi SA e SUM.
Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476), si parlava ancora latino nell’area di ponente dell’impero, perché nella parte orientale si parla solo greco. Il greco resterà la lingua ufficiale dell’impero romano d’oriente per un millennio. Bisanzio cade nel 1453. Il greco non è più quello classico, ma quello bizantino. Per quanto riguarda l’area europea soggetta a molte guerre nei primi secoli dell’età medievale, lo sviluppo di nuove lingue rispetto al latino può essere fatto risalire al VII-VIII-IX secolo. Tra le diverse lingue neolatine, le varietà italo-romanze sono testimoniate molto tardi.
L’Indovinello veronese è un documento dubbio perché è difficile identificare la lingua in cui è stato redatto (è una scritta marginale su un manoscritto latino). Il Placito Capuano è certamente un documento in una lingua nuova rispetto al latino. Con grande certezza possiamo dire che documenti relativi all’antico francese sono di gran lunga precedenti.
Dobbiamo ricordare che il più antico documento in antico francese risale al 842, il Giuramento di Strasburgo. A un certo punto Carlo Magno muore e il territorio da lui dominato inizia a essere diviso tra i vari successori. I due nipoti di Carlo Magno, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico si alleano contro un altro fratello e fanno un giuramento. Carlo il Calvo regnava sul territorio che corrisponde circa all’attuale Francia, mentre Ludovico regnava sul territorio germanico. Uno storico di allora nella sua opera relativa a queste guerre trascrive il giuramento che fecero i due sovrani. L’opera è in latino, però per maggiore fedeltà lo storico trascrive il giuramento nelle due lingue in cui fu pronunciato: varietà di tipo francese e varietà di tipo tedesco. I due sovrani giurano l’uno nella lingua dell’altro, mentre i generali giurano nella propria lingua. Il testo in antico tedesco non fu il primo documento in questa lingua, mentre il testo in antico francese fu il primo documento di questa lingua.
L’Indovinello Veronese è uno dei primi possibili documenti italoromanzi. Poco accreditato come fatto, in quanto si pensa sia ancora in latino. Rimane un documento molto antico, risalente al VIII-IX secolo.
Se pareba boves
Alba paratalia araba
Et alba versorio teneba
Et negro semen seminaba
Complessivamente si riferisce alla mano che scrive. Se pareba boves: non ha ancora un’interpretazione definitiva, ma probabilmente significa “Spingeva i bovi”, si riferisce alle dita della mano Alba pratalia araba: si riferisce allo scrivere sulla pergamena, “arava bianchi prati”. Et alba versorio teneba: indica la piuma d’oca per scrivere. Et negro semen seminaba: parla dell’inchiostro sul foglio, “e seminava nero seme” (manca il suffisso finale t. La forma negro non viene dal latino classico). Si può complessivamente considerare un testo latino con tratti volgari.
L’Iscrizione di Commodilla si trova a Roma nella catacomba di Commodilla. Si tratta di un’incisione sul muro che non ha precisa datazione, ma si pensa risalga all’VIII-IX secolo. Sicuramente è stata vergata prima del giuramento di Strasburgo, in quanto in seguito a quella data la catacomba è stata abbandonata. Dopo che questi luoghi sono andati in disuso, sono stati riscoperti solo recentemente. La scritta è stata rovinata e non è più visibile all’interno della cripta. Dal punto di vista linguistico è molto interessante.
Non dicere ille secrita abboce
Letteralmente significa “Non dire le cose segrete a voce alta”. Queste “cose segrete” sarebbero una parte della liturgia. Molto più complicato è capire in che lingua sia stato scritto. Rispetto all’indovinello le cose sono più miste. Non dicere: è ancora inseribile nel latino classico. Ille: sarebbe il dimostrativo ille, illa, illud del latino, ma sembra essere già avviato il processo che lo trasforma nell’articolo determinativo italiano (illum=lo, illi= li, illas= le). Abboce: è la parte più interessante. La V latina è scritta con una B (begetismo), ma la parte interessante è la seconda B, sicuramente scritta in un secondo momento rispetto al resto del testo. La pronuncia era come se fossero due B. Rappresenterebbe l’ad vocem latino.
È un testo latino, volgare o intermedio. Quello che ci manca è sapere se lo scrittore fosse a conoscenza del fatto che scriveva in una lingua diversa dal latino. Non è del sbagliato indicare questo testo come primo testo in volgare italiano, ma non è neanche completamente corretto.
Nel Placito Capuano è certamente presente la consapevolezza di una nuova lingua. Si tratta di un codice di pergamena fittamente scritto. Il placito è un documento giuridico, che in questo caso riguarda l’altare posto su un territorio rivendicato dall’abate di Montecassino nei confronti di un feudatario locale. Il contenuto sono le testimonianze di tre persone a favore dell’abate che rivendicava la proprietà del terreno. È un processo di usucapione; l’abate dopo trent’anni di uso del terreno ne rivendica la proprietà. La gran parte di quello che è scritto è in latino medievale. I tre testimoni si presentano davanti al giudice e devono ripetere una formula per difendere la casa dall’abate.
Sao ko kelle terre per kelle fini que ki contene trenta anni le possette parte Sancti Benedicti
“So che quelle terre, limitatamente ai confini in cui sono contenute, per trent’anni la ha possedute il monastero di San Benedetto”. Dal punto di vista dell’impianto, è evidente che lo scrivente usa una lingua diversa dal latino. A parte alcuni elementi, di latino c’è poco, anche se il sintagma è ancora quello latino. Sao: significa so. È riconducibile alla forma latina sapio. Non si tratta né di “so” né di “saccio”. Questo problema è stato discusso dai filologi, perché da un testo di questo tipo ci si aspetta un tipo di volgare più simile a quello meridionale, quindi un uso di “saccio”. Ci troviamo quindi in un periodo molto tardo rispetto al Giuramento di Strasburgo. Per molto tempo si è pensato che questa forma fosse stata influenzata da usi settentrionali, ma questo è molto improbabile. Parte Sancti benedicti: è scritto ancora in latino. “Il santuario di san Benedetto”. Ci sono molti altri placiti di questo periodo che sono scritti interamente in latino. Probabilmente il testo non è tradotto per permettere a tutte le persone coinvolte di capire la decisione finale.
La poesia della Scuola siciliana (della corte di Federico II, morto nel 1250) è fortemente influenzata dai modelli specialmente provenzali. Tuttavia noi la leggiamo in una forma toscanizzata (cioè come ce l’hanno trasmessa i copisti toscani: allo stesso modo la leggeva Dante due o tre generazioni dopo, che per altro – differentemente da noi – non ne era consapevole).
Un esempio di siciliano illustre nella sua forma originale (uno dei pochi che abbiamo, fortunosamente trascritto durante il Cinquecento insieme a pochi altri) è la canzone di Stefano Protonotaro. C’è una grande differenza con molte altre opere, per esempio quelle di Giacomo da Lentini, che sono invece toscanizzate (per opera dei copisti).
Non sappiamo molto sui Siciliani di quel periodo. Comunque, da quel poco che si sa, Giacomo è di generazione precedente e contemporaneo di Federico II (è la figura più importante della Scuola siciliana), mentre Stefano Protonotaro dovrebbe collocarsi (ma ci sono poco documenti) in una generazione successiva.
Nelle generazioni successive, la corrente principale della poesia passa per la Toscana: la poesia conserva alcuni elementi del siciliano (sicilianismi), ma per lo più si rifà direttamente ai modelli francesi (provenzalismi, francesismi). Si pensi ai nomi con suffisso in -anza (come amanza), di chiara origine provenzale. Questi prestiti si trovano ancora copiosamente nel più grande tra i poeti che precedono Dante, cioè il fiorentino Guido Cavalcanti. Vanno poi invece decrescendo nelle Rime di Dante, specie quelle della maturità.
Un discorso molto diverso deve essere fatto per la Commedia di Dante – che, secondo la concezione degli stili medievale, è appunto un’opera comica e non lirica. Non possiamo parlare con assoluta certezza della lingua di Dante perché NON esistono manoscritti autografi a lui risalenti (i primi grandi testi della letteratura italiana di cui abbiamo un manoscritto autografo sono il cosiddetto Canzoniere di Petrarca e il Decameron di Boccaccio). Tuttavia, pur consapevoli che il testo della Commedia è frutto di una difficile ricostruzione operata dai filologi, possiamo dire che essa è nettamente segnata da un forte plurilinguismo. La base è data dal fiorentino dei tempi di Dante, ma ci sono contributi di molti altri codici linguistici: la parte del leone la fanno senz’altro i latinismi. Ma quel che più conta è la commistione degli stili: Dante non esita, tanto più nell’Inferno, ma anche nel Paradiso, a mischiare senza ritegno alto e basso dal punto di vista linguistico: il che non piacerà per nulla al classicismo cinquecentesco.
Dante è straordinariamente importante per la storia della lingua italiana non solo per le sue opere poetiche, considerate tanto ben fatte da essere prese a modello dell’italiano, ma anche per la riflessione sul volgare che ha condotto in due testi fondamentali, il Convivio e il De Vulgari Eloquentia.
Entrambe le opere risalgono ai primi anni dell’esilio (1304-1306) ed entrambe sono incompiute -evidentemente abbandonate per la redazione della Commedia. Le tesi presentate nelle due opere sono leggermente diverse. Se nel Convivio Dante (commentando in volgare i suoi stessi testi poetici in volgare) sostiene che il volgare è un nuovo sole destinato a portare la luce a coloro che non l’hanno (quelli che non sono illuminati dal vecchio sole, cioè il latino) – ma che tuttavia il latino è ancora superiore al volgare, invece nel De Vulgari Eloquentia Dante sostiene con argomenti filosofici la superiorità del volgare (NOBILIOR EST VULGARIS) in quanto lingua naturale rispetto al latino, lingua artificiale.
Dante cerca di rintracciare questo volgare non ancora esistente: volgare che definisce con una celebre sequenza di attributi: un VOLGARE ILLUSTRE, AULICO, CURIALE, CARDINALE):
- ILLUSTRE = alto, che illumina gli altri
- AULICO = che sarebbe quello parlato in una aula (=sede reale) se ci fosse un re in Italia
- CURIALE = sempre parlato in un’aula, ma relativo alla curia (corte)
- CARDINALE = punto di riferimento per gli altri volgari, che farebbe cioè loro da cardine.
Molti anni dopo Machiavelli rimprovererà a Dante l’incoerenza tra quanto sostenuto nel De Vulgari Eloquentia e la sua lingua nella Commedia. Molti addirittura sosterranno che il De Vulgari Eloquentia (che scompare, e ricompare nel Cinquecento in un unico manoscritto) non sia opera di Dante.
In realtà Dante nel De Vulgari Eloquentia parla, nel primo libro, del volgare in generale, e nel secondo, quello interrotto, del volgare da usare nella poesia lirica. In questo senso depreca l’uso di molti volgari, COMPRESO il fiorentino (che sarà poi la base della Commedia, scritta in anni successivi). E predilige il bolognese e il siciliano (o meglio quello che lui pensava fosse il siciliano): non a caso i due volgari in cui si era espressa fin lì la migliore poesia lirica (i siciliani e Guinizzelli). Quindi, se Dante al momento del De Vulgari Eloquentia pensa al volgare che si sta usando nella produzione lirica coeva (sonetti, canzoni, ecc.), non pensa però a quello che userà di lì a poco nella Commedia. La Commedia è, nella logica degli stili medievali, un testo stilisticamente più basso: e quindi Dante può usare per essa un volgare MENO illustre, più vicino (almeno nella veste fonomorfologica) alla lingua che lui davvero parlava in quanto fiorentino. Anche se abbiamo già detto che questo fiorentino si intreccerà poi nella Commedia con una notevole presenza di altri codici. Non per nulla, quando compare nel Purgatorio il grande poeta provenzale Arnaut Daniel (che Dante definisce “il miglior fabbro del parlar materno”) Dante gli consente addirittura di esprimersi nella sua lingua madre: e scrive quindi nove versi in provenzale: il provenzale è un esempio di commistione di stili.
Petrarca e Boccaccio sono fondamentali, in quanto il canone che si formerà nel Cinquecento li additerà come principali modelli non solo di stile, ma proprio di lingua. Inoltre, come abbiamo detto, si tratta dei primi grandi autori di cui abbiamo un manoscritto autografo. Nel caso di Petrarca si tratta del celebre Vat. Lat. 3195, che per la verità è in parte autografo, in parte idiografo (cioè scritto da mano diversa da quella dell’autore, ma sotto stretta sorveglianza di quest’ultimo). Questo codice riporta il celebre (cosiddetto) Canzoniere, titolo cinquecentesco per un’opera che l’autore aveva battezzato Rerum Vulgarium Fragmenta (“Frammenti di cose volgari”, cioè scritte in lingua volgare – non in latino). Parlando del Canzoniere, bisogna in primo luogo osservare come la lingua, e specialmente il lessico di Petrarca, sia tendenzialmente monolinguistico (rispetto al plurilinguismo dantesco). Ciò è vero non solo nei confronti della Commedia (che apparteneva a un genere diverso), ma anche rispetto alle rime di Dante. In particolare, il lessico poetico del Canzoniere è piuttosto ridotto, astratto e antirealistico e mette in atto una fortissima selezione sul lessico della poesia precedente, compresa quella di Dante. Lo stesso accade sul piano della metrica: Petrarca usa pochi schemi e pattern ritmici dell’endecasillabo: questa selezione condizionerà la poesia italiana per almeno cinque secoli. Per esempio, l’endecasillabo accentato sulla quinta sillaba, che in Dante si trova ancora, non si trova mai in Petrarca: il fatto che l’endecasillabo sia accentato sulla quarta o sulla sesta diventerà una regola vera e propria, almeno a partire dal Cinquecento.
Se Petrarca diventerà modello assoluto di poesia (e della lingua da usare in poesia), un processo analogo di canonizzazione avverrà nel Cinquecento per Boccaccio. Anche in questo caso, abbiamo per nostra fortuna un autografo: l’Hamilton 90 conservato a Berlino (si tratta però di un’identificazione recente: l’autografia è stata notata solo negli anni ’40, e certificata nel 1962). Questo codice contiene l’opera più nota di Boccaccio, cioè il Decameron (che andrebbe pronunciato con l’accento sulla o). Il Decameron è costituito di un proemio, di un’introduzione e di dieci giornate (in greco deka emerai), comprendenti dieci novelle ciascuna. Le cento novelle si fingono raccontate da sette donne (Pampinea, Filomena, Neifile, Fiammetta, Elisa, Lauretta, Emilia) e tre giovani (Filostrato, Dioneo, Panfilo), in una villa di campagna presso Firenze, dove la brigata di giovani si è rifugiata per sfuggire al periodo più crudo della pestilenza del 1348. La lingua delle novelle è piuttosto varia, e, seppure basata sul fiorentino, rispecchia un gusto di Boccaccio per la varietà linguistica. Alla molteplicità di situazioni comunicative, di luoghi e di personaggi appartenenti ai diversi ceti sociali corrisponde quindi un plurilinguismo che trova nel lessico la sua espressione più evidente. Ad esempio i personaggi socialmente più bassi, o marginali, o di provenienza rustica tendono a usare elementi di lingua più vicini al parlato. O anche, se di provenienza non fiorentina, a usare forme tipiche del loro luogo d’origine. Questa varietà linguistica e stilistica non scalfisce però il fatto che l’influenza maggiore sulla prosa italiana la ebbe la sintassi del Decameron. Questo perché la canonizzazione cinquecentesca additò in particolare quel modello. La sintassi delle parti più alte del Decameron è complessa e latineggiante, basata su accumulazione di subordinate a sinistra del periodo, massima interposizione frasale, collocazione del verbo a fine periodo Questo tipo di periodo, basato sui modelli latini di Cicerone e di Livio, rappresenterà un modello importantissimo per la prosa italiana a venire.
 Perché Petrarca e Boccaccio danno titoli latini a opere scritte il volgare? Sia Boccaccio sia soprattutto Petrarca anticipano quello che siamo abituati a chiamare umanesimo (latino), e che culminerà nel Quattrocento. Entrambi scrivono anche in latino, e Petrarca scrive quasi solamente in latino. Quindi nel caso del Canzoniere il titolo (che poi è – come di norma allora – da intendere come una indicazione sul contenuto del codice) è in latino in quanto, per così dire, fuori dall’opera stessa. Per quanto riguarda Boccaccio, la risposta deve essere più complessa. In questo caso la parola è – diciamo così – un tentativo di grecismo, senza passare dal latino. Boccaccio, diversamente da Petrarca, tentò di studiare il greco – e lo fece con il monaco calabrese Leonzio Pilato: uno dei pochi allora in Italia che avessero competenza per insegnarlo.
Perché Petrarca e Boccaccio danno titoli latini a opere scritte il volgare? Sia Boccaccio sia soprattutto Petrarca anticipano quello che siamo abituati a chiamare umanesimo (latino), e che culminerà nel Quattrocento. Entrambi scrivono anche in latino, e Petrarca scrive quasi solamente in latino. Quindi nel caso del Canzoniere il titolo (che poi è – come di norma allora – da intendere come una indicazione sul contenuto del codice) è in latino in quanto, per così dire, fuori dall’opera stessa. Per quanto riguarda Boccaccio, la risposta deve essere più complessa. In questo caso la parola è – diciamo così – un tentativo di grecismo, senza passare dal latino. Boccaccio, diversamente da Petrarca, tentò di studiare il greco – e lo fece con il monaco calabrese Leonzio Pilato: uno dei pochi allora in Italia che avessero competenza per insegnarlo.
Oltre a essere un grandissimo architetto, Alberti è importante anche per la storia della lingua, per almeno tre ragioni:
- L’organizzazione del Certame coronario, concorso pubblico di poesia in volgare sul tema dell’amicizia, che Alberti ideò e organizzò a Firenze nel 1441. Alla gara parteciparono in quattordici, dei quali solo otto furono ammessi a recitare i propri testi pubblicamente in Santa Maria del Fiore, sottoponendoli a dieci giudici – di cultura umanistica. Ma la giuria, che nelle intenzioni di Alberti indicando un vincitore avrebbe legittimato la poesia in volgare, decise di non assegnare il premio; e di ciò si lamentò Alberti nella Protesta (che circolò anonima nei giorni immediatamente successivi alla gara, ma certamente di Alberti).
- La cosiddetta Grammatichetta vaticana (perché conservata in un codice della Biblioteca Vaticana): è la prima grammatica di un volgare italoromanzo, ma rimase nel cassetto di Alberti, senza alcuna diffusione. L’operazione è di grande modernità. Alberti descrive non una lingua letteraria, ma il fiorentino quattrocentesco – quello del suo tempo. Le categorie grammaticali applicate tuttavia sono quelle umanistiche, proprie dei grammaticografi latini, anche con l’intento di dare prestigio al volgare.
- La riflessione sulla lingua nel Proemio del trattato sulla Famiglia, in cui Alberti spiega che il volgare, se adeguatamente valorizzato dall’uso degli scrittori e trattato secondo canoni umanistici, può assurgere alla grandezza del latino.
Alberti era nettamente in controtendenza rispetto alla sua epoca (la prima metà del Quattrocento). Ma nella seconda metà del Quattrocento la sua visione diventerà invece centrale, almeno nella cerchia fiorentina della corte del Magnifico. Le motivazioni di Lorenzo sono però in parte diverse. Nella logica di imporre un’influenza culturale, laddove non è possibile realizzare un controllo militare, Lorenzo de’ Medici usa il fiorentino anche come strumento di propaganda, vista la sua grande tradizione poetica. Alla sua corte raccoglie grandi umanisti, che però mostrano interesse per il volgare: Cristoforo Landino, ad esempio. Ma primo tra tutti il più grande poeta dell’epoca, Poliziano. In questo senso va la Raccolta aragonese, promossa da Lorenzo. Si tratta di una antologia che comprende 499 testi dei maggiori poeti toscani dal Duecento al Quattrocento (culminante con Lorenzo stesso). Nel 1476 il Magnifico donò la Raccolta a Federico d’Aragona, figlio del re di Napoli Ferrante (da qui il nome con cui è nota la raccolta), accompagnandola con una lettera dedicatoria a sua firma. Come è stato dimostrato, tuttavia, l’autore della lettera è Angelo Poliziano, che giustifica la realizzazione dell’opera per dimostrare la grandezza della tradizione poetica toscana e la dignità estetica del volgare.
Dante e Petrarca qui stanno ancora insieme come capisaldi. Ben altro sarà lo sviluppo della questione della lingua nel Cinquecento. Intanto ci si può domandare perché proprio in quel momento storico alcuni tra i più grandi ingegni dell’epoca si accaniscano a discutere su quale lingua si debba adottare. Il contesto storico è ormai quello delle cosiddette Guerre d’Italia. Dopo il periodo di relativa stabilità della seconda metà del Quattrocento (si pensi all’introduzione della Storia d’Italia di Guicciardini – e alla individuazione, da lì in poi topica, della morte del Magnifico nel 1492 come ultimo momento di pace nel territorio italiano) arriva un’età di grandi rivolgimenti, che inizia con la discesa del re di Francia Carlo VIII in Italia, e con continuerà poi con la lunga e violenta guerra tra Carlo V e Francesco I. Proprio mentre l’Italia diventa terreno di combattimento e perde rapidamente la sua autonomia politica, urge il dibattito su una sorta di unità culturale, letteraria e linguistica. Le posizioni sono molte e variegate, ma tradizionalmente (da Bruno Migliorini in poi, il primo autore di un manuale di Storia della lingua italiana) si riassumono in tre posizioni prevalenti:
- La proposta classicista, che individua come soluzione il fiorentino letterario trecentesco (Pietro Bembo ne è il padre – e in fondo si può dire che sia anche in questo senso il padre della lingua italiana come la parliamo e scriviamo noi – o almeno il più plausibile tra i possibili padri).
- La lingua cortigiana: alcuni propongono di adottare il linguaggio che si parla “naturalmente” nelle corti e che si scrive nelle lettere diplomatiche e nei documenti di cancelleria. Il principale modello è la corte papale di Roma.
- Il cosiddetto naturalismo fiorentino: la proposta di usare il fiorentino contemporaneo (cioè quello di inizio cinquecentesco), che è memorabilmente espressa in un testo la cui autorialità era un tempo disputata, ma che oggi si può attribuire senza alcun dubbio a Machiavelli (il Discorso intorno alla nostra lingua).
Visto che la prima posizione sarà di gran lunga quella prevalente, soffermiamoci un momento sulle altre due.
Iniziamo dalla lingua cortigiana. Già nel Quattrocento si erano formate, specie nelle cancellerie dei vari stati, delle lingue di koinè (= lingua comune che si diffonde in un determinato territorio), dovute allo sforzo dei diplomatici e cancellieri di superare le differenze dei loro codici attraverso un’operazione di conguaglio. Le caratteristiche di queste lingue sono:
- minore incidenza dell’elemento linguistico locale;
- forte presenza di latinismi, che sostituisce spesso l’espressione locale troppo marcata i (o il toscanismo);
- presenza non sporadica di tratti fonomorfologici e lessicali toscani, in particolare fiorentini, specie se coincidenti con fenomeni locali.
Questo modello, patrocinato anche da un illustre scrittore come Castiglione (nel suo Libro del Cortegiano), non si imporrà soprattutto per due motivi: assenza di una norma condivisa (ogni corte faceva un po’ a modo suo) e diffusione della stampa, che pretendeva una normalizzazione della polimorfia, molto diffusa nei testi cortigiani. Inoltre va anche ricordata la decadenza delle corti potenzialmente alternative al modello toscano.
Quando parliamo di polimorfia intendiamo la varietà di esiti fonomorfologici della stessa parola, per esempio: Core/cuore, gioco/giuoco, maraviglia/meraviglia, sacrificio/sagrifizio. Ovviamente la polimorfia era mal digerita dalla stampa, mentre non poneva problemi finché i singoli copisti redigevano i loro codici. La posizione cortigiana fu in un certo senso continuata anche da Trissino (cosiddetta linea italianista), che piega il contenuto del De Vulgari Eloquentia dantesco (da lui riesumato) a un patrocinio nobile della posizione cortigiana. Sia Castiglione sia Trissino parlano senz’altro non di lingua cortigiana (o cortegiana), ma di lingua italiana.
Le Prose della volgar lingua di Pietro Bembo, pubblicate nel 1525, sono senz’altro il testo più importante nell’ambito del dibattito cinquecentesco sulla lingua. Basate su un classicismo di stampo umanista, ma applicato al volgare, e sulla teoria dell’imitazione, che del classicismo è un corollario, esse promuovono appunto dei modelli. Modelli di stile, ma anche propriamente modelli di lingua. Così come per il latino i due modelli erano Cicerone e Virgilio, l’uno per la prosa, l’altro per la poesia, così Bembo propone per il volgare i modelli di Petrarca per la poesia e di Boccaccio per la prosa. Al terzo modello, cioè a Dante, Bembo rimproverava l’uso di un lessico basso, ovvero la caduta stilistica, che in Petrarca non si era verificata mai. Anche Boccaccio aveva adoperato, in certe parti del Decameron (per esempio quelle in cui c’è mimesi del parlato) un linguaggio meno elevato, ma Bembo invitava a considerare non le zone basse, ma quelle in cui lo stile era più alto, come la cornice o le novelle più tragiche. Già Bembo si era occupato di Dante e Petrarca a inizio 500, curando per il prestigioso editore umanista Aldo Manuzio, il Canzoniere e la Commedia. Già qui Bembo si era esercitato sulla lingua dei due grandi poeti fiorentini (vi ricordo che anche Petrarca linguisticamente era tale). Ma come si può leggere in Prose II, 5, sono pesanti le sue riserve su Dante. Parole dantesche come stregghia, scabbia o biscazza sono inaccettabili per il gusto classicista cinquecentesco.
Le Prose sono un trattato dialogico in tre libri – i personaggi che dialogano sono Carlo Bembo (portavoce delle idee del fratello), Giuliano de’ Medici (non ovviamente il fratello di Lorenzo, ucciso nella congiura dei Pazzi nel 1478, ma l’ultimo dei figli di Lorenzo), Federico Fregoso (un nobile genovese), Ercole Strozzi (un ferrarese noto come poeta in latino). Giuliano è un po’ il continuatore della linea di suo padre, il cosiddetto umanesimo volgare fiorentino – di cui abbiamo parlato.
Rimane pacifico che per Bembo, e in realtà per la maggior parte dei lettori cinquecenteschi (escluso qualche fiorentino) Petrarca è di gran lunga superiore a Dante. Del resto, il grande “successo”, italiano e mondiale, di Dante – arriva soprattutto dall’Ottocento in poi.
Il terzo libro delle Prose di Bembo è – sia pure in forma dialogica – una grammatica. Utile per tutti, visto che neanche un fiorentino deve ritenersi naturalmente capace di scrivere bene (l’appunto è rivolto a Giuliano) solo perché è nato fiorentino. Questo perché il fiorentino del Quattrocento e primo Cinquecento era ormai sensibilmente diverso da quello del Trecento. Ed è appunto il fiorentino letterario del Trecento che Bembo raccomanda all’imitazione – e di cui cerca di allestire una grammatica. Non la prima in assoluto, perché circa un decennio prima uscirono le Regole grammaticali della volgar lingua pubblicate da Giovan Francesco Fortunio nel 1516 (la prima grammatica a stampa dell’italiano). Per quanto riguarda Bembo, il terzo libro delle Prose riesce a sintetizzare tutta la grammatica del volgare fiorentino nelle battute di un dialogo. La trattazione è quindi poco tecnica: gli schemi grammaticali non ci sono (differentemente da quanto avveniva nella Grammatichetta di Alberti), e le stesse parti del discorso non sono fissate in un elenco univoco. La terminologia grammaticale viene resa con parole tratte dal linguaggio comune: divertimento per «elisione», maniera per «coniugazione», pendente per «imperfetto», senza termine per «infinito»; numero del meno e numero del più invece di «singolare» e «plurale», e del maschio e della femmina invece di «maschile» e «femminile». La morfologia nominale è basata sul fiorentino trecentesco, ma selezionando e discutendo le eccezioni, cioè in pratica facendo un’opera di standardizzazione.
In alcuni casi le prescrizioni bembiane possono sembrare oggi arcaiche, ma più spesso coincidono con le forme ancora in uso in italiano. Di lì a poco cominciarono a uscire opere che sintetizzavano e divulgavano il contenuto (la grammatica) delle Prose. E questa grammatica diventò presto la norma per gli stampatori, almeno per i più consapevoli: molte opere furono riviste in senso bembiano a livello editoriale. O talora dagli autori stessi: celebre il caso dell’Orlando furioso. Ariosto, nella terza edizione del 1532, si mette alla scrivania e corregge minuziosamente (dal punto di vista linguistico) la sua opera in senso bembiano. Per esempio sostituisce tutti gli articoli maschili singolari ‘el’ (fiorentino quattrocentesco e settentrionale) con la forma fiorentina trecentesca ‘il’, raccomandata da Bembo.
L’importanza di Bembo per la storia della lingua italiana è enorme. Anche se non più riconosciuto come il principe dei poeti petrarchisti come ai suoi tempi (e insomma ridimensionato con il tempo nel borsino dei valori letterari), il contributo di Bembo alla storia della lingua italiana è stato decisivo. La fonomorfologia (insieme dei tratti fonologici e morfologici di una lingua) della lingua che parliamo oggi è – sostanzialmente – ancora quella del fiorentino trecentesco. La morfologia è il settore della linguistica che studia la struttura interna delle parole e le relazioni fra i cambiamenti di forma e i cambiamenti di senso delle parole. La definizione di fonologia è più complessa, ma sempre in sintesi studia i foni (i suoni con articolazione linguistica) come enti astratti, mentre la fonetica li studia come fenomeni empirici.
Possiamo solo accennare al naturalismo fiorentino. Machiavelli aveva scritto: “la disputa, nata più volte ne’ passati giorni, se la lingua nella quale hanno scritto i nostri poeti et oratori fiorentini è fiorentina, toscana o italiana. Nella qual disputa ho considerato come alcuni, meno inhonesti, vogliono ch’ella sia toscana; alcuni altri, inhonestissimi, la chiamano italiana; et alcuni tengono ch’ella si debba al tutto nominare fiorentina”. Ma per fiorentina lui intendeva nettamente la lingua da lui parlata: il fiorentino tardo-quattrocentesco e di inizio Cinquecento. Questa posizione non poteva quindi che essere in contrasto con quella di Bembo: anche se Bembo se la prende esplicitamente solo con i cosiddetti “cortegiani”.
La conciliazione tra le idee di Bembo e il punto di vista fiorentino si ebbe solo con l’Ercolano del filosofo aristotelico Benedetto Varchi (pubblicato postumo nel 1570). Varchi riportò l’attenzione sulla dignità del parlato, mostrando le qualità del fiorentino vivo e vanificando così il rigore delle Prose. L’Ercolano, pur tributando a Bembo un grande elogio, ne tradisce l’insegnamento, perché sancisce il principio dell’autorità ‘popolare’ (non il “popolazzo” – come dice lui -, ma il popolo ‘medio’) accanto a quella degli scrittori. Firenze può così candidarsi di nuovo alla guida e al controllo della lingua, dopo che il successo della teoria bembiana le aveva tolto il primato. Successivamente, la cultura linguistica fiorentina, con Lionardo Salviati, prosegue nell’operazione di lodare e disattendere al tempo stesso Bembo. A Salviati si deve la scelta del canone che portò nel 1612 al Vocabolario della Crusca. Salviati collocò, accanto ai tre grandi del Trecento, una serie di autori minori e spesso molto minori. Bembo aveva in pregio anche e soprattutto il valore letterario; per Salviati e per la Crusca conta l’arcaismo in sé. Fu comunque Salviati a gettare le basi per l’Accademia della Crusca, negli anni ’80 del Cinquecento. L’Accademia esisteva già, ma Salviati la indirizzò su studi linguistici. Dal lavoro dell’Accademia nacque il primo grande vocabolario europeo, pubblicato nel 1612, secondo un progetto nato appunto da Lionardo Salviati, che però morì prima della sua realizzazione. Mancando dopo di lui una figura di spicco (nessuno degli accademici aveva una matura competenza lessicografica o linguistica), l’Accademia della Crusca agì collegialmente.
Il Vocabolario della Crusca accetta di preferenza gli autori antichi: accoglie testi di qualunque tipo, purché trecenteschi. Solo quando di una certa parola non ci sono attestazioni antiche, finisce per accettare esempi da autori più recenti. Esclude comunque gli autori più avanzati e soprattutto quelli che rifiutano il primato del fiorentino. Clamorosa è l’esclusione di quello che era stato di gran lunga il maggior poeta del secondo Cinquecento, cioè Tasso. Vengono invece privilegiate voci arcaiche, purché fiorentine. E si cita non solo da testi a stampa, ma – discutibilmente – anche dai cosiddetti testi a penna, cioè manoscritti fiorentini inediti in possesso degli stessi accademici
Il lavoro che portò al Vocabolario della Crusca era durato molto, dagli anni ’90 del Cinquecento fino al 1612. Mettere insieme un po’ forzatamente come aveva fatto Varchi, il classicismo di Bembo che però era tutto giocato sull’imitazione dei grandi modelli con le opinioni di Salviati che erano rivolte all’uso come modello di qualunque tipo di scrittore purché venisse dal 300.
Autore di opere fondamentali, Tasso era una specie di bestia nera per Salviati e per la Crusca, perché non riconosceva il primato del toscano. Di fatto, Tasso preferisce usare parole lombarde quindi settentrionali, latinismi, ma non riconosce il primato del fiorentino e del toscano, come invece aveva fatto Ariosto, nella revisione dell’Orlando. Tasso aveva teorizzato una procedura stilistica che noi chiamiamo “parlar disgiunto”, non mirava all’equilibrio tipico del Trecento. Il povero Tasso entrerà tra gli autori accettati dalla Crusca solo nella terza edizione, quindi a fine Seicento (1691). Questo per dire che ci vuole un secolo dopo la morte di Tasso perché questo veto posto da Salviati venga annullato.
Per quanto riguarda le innovazioni tra le varie edizioni della Crusca la cosa più importante è l’aumento di lessico scientifico dal 1612 al 1691. Già nella seconda edizione del ’23 probabilmente qualcosa entra con Galileo. Sicuramente avrà a che fare con la terza edizione del ’91, perché due suoi discepoli, Redi e Magalotti, partecipano alla redazione.
Spendiamo anche qualche parola sull’opposizione alla Crusca, perché non tutti sono contenti quando esce il vocabolario. Addirittura nello stesso anno di pubblicazione esce il libro di Paolo Beni “L’anticrusca”. Lui aveva scritto un libro contro alcune riprese che erano state fatte, cioè la modellizzazione dello stile di Boccaccio. Era un libro contro la lingua di Boccaccio, però poi quando esce il vocabolario della Crusca, vista la grande presenza di Boccaccio, decide di chiamarlo “Anticrusca”. Leggendolo ci si accorge che non parla quasi per niente della Crusca. Il vocabolario della Crusca rimane comunque il primo vocabolario in area europea.
Alessandro Tassoni (modenese che vive a cavallo tra Cinquecento e Seicento), autore della “Secchia rapita”, fu un altro oppositore alla Crusca. Lascia degli appunti in cui se la prende con l’arcaismo della Crusca. Sono presenti troppo arcaismi inutili. Se proprio ce li dovete mettere, dice lui, almeno contrassegnateli in qualche modo. Infatti nelle edizioni successive ne troviamo meno e contrassegnate con V.A. (voce antica).
Tra i contestatori della Crusca, Daniello Bartoli, un gesuita autore di opere importanti, noto per una strana operina “Il torto e il diritto del non si può” che è un’opera di argomento grammaticale in cui protesta contro il fatto che le regole grammaticali non sono sempre delle vere regole. A volte quando i grammaticografi prescrivono l’uso di alcuni elementi linguistici lo fanno a torto perché in realtà sono delle possibilità che rientrano nella legittima libertà dello scrivente. In realtà per quanto sia di solito inserito tra gli oppositori della Crusca, non la critica direttamente. Sicuramente ha una posizione distante da quella dei cruscanti. I gesuiti erano comunque famosi per la prosa. Leopardi per esempio ritiene Bartoli il più grande autore di prosa.
Il linguaggio scientifico di fatto ancora a inizio Seicento era in latino. La lingua con cui si scriveva di scienza era il latino. Soltanto nel Seicento ci sono i primi tentativi di scrittura scientifica in lingua volgare. Leibniz non scrive mai nella sua lingua (il tedesco) opere scientifiche e filosofiche, scrive sempre o in latino o in francese. Mentre Cartesio scrive sia in latino che in francese, che era la sua lingua. Il tedesco non aveva ancora una rilevanza tale per questi scopi. Galileo in modo molto innovativo inizia a usare il fiorentino per le sue opere scientifiche. Non lo usa per tutte. Il Sidereus Nuncius è in latino. Le due opere per cui è maggiormente conosciuto sono in toscano: Il saggiatore e Il dialogo sopra i due massimi sistemi.
Alcune cose importanti su Galileo: se si fosse astenuto da scrivere in volgare, soprattutto un’opera come il Dialogo con cui confutava il sistema tolemaico a favore di quello copernicano, sarebbe stato lasciato in pace e non sarebbe stato costretto all’abiura delle sue idee. Spesso si dice non senza qualche ragione che se Galileo avesse scritto le stesse opere in latino, l’Inquisizione e la Chiesa romana non lo avrebbero perseguitato.
Per quanto riguarda il lessico scientifico esistono due modalità per coniare nuovi termini scientifici:
- rideterminazione semantica (prendo una parola di lessico comune e la ridefinisco, seguendo un accordo con il lettore);
- coniare nuovi termini usando basi latine
Galileo, per la fisica meccanica, ridetermina semanticamente. Prendiamo per esempio “forza”, “movimento”: sono parole comuni che prese in ambito scientifico hanno un significato specifico. Questo non fu il metodo che prevaleva. La procedura destinata a prevalere era quella di coniare nuovi termini usando basi latine.
Sappiamo che Galileo ha inventato il telescopio. In realtà, diciamo che non è del tutto vero perché Galileo sfrutta un sistema che era già stato escogitato in zona fiamminga di cui però lui aveva intuito la potenzialità scientifica. Dal punto di vista del lessico, Galileo in latino non ha problemi (perspicillum), invece in volgare lo chiama “cannone” o “occhiale”. A quanto pare, non Galileo ma un altro studioso (Biancani) usa la parola “cannocchiale”. Questa strana parola è quella che prevale in italiano, anche se Galileo non la usa mai.
Ancora più interessante è il fatto che a prevalere non è nemmeno cannocchiale, ma telescopio. Noi quando diciamo cannocchiale non intendiamo l’invenzione di Galileo. Telescopio è un latinismo (telescopium) formato da elementi greci. Così compare nei primi testi che loro usano. Da un certo punto in poi inizia ad essere usata anche l’italianizzazione di questo termine, Galileo stesso la userà nei suoi scritti. Dal Settecento in poi i termini scientifici vengono coniati utilizzando latinismi o grecismi (ancora di più dei latinismi). Il nuovo lessico scientifico entrerà gradualmente anche nella letteratura.
Un’altra cosa fondamentale che accade nel Seicento è la nascita del melodramma. La data che si prende arbitrariamente per far iniziare il melodramma è il 1600 con l’Euridice di Peri, su libretto di Rinuccini. Quello che conta è che questa nuova modalità che poi diventerà decisiva nella storia dello spettacolo successivo, nasce in modo molto singolare. Vede la luce come un’iniziativa fondamentalmente di élite presso un entourage sempre fiorentino, che è la Camerata dei Bardi, con la quale aveva a che fare il padre di Galileo, Vincenzo Galileo. In questo contesto nasce il primo melodramma. La nascita del melodramma ha una base colta, perché quello che vogliono fare questi intellettuali è provare a rifare la tragedia greca, nella quale la musica aveva una grande importanza. Nei primi melodrammi seicenteschi, tra cui spiccano quelli di Monteverdi, il linguaggio verbale ha una rilevanza maggiore rispetto a quello che avrà nei due secoli successivi. Di Monteverdi ci sono rimasti solo tre melodrammi, anche se ne ha fatti più. Molto belli sono anche i suoi madrigali, per esempio Il combattimento di Tancredi e Clorinda.
Per molto tempo l’italiano rimane una lingua fondamentale per il melodramma. Nel Settecento nei paesi di lingua tedesca i melodrammi avranno un testo in italiano. Un esempio celebre è l’opera di Mozart su libretto di Da Ponte. Lo stesso Metastasio faceva il librettista a Vienna in italiano.
Nel Settecento a livello europeo acquista grande importanza il francese. Già ai tempi di Re Sole diventa la lingua dominante nel continente europeo, ruolo ricoperto dallo spagnolo nel Cinquecento. Le altre lingue europee non avevano grande rilievo. L’inglese come al solito è ancora abbastanza confinato alla sua vocazione insulare. Per quanto ci sia un’importante stagione di romanzo borghese, gli altri europei non lo leggono in inglese bensì nelle sue traduzioni in francese. Se una persona si recava a Vienna alla corte degli Asburgo, poteva essere capita con l’italiano, meglio ancora con il francese, non c’era bisogno di sapere il tedesco.
Questa cosa aumenta ancora di più nel Settecento con l’Illuminismo. Un’opera importantissima che è l’Encyclopedie di Diderot e D’Alambert viene stampata ovunque in francese, anche perché è un’opera molto difficile da tradurre. Questo fa sì che aumenti ancora di più la diffusione del francese. Questo aumenta anche la convinzione dei francesi che la lingua francese rispecchi al meglio il pensiero, come lingua della logica e della chiarezza. Viene quindi contrapposta allo spagnolo e all’italiano. La vera lingua della ragione è il francese. Questa tesi non è sciovinista, fu presentata dall’illuminista Rivarol, che scrisse una memoria che presentò all’Accademia di Berlino in francese: Dell’universalità della lingua francese. Il francese veniva contrassegnato come lingua universale per la sua naturale chiarezza. La linearità della sintassi del francese era una conseguenza della storia del francese perché fu una lingua molto parlata, mentre l’italiano è una lingua più scritta, perché oralmente venivano utilizzati i dialetti. Da molti questa veniva considerata una superiorità della lingua francese sulle altre.
A questo ragionamento si oppose Melchiorre Cesarotti, il più grande pensatore italiano sulla lingua. Scrisse un testo che non ebbe un grande successo, Saggio sulla filosofia delle lingue, con varie edizioni, testo di fine Settecento. Cesarotti, sia da una prospettiva storica che filosofica, dice che nessuna lingua nasce barbara, ma nascono tutte rozze e meschine, e poi si raffinano con il tempo. Questo è contro una tesi che veniva dal Quattrocento e Cinquecento che l’italiano fosse una corruzione e un imbarbarimento del latino, con l’influsso dei barbari che avevano occupato l’Italia.
Cesarotti sosteneva contro la purezza: nessuna lingua è pura. Questo dava contro alcune tesi antiche sulla perfezione e la purezza del latino o dell’ebraico biblico, o sulla presunta superiorità del francese.
Le lingue nascono non da un piano razionale ma tutte nascono dal caso. Questa è una posizione molto moderna e illuminista. È una posizione implicitamente antiteologica. Nessuna lingua fu coniata. Le autorità a livello linguistico non servono a niente. Le autorità non ha senso che impongano un modello linguistico. “Libero e non espresso consenso del maggior numero”: il signore della lingua è l’uso, è l’uso che decide cosa è grammaticale e cosa no. Qui c’è una tesi molto avanzata: quando la maggior parte del popolo, o se non altro degli scrittori e del popolo, comincia a usare una certa parola o una certa costruzione, questa cosa piano piano si affermerà.
Altro elemento molto interessante è che nessuna lingua è perfetta, perché è un prodotto tipicamente umano. Come per altre questioni tipicamente umane, ciascuna lingua non è mai talmente ricca da non potersi arricchire. Questo è importante perché nello stesso periodo c’è un atteggiamento di forte condanna da parte dei puristi nei confronti dei prestiti dal francese. Pure Macchiavelli dice che la ricchezza della lingua sta nel saper accogliere parole di altre lingue e saperle accogliere.
Nessuna lingua è inalterabile, le lingue cambiano continuamente. Nessuna lingua è parlata uniformemente dalla nazione.
Una tesi caratteristica di Cesarotti paga pegno a un tema tipicamente settecentesco e ottocentesco che è quello del genio della lingua, che contraddistingue le varie lingue. Questa del genio della lingua non sembrerebbe nelle corde di Cesarotti, cioè che ci sia questa forte distinzione data dal genio che detta le caratteristiche di una lingua. Cesarotti lo risolve attraverso una distinzione tra qualcosa di più presente nella lingua da qualcosa di più variabile. L’elemento più stabile è quello che lui chiama “genio grammaticale” distinguendolo da elementi più propriamente stilistici che possono essere variabili storicamente. Quest’altra caratteristica la chiama “genio retorico”, quello che consente le variazioni storiche e individuali.
Da parte di Cesarotti ci sono anche delle proposte operative. Non ammette che la Crusca come istituzione possa esistere, però crede che possa esserci un Consiglio Nazionale per la Lingua. Questo consiglio non deve stabilire delle regole, ma deve essere un luogo in cui si esamina il lessico, fornendo suggerimenti e creando vocabolari. Se c’è una cosa che possiamo dire, la sede dovrebbe essere a Firenze anche per Cesarotti, infatti egli non sostiene una polemica anti-fiorentina.
Per quanto riguarda il Settecento dobbiamo dire ancora qualcosa sul linguaggio teatrale. In particolare, è opportuno parlare del teatro di Goldoni. Il suo teatro apparentemente non è particolarmente assillato dal problema della lingua. Le sue commedie hanno una lingua che passa da un italiano comprensibile per piegare talvolta verso il dialetto veneziano, che tenta però di essere comprensibile anche ai non veneziani (a parte alcuni casi). La tradizione della commedia dell’arte presentava parti in diversi dialetti che dovevano essere comprese da un pubblico variegato. Goldoni a un certo punto proprio nel presentare una raccolta delle proprie opere, parla della lingua da lui usata. Dottore nella tradizione si esprimeva in bolognese, mentre nelle opere di Goldoni si esprime in italiano. Le cose poi possono variare molto a seconda delle commedie, a seconda se siamo in presenza di testi che oscillano verso l’italiano o verso il dialetto (di Chioggia per esempio). Complessivamente si tratta di una lingua che ha lo scopo della comprensività. Per fare questo Goldoni non ha mai potuto operare una mimesi nei confronti della lingua volgare parlata, ma la sua è un’opera di costruzione per il teatro (“fantasma scenico”, come lo chiama Gianfranco Folena). È una creatura che non è mai esistita nella realtà, ma solo nell’ambito teatrale. Goldoni passa l’ultima parte della sua vita in Francia e scrive delle opere in francese, tra cui le sue Memorie (un francese un po’ sgrammaticato).
Un altro tema a cavallo tra Settecento e Ottocento è quello del cosiddetto purismo. Il purismo è un atteggiamento ostile alle innovazioni nella lingua, ostile agli influssi da parte delle altre lingue. Era un atteggiamento tipico già di alcuni gruppi, tipo Salviati e la Crusca. Come fenomeno storico però esplode alla fine del settecento e inizi Ottocento, anche come reazione alla grande influenza del francese che si trovava in Italia e non solo.
Antonio Cesari è un autore di libri religiosi, di studi danteschi, ma soprattutto è uno studioso che fa una specie di edizione pirata del vocabolario degli accademici della Crusca, che non si può considerare come una quarta edizione dello stesso. Ma si può considerare come un aggiornamento, con un’aggiunta. Cesari continua la tradizione del conservatorismo e del toscanismo che già avevano caratterizzato la Crusca, aggiungendo un tratto di ossessivo rifiuto del nuovo e del diverso. L’unico modo secondo Cesari è restaurare la lingua trecentesca.
Basilio Puoti, maestro di Francesco de Sanctis, fu più moderato. Questo tipo di atteggiamento provocò delle reazioni. Uno dei più famosi a reagire contro queste posizioni così estreme fu Vincenzo Monti, che aveva una posizione di tipo neo-classicista. Riteneva queste posizioni insopportabili. “Gran muffa stronzolo” chiamava così Cesari. Monti fa un lavoro di proposte di correzioni al vocabolario della Crusca scrivendo parecchio di questioni lessico-grafiche.
In questo dibattito intervenne Stendhal, autore del Il rosso e il nero, La Certosa di Parma, uno dei più grandi scrittori mondiali dell’Ottocento. In quel momento si trovava a Milano, città che lui amava molto. Stendhal, sconcertato da queste posizioni, scrive un testo che rimane inedito, che si intitola Dei rischi e dei pericoli della lingua italiana, ispirato al sensismo francese e alle teorie illuministe di Condillac. Accusa la follia di queste tesi puristiche e mostra che l’uso di una lingua così “pura” è disastrosa per poter scrivere testi interessanti. Dice che nessuno nel passato aveva questo atteggiamento, nessuno tra i grandi autori scriveva con una lingua vecchia e imbalsamata di secoli.
Questo problema fu preso di petto e affrontato da quello che non possiamo non ammettere sia stato il più grande autore dell’Ottocento italiano, Alessandro Manzoni. Manzoni ha avuto il problema della lingua per tutta la vita e ci si è dedicato. Oltre che con i Promessi Sposi, lo affrontò anche con altri scritti rimasti inediti fino alla sua morte e oltre. Fin dal 1821, Manzoni matura l’idea di questo romanzo storico. È profondamente insoddisfatto fin da subito. Nel 1823 è pronta la prima edizione del Fermo e Lucia che non venne mai pubblicata. Manzoni non è soddisfatto di questo testo e i motivi della sua insoddisfazione sono di tipo linguistico. Nel Fermo e Lucia, Manzoni ha usato un linguaggio letterario pieno di lombardismi, toscanismi, latinismi e francesismi. Egli non sentiva questo linguaggio come naturale, anzi gli sembrava libresco.
Manzoni dice che scrive male, ma non è colpa sua, bensì della lingua a sua disposizione. Manzoni aveva a disposizione il dialetto (sua lingua nativa), il toscano letterario, il francese. La lingua che riesce a usare è il milanese e c’è una sola lingua più bella che è quella toscana. Manzoni sa che per quanto riguarda la lingua toscana non c’è un modello della lingua parlata recente che sia soddisfacente per scrivere un romanzo. È tutt’altro che una curiosità uno dei tanti dizionari postillati da Manzoni. Manzoni scrive delle note accanto alla Crusca veronese di Cesari. Manzoni scrive che quello che è stato redatto da Cesari non ha nulla a che fare con la lingua toscana parlata in quel momento.
Manzoni cerca di rivedere il Fermo e Lucia. Fa un’opera di revisione attraverso una serie di foglietti. Gli studiosi riescono a riscostruire due edizioni del Fermo e Lucia (la prima minuta e la seconda minuta). Però non è soddisfatto quindi inizia a scrivere un altro romanzo, che riprende i temi del primo. Tra il 1824 e il 1827 viene pubblicata la ventisettana, che è la seconda edizione dei Promessi Sposi. Ci sono dei cambiamenti a livello di contenuto: viene estrapolata la parte della colonna infame e vengono ridotte le parti su Gertrude. A noi interessano le modifiche linguistiche. Manzoni cerca di sostituire quel “composto indigesto” fatto di tante lingue e cerca di ricorrere a quegli elementi che possono riprendere la lingua parlata (fase lombardo/milanese-fiorentina). Manzoni che all’epoca è ancora a Milano, cerca di leggere quei testi della tradizione toscana che sono più lontani dai testi aulici della tradizione trecentesca (cronisti, ecc.). Fa poi uno sforzo enorme con i dizionari, soprattutto con il vocabolario della Crusca nell’edizione veronese del Cesari e con il vocabolario milanese italiano del Cherubini (1814). Il problema del Cherubini per esempio è che per quanto sia abbastanza affidabile sul dialetto, tende a riportare le definizioni delle parole dal dialetto milanese a un dialetto toscano abbastanza imbalsamato. È una cosa che ritroviamo più o meno in tutti i dizionari dialettali ottocenteschi (anche quello Genovese del Casazza). All’epoca non erano ancora usciti i dizionari del fiorentino vivo (Petrocchi, Rigutini-Fanfani, Giorgini-Broglio), operazioni che avvengono a seguito della spinta manzoniana. Quindi Manzoni si deve limitare a quello che c’è. Il risultato nell’edizione ventisettana è un linguaggio troppo letterario e lontano dall’uso, o se non letterario un fiorentino troppo basato sulle locuzioni trovate nei libri e nei dizionari. C’è da dire che l’edizione ventisettana ha un grande successo di pubblico, addirittura il profitto fu maggiore della edizione quarantana (prima edizione dei Promessi Sposi come li conosciamo noi). Manzoni era insoddisfatto anche di questa edizione.
Fin da subito, decide di andare a fare delle vacanze studio a Firenze, il processo chiamato “risciacquare i panni in Arno”, cioè avere un rapporto più diretto con le fonti di oralità della lingua parlata a Firenze in quel momento e metterlo per iscritto nel suo romanzo. Quindi Manzoni riprende a scrivere in contatto diretto con la lingua fiorentina viva. Manzoni è soddisfatto nel sentire il fiorentino vivo, che ha un altro effetto. Interroga tutti i suoi amici fiorentini e la sua governante fiorentina, Emilia Luti. Tutto questo lavorio sul campo porta poi all’edizione dei Promessi Sposi che noi leggiamo, la cosiddetta quarantana, che esce a dispense come la ventisettana (1840-42). Manzoni vuole proprio creare un modello. I Promessi Sposi escono in 108 edizioni illustrate (illustrazioni di Francesco Gonin). L’opera ira in 10mila copie. Anche se ha un successo di mercato inferiore all’edizione ventisettana.
I Promessi sposi hanno importanza incalcolabile non solo per la lingua del romanzo, ma anche per la storia dell’italiano, per lo meno per l’italiano scritto. Fissa una svolta. Ci saranno alcuni fautori di Manzoni che proporranno la lingua di Manzoni come base, tipo De Amicis.
Passiamo alla Relazione del 1868: Manzoni nel 1868 ha la sua bella età (83 anni). È un uomo piuttosto importante, è senatore nel Regno di Italia. Il ministro Broglio, con il quale Manzoni aveva anche relazioni personali, gli chiede di scrivere un testo su una questione di fondo, cioè su cosa bisognava fare con l’italiano a scuola (primaria). Broglio gli chiede di fare una specie di prontuario su cosa sarebbe opportuno fare. Manzoni fa una proposta. Intanto pone come modello il fiorentino vivo. Propone che si faccia un vocabolario della lingua italiano basato sull’uso del fiorentino vivo e propone che affianco a questo vocabolario vengano fatti una serie di vocabolari bilingui tra i dialetti e il toscano. Questo è un’operazione un po’ difficile. C’erano dei dizionari bilingui, ma questo esisteva solo per i grandi dialetti di tradizione cittadina, non esistevano per i dialetti meno parlati.
L’altra cosa che propone è di usare degli insegnanti che secondo lui devono essere madrelingua toscana o che hanno fatto un training a Firenze o dintorni, come aveva fatto lui. Questo aveva senso perché molti maestri della scuola elementare non avevano padronanza dell’italiano, ma insegnavano in dialetto.
Questa soluzione aveva il merito della chiarezza. Va detto però che si trattava di una soluzione presa a tavolino, non facile da attuare, molto calata dall’alto che non prendeva in esame l’aspetto sociale che c’era dietro l’unità linguistica che mancava. Questa imposizione dall’alto di un modello poteva risultare un po’ difficile e per certi versi inopportuno. Ci furono posizioni filo-manzoniane, ci furono posizioni avverse a Manzoni.
Dopo l’unità d’Italia si è cercato di unificarne enormemente la lingua degli italiani. I fattori dell’unificazione linguistica sono stati:
- abbandono delle campagne e successiva urbanizzazione del Paese;
- diffusione della burocrazia statale;
- aumento della scolarizzazione;
- leva militare obbligatoria;
- nascita e sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa.
Questi sono i fattori di unificazione linguistica, di fatto quelli che concludono la storia della lingua, prima dell’italiano contemporaneo. Questi fattori portarono a un’unificazione dell’italiano, che si ottenne negli anni ’60 e ’70 del Novecento.
Bibliografia
- G. Inglese, Come si legge un’edizione critica. Elementi di filologia italiana, Roma 2003;
- C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Bologna 2004;
- B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano 2007;
- G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna 2002;
- L. Serianni (a cura di), La lingua nella storia d’Italia, Roma 2001;
- L. Serianni, La lingua poetica italiana, Roma 2018;
- L. Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma 1998;
- L. Serianni, Prima lezione di storia della lingua italiana, Roma-Bari 2015;
- L. Serianni, G. Antonelli, Manuale di linguistica italiana. Storia, attualità, grammatica, Milano-Torino 2011;
- A. Stussi, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna 2006;
- A. Stussi, Breve avviamento alla filologia italiana, Bologna 2009.
Immagini liberamente acquisite sul web