Tale padre tale figlio. Da Pierre a Justin: dagli omosessuali ai transessuali, e via continuando
Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, è un intemerato e celebrato condottiero nella crociata per la difesa della comunità Lgbtq+, incalzata da presso – secondo la vulgata del “wokismo” – dalle forche degli omofobi e transfobici che sarebbero moltitudini nel nostro Occidente.
Fu il padre di Justin: Pierre Trudeau, che da primo ministro del Canada introdusse nel 1968 un progetto di legge, poi adottato, a favore degli omosessuali. È sua la frase, divenuta celebre in Canada: “Noi non invieremo la polizia nelle camere da letto per vedere cosa succede tra adulti maggiori, consenzienti, in privato. […] Noi estromettiamo dal Codice Penale l’idea del peccato.” Ma l’idea del peccato, da allora, ha fatto un enorme balzo in avanti lasciando alle spalle la camera da letto: sono considerati peccatori, oggi, quelli che si dimostrano timidi nell’applaudire la comunità LGBTQ+ che si arricchisce continuamente di nuovi attivisti. Oggi, solo a dichiararsi indifferenti alle fantasie e pratiche sessuali altrui si diviene individui sospetti, passibili di messa al bando dal consorzio civile.
È un nuovo culto direi obbligatorio del diverso, orgoglioso di esserlo e che celebra questo orgoglio nelle gay parade, cosi’ simili alle processioni che un tempo avvenivano dietro il santo patrono o altri santi. Ma, a differenza di allora, nei confronti di questo nuovo culto moderno delle preferenze sessuali, l’agnosticismo non è tollerato: occorre applaudire. A fare poi dell’ironia su questi nostri nuovi santi, come sto facendo io, il rischio è alto. Ma dopo aver trascorso una vita lavorativa nelle biblioteche a Montréal, in cui i clan omosessuali maschili e femminili erano ben presenti ed attivi, posso testimoniare che in quell’ambiente questi diversi, lungi dall’essere perseguitati, si trovavano a loro agio; ed anzi, molto abili nelle alleanze e nelle strategie, spesso menavano addirittura il ballo.
In Canada, del resto, l’essere umano ha ormai il diritto di dichiararsi uomo o donna a prescindere dal sesso biologico in cui è nato. E se noi facciamo un uso sbagliato di grammatica e vocabolario, rivolgendoci o riferendoci a una tale creatura, rischiamo d’incorrere nel reato di transfobia.
Molto lungo, quindi, il cammino da allora percorso dai diversi, gruppi che spero s’ingigantisca fino ad includere tutti i diversi, nessuno escluso, senza preferenze cioè per certe scelte sessuali minoritarie, a danno di quelle maggioritarie. Scelte che dovrebbero rimanere un fatto privato e non un titolo di credito da presentare all’incasso contro di noi, per le situazioni di cui i “diversi” furono vittime nei secoli passati. O se non altro non nei confronti di chi, come me, non ha mai provato sentimenti di disprezzo verso di loro, pur giudicando che certi tratti della loro diversità, per molti di loro, investe il loro intero essere, e non rimangono circoscritti a quella camera da letto di cui parlava Pierre Elliott Trudeau, primo ministro del Canada del tempo; e dalla quale gli omosessuali e gli altri della comunità Lgbtq+, sono usciti in massa, vocianti e anche aggressivi, innalzando cartelli di protesta e rullando i tamburi.
L’identità di genere e i reati linguistici in Canada
Oggi, in molti paesi, l’essere umano ha il diritto di dichiararsi uomo o donna a prescindere dal sesso biologico in cui è nato. E se facciamo un uso sbagliato di grammatica e vocabolario, rivolgendoci o riferendoci a una tale creatura, rischiamo d’incorrere nel reato di transfobia.
Da un quotidiano di Montréal: “Mégenrer est une violation des droits de la personne, tranche une Cour canadienne”. “Mégenrer”, in inglese “misgender”, vuol dire “riferirsi a qualcuno (soprattutto transgender ossia transessuale) usando parole, pronomi o appellativi che non riflettono il genere nel quale la persona si identifica. L’azione può essere volontaria o accidentale.”
La vittima del reato linguistico, sanzionato dal giudice canadese, è una persona “non binaria” e “gender fluid” che aveva denunciato al Tribunale dei diritti della persona della Columbia Britannica i proprietari del ristorante in cui lavorava. Questi sono stati giudicato responsabili, tra l’altro, del fatto che i colleghi della persona transgender usassero, talvolta, i termini sbagliati (parole, pronomi, appellativi), parlandole/gli. E sono stati condannati a 30.000 dollari di risarcimento. Rivolgersi a chi si sente maschio, ma è nato femmina, usando il pronome femminile è “offensivo, degradante, e riduttivo” ha stabilito il tribunale.
Mi asterrò dal fare del sarcasmo, perché io capisco il dramma di chi è “transgenere” (transgender). La complicazione per tutti noi, ben decisi a non violare i diritti dei “trans”, nasce dal fatto che chi ci appare donna, può sentirsi invece uomo, e chi ci appare uomo, può sentirsi donna. Ma la casistica è ancora più complessa…
La nuova sensibilità alle questioni d’identità di genere ha fatto sì che vi sia una crescente opposizione alla regola grammaticale che vuole che il maschile prevalga sul femminile. Nella nostra grammatica “studenti” include “studentesse”. In nome dell’uguaglianza dei sessi, alias generi, la lingua ufficiale di certe istituzioni è diventata “bisessuale” obbligando gli addetti, quando redigono una lettera o un documento, a ripetere ogni volta il sostantivo e l’aggettivo sia al maschile sia al femminile. Qualcuno usa ormai il linguaggio “schwa” o “scevà”, adatto a indicare un genere indistinto. Dal dizionario Treccani: “Scevàs. m In glottologia, termine col quale si indica una vocale di timbro indistinto (vocale neutra), di quantità ridotta, di scarsa sonorità e scarsa tensione articolatoria, graficamente rappresentata dai glottologi con il segnoə.” Altri troncano le lettere finali della parola e vi mettono un asterisco, la cui funzione è di includere il maschile, il femminile e il “transgenere”. Alcuni propongono il segno neutro “u”. E ciò per rispetto della “comunità” LGBDQ+, che altrimenti si sentirebbe esclusa. Suggerisco il sito https://www.transmediawatchitalia.info/linguaggio-neutro-inclusivo/ per vedere i piani di lavoro di uno degli artigiani stakanovisti di questo letto di Procuste linguistico.
L’uso del termine “donna” è inviso ai guardiani della “political correctness” poiché trascura la varietà e la fluidità dei “generi”. La British Medical Association suggerisce, pertanto, di usare l’espressione “persone incinte” invece di “donne incinte”. In uno scritto scientifico si è parlato del diritto delle “persone” (“people”) all’aborto. Lo si è fatto per rispetto di quegli esseri che anatomicamente non potranno mai avere una gravidanza, poiché sono nati uomini, o quasi uomini, ma si considerano ormai donne. “Bodies with vagina”” è stata l’espressione usata in copertina dai redattori della rivista medica Lancet. Usando il termine “corpi con vagina”, al posto di “donne”, la rivista Lancet ha voluto significare che si può essere donna anche senza avere la vagina.
Non so se voi avete capito la logica della messa al bando di “donna”. Io ci ho messo un bel po’ prima di capire…
In questa nuova realtà alla Eugène Ionesco vi è l’attacco di una ridottissima minoranza, degna comunque di ogni rispetto, al vocabolario usato da un gruppo infinitamente maggioritario. La political correctness, infatti, intende instaurare una utopia-distopia transessuale, esaltante il neutro e con un programma di uguaglianza da attuare a tutti costi, forse anche attraverso i tribunali del popolo.
È venuto forse il tempo di dire – tra mille cautele– alle donne nordamericane, sia le vere sia le presunte, di non usare più quel sadomasochistico “Hey guys!” quando si rivolgono alle “sorelle”. Dopo tutto, “guy” è un termine maschile e si riferisce all’orribile uomo che le ha martirizzate nei secoli, imponendo loro, per soprammercato, un vocabolario sessista. Che però, ormai, sembra avere i giorni contati…
Un multiculturalismo di Stato in cui sono attivi i nazionalismi stranieri
La stampa canadese ha dato ampio spazio al forte contrasto sorto di recente tra il Canada e l’India.
L’indo-canadese Hardeep Singh Nijjar, appartenente al movimento separatista Sikh che si batte per l’avvento di un futuro stato sovrano chiamato Khalistan, fu ucciso – era il 2019 – all’esterno di un tempio Sikh della Columbia Britannica. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha accusato ultimamente il governo indiano di essere coinvolto in quell’atto terroristico. Harjit Sajjan, ministro canadese dell’“Emergency preparedness”, è intervenuto fornendo precisazioni circa le accuse mosse all’India.New Delhi ha rabbiosamente smentito, mettendo in crisi le relazioni diplomatiche con il Canada.
Harjit Sajjan è un Sikh, come il defuntoHardeep Singh Nijjar, eostenta orgogliosamente i contrassegni nazional-religiosi che tutti noi conosciamo: il tipico turbante e una barba cespugliosa.
Si è molto discusso sull’infantilismo e la goliardia di Justin Trudeau dopo la scoperta che il nostro primo ministro aveva impersonato, da giovane, personaggi di origine africana colorandosi il viso di nero e indossando gli abiti “appropriati”. Lo faceva per divertimento, senza essere sfiorato dal dubbio circa il cattivo gusto di simili comportamenti. Si è giustificato così: “Non mi rendevo conto del significato di una faccia bruna o nera.”
Questa maniera di agire e di pensare del seducente Justin Trudeau ci permette di capire un aspetto particolare del suo carattere, del suo spirito, della sua sensibilità; e della sua faciloneria. Eppure, anche prima che venissero alla luce questi suoi trascorsi goliardici nei confronti dei neri non erano mancate le occasioni che ci avrebbero dovuto far cogliere certi aspetti particolari del suo mondo di valori, del suo credo.
A farmi capire il vero Justin Trudeau è stato il comportamento da lui tenuto nel corso di un suo viaggio in India, dove il nostro primo ministro, in visita ufficiale, ha dato veramente spettacolo di sé. Senza avvertire il ridicolo di certi suoi abbigliamenti, si presentava ogni volta ai suoi anfitrioni locali con indosso il colorato, sontuoso, elaborato abito cerimoniale della particolare regione indiana in cui si trovava, come se si stesse recando a una recita “bollywoodiana”.
Trudeau è un entusiastico sostenitore del mondialismo e del multiculturalismo di Stato, tanto da aver nominato come ministro canadese della difesa un Sikh con turbante, Harjit Sajjan (gia’ citato, divenuto poi il ministro canadese dell’“Emergency preparedness”) appartenente alla casta superiore Jatt; la casta guerriera che sia in Punjab sia in Canada è in posizione dominante sul resto della comunità “Punjabi”. Per Trudeau, evidentemente, il turbante e la maniera particolare di vestirsi dei Sikhs canadesi sono semplice abbigliamento. Invece riflettono un’identità etnica, religiosa, nazionale ben particolare. Ma semplice abbigliamento erano per lui anche gli elaborati costumi tradizionali che aveva voluto di volta in volta indossare, insieme con la consorte e i figli, durante quel suo viaggio ufficiale in India.
Vi è chi non vede che una bandiera non è solo colori e che un semplice drappo può avere un fortissimo significato simbolico. In India, Trudeau aveva mostrato certi gravi limiti credendo infantilmente che anche gli altri, le popolazioni visitate, fossero come lui. E travestendosi quasi celebrasse un carnevale non rispettava il detto “Scherza coi fanti ma lascia stare i santi”, perché gli abiti tradizionali esprimono una forte identità collettiva, ossia un’appartenenza, una comunanza, una fratellanza basate su un passato condiviso da non prendere alla leggera. Ma l’angelico e disarmante Trudeau, negli abiti tradizionali, che ogni volta rivestiva visitando questa o quella regione dell’India, non vedeva la maniera di essere, il passato, l’identità di etnie spesso in conflitto tra loro e provviste, ciascuna, di un forte sentimento di appartenenza e di orgoglio.
Si direbbe che a un Trudeau fortemente mondialista e antisovranista, esaltatore dei diritti individuali, i valori collettivi dicano assai poco. Il passato nazionale, invece, pesa fortemente sugli individui che si identificano con una terra particolare: la patria, grande o piccola ch’essa sia. Comprensibili quindi le critiche che su Trudeau piovono dagli ambienti patriottici del Québec, i quali vedono che il principio dei due popoli fondatori, un tempo in auge, è stato fatto a pezzi da un multiculturalismo che vede i “francesi canadesi” ridotti al rango di semplice tessera del colorato mosaico confederale. La giornalista Denise Bombardier è stata molto diretta: Justin Trudeau “ha trasformato la società canadese in una avanguardia mondiale del multiculturalismo angelico.” E ancora: il primo ministro canadese è “l’inventore del paese post-nazionale”.
La tragedia degli aborigeni canadesi
Nel corso del suo periplo in Canada, nel 2022, Papa Francesco ha chiesto scusa a diverse riprese per il comportamento di certi indegni membri della Chiesa nelle scuole-convitto create per figli degli autoctoni, strappati alle loro famiglie. E, addolorato, ha chiesto perdono anche per la distruzione culturale e l’assimilazione forzata di questi giovani.
Basteranno queste scuse alle Prime Nazioni del Canada?
La visita del papa è stata vista da loro come un inizio, e non come una conclusione. Lo stesso ministro canadese delle “Relazioni Corona-Autoctoni”, Marc Miller, ha detto che la peggior cosa sarebbe non fare nulla dopo il viaggio storico del Papa in Canada. E assai simile al suo è il giudizio della maggioranza degli stessi aborigeni, che aspettano, come dire, un risarcimento per i torti subiti ad opera dei colonizzatori.
Il tema è troppo complesso per poterlo presentare in qualche riga. Inoltre è un tema controverso. Farò solo un accenno a certe voci dissonanti rispetto alla recitazione corale del “confiteor” nei confronti dei nativi canadesi.
I loro leader non sono sempre un modello di virtù.
Il termine “genocidio”, relativamente alla disfatta della cultura dei popoli aborigeni ad opera della cultura europea, al quale i nativi ricorrono, e che è stato usato dallo stesso Papa, non è accettato da tutti. Ad esso alcuni preferiscono “etnocidio”. Altri: genocidio culturale.
Il giornalista quebecchese Christian Rioux (Le Devoir), difensore dei valori tradizionali dell’Occidente, mette in guardia contro chi vuol negare a generazioni intere, in Occidente, “il minimo motivo di orgoglio per una civiltà cristiana che, dopo aver praticato la schiavitù, è stata la sola ad averla abolita.” Gli accusatori dell’Occidente non si rendono conto che si contraddicono, continua Rioux, “poiché non hanno in bocca che i diritti dell’Uomo… invenzione prettamente occidentale, dopo tutto”.
Rioux ci mette in guardia contro il sensazionalismo mediatico, il delirio vittimistico, e “la volontà utopica di pulire il mondo (…) di tutte le sue macchie per renderlo perfetto” come scrive Chantal Delsol.
La Storia “non ha per scopo di confortare né i vincitori né i vinti”, asserisce questo intellettuale, spirito coraggioso e anticonformista.
Christian Rioux cita lo storico francese Frédéric Dorel, il quale si dichiara contro l’uso del termine genocidio, dal momento che “i cattolici videro nell’indiano un dimenticato da Dio da salvare attraverso il battesimo” e non certo da uccidere.
Anch’io sono restio a questo continuo chiedere scusa degli occidentali al resto del mondo. La Chiesa, dopo tutto, ha certamente fatto anche del bene agli abitanti del Canada, aborigeni inclusi. Eppure, nell’intimo, riconosco pienamente la tragedia delle popolazioni indigene canadesi, anche se non è sempre facile indicare i colpevoli delle loro sfortune. E mi sento solidale con loro.
Dai giornali di non molto tempo fa: “I resti mortali di 215 bambini autoctoni ritrovati sul sito di un collegio.” Ma non è la sola notizia di questo genere. Ve ne sono state diverse altre, riguardanti i rozzi cimiteri – di cui non si sapeva nulla – scoperti nelle vicinanze di queste scuole residenziali, sorta di reclusori di rieducazione.
È una grande tragedia che suscita pietà.
Ma vi è stato qualcuno che li ha capiti e li ha aiutati: il nostro John Ciaccia, il quale ha spiegato così il suo desiderio di aiutare i “diversi”: “Crescendo da bambino come italiano canadese mi ero visto negare la mia cultura. Conoscevo tutto dei contrasti e tormenti nei campi da gioco. Stavo forse esprimendo i miei bisogni che proiettavo sui Nativi? Poiché rappresentavo il Governo, io ero il Governo. Mai avrei permesso che ingiustizie simili avvenissero ai Nativi”.
Il Canada e l’internamento degli italiani “enemy aliens”
L’internamento e le ostilità che durante la seconda guerra mondiale tanti italo-canadesi subirono nella loro patria adottiva, perché furono considerati “enemy aliens” (“nemici stranieri”), è una realtà storica ignota ai più. Hollywood non si è mai interessata alla vicenda… Furono oltre seicento i detenuti, ed altri 31.000 finirono sotto la stretta sorveglianza della polizia federale.
Il 27 maggio 2021, il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha presentato le scuse formali per l’internamento e per le ostilità subite dagli italiani in quei lontani giorni. Le sue parole: “Agli uomini e alle donne che sono stati portati nei campi d’internamento o in prigione senza una precisa accusa; alle decine di migliaia d’innocenti italo-canadesi che furono etichettati come ‘nemici stranieri’; ai figli e ai nipoti che hanno portato la vergogna e il dolore della generazione passata; e alla loro comunità che tanto ha dato al nostro Paese, [noi diciamo] ‘ci dispiace’.”
Trudeau ha aggiunto che gli internati non conoscevano quanto sarebbe durata la loro carcerazione, ma che l’impatto di quella condanna, inflitta senza processo, duròun’intera vita.
Il 10 giugno 1940 – entrata in guerra dell’Italia – il sospetto verso i cittadini di origine italiana, visti come sabotatori e spie, raggiunse in Canada il parossismo. Confondendo “italianità” e “fascismo” le autorità canadesi colpirono indiscriminatamente, senza accuse specifiche, senza processi, senza sentenze individuali di condanna. Il tutto si svolse all’insegna dell’arbitrio, tanto che lo studioso Robert F. Harney fa ricorso ai termini “paranoia” e “razzismo”.
Lo spettro della quinta colonna accecò gli animi. Non bisogna però dimenticare che allora, in Canada, il quebecchese Adrien Arcand era un ammiratore di Hitler; e che Camilien Houde, sindaco di Montréal, era decisamente opposto, insieme con tanti altri (incluso il giovane Pierre Trudeau, padre di Justin), alla leva obbligatoria che inviava i canadesi in Europa a combattere per “gli interessi dell’impero britannico”. Qualcuno potrebbe anche dire che di fronte alle morti, al sangue e alle torture che sconvolsero il mondo in quel tempo, l’internamento di un innocente, in Canada – in condizioni sanitarie, di vitto, ecc., tutto sommato più che buone – può apparire poca cosa. Inoltre, i giapponesi del Canada pagarono un prezzo ben più alto del nostro… Lo stesso chiedere perdono per gli errori e gli sbagli storici del passato meriterebbe un approfondimento critico. Mi limiteròa dire, a questo proposito, che chiedendo perdono agli uni si condannano quelli cui non si domanda perdono. E la lista dei candidati meritevoli di perdono è molto lunga, anche in Canada. Questa presentazione di scuse agli italiani ha infatti suscitato l’immediato risentimento degli ambienti nazionalisti del Québec i quali vorrebbero invece da Justin Trudeau le scuse per le misure di guerra adottate, nel 1970, dal padre Pierre, primo ministro del tempo, e che si tradussero nella violazione dei diritti umani di tanti quebecchesi nazionalisti. Io a costoro replicherò che in Québec noi italiani siamo stati il bersaglio per anni di un’attiva, disinvolta, “italofobia”, per la quale mai nessuno ci chiederà perdono. Ed è un’italofobia che ogni tanto riemerge…
La realtà del Québec e del Canada è complessa, ed anche contraddittoria. Dico ciò non per farmi l’avvocato del diavolo né per insinuare dubbi sulla pertinenza ed efficacia di questa richiesta di perdono, ma semplicemente per dire che il Canada, divenuto oggi il campione di un mitico multiculturalismo, può apparire solo da lontano un paese dove si vive da sempre d’amore e d’accordo.
Una cosa è certa: l’internamento dei “pericolosi nemici stranieri” di origine italiana, in dispregio dei diritti fondamentali dell’uomo, non è una pagina gloriosa della storia del Canada. E difatti nessuno studioso si sogna, oggi, di difendere quel triste evento a spada tratta, come invece fanno alcuni studiosi italo-canadesi, di grandi virtù accademiche antifasciste. Per loro, in quei tempi vi fu un temibilissimo pericolo fascista, che non cessano di denunciare a voce e per iscritto. Il punto di vista della maggioranza degli studiosi canadesi può essere invece espresso attraverso le lucide parole degli autori dell’autorevole “The Canadian Encyclopedia” (Edmonton: Hurtig Publishers, 1985. 3 vol.), che alla voce “Italians” ci dicono:
“Come conseguenza dell’alleanza dell’Italia con la Germania nella 2° guerra mondiale, gli Italo Canadesi furono designati ‘enemy aliens’ – ‘nemici stranieri’ – e furono vittime di diffusi pregiudizi e discriminazioni. Molti persero il lavoro, vi furono negozi italiani vandalizzati, le libertà civili furono sospese in virtù del War Measures Act, centinaia di loro furono internati nel Campo Petawawa nel nord dell’Ontario. Mentre alcuni di loro erano stati attivi fascisti, molti non lo erano stati. E questi, come anche le loro famiglie cui fu negata assistenza, pagarono lo scotto dell’ostilità. Come conseguenza, diversi italiani in seguito anglicizzarono il loro nome e tennero nascosta la loro origine.”
Tra gli internati vi fu anche Mario Duliani, autore di “Città senza donne”, libro descrivente la vita degli internati. Un suo compagno di prigionia dà questa spiegazione circa i sentimenti che le notizie di un’Italia nuova, l’Italia fascista, avevano provocato tra le masse degli emigrati: “La trasvolata di Balbo finì coll’ubriacare tutti. Perché negarlo? Già l’intravedevamo più grande, più forte, più rispettata questa nostra vecchia Italia, sì micragnosa un tempo, che ci stava nel cuore come un’indimenticabile madre…”
Duliani, al pari della maggioranza degli Italiani d’America, aveva sperato che l’Italia restasse fuori dal conflitto. Ma, tragicamente, così non fu… E ancora oggi permangono le stigmate di una storica sconfitta che nessun gioco di bussolotti può alterare nella sua drammatica realtà, che sempre peserà su di noi, soprattutto di noi espatriati che viviamo oggi nella casa dei vincitori.
Italia vs Canada
Agitazione vs torpore
Nella Tv italiana l’esagerazione è di casa. Gli episodi di cronaca nera e specie gli omicidi hanno diritto alla grancassa. Se il corpo della vittima – mi scuso per il cinismo – non è stato ritrovato, il telespettatore avrà modo di seguire sullo schermo le operazioni di ricerca, di scavo, di dragaggio. Talvolta per mesi…
L’allarmismo è il fattore chiave della coscienza nazionale degli italiani, i quali sono convinti, dalle Alpi alla Sicilia, che “queste cose succedono solo in Italia”. Grazie quindi al clima “bestiale” e ai tremendi fatti di cronaca nera, che assurgono a eventi nazionali, l’Italia-villaggio riesce ad essere finalmente una.
E il Canada? Il Canada appare un’oasi di pace, anche se il suo indice di omicidi è quasi il triplo di quello italiano. Ma nessuno lo sa… In Canada non esistono fatti di cronaca nera di portata nazionale. Del resto, più di un migliaio di donne aborigene sono potute sparite senza che la stampa se ne interessasse. Nel paese dei grandi spazi e delle vaste province gli episodi di violenza, proprio come il clima, riguardano unicamente gli abitanti della limitata area geografica in cui avvengono. E i giornali e le Tv ne parlano solo se non ne possono veramente fare a meno.
Nella “pacifica” Montréal, il crescente uso delle armi da fuoco con regolamenti di conti e sparatorie varie sembra aver risvegliato le autorità locali dall’abituale letargo. A Toronto, beninteso, avviene di peggio, ma ciò che succede a Toronto riguarda gli abitanti di Toronto. Questa è la logica canadese…
Ma ecco che nel paese del multiculturalismo – dove ogni “comunità” segue avidamente i fatti di cronaca del proprio paese di origine – avviene un episodio di rilevanza nazionale. Julie Payette, un’ex astronauta carica di testosterone divenuta Governatrice generale del Canada, ossia la rappresentante ufficiale di Elisabetta II, ha dovuto dimettersi per le continue vessazioni sfioranti l’aggressione fisica inflitte ai suoi dipendenti. Un fatto isolato nel tranquillo, pacifico, comatoso Canada? Non proprio. La rappresentante, in Québec, della “nostra” sovrana Elisabetta II, Lise Thibault, è stata condannata nel 2018 a un anno e sei mesi di reclusione per una sequela di frodi e abusi commessi durante il suo mandato.
Si direbbe che la Regina non porti fortuna ai Canadesi… Infatti, il colonnello Russell Williams che, carico di onorificenze, pilotava l’aereo canadese di Stato riservato ai vip, inclusi il governatore generale del Canada e il primo ministro canadese, e che aveva trasportato anche la regina Elisabetta II e il Principe Filippo in visita da noi, ha ricevuto nel 2010 una condanna a ben due ergastoli per una serie di aggressioni, stupri e per due femminicidi. Orrido particolare: a questo sadico pluriomicida piaceva mettersi in posa per un autoritratto, con indosso indumenti femminili succinti, accanto alle sue povere vittime. Ma quanti conoscono la storia di Russell Williams?
Questo letargo è forse un bene, perché così il Canada può continuare a godere fama di Paese dove tutti vivono in armonia e dove non succede mai nulla. E noi, all’abituale “Beato te che vivi in Canada!”, potremo reagire con un serafico sorriso di autocompiacimento…
Rapaille e la “Guerre des Glands”
I quebecchesi sono “completamente nevrotici” e con gli inglesi hanno una “relazione sadomasochista”. Questa è la diagnosi dello psicanalista Clotaire Rapaille, il quale ha analizzato l’ambivalente identità quebecchese, dietro compenso di 300.000 dollari.
Rapaille è un esperto mondiale nel campo dell’antropologia culturale, della psicologia dei popoli e del marketing. Ma diciamocelo: anche un dilettante avrebbe potuto formulare un simile diagnosi. Avrebbe potuto farlo basandosi su fatti evidenti, tra cui le indefesse proclamazioni dei quebecchesi: “Siamo troppo buoni! (On est trop gentils!)”, “Gli altri ci tosano e noi li lasciamo fare! (On s’est laissé manger la laine sur le dos!)”, “Gli inglesi ci annegano sotto ondate d’immigranti!”. A cui va aggiunta la perenne ambivalenza nei confronti di Ottawa, vista come un “inferno” ma anche come una capricciosa dispensatrice di diritti e privilegi. Gli stessi leader dell’indipendenza – vedi Bourgault, Parizeau, Lévesque, Bouchard – prima di essere folgorati dalla verità sulla via di Damasco, dimostrarono attaccamento all’identità britannica, pennacchi reali compresi.
Non vale poi la pena addentrarsi nell’abbondante martirologio quebecchese, con la sconfitta delle “Plaines d’Abraham”, la commemorazione dell’impiccagione dei patrioti, le torture subite da Jean de Brébeuf, e la storia di “Aurore, l’enfant martyre”, che hanno formato o piuttosto deformato la sensibilità di stuoli di quebecchesi destinandoli a una vita di lamentele contro gli “altri” e in particolare contro Ottawa, matrigna sadica e capricciosa.
Dopo la trasmissione televisiva “La Guerre des Glands” si è fatto forte in me il desiderio, che naturalmente rimarrà inappagato per mancanza di fondi, d’affidare a Clotaire Rapaille il compito di mettere in luce le radici dello strano rapporto che i franco-quebecchesi hanno nei confronti degli “Italiens” (parola da pronunciarsi atteggiando le labbra a smorfia). Sono sicuro che ne verrebbero fuori delle belle. Il nostro Rapaille non ha certo bisogno dei miei suggerimenti, ma ecco qualche campione d’analisi che io propongo fin d’ora all’attenzione di questo studioso della psicologia dei gruppi umani, nell’eventualità che un tal progetto possa, nonostante tutto, realizzarsi un giorno.
Nell’immaginario nordamericano la “mafia” – e noi italiani stando alle cretinerie quebecchesi siamo tutti mafiosi in atto o potenzialmente – ha un forte sottofondo psicanalitico “maschio”. I mafiosi, grazie all’immagine di Hollywood, sono dei gran fallocrati, quindi con forti tendenze amatorie anche se sadiche. A ciò si aggiunga il fatto che gli italiani, gran bevitori di vino, beneficiano della relazione che in questo continente si stabilisce tra alcol e sesso: “Alcohol spells out sex” è il motto degli abitanti di una terra dove il termine “bar” deriva dalle “sbarre” che all’inizio sbarravano lo spaccio degli alcolici, luogo di perdizione tenuto ancor oggi in penombra.
Le mangiate gargantuesche che ci vengono attribuite – vedi i nostri banchetti matrimoniali che a loro appaiono di tipo orgiastico – contribuiscono anch’esse all’edificazione di una nostra immagine a carattere un po’ animalesco.
Un ulteriore elemento in questa costruzione fantasiosa dell’“italiano mandrillo” – nella ridicola iconografia su di noi invalsa per anni nella Belle Province – è costituito dall’immagine della “grosse maman italienne” fattrice instancabile di bambini. E quest’ultima evoca, per la sua stazza, un provveditore, il marito, non solo gagliardamente disposto alle frequenti seminagioni necessarie alla produzione di tanti futuri mafiosi, ma necessariamente ben fornito per poter raggiungere il punto più recondito ma proficuo della “grosse maman”.
La nostra abitudine di far crescere melanzane, pomodori, zucchine e ortaggi vari nel giardino-orto di casa è stata vista, all’inizio, quasi come un attentato al pudore, dagli “autoctoni bianchi francofoni” del Québec, gran adoratori dell’asettico prato all’inglese. Per non parlare poi della nostra “sconcia” passione culinaria per i diabolici “pissenlits”, pianta del male per loro (ed evocante nel nome l’organo sessuale, sia pur ridotto alla sua funzione meno nobile). Ma è il film – capolavoro “Léolo” del compianto regista quebecchese Jean-Claude Lauzon a fornirci il testo psicanalitico “ad hoc” che ci permette di far luce completa sul misterioso complesso dei Québécois nei nostri confronti.
Nel film il bambino protagonista, Léo Lauzon, per sottrarsi alla propria famiglia “pure laine” degenerata e nevrotica, s’inventa una nuova identità dandosi un nuovo nome: “Leolo Lozone”. Il poveretto, nel suo desiderio di fuga dalla mediocrità familiare, sogna anzi delira di essere nato da un accoppiamento per metà italiano: sua madre, interpretata dalla grossa e vogliosa Ginette Reno, sarebbe stata ingravidata da… un pomodoro, importato dall’Italia, sovraccarico degli spermatozoi di un allupato contadino siciliano. Se non è questa un’“invidia del pene” nei nostri confronti, anche se non espressa nei termini classici freudiani, ditemi allora cos’è…
Ma prima di questo film era successo qualcos’altro. Il discorso sull’animalità sessuale degli italiani ebbe un rigurgito razzista nel 1971 con il feroce attacco condotto dall’intellettuale François Hertel, contro – guarda, guarda… – i siciliani: l’articolo, “Ces affreux Siciliens”, apparve nella rivista “L’information médicale et paramédicale” del 5 ottobre 1971. Il prete spretato Hertel, nume tutelare di tanti nazionalisti e al quale sono dedicate diverse strade nel Québec, in questo sgangherato, fetido articolo espresse contro di noi idee razziste alla Rosenberg e alla Gobineau: “Hanno il coito puzzolente”, pensano solo a fare figli (“Plus le coït est puant, plus il est fécond!”); bisogna fermarli alle frontiere del Québec impedendo loro di entrare!
Se menziono questo lurido pamphlet, lo faccio solo per l’aiuto prezioso ch’esso ci apporta in questa mia ricerca psicanalitica, sotto il patrocinio ideale di Clotaire Rapaille, mirante a rischiarare le cause o se non altro la causa maggiore della patologica animosità dei quebecchesi nei nostri confronti. E sulla diagnosi finale non è possibile aver più alcun dubbio: si tratta dell’“invidia del pene”, un pene non solo loquace ma per soprammercato anglofono o almeno giudicato, erroneamente, tale.
Qualcuno a questo punto penserà che io esageri in questa psicanalisi da lupanare. Ma è tutto vero ciò che dico. Ma non basta… aspettate un po’… qual è il nome del recente programma satirico TV che ha visto contrapposta la famiglia “tipica” italiana di corrotti e di mafiosi: i “Jamboni”, alla famiglia “tipica” quebecchese, composta manco a dirlo di persone angeliche: i “Bienveillant”? Ebbene, non ricordate il nome di questa trasmissione? Ve lo ricordo io: “La guerre des Glands”.
Il termine francese “gland” riecheggia “clan” e anche “ghianda”, ma nel contesto significa fuori di ogni dubbio “glande” = estremità del membro virile. In sostanza i quebecchesi, nevrotici e sadomasochisti con gli inglesi, dimostrano di essere afflitti da un’insanabile invidia del pene nei nostri confronti.
Ci dispiace dirlo, ma la “Guerre des Glands” è una guerra persa, da tempo, per loro. E la causa va attribuita anche ai nostri meriti, oltre che, beninteso, al loro rapporto “sado–maso” con Ottawa, crudele castratrice.
L’immondo lavoro teatrale “Medium saignant”
Gli studi sociologici e di altra natura, effettuati in Québec sugli italiani, sono stati condizionati dall’ossessione linguistica dominante l’animo degli autori di tali studi.
Ossessione probabilmente legittima – non è questo il punto – e che è da collegarsi al desiderio di affermare in maniera definitiva in questo angolo di terra la propria identità francese contro la minaccia egemonica del gruppo britannico; oggi da chiamare piuttosto gruppo “anglofono”. Fatto sta che quest’ottica unidimensionale ha impedito per troppo tempo che i franco-quebecchesi si interessassero agli italiani da un punto di vista umano, storico, sociale, antropologico, avendo l’animo pieno, invece, dell’ossessione per le scelte linguistiche, vere o presunte, dei nuovi arrivati, di cui gli italiani erano il gruppo più numeroso. Di conseguenza, nelle riviste e nei giornali gli scritti sulla nostra comunità erano improntati quasi sempre ad aperta antipatia, ruotando ossessivamente intorno al tema della lingua da noi prescelta – secondo i nostri detrattori, l’inglese – e dei dati statistici denuncianti la nostra presenza massiccia in questo o quel quartiere, in questa o quella scuola.
Noi italiani siamo stati additati dai quebecchesi come le truppe mercenarie assoldate dal nemico inglese in una guerra volta allo sterminio linguistico dei discendenti dei francesi. L’immagine preferita era quella dell’inondazione e dell’annegamento. Lord Durham avrebbe infatti detto: “La migliore maniera è di annegare la popolazione francese sotto il flusso continuo d’una immigrazione organizzata metodicamente, controllata alla partenza, accolta all’arrivo, e con una situazione assicurata di privilegio nella colonia”. E noi siamo stati visti, appunto, come i flutti di queste ondate anglofone volte ad annegare gli eredi di Jacques Cartier. Conseguenza di questa visione manichea era l’ostilità verso gli immigrati, considerati in massa degli alleati degli inglesi in una strategia posta in atto da quest’ultimi per anglicizzare definitivamente il Québec.
A ciò si aggiungeva poi la tradizionale accusa rivolta agli italiani di venire qui a rubare i posti di lavoro spettanti ai Québécois, e di accettare, per giunta, retribuzioni molto basse con la conseguenza perniciosa di far abbassare anche per gli altri il livello delle retribuzioni. Ciò spiega la sempiterna girandola di dati statistici che accompagnavano ogni scritto che trattasse della nostra presenza.
In quei tempi – ne ho un chiaro ricordo – negli incontri individuali, cioè nelle conversazioni con i franco-quebecchesi, appena incontrati, io spesso suscitavo un riferimento agli altri italiani: “Vous, les Italiens”. E ben presto nella conversazione facevano capolino la questione linguistica e i relativi dati statistici, demografici, ecc., tutti comprovanti una nostra presenza eccessiva qui, nel loro Québec.
I quebecchesi sembravano incapaci di fare astrazione dalla questione linguistica e ci ponevano sempre in stato d’accusa.
Uno dei punti più bassi di questa “italofobia” fu toccato nel 1971 da un ignobile scritto razzistico di una rivista scientifica canadese, denunciante – nientedimeno – l’inferiorità genetica dei siciliani. L’autore dello scritto era un notissimo esponente dell’intellighenzia nazionalistica canadese, certo François Hertel, da tempo scomparso. Questo ex prete, ancora oggi venerato come specchiato patriota, era stato il mentore di una schiera di intellettuali, tra cui il giovane Pierre Trudeau.
Di quel turpe, grottesco e stupido esercizio di puro razzismo mai è fatta menzione. Nei vari libri che citano con abbondanza di particolari l’importante personaggio, mai è citato quel suo orrendo scritto pubblicato in una rivista di divulgazione scientifica. Dopo tutto, bersaglio del suo delirare erano “les Italiens”, visti per decenni in questa provincia come una razza a parte che non meritava alcun riguardo. Ognuno di noi potrebbe oggi enumerare decine di episodi attestanti l’italofobia di un passato recente, di cui noi siamo stati i diretti testimoni anzi le vittime.
Un altro sconcio attacco veniva sferrato contro gli italiani del Québec da Françoise Loranger con il suo “Medium saignant” (scritto nel 1970), lavoro teatrale di una violenza poco comune. Gli italiani del Québec venivano presentati come la sentina di tutti i vizi. Gli attori che li rappresentavano su scena apparivano ricchi, impellicciati, ingioiellati, e nello stesso tempo erano volgari, aggressivi, disonesti, canaglie.
L’autrice faceva leva abilmente sui sentimenti del pubblico, il quale veniva pesantemente provocato dagli attori raffiguranti gli italiani. Il risultato di tale indegna manipolazione delle emozioni, operata da questo gioco al linciaggio, era ogni volta la reazione verbale e fisica del pubblico presente alla “Place des Arts”. Infatti, molti spettatori, durante lo spettacolo, si scagliavano animalescamente contro gli attori – gli italiani – facendosi sotto la scena con grida, epiteti, gesti aggressivi e persino con sputi. Ricordo di aver temuto, per un momento, per la mia stessa incolumità – io mi trovavo tra gli spettatori – a causa di questa ondata d’odio di folla, nel caso che qualcuno mi riconoscesse come italiano. Uno studente universitario francese (cittadino francese), che io conoscevo, mi riconobbe tra il pubblico e venne verso di me, nella confusione che si era creata con gli spettatori che erano all’impiedi e urlavano. E mi sussurrò, con fare allarmato, un invito ad essere prudente.
Ciò avvenne durante una delle “scene d’odio” cui partecipava anche il pubblico, che si agitava, urlava, scavalcando posti e file, aizzato non solo dagli attori su scena ma anche provocato, io credo, da attori non riconoscibili nascosti tra gli spettatori. Gli spettatori, del resto, erano stati invitati all’inizio del lavoro teatrale a partecipare all’azione.
Uno o due giorni dopo mi trovai a parlare con lo scrittore Giorgio Bassani, ospite dell’Istituto italiano di cultura di Montréal. Credendolo molto sensibile ai problemi di razzismo e discriminazione, dato il tema della sua opera “Il giardino dei Finzi Contini”, tema che aveva finito appena di trattare in quell’occasione, gli denunciai l’accaduto nel corso del cocktail che seguì la conferenza, invitandolo ad andare a vedere “Medium saignant”. Ma non lo fece. Non vi andò. Né lo fecero i membri di un organismo comunitario italiano di Montréal cui denunciai la cosa.
“Con il lavoro teatrale ‘Medium saignant’, il germe del pregiudizio razziale si è manifestato in questa città cosmopolita. Si può solo sperare che il germe non si propaghi e che il veleno sia fermato per impedire così danni irreparabili. Con ‘Medium saignant’ di Françoise Loranger, per la prima volta un lavoro teatrale ha provocato uno choc negli spettatori con la virulenza del suo inatteso attacco contro gli immigrati italiani di qui.” Così scrisse con molto realismo un critico teatrale del quotidiano “Montreal Star”. Un altro critico, sempre sul “Montreal Star”, comparò senza mezzi termini il discorso d’odio di “Medium-saignant”, per violenza e intensità, alla propaganda in voga nella Germania nazista.
Ma tant’è, se non se la presero gli stessi italiani (probabilmente all’oscuro di tutto), non c’è da meravigliarsi che non ne sia mai parlato da allora, e che bib si sia interessato alla cosa lo scrittore Mordecai Richler, pur pronto a denunciare tutto quanto egli abbia visto come un attacco, vero o presunto, contro i propri simili. Ma appunto: i propri simili. Forse il multiculturalismo vuol dire anche questa solidarietà di tipo tribale, cui nessuno finisce con lo sfuggire. Ma che nella comunità italiana, almeno allora, non era molto vivace.
Io denunciai il razzismo di quell’indegno lavoro teatrale in un breve articolo sul “Cittadino canadese”. Non volli tornare sulla cosa in seguito, perché il riandare con la mente all’enormità di quella ignobile creazione razzista, impunemente rappresentata su scena, mi creava turbamento e disgusto.
Mordecai Richler
A Mordecai Richler, difensore intemerato degli ebrei contro gli stereotipi antisemiti, dobbiamo questo scritto apparso nella prestigiosa rivista “The Spectator” (22-02-2000), celebrante il classico stereotipo antitaliano. Richter avrebbe potuto ricordare, in questa occasione, anche le giovani donne italiane, che lavoravano nelle manifatture di Montréal, e che dovevano subire le avances sessuali del proprio datore di lavoro; come mi è stato raccontato da più fonti. Ma ecco il pezzo antropologico di Richler:
“Quando ero ragazzo, gli immigranti in Canada, i miei nonni erano fra questi, giunti in una stiva di nave nella quasi terra promessa, potevano essere identificati dalla loro iniziale attività lavorativa: i cinesi consacravano un numero incalcolabile d’ore in una delle lavanderie del vicinato, gli ebrei erano curvi su macchine da cucire nelle manifatture di abbigliamento o aprivano un buchetto da calzolaio, e i greci e gli italiani preferivano aprire un negozietto di frutta e verdura e rivendite di cibo pronto per il consumo. Altri, italiani più premurosi, merita notare, presero a visitare le lavanderie, le calzolerie, i negozi di fruttivendoli e i ristorantini offrendo loro di assicurarli contro disgrazie e incidenti”.
Mordecai Richler non ce la racconta giusta. In quell’epoca Montréal era considerata in Nord America la città del peccato. Con una forte presenza di ebrei, però, tra i delinquenti. Ci ricorda Maryse Bédard, studiosa di quel periodo: “Il crimine organizzato s’impianta a Montréal a partire dagli anni 20 e aumenta gradualmente la sua influenza. Negli anni 1940-1950, diversi locali notturni, ristoranti e case da gioco si trovano in tal modo sotto il suo controllo della malavita locale e di New York. Traffico di droga, contrabbando, riciclaggio di denaro, prostituzione, giochi e scommesse illegali: la criminalità s’infiltra ovunque. Harry Davis e Harry Ship [ebrei] sono tra gli esponenti più noti, ma gli affiliati al giro malavitoso sono numerosi”. Tra questi, in quel periodo, le cronache del mondo dell’illegalità registrano Armand Courville e Lucien Rivard [franco-canadesi]. Luigi Greco, Giuseppe Cotroni, Carmine Galante [italiani]. Frank Petrula [ucraino]. Gli ebrei sono ben presenti e addirittura in posizione di spicco: a Davis e a Ship, già menzionati, si si aggiungono il potente Max Shapiro, definito “personaggio centrale della malavita ebraica di Montréal”, proprietario di club e ristoranti, tra cui Ruby Foo’s, e Harry Feldman proprietario di una casa da gioco sita sulla strada principale di Montréal (la Rue Sainte-Catherine) che subisce – ma senza gravi conseguenze grazie ai suoi potenti appoggi – ben 200 irruzioni da parte delle forze dell’ordine.
Cosa volete, siamo noi, io e voi, i testimoni dell’indecente italofobia del passato. E sta a noi parlarne, perché nessun altro lo farà al posto nostro.
L’italofobia
Quando si vive all’estero l’“italofobia” (vedi Wikipedia) ci colpisce nell’anima. Per noi espatriati l’analisi di questa italofobia non è un esercizio accademico, ma una necessità; anche per difendere i nostri figli, ai quali trasmettiamo il nostro cognome italiano.
Il mandolino, una treccia d’aglio, gli spaghetti con il rosso della salsa, Arlecchino e Pulcinella, la mafia – noi italiani siamo tutti mafiosi – la pizza, il fiasco di vino… I caricaturisti del settimanale “The Economist”, e di altri giornali attraverso il mondo soprattutto quelli tedeschi, non devono spremersi le meningi per riuscire a trovare a colpo sicuro le immagini di supporto ai loro ricorrenti, quasi sempre gratuiti, attacchi di italofobia.
E dire che nella penisola circolano da sempre ridicole frasi che fanno leva su una nostra eccellenza in tanti campi che farebbe sì che “all’estero tutti ci invidiano”. In realtà siamo soprattutto noi che infantilmente invidiamo il “favoloso” Estero e i suoi “fortunati” abitanti. Non possiamo neppure ignorare che il disgustoso accanimento verso gli italiani è favorito dal nostro scarso sentimento nazionale, rimpiazzato dall’isteria ideologica e dal culto degli odi civili e calcistici.
Ma quali sono le cause dell’italofobia?
Permangono all’estero i residui di certe prevenzioni folcloriche di cui facemmo le spese nel passato, soprattutto nei Paesi nordici: il viscido olio d’oliva contrapposto al virtuoso burro, il puzzolente aglio, la cicoria selvatica, la pizza, gli spaghetti, il vino… Paradossalmente, la nostra superiorità in campo alimentare è stata vista, nel passato – penso al Canada – come una sorta di handicap morale. Oggi le cose sono cambiate. Tuttavia riemergono talvolta gli indigesti residui di questo “moralismo alimentare” nei nostri confronti, con il ricorso alle tradizionali ingiurie: “spaghetti” e “pizza”.
Un’altra causa? Noi abbiamo un senso molto avanzato della comunicazione: parliamo forte, gesticoliamo, tocchiamo l’interlocutore, inoltre abbiamo una mimica facciale e corporale molto espressiva. E ciò è visto come un comportamento di tipo primitivo e quasi animalesco. L’alzare la voce, l’agitarsi, il polemizzare – il comportarsi insomma da italiani – sono visti come un’evidente manifestazione d’inferiorità mentale e morale. Basti osservare nei film hollywoodiani il comportamento dell’eroe americano, personaggio quasi sempre solitario e parco di parole, antitesi quindi dell’eroe all’italiana, il quale è spesso incarnato nei film della penisola da un furbetto ammiccante, pauroso e vigliacchetto.
Le stesse maschere della nostra commedia dell’arte – vedi Arlecchino e Pulcinella – sono un inno all’inaffidabilità e all’opportunismo. E paurosi e opportunisti sono anche gli eroi del nostro cinema comico. Finisce insomma che i nostri detrattori ci vedano permanentemente installati su un palcoscenico, nelle vesti assai spesso di saltimbanchi e d’interpreti di un’opera buffa. Lo stesso Vaticano, in passato, fu visto dai popoli nordici come un palcoscenico sfarzoso con un “dietro le quinte” ribollente di ambizioni, ipocrisie, immoralità, edonismi e familismi.
Ma vi sono altre cause: il basso livello culturale degli immigrati italiani – là dove noi espatriati costituiamo una presenza ben visibile: Europa, Australia e Nord America – il nostro culto della “furbizia”, il “familismo”, la nostra scarsa autodisciplina, la nostra propensione alla disonestà (l’indice di corruzione pone il nostro Paese tra i primi di una vergognosa classifica), il mito negativo che i popoli nordici hanno di Machiavelli, la nostra propensione al voltar gabbana, alla slealtà, al trasformismo; vedi il voltafaccia nella seconda guerra mondiale e il nostro opportunismo nella prima.
La disunità nazionale fa sì che gli italiani non reagiscano alle offese contro di loro come collettività, contro la loro Nazione insomma, ma solo alle offese dirette a loro individualmente o alla loro fazione. Non solo, ma vi è un fenomeno collegabile a quell’esterofilia dirompente da cui siamo posseduti e che ci fa esaltare il magico Estero dove tutto funzionerebbe alla perfezione. È il fenomeno del “compiacimento autodenigratorio” di cui siamo campioni e in cui ci crogioliamo, ma con il quale non sono da confondere le mie realistiche sofferte critiche.
Sarà per la radice cattolica che ci spinge alla predica, al moralismo e all’autoassoluzione, sarà per l’esterofilia, ma numerosissimi sono gli italiani disposti a parlare male gratuitamente degli altri italiani, anche perché loro “non si sentono italiani”. Addirittura scritti razzistici del passato sugli italiani, negli USA ad esempio, appaiono agli italiani di oggi come una prova scientifica della nostra inferiorità (vedi il nostro Gian Antonio Stella, stella polare dell’autodenigrazione italiana). È il fenomeno del “compiacimento autodenigratorio”, per usare l’espressione di Sergio Romano. Ed è un po’ come se gli ebrei si basassero sulla descrizione contenuta negli scritti antisemiti tedeschi di ieri come prova delle proprie caratteristiche di popolo molto particolare.
Dobbiamo solo sperare che le offese fatte ieri alla nostra bandiera da quelli della Lega, trasformatisi oggi in ardenti nazionalisti, siano rimaste entro i soli confini italiani (dove non hanno scioccato nessuno).
Io credo che la presenza ormai massiccia in ogni angolo della penisola di venditori ambulanti abusivi, di questuanti, e di attruppamenti di individui loschi, provenienti in buona parte dall’Africa, e le loro frequenti risse, finiranno con alterare anche l’immagine ingenua e idilliaca, veicolata da libri e film, di un’invidiabile Italia con le sue città d’arte, le sue piazze, i suoi monumenti, i suoi paesini arroccati sulle colline, i suoi borghi marini. e i suoi uomini e le sue donne. Oggi l’affollamento di venditori ambulanti insistenti e di perdigiorno provenienti dal terzo mondo rischia di divenire il tratto dominante di questa nuova cartolina tricolore divenuta multietnica.
Vi sono poi i nostri governi che continuamente girano e cambiano come in una giostra per bambini o in un carnevale, e altresì vi sono il disordine cronico nella penisola e le mini-fregature con cui spesso accogliamo il turista. L’Italia è diventata, dopo tutto, un’enorme Napoli, senza però averne lo charme.
Ma veniamo al Canada e al Québec. Ciò che è stato scritto sugli italiani del Canada ha risentito, per molti anni, di un’innegabile antipatia verso di noi, quando non si è trattato di una vera e propria avversione: l'”italofobia”, per usare il termine usato dallo studioso Robert F. Harney (1939-1989) dell’Università di Toronto, vero amico degli italiani del Canada, e al quale gli studi sulla collettività italo-canadese tanto devono. A dire il vero Harney ha usato questo termine in relazione al mondo anglosassone, di cui un politico canadese espresse tempo addietro un’idea diffusa: “I doubt if Italians from the South could ever become an asset to our country”.
Ma anche in Québec gli italiani sono stati oggetto di avversione e di antipatia, soprattutto perché accusati di preferire la lingua inglese a quella francese. I quebecchesi sono stati afflitti per molto tempo nei nostri confronti dall’ossessione linguistica e statistica. Essi hanno creduto di vedere in noi le truppe mercenarie di una guerra condotta dai famigerati inglesi contro la presenza francese in questo ampio angolo di terra. Giornalisti e studiosi “pure laine” hanno focalizzato l’interesse e l’attenzione del lettore dei loro studi e articoli sulla nostra consistenza numerica e su tutte le altre percentuali, demografiche e linguistiche così minacciose per loro. Per anni era quasi impossibile trovare in uno degli articoli, pubblicati da questo o quel giornale “francese”, un solo accenno di vero interesse, e di comprensione e di simpatia verso la nostra presenza in questa terra.
Forse è per evitare di scoperchiare gli altarini del vittimismo dei quebecchesi, pietra angolare della loro identità, che gli studiosi non hanno voluto approfondire una realtà che in Québec si dà per scontata: la presunta scelta spontanea della scuola inglese da parte degli immigrati. Io ho avuto decine e decine di testimonianze che smentiscono la vulgata, causa del loro risentimento verso di noi, secondo la quale gli italiani disdegnarono in massa gli studi in francese per i loro figli. In realtà, tanti figli d’immigrati italiani furono rifiutati dal sistema scolastico cattolico-francese, che preferiva dirigerli verso le scuole inglesi. Chi è causa, in tutto o in parte, del suo mal dovrebbe piangere sé stesso. Ma in Québec ciò non avviene, perché la colpa è sempre degli altri.
Ultimamente (11 aprile 2015) ho udito dalla viva voce dell’industriale Nicholas Di Tempora, ai vertici della Mapei negli USA, una testimonianza sulla “scelta della scuola”: se, arrivando qui a Montréal dall’Italia, egli intraprese gli studi nel sistema educativo protestante inglese, ciò avvenne perché gli era stato rifiutato, come italiano, l’accesso al sistema educativo cattolico francese. Di Tempora ha aggiunto con ironia: “fortunatamente”, poiché in seguito deciderà di trasferirsi negli Stati Uniti dove avverrà la sua brillante carriera imprenditoriale.
Una buona parte degli scritti su di noi provenienti dalla nostra stessa gente, qui residente, è caratterizzata da quella che chiamerei l'”autocelebrazione”. Si tratta di un fenomeno ben noto alle minoranze, in particolare a quelle che non godono di un’alta considerazione nella società in cui vivono. Nessuno potrà negare che questo sia stato il caso nostro, di noi “les Italiens”, nel periodo che va in Québec dal dopoguerra in poi e che è durato fino a pochi anni fa.
Chi si sa poco considerato tende ad autoincensarsi, per compensazione, con risultati che appaiono patetici o addirittura ridicoli. Certe imprese editoriali basate sulla storia di successo della nostra gente in questa terra sono state portate a termine per ragioni spesso di puro profitto, e facendo leva sulla vanità di quegli emigrati che hanno fatto fortuna o che semplicemente hanno raggiunto l’agiatezza. Questi emigrati ritengono di non aver ottenuto il riconoscimento ufficiale che – sono convinti – spetterebbe loro dopo tanti sacrifici, compiuti in una terra così lontana dalla madrepatria. Di conseguenza, sono disposti a pagare il prezzo chiesto dal redattore del testo e dall’editore, pur di vedere la propria vicenda umana consacrata sulla pagina scritta, in un libro che potranno diffondere tra la gente di qui e soprattutto tra la parentela e gli amici rimasti al paesello. Immancabilmente, in queste opere, la storia dell’emigrato viene presentata con un tono agiografico degno del racconto di una vita esemplare.
Chi vive da minoritario in una terra d’immigrazione tende anche a valorizzare – la cosa è comprensibile – il contributo storico apportato dalla propria gente alla scoperta e alla “edificazione” del paese. Sovente queste ricerche sul contributo italiano alla “nascita” e all’accrescimento del Paese derivano non tanto da un sentimento di frustrazione, quanto da un desiderio legittimo di far conoscere alla popolazione locale certe pagine di storia che vengono di solito ignorate. Prendiamo il navigatore Giovanni Caboto, e con lui altri personaggi storici di origine italiana, visti però come il fumo negli occhi da tanti qui in Québec, sensibili solo a ciò che parli di Francia. I franco-quebecchesi, ambienti accademici inclusi, non ci tengono a ricordare che non tutto venne dalla Francia. Il monumento a “Giovanni Caboto” dello scultore Guido Casini, presente nel piccolo parco “Square Cabot”, suscitò al momento della sua installazione (1935) molte perplessità. La maggioranza, infatti, trovava ridicolo e assurdo che si potesse onorare un “Giovanni” come “scopritore del Canada”, al posto di un “Jacques”: Jacques Cartier. D’accordo con l’ostilità che il progetto incontro’ allora è lo studioso italiano Gerardo Acerenza, le cui perplessità sono ancora maggiori, poiché egli vede nell’erezione del monumento una strategia dei fascisti diretta a destare l’orgoglio nazionale negli immigrati italiani, nella quasi totalità analfabeti, attraverso “un tentativo di revisione storica”, ossia presentando “Jean Cabot” come scopritore del Canada”. È interessante leggere lo scritto di questo studioso, secondo il quale la Casa d’Italia di Montréal fu costruita per “impiantare il mito di Mussolini a Montréal” (Polish Journal of Canadian Studies/Revue polonaise d’Études Canadiennes – Poznan 2017).
Nel campo degli studi di volgarizzazione storica padre Menchini ha scritto delle cose egregie, ristabilendo fatti troppo spesso trascurati o ignorati. Lo studioso Bruno Villata dell’Università Concordia ha da parte sua sottolineato la forte presenza di elementi piemontesi nel “Régiment Carignan”, che Luigi XIV inviò (1665) nella Nuova Francia per difendere la colonia dagli attacchi degli irochesi. Il carattere piemontese di questo nucleo militare è sottaciuto dagli storici di qui, molto sensibili al valore simbolico dell’identità etnica di certe presenze. Bruno Villata si è interessato alla presenza di un buon numero d’italiani nei ranghi dei reggimenti mercenari Meuron e de Watteville, inviati in queste terre dal governo inglese, durante il conflitto con gli Stati Uniti. Ma per lo studioso Gerardo Acerenza, “è nella metà del XIX secolo che una cinquantina di famiglie – ‘i precursori’ – originarie del Nord Italia si installano a Montréal per ragioni professionali”. Le costruzioni storiche miranti ad illustrare una presenza italiana anteriore e rivendicanti un ruolo storico maggiore di quello di semplici emigrati, per gli italiani del Canada, sono da lui viste quali espressione di “un amore smisurato per la patria d’origine”, che chiama “italianità”; riprendendo questo termine, che giudica invero strano, da un lavoro di Filippo Salvatore; e che fu un sentimento diffuso – ci dice – tra gli italiani nel periodo che va dal 1920 al 1940.
Molto resta ancora da scrivere sulla realtà degli immigrati italiani in questa terra. Pochissimi hanno scritto sul complesso fenomeno psicologico della scelta di una nuova identità “etnoculturale” per i propri figli. C’è da chiedersi, infatti? Per quale ragione numerosi italiani rifiutano in cuor loro di vedere i propri figli trasformarsi in quebecchesi “pure laine”? La risposta non è semplice. Possiamo però dire che l’identità quebecchese è un’identità ancora gracile, anche se un po’ meno tormentata rispetto a un passato ancora recente. La debolezza dei franco-quebecchesi esiste – e forse dovremmo dire “esisteva” – non solo sul piano del puro potere economico – il dollaro, in Nord-America, dopo tutto, “parla inglese” – ma sul piano degli stili di vita, dei valori familiari, del risparmio, della lingua, delle abitudini alimentari… Il Québec non ha avuto finora abbastanza da offrire ai nuovi venuti, anche perché è stato dominato per troppo tempo da un sentimento di persecuzione e d’autocommiserazione. Il “vittimismo” in questa provincia è un atteggiamento psicologico ancora presente, anche se l’introspezione, il narcisismo, il sentimento di persecuzione, la chiusura all’altro hanno cominciato ad attenuarsi.
Lo stile di vita del franco-quebecchese è basato su certi valori che l’immigrato italiano considera, nell’insieme, poco appetibili. Tanto per fare un esempio, certamente banale ma per noi italiani invece significativo: il fatto che i quebecchesi dopo più 400 anni di “controllo” del territorio disdegnino i deliziosi funghi selvatici, mentre sono pronti a fare 50 chilometri in auto per mangiare la “poutine”, è qualcosa di semplicemente incomprensibile per noi italiani, così sensibili al cibo.
Il giornalista-scrittore Camillo Carli è stato tra i pochi ad affrontare certi temi. Più di una volta, infatti, con accenti amari egli accenna in “La giornata di Fabio” e in “Questa è la mia terra” al dissidio culturale, all’inconciliabilità di lingua e di sensibilità, tra i padri italiani e i figli nati in Québec.
Sui complessi rapporti tra padri, fedeli alla patria antica, e figli, fedeli alla nuova o piuttosto: incerti sul da farsi, e sulla scelta di un destino collettivo, cioè sulla scelta dell’identità da parte di chi per parte di padre e per parte di madre appartiene a mondi divergenti, lo studioso Claude Corbo – rara eccezione – ha scritto con una profonda sensibilità delle pagine semplici, toccanti, vere.
Cosa è cambiato a Montréal e nel Québec dal 1967, anno del fatidico Expo? Tanto, tantissimo è cambiato per Montréal, per il Québec, per il Canada, e soprattutto per noi di origine italiana. Infatti, in qualche decennio noi italiani del Québec e del Canada siamo riusciti a raggiungere una posizione di tutto rispetto nel campo economico e anche, ma in misura inferiore, in quello sociale. Fino a non molti anni fa i quebecchesi ci accusavano un po’ di tutti i mali. Immancabilmente caricaturale era la loro maniera di raffigurarci in TV, al cinema, e di riferirsi a noi nelle conversazioni dei salotti. Le barzellette sugli italiani erano socialmente ben accolte. Il francese parlato da noi con accento italiano suscitava lazzi, venendo associato alla maniera di parlare di tipi umani grossolani, e ai mafiosi. Il loro francese era ed è invece, per decisione maggioritaria, “senza accento”.
Parlo di una realtà che ho vissuto.
In realtà, il principale torto di noi “Italiens” – preciso io – era di costituire un gruppo debole, e di incarnare i poco amati “Immigrants”. Non trascorreranno molti anni e certi quebecchesi subiranno un vero choc scoprendo di essere divenuti inquilini di uno di quegli “Italiens”, per i quali non avevano mai provato simpatia e di cui avevano stupidamente sottovalutato le capacità. Le nostre qualità da loro ridicolizzate – tra cui la frugalità, lo spirito di sacrificio, il culto della famiglia, una concezione molto realistica della vita, le solidarietà “paesane” – avevano cominciato a produrre i loro frutti a nostro vantaggio.
L’immigrazione dall’Italia verso il Québec e il resto del Canada è da tempo cessata. “Immigrant” non è più sinonimo di “Italien”. Chi ieri ci criticava per mille e una cosa, oggi si trova ad avere di fronte altre masse di immigrati, che si guarda però dal criticare perché ciò non è più socialmente accettabile, anzi non è più permesso. I tempi sono cambiati. Oggi vige il culto dei diritti umani.
L’italofobia nelle sue forme più crude appare un lontano ricordo, anche se certi miasmi ogni tanto ritornano. Dimenticato è l’ignobile lavoro teatrale “Medium saignant” di Françoise Loranger. È finito nel dimenticatoio anche lo sconcio scritto razzistico contro i siciliani, che François Hertel (vero nome: Rodolphe Dubé), ancora oggi venerato dai nazionalisti del Québec, pubblicò nella rivista scientifica: “L’information médicale et paramédicale” (5 ottobre 1971).
Oggi il più ricco del Québec – non dispiaccia loro, e in verità a moltissimi dispiace – è proprio un nativo di Sicilia: Lino Saputo, geniale imprenditore, persona semplice, e generoso contributore di cause meritorie. Ma Lino Saputo, essendo italiano e per soprammercato siciliano, stenta a scendere nella strozza dei mass media locali.
Anche se non sono sempre e solo rose e fiori per noi e per i nostri discendenti, il dichiararsi di origine italiana in Québec non crea più i complessi di allora. Il nostro cammino non è stato però facile. Non si dimentichi che noi siamo stati considerati, nel periodo in cui “Italien” era sinonimo di “immigrant”, e “immigrant” di “Italien”, le truppe mercenarie di una guerra condotta dagli inglesi per lo sterminio linguistico dei francesi. In realtà, vi fu un’epoca in cui le domande di ammissione nelle scuole francesi da parte degli italiani erano rifiutate, perché noi eravamo considerati degli estranei – “Vous autres, les Italiens!” – da respingere verso la sponda inglese. Ma questa semplice verità storica stenta, ancora oggi, ad entrare nelle meningi della maggioranza; da sempre adepta di un’interpretazione vittimistica del proprio passato.
Sulla maniera di vivere dei quebecchesi hanno inciso positivamente maniere e usanze nostre e di altri gruppi d’immigrati simili a noi. Numerosi esempi dimostrano l’influenza operata sui “nativi” da certe nostre consuetudini. Vi ricorderò, ad esempio, che anni fa gli uomini italiani che chiacchieravano in crocchio sul marciapiede potevano essere importunati dalla polizia che intimava loro di disperdersi o addirittura li caricava su un cellulare e li metteva al fresco. Adesso esistono le strade riservate al passeggio. Inoltre vi è un’infinità di avvenimenti culturali e commerciali il cui scopo principale è di raggruppare la gente, in strada e sui marciapiedi: les “ventes trottoir”, i festival all’aperto con saltimbanchi e “amuseurs publics”, ecc. Mi sembra lecito dire che in ciò noi siamo stati dei precursori. Per i quebecchesi, insomma, la strada ha cessato di essere un semplice raccordo tra due punti topografici.
Ricordate il fastidio con cui la gente locale guardava alla nostra abitudine di coltivare l’orticello? Gli autoctoni francofoni del Québec erano dei gran adoratori dell’asettico prato all’inglese, e il nostro far crescere nel giardino-orto di casa turgide melanzane, rossi pomodori, zucchine dalle foglie pelose, e altri misteriosi ortaggi, fu da loro vista all’inizio come un attentato al pudore. Oggi invece esistono persino gli orti comunitari. Dopo tante carote e tante patate, i quebecchesi hanno finalmente scoperto l’attraente varietà degli ortaggi.
I nostri ristoranti hanno conquistato il cuore e la tasca dei quebecchesi. Il vino, poi, è diventato addirittura una bevanda simbolo del carattere francese di questa provincia, “pas comme les autres”. Dopo gli spaghetti, la pizza, l’olio d’oliva, il vino fatto in casa, il prosciutto crudo, il parmigiano, il tiramisù, l’espresso, è da sperare che ben presto trionfi sulle tavole da pranzo quebecchesi anche la deliziosa cicoria selvatica – i “pissenlits” – che ieri li faceva inorridire.
Il campo dell’edilizia è stato anch’esso influenzato dalla forte presenza di noi italiani, con i nostri metodi, stili, “prodotti”: marmo, piastrelle, accessori vari… Il campo dell’automobilismo è un settore che da sempre ci avvantaggia, basterà citare la Ferrari. Un italo-canadese di Toronto, trapiantato in Italia, Sergio Marchionne, è riuscito a risuscitare e a rendere popolare la Cinquecento attraverso il mondo, Québec incluso. Chi lo avrebbe mai immaginato ai tempi in cui FIAT voleva dire in Nord America: “Fix It Again Tony!”?
Motivati dalla rapida ascesa che abbiamo conosciuto in questa terra, noi immigrati di origine italiana scivoliamo con facilità verso l’autocompiacimento e l’autocelebrazione.
Dobbiamo essere, sì, orgogliosi, ma con senso critico, col desiderio di far meglio, e sempre con spirito di simpatia e solidarietà verso gli altri italiani, i “paesani”, perché non dobbiamo dimenticare una verità fondamentale: qui in Québec e in Canada, grazie anche al multiculturalismo e alle cosiddette “comunità”, noi siamo legati, nel bene e nel male, agli altri della nostra stessa origine. Che lo vogliamo o no…
Claudio Antonelli




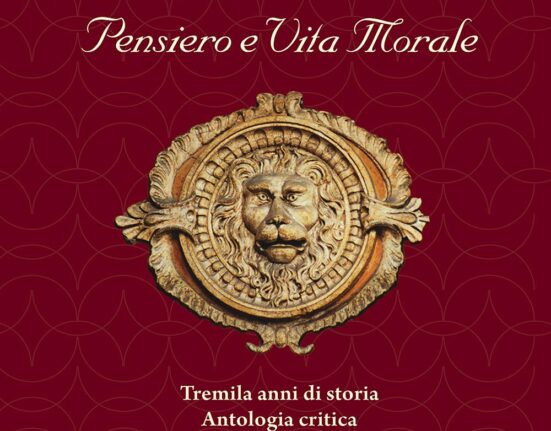



3 Comments