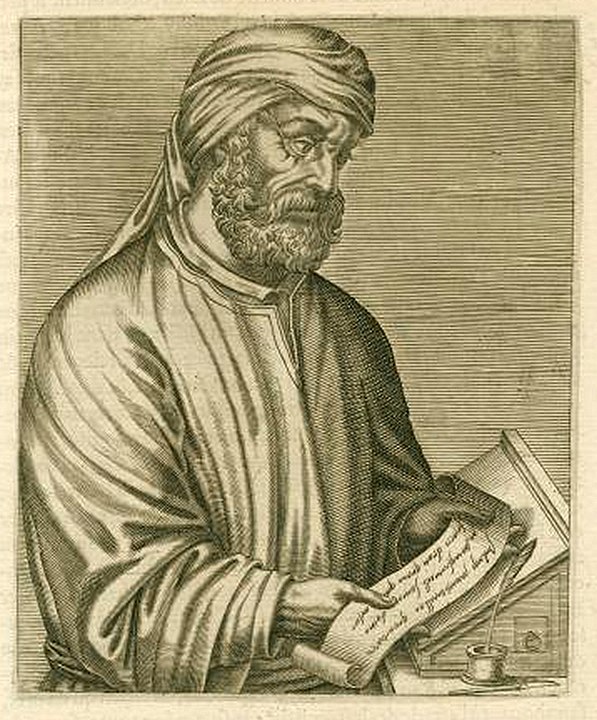Il sapiente egiziano Ptahhotep nel suo noto testo sapienziale (contenuto nel celebre Papiro Prisse) esaltava l’ascolto del discepolo nei confronti dei padri. Chi non ascolta “fa sempre ogni cosa che è odiosa/biasimevole (cioè: commette atti odiosi)”. L’originale egiziano suona così: jrr=f xbd.t nb.t. Ed è molto più pregnante della traduzione. Il verbo fare è jrr=f, nella forma mrr=f, usata per azioni ripetitive, iterative, cioè: fare sempre. La parola egiziana xbd.t indica ciò che è odioso, al femminile, usato dagli egiziani per indicare anche il neutro (come x.t, cosa). È un lemma che passa da xbD.t a xbd.t, con la depalatalizzazione della pronuncia.
Pertanto Ptahhotep in questo suo testo, uno dei libri più antichi dell’umanità, ci ricorda ancora oggi che è conveniente prestare ascolto ai sapienti per non commettere il male. Non è forse questa l’essenza di ogni religione? Tendere l’orecchio agli insegnamenti dei padri (ispirati dalle divinità) per agire conformemente al retto sentiero e non tralignare.
L’induismo viene considerato la religione più antica del mondo. In realtà il termine “induismo” è una etichetta affissa dagli inglesi in epoca moderna: non esiste un solo induismo, infatti gli indiani hanno una molteplicità di sette e scuole assai diverse tra di loro. Oggi le correnti più in voga in India sono l’adorazione a Vishnu, a Shiva e alla Devi. Questi tre culti sono praticati adesso soprattutto in modalità bhakti, cioè come devozione personale (non dipendente dalla mediazione del sacerdote): il fedele fa in prima persona una offerta (puja) alla divinità nel tempio. Il tempio induista prevede a tutt’oggi un itinerario individuale che si conclude con la puja.
Non è raro vedere nelle sculture templari indiane rappresentazioni di coppie in atteggiamenti amorosi (mithuna). Tali iconografie sono molto più frequenti nelle produzioni artistiche dell’India settentrionale. Mentre nei templi del sud prevalgono le iconografie puraniche. Queste rappresentazioni sensuali si articolano su vari livelli, raffigurando scene che vanno dalla complicità all’amplesso di vario tipo. Solitamente in associazione con le rappresentazioni di mithuna proliferano anche le rappresentazioni di figure femminili, identificate come figure semidivine
 (talvolta chiamate apsara o devangana). Per quanto frequenti le iconografie erotiche nei templi assurgono al ruolo di vero e proprio programma iconografico nei templi di Khajuraho. Nonostante la grande importanza riservata alle rappresentazioni più esplicitamente erotiche, non dobbiamo cadere nell’errore di ignorare il fatto che esse facciano sempre parte di una narrazione più ampia del divino, infatti le pareti dei templi, anche nel caso di Khajuraho, pullulano di raffigurazioni di divinità, in forma di mithuna o meno.
(talvolta chiamate apsara o devangana). Per quanto frequenti le iconografie erotiche nei templi assurgono al ruolo di vero e proprio programma iconografico nei templi di Khajuraho. Nonostante la grande importanza riservata alle rappresentazioni più esplicitamente erotiche, non dobbiamo cadere nell’errore di ignorare il fatto che esse facciano sempre parte di una narrazione più ampia del divino, infatti le pareti dei templi, anche nel caso di Khajuraho, pullulano di raffigurazioni di divinità, in forma di mithuna o meno.
“Nell’abbraccio della sua amata un uomo dimentica il mondo intero, tutto ciò che è dentro e tutto ciò che è fuori; allo stesso modo, colui che abbraccia il Sé non conosce né il dentro né il fuori”. (Brhadaranyaka Upanishad). L’immaginario erotico templare può essere interpretato in parte come una trasposizione grafica di questo concetto. L’atto d’amore è scelto a rappresentare la condizione ultima nella quale l’individuo e l’universale cessano di essere separati. Quindi l’unione dei sessi vista come immagine divina permette il progresso sulla via della realizzazione.
Inoltre il saggio rinuncia ai piaceri mondani solo dopo averli esperiti. Le sculture erotiche sono le pietre di paragone che consentono all’uomo votato alla rinuncia di valutare se il suo desiderio di castità è genuino.
Non dimentichiamo poi che la religione deve portare a percepire il Divino anche in quelle forme che rendono maggiormente propensi a dimenticarlo. Se in qualsivoglia aspetto del manifesto smettiamo di percepire il Divino allora siamo sulla via erronea del dualismo.
L’atto amoroso è anche simbolo della bhakti, la devozione personale nei confronti della divinità che assume quasi le caratteristiche della passione amorosa.
“Vi è equivalenza tra l’unione dei sessi e la sillaba mistica AUM. Quando i due sessi di uniscono, allora nell’uno si compie il desiderio dell’altro” (Chandoghya Upanishad).
“In tale appagamento consiste la natura dell’unione tra I sessi […]. Nel mondo, un uomo e una donna si uniscono. Entrambi traggono piacere dalla loro unione, e si compie nell’uno il desiderio dell’altro. Ugualmente la sillaba AUM, per la congiunzione dei propri elementi, è il compimento di ogni desiderio (Commentario alla Chand. Up, di Shankaracharya).
L’approccio colonialista ha individuato nella scultura erotica il segno della decadenza morale nel periodo medievale indiano, ma questo è un grave errore. Qualunque interpretazione si dia ai rilievi erotici è essenziale chiarire che non vi è NULLA DI MORBOSO, SORDIDO O VERGOGNOSO in essi. Bisogna coglierne la grazia, l’eleganza, la fine manifattura prima ancora dei numerosi livelli di interpretazione simbolica. I movimenti sono fluidi, le posture estremamente aggraziate e studiatissime. Si coglie il reciproco abbandono negli sguardi degli amanti. Le genti che hanno prodotto questi rilievi senz’altro avevano una visione integrata della sessualità nella vita: kama (desiderio) è un passo necessario per conseguire moksha (liberazione).
Per comprendere l’arte erotica però non è possibile trovare una spiegazione univoca. La coppia in atteggiamento amoroso è simbolo di prosperità, fertilità e abbondanza, pertanto diventa un simbolo benaugurale.
Secondo alcuni studiosi ciascuna posizione dello yoga corrisponde ad una posizione erotica, che permette di esperire l’unione. Il legame della scultura erotica con lo yoga è stato letto come collegato alla diffusione nell’India medievale di dottrine tantriche e sette legate a comportamenti antinomistici (Es. Kapalika).
Khajuraho è un importante sito con rilievi erotici, molti altri templi in India hanno sculture erotiche, alcuni fra i più celebri sono:
- Sun Temple, Konark, Orissa
- Virupaksha Temple, Hampi, Karnataka
- Jain Temples, Ranakpur, Rajasthan
- Sun Temple, Modhera, Gujarat
- Lingaraj Temple, Bhubaneshwar, Orissa.
Per l’induismo lo scopo della vita è la soppressione del desiderio (kama) che tiene relegata la persona in questa dimensione terrena, cosicché, liberata dai legami, essa possa staccarsi da questo mondo doloroso e rei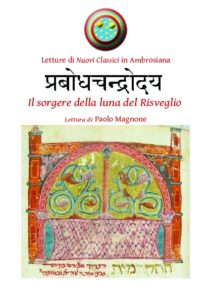 ncarnarsi in una condizione di vita migliore o cessare del tutto il ciclo delle rinascite. La tappa finale dell’essere umano è la definitiva unione con il Brahman, cioè l’Assoluto, Dio. Esso è un essere impersonale e “privo di forma” (a-rūpavat: Brahmasūtra III, cap. 2, 14) ma che sta alla base di tutto.
ncarnarsi in una condizione di vita migliore o cessare del tutto il ciclo delle rinascite. La tappa finale dell’essere umano è la definitiva unione con il Brahman, cioè l’Assoluto, Dio. Esso è un essere impersonale e “privo di forma” (a-rūpavat: Brahmasūtra III, cap. 2, 14) ma che sta alla base di tutto.
I culti indiani non riconoscono un vero e proprio politeismo, come può essere quello greco-romano: le diverse divinità sono tutte manifestazioni del Brahman. La dualità è la condizione che fa percepire l’uomo separato dalle cose. Invece è tutto uno: esiste una sola realtà. Per questo Vasugupta, nei suoi aforismi (36), riportava: “Cessata la dualità, può operare un’altra creazione” (bhedatiraskāre sargāntarakarmatvam). Per Shankara non è sensato sforzarsi di investigare la relazione tra il Brahman e il mondo, perché una relazione presuppone l’esistenza di due entità distinte che possano rapportarsi vicendevolmente, dal momento che il Brahman è la sola realtà, e il mondo non è reale né irreale e si può definire come ciò che non è caratterizzato da essere o non essere (sadasadvilakṣaṇa). Il Brahman e il mondo non sono differenti (ananya), quindi non possono essere messi in rapporto. Pertanto il rapporto tra il Brahman e il mondo è inesplicabile, inesprimibile (anirvacanīya).
La Bhagavadgītā, parte finale di un lungo poema epico indiano che fa parte dei Veda, i testi sacri dell’induismo, insegna che la estinzione del desiderio si ottiene mediante lo yoga (inteso come “il dissolvimento dell’unione con il dolore”, duḥkhasaṃyogaviyogaṃ yogasaṃjñitam VI, 23). Esistono tre tipi di yoga: karma-yoga o dell’azione (agire senza desiderio, senza volontà di agire), bhakti-yoga o devozionale (culto a una divinità), jñāna-yoga o della conoscenza (che si realizza sforzandosi di vedere “il proprio Sé dimorare in tutti gli esseri e tutti gli esseri nel proprio Sé”, sarvabhūtastham ātmānaṃ sarvabhūtāni cātmani VI, 29, vale a dire di vedere ovunque “la stessa cosa”, īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ VI, 29). Questo perché Brahman (Dio, Assoluto) e Ātman (anima individuale) coincidono.
Nel VI secolo a.C. il Buddha predicò nel nord dell’India e portò avanti una religione (definita dagli occidentali “buddhismo”, mentre i buddhisti la chiamano dharma) che si pone in contrasto con l’induismo. Infatti per il Buddha la tappa definitiva dell’essere umano, alla fine del ciclo delle rinascite, con è la unione con il Brahman, bensì la estinzione nel vuoto, nel nulla.
Le Quattro Nobili Verità alla base della dottrina del Buddha sono:
- esiste il dolore nella vita umana;
- il dolore nasce dal nostro attaccamento per ciò che è effimero: cose e persone;
- per eliminare il dolore dobbiamo lasciare andare l’attaccamento per ciò che è effimero;
- esiste un percorso per attuare questo, cioè per liberarsi dal dolore: è il Nobile Ottuplice Sentiero (retta comprensione, retta motivazione, retta parola, retta azione, retti mezzi di sussistenza, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione meditativa).
L’illuminazione o buddhità consiste nel passaggio dall’ignoranza (avijja) al rendersi conto di come è fatta l’esistenza. Chi mediante la pratica soprattutto della meditazione riesce ad ottenere questa conoscenza profonda del reale non è più come prima, è come se avesse fatto un viaggio ma alla scoperta della natura dell’esistenza, che è caratterizzata da:
- anicca: impermanenza, tutto è soggetto a mutamento, non c’è alcuna realtà stabile, perché tutto è vuoto e ciò che sembra stabile è dettato dalla ignoranza;
- anatta (formato da a + Ātman, cioè non Ātman): non esiste una individualità stabile, vale a dire non esiste l’ Ātman individuale degli induisti in quanto l’ Ātman universale non sussiste, essendo tutto vuoto;
- dukkha: sofferenza, determinata dall’attaccamento illusorio nei confronti di ciò che in realtà non è.
Nel buddhismo canonico il vuoto si situa almeno in questi ambiti:
- a livello di anatta: le cose non hanno una dimensione propria, non hanno una individualità, una forma esteriore e interiore che le separi dalle altre, in poche parole tutte le cose sono tra loro interdipendenti (teoria della pratityasamutpada);
- a livello di aniccia: le cose hanno un vuoto di continuità, per cui svaniscono all’improvviso, sono fumo che si dilegua, sono in poche parole impermanenti;
- a livello della coscienza: emozioni, sensazioni, pensieri, volontà sono mutevoli, quindi sono vuoti, non hanno essenza stabile;
- a livello della coscienza dell’impermanenza: anche questa idea è vuoto, il buddhismo arriva al vuoto assoluto anche della illuminazione, “vuoto del vuoto” (sunya sunyata).
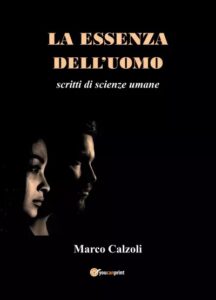
Questa idea del vuoto è presente già nei testi canonici del buddhismo, ma viene esaltata anche nella Prajnaparamita, composta da Vimalakirti Nirdesa Sutra (I secolo d.C.), Sutra del Cuore (IV secolo), Sutra del Diamante (IV secolo). In questi testi si dice che ogni essere ha una essenza vuota. Ciò vuol dire che la essenza di ogni essere si identifica con l’assenza di forme composte stabili in sé stesse. Non avendo forme stabili un essere semplicemente è mutevole, è impermanente.
Nella biografia del Buddha attribuita a un certo Buddhagoṣa (da non confondere con quello più noto) e intitolata Padyacūḍāmaṇi, il Buddha alla fine ottiene la illuminazione con queste parole conclusive (X, 59):
siddhārthaś ciravāsanāparigatān ucchidya doṣadviṣo
muktikṣetrakuṭumbarakṣaṇavidhau mūrdhābhiṣikto ‘bhavat,
“Avendo estirpato i nemici che sono i vizi, accompagnati per lungo tempo dalle tracce mentali, (egli) si consacrò al compito di proteggere la famiglia (di coloro che dimorano) nella terra della liberazione”.
Il Buddha, vinta l’ultima tentazione costituita dalla seduzione delle donne inviate da Kama, ha sradicato da sé i vizi (doṣa) e le tracce mentali (vāsāna) che li generano, le quali tra l’altro fanno credere che la realtà esista in sé stessa. Quindi egli consegue l’illuminazione, votandosi alla protezione di coloro che seguiranno il suo insegnamento.
Aśoka, terzo sovrano della dinastia Maurya, regnò sull’India per più di trenta anni nel III secolo a.C. I suoi editti, incisi su colonne e su roccia nei luoghi più vari del suo regno, sono fra le più antiche testimonianze di scrittura che l’India ci abbia trasmesso. Ad eccezione di quelle rinvenute nel Panjab, tutte le epigrafi sono nella scrittura detta Brahmi, un sistema alfabetico destrorso, di origine semitica, prototipo della scrittura devanagari. Le poche epigrafi del Panjab sono nella scrittura Kharosthi, sinistrorsa, di origine aramaica. La lingua è fondamentalmente quella medio-indiana della cancelleria imperiale del Magadha, naturalmente le versioni riflettono peculiarità dei dialetti locali e non possono escludere errori degli amanuensi e dei lapicidi.
Aśoka si convertì al buddhismo e negli editti traspare la sua nuova fede. Infatti gli orrori della guerra di conquista procurarono in lui una crisi mistica che lo portò a convertirsi al buddhismo come devoto laico (upasaka). Nell’editto XXIV è detto che la conversione prese piede gradatamente e il suo zelo divenne intenso dopo un anno e mezzo. Ma la predicazione che fa Aśoka non è quella buddhista in senso stretto, il sovrano infatti promulga un insegnamento che sia possibile a tutti, cioè ai seguaci di ogni tipo di confessione religiosa. Egli promulga l’amore universale (insegnamento tipico del buddhismo) ma anche il rispetto per ogni credo e ogni condizione delle persone a cui giunge l’insegnamento.
In seguito il buddhismo si staccò dall’India e oggi è diffuso soprattutto fuori dall’Asia meridionale. Mentre l’induismo è una religione tradizionale, il buddhismo viene fondato di sana pianta dal Buddha storico.
Anche l’ebraismo è una religione tradizionale, che c’è sempre stata presso gli ebrei, mentre il cristianesimo emerge dal primo mediante la predicazione di Gesù Cristo. Ebraismo, cristianesimo e Islam credono in un solo Dio: monoteismo.
Ebraismo e cristianesimo basano il loro credo sulla Bibbia, una raccolta di 46 libri (Antico Testamento) + 27 libri (Nuovo Testamento). L’Antico Testamento è scritto quasi tutto in ebraico (tranne sette libri in greco e alcune sezioni in aramaico), invece il Nuovo Testamento ci è giunto tutto redatto in greco.
La Bibbia è una immensa opera letteraria che conosce tutti i generi e le risorse della letteratura di tutti i tempi. I suoi libri sono sia in prosa sia in poesia. I linguisti e i filologi li studiano in continuazione analizzando minuziosamente lessico, grammatica e stile, le fonti, e così via. La poesia biblica si caratterizza, a detta di Kugel, con una peculiare coincisione espressiva (terseness), talora ambiguamente ellittica, che segnala la levatura del dettato poetico.
La Bibbia serba tesori di altissima qualità letteraria, soprattutto la poesia. Nel Cantico dei Cantici, delizioso poemetto di poco più di mille parole ebraiche, ma intensissimo, nel quale viene cantato l’amore di un amato e di una amata, è scritto (1, 9-10):
“9 Alla puledra del cocchio del faraone
tu somigli, o compagna mia!
10 Affascinanti sono le tue guance tra gli orecchini,
il tuo collo tra fili di perle!”
Citiamo solo questi due versetti, che sono stati commentati da millenni sia dagli ebrei che dai cristiani. La comparazione dell’amata a una puledra può sembrare strana alla nostra sensibilità, ma era consueta nell’antichità: il cavallo era visto come uno degli animali più belli e i migliori erano scelti da personaggi illustri, come il faraone qui menzionato. Immagine plastica di agilità e di eleganza. Il cavallo con la raffinatezza della sua forma, il fremito dei suoi muscoli, l’armonia della sua corsa è un simbolo di perfezione e di bellezza. Ma l’immagine della puledra richiama anche la fecondità: nel corposo realismo della poesia amorosa dell’antichità i fianchi opulenti di una donna sono a volte paragonati a quelli della cavalla e visti come espressione non solo di bellezza ma anche di capacità gener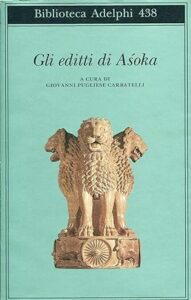 ativa. Non dimentichiamo poi che il faraone Amenofi II era innamorato di una delle sue cavalle, quindi possiamo ravvisare anche un’altra iridescenza segreta nella menzione del faraone in questo passo biblico, cioè la donna amata suscita attorno a sé una attrazione irresistibile. La poesia biblica è spesso polisemica: l’ebraico biblico è una lingua assai povera (con solo 5000 parole diverse) e compensa questa mancanza con significati vertiginosi da dare allo stesso termine. Ci soffermiamo sul valore del vocabolo ra’jati, che abbiamo tradotto con “compagna”. C’è senz’altro una allusione alla radice ebraica r’j, “prendersi cura, deliziarsi, provar piacere”: quindi questa donna è un essere tenero di cui prendersi cura e in questa maniera deliziarsi nell’atto di proteggerla e sostenerla. Ma all’ebreo di allora il termine doveva richiamare alla mente anche la radice ebraica di rea’, “prossimo, vicino”, con una connotazione di tenerezza, di vincolo amoroso, di solidarietà di vita. Quanti significati e sfumature in queste poche parole! Nel secondo versetto che abbiamo richiamato, compare anche un hapax (un termine che nella Bibbia è attestato una sola volta), quindi un preziosismo linguistico: ḥarukim, che nell’ebraico posteriore significherà il filo di perle o pietre preziose o coralli. In 4, 9 compaiono collane di perle sul collo della donna. Possiamo quindi pensare che anche qui si tratti di una immagine analoga.
ativa. Non dimentichiamo poi che il faraone Amenofi II era innamorato di una delle sue cavalle, quindi possiamo ravvisare anche un’altra iridescenza segreta nella menzione del faraone in questo passo biblico, cioè la donna amata suscita attorno a sé una attrazione irresistibile. La poesia biblica è spesso polisemica: l’ebraico biblico è una lingua assai povera (con solo 5000 parole diverse) e compensa questa mancanza con significati vertiginosi da dare allo stesso termine. Ci soffermiamo sul valore del vocabolo ra’jati, che abbiamo tradotto con “compagna”. C’è senz’altro una allusione alla radice ebraica r’j, “prendersi cura, deliziarsi, provar piacere”: quindi questa donna è un essere tenero di cui prendersi cura e in questa maniera deliziarsi nell’atto di proteggerla e sostenerla. Ma all’ebreo di allora il termine doveva richiamare alla mente anche la radice ebraica di rea’, “prossimo, vicino”, con una connotazione di tenerezza, di vincolo amoroso, di solidarietà di vita. Quanti significati e sfumature in queste poche parole! Nel secondo versetto che abbiamo richiamato, compare anche un hapax (un termine che nella Bibbia è attestato una sola volta), quindi un preziosismo linguistico: ḥarukim, che nell’ebraico posteriore significherà il filo di perle o pietre preziose o coralli. In 4, 9 compaiono collane di perle sul collo della donna. Possiamo quindi pensare che anche qui si tratti di una immagine analoga.
Il Nuovo Testamento è scritto in greco ma da ebrei, quindi risente delle forme linguistiche e contenutistiche del giudaismo. La sintassi è semplice, spessissimo paratattica (soprattutto il vangelo di Marco), ad imitazione dell’ebraico biblico. Sono molti i semitismi, cioè espressioni greche ma che si giustificano con lo sfondo giudaico, per esempio quando si parla del “mare di Tiberiade”, che è un lago, in quanto in ebraico una sola parola, yam, indica sia il mare sia il lago. Lo stile dei vangeli è molto terso e icastico, con una prosa che assomiglia a quella giornalistica di oggi, un po’ espressione di una vocazione alla memoria e alla fedeltà dei fatti.
Oggi un campo di studi che sta evolvendosi è quello della controversistica giudaica (mahloqet) in rapporto agli scritti del Nuovo Testamento. Gli ebrei facevano spesso delle dispute per questioni dottrinarie e giuridiche, nonché di amministrazione, e le risolvevano interpretando un passo della Bibbia. Quindi queste controversie nascevano esternamente dalla Bibbia e si risolvevano internamente alla Bibbia stessa. Queste dispute erano dipanate quindi mediante delle regole esegetiche (middot) che i rabbini, specie Hillel, avevano formalizzato per capire a fondo la Bibbia.
La più antica menzione di una disputa giudaica la abbiamo nel Pirkè Avot (5, 18). Dai testi giudaici si evince che esistevano due tipi di dispute: quelle fatte per raggiungere la verità (come tra Hillel e Shammai) e quelle fatte per opporsi alla autorità, cioè per litigare e sovvertire il potere (il cui esempio massimo è la sedizione di Core e dei suoi seguaci contro Mosè e Aronne in Numeri 16).
Anche Gesù nei vangeli intrattiene spesso dispute con i giudei. In Matteo 22, 34-40 è scritto: “Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?. Gli rispose: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente (Deuteronomio 6, 5). Questo è il più grande e il primo dei comandamenti, autē estin ē megalē kai prōtē entolē. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso (Levitico 19, 18). Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”. È sorta una controversia e Gesù la risolve mediante l’applicazione di una regola esegetica rabbinica, nello specifico la gezerah, che pone a confronto due passi biblici diversi con lo scopo di trovarne un nesso in comune. Nel passo di Matteo il nesso è l’amore, che accomuna la citazione del Deuteronomio e quella del Levitico, tanto che nella versione parallela di Luca (10, 25-28) seguire questi due precetti costituisce la condizione per ottenere la vita eterna.
La controversia ha un inizio (la discussione tra due contendenti) e ha una fine, suggellata dalla middot, cioè dalla regola esegetica la quale, entrando nel vivo del testo biblico, lo interpreta in una chiave vincente. Per questo la controversia e la regola esegetica sono intimamente unite, soprattutto la gezerah.
Per l’Islam i grandi personaggi dell’Antico Testamento e Gesù Cristo sono profeti (rasul), i quali preparano la via all’ultimo profeta, Maometto, il quale riceve la rivelazione divina mediante l’arcangelo Gabriele nel VII secolo d.C.. Invece per il cristianesimo Cristo è Dio che si è fatto uomo.
Non esiste un solo Islam, diciamo che ogni nazione ha un tipo particolare di interpretazione del Corano, ma grossomodo esistono due tipi fondamentali di religione islamica: il sunnismo (quello ortodosso, diffuso soprattutto in Arabia Saudita) e lo sciismo (la minoranza, soprattutto in Iran).
L’Islam si fonda sul Corano, che costituisce non solamente la legge religiosa ma anche quella civile. Come interpretazione del Corano, sono nati sia nel sunnismo sia nello sciismo un diritto e una giurisprudenza.
Islam significa etimologicamente “sottomissione” a Dio, quindi è una parola strettamente connessa a din, comunemente tradotto come “religione”, ma che ha più il senso degli “obblighi” cui Dio assoggetta l’uomo in quanto creatura. Nel termine è dunque implicita l’idea del debito che l’uomo ha verso Dio a seguito del “patto primordiale” (mītāq). Più precisamente l’islam è un “arrendersi” (taslīm) alla volontà di Dio nella forma in cui è espressa nel Corano, è una “obbedienza” (inqiyād) ai suoi comandamenti.
Il Corano esiste e è tramandato dalla “comunità” (umma) dei musulmani, quindi la fede islamica si connota entro la comunità islamica, la quale compie gli atti religiosi. Ragion per cui mulk e din sono fratelli gemelli: lo Stato e la religione sono intimamente legati e partecipi l’uno dell’altro.
Sono tre i modi con i quali Dio comunica la Sua conoscenza che deve essere seguita dagli uomini:
- Waḥy: rivelazione ai profeti e soprattutto al Profeta Maometto, che è rivolta a tutta la comunità;
- Ilhām: rivelazione privata;
- ‘Ilm ‘aqli: conoscenza razionale (filosofica, teologica, scientifica) che può essere ottenuta per deduzione, ma è sempre un dono del Dio creatore di tutto.
Questi tre modi valgono per i sunniti. Invece per gli sciiti ogni conoscenza e ogni magistero vengono demandati alla figura dell’Imam.
L’Islam non è la religione ideale, ma l’unica religione, le altre religioni (adyān) sono tali solo in quanto partecipano dell’Islam. Per l’Islam anche i grandi profeti del passato, come Abramo, Mosè, Gesù, sono “musulmani” nel senso che si sono abbandonati a Dio. Ogni profeta del passato ha la sua milla (“comunità” specifica e “credo” specifico), ma il din è unico. Il din è una combinazione di:
- Pratica dell’Islam;
- Contenuti della fede, imān;
- Interiorizzazione della fede, iḥṣān.
I cinque precetti fondamentali dell’Islam sono:
- Fede nell’unico Dio e nel suo Profeta Maometto (shahāda);
- Preghiera (salat);
- Elemosina (zakat);
- Digiuno (sawm);
- Viaggio alla Mecca almeno una volta nella vita (hajj).
Per alcune scuole il jihad armato sarebbe quasi un sesto precetto. La parola jihad è un termine comunemente utilizzato nel linguaggio islamico e presente nel testo del Corano che tradotto letteralmente significa “sforzo”. Oggi, jihad è diventato un termine giornalistico molto utilizzato nel linguaggio comune, che si traduce come “guerra santa” per indicare dei guerriglieri – terroristi (spesso definiti “jihadisti”) che si oppongono agli infedeli.
Bisogna fare una doverosa premessa sul concetto di jihad che varia in riferimento ad un periodo storico ben preciso:
-
Al tempo della rivelazione coranica, il Profeta Maometto si trovava a La Mecca e il concetto di jihad veniva interpretato come “sforzo spirituale per comprendere i misteri divini”, una vera e propria lotta interiore.
-
Successivamente, con il trasferimento a Medina e la nascita di un vero e proprio Stato Islamico il Corano autorizza il combattimento difensivo attraverso le parole harb (guerra) e qitâl (lotta).
Nella tradizione islamica, i musulmani danno alla parola jihad sostanzialmente due significati:
-
jihād al-ākbar e cioè grande jihad che ha un significato interiore: consiste nella lotta contro il male e contro le propulsioni del peccato e dell’Io.
-
jihād as-asghar e cioè piccolo jihād che ha un significato esteriore: consiste in uno sforzo militare, cioè una guerra legale; da esercitarsi solo in caso di attacco personale.
Per quanto riguarda il jihad armato, si distingue tra:
-
Jihād difensivo: la stragrande maggioranza dei musulmani considera la lotta armata contro l’occupazione straniera o contro un regime dittatoriale interno troppo opprimente, come degna causa del jihad difensivo.
-
Jihād offensivo: consiste in una vera e propria guerra di aggressione e di conquista contro i non-musulmani e gli infedeli (kafiruna).
Spesso si confonde il jihad religioso con il fenomeno del terrorismo islamico, che è balzato prepotentemente all’onore della cronaca internazionale con gli attentati del 11 settembre 2001. In realtà i due fenomeni non sono sempre la stessa cosa.
L’esoterismo islamico più conosciuto in Occidente è il sufismo. Quando parliamo di esoterismo, ci riferiamo a un insegnamento segreto ai profani, il quale viene rivelato solo a una cerchia di prescelti. Il sufismo quindi è al di là del sunnismo e del sciismo, insegnamenti rivolti a tutti i credenti, ma viene riservato a degli iniziati. È un po’ come la cabala per l’ebraismo e la gnosi per il cristianesimo, due forme di esoterismo entro queste due religioni monoteiste.
del sciismo, insegnamenti rivolti a tutti i credenti, ma viene riservato a degli iniziati. È un po’ come la cabala per l’ebraismo e la gnosi per il cristianesimo, due forme di esoterismo entro queste due religioni monoteiste.
Il più grande sufi (nonché teologo dell’Islam) è Ibn Arabi, un pensatore musulmano medioevale terribilmente importante, dopo il quale la riflessione islamica non sarà più la stessa cosa. Ibn Arabi era un teologo, come abbiamo detto, invece il più grande poeta mistico del sufismo è stato Rumi (1207-1273), considerato da Nicholson “il più grande poeta mistico di tutti i tempi”.
Il più grande poeta profano della letteratura persiana è stato Hafez, invece il più grande poeta religioso è stato Rumi. Rumi scrive un Canzoniere immenso e anche un’opera diremmo teologico-poetica, insomma teosofica, il Masnavi. Il Masnavi appartiene ad un genere non usuale in Occidente, nel quale Rumi fa un continuo monologo interiore o flusso di coscienza, cioè inizia un argomento poi se ne allontana per parlare di altro per molte righe e alla fine si riallaccia al primo argomento. Pensiamo a certa musica orientale che sviluppa temi assai diversi ma sembra ritornare continuamente su sé stessa. Il Masnavi di Rumi è fatto in maniera analoga, possiamo dire in qualche misura, come è il Corano.
Per l’Islam ortodosso Dio è un essere vivente, è un grande Signore che domina l’intero mondo degli uomini, del quale è il padrone, sedendo su un trono in cielo. Invece per Rumi Dio e Nulla (‘adam) coincidono. È una tesi estrema del sufismo, il quale per diversi aspetti dottrinari non è stato sempre accettato dalla ortodossia islamica (kalam). Nel Masnavi Rumi scrive: “Volgiti dall’Essere verso il Nulla, se cerchi Dio e sei divino … Il Nulla è il luogo delle entrate, l’Essere è il luogo delle spese, il luogo del più e del meno”. Dio è al di sopra di tutti gli schemi umani: essere/non essere, bene/male, e quant’altro.
Si racconta che Rumi componesse versi (Canzoniere e Masnavi) mentre danzava in estasi. A sua imitazione sono nati i cosiddetti dervisci danzanti, sufi che riescono tuttora ad entrare in estasi e a parlare con Dio danzando vorticosamente. Quindi Rumi era ispirato dal mondo soprannaturale mentre compiva tali strane piroette, questo giustifica il fatto che le sue opere non sono internamente coerenti in senso occidentale, ma presentano diversi aspetti, all’apparenza contraddittori, della esperienza che il mistico Rumi fece del mondo divino.
Rumi era un iniziato. Il suo passaggio fondamentale avvenne con la conoscenza del suo illustre maestro, sconosciuto, che egli chiama Sole di Tabriz. Rumi riesce quasi a divinizzarlo tanto ne era attaccato nella venerazione. Pensiamo al fatto che il genere persiano del ghazal, paragonabile al nostro sonetto, cioè un breve componimento lirico, prevede al penultimo verso il nome dell’autore della poesia, invece Rumi innova e inserisce lo pseudonimo del suo grande maestro. Ebbene, la conoscenza iniziatica prevede che il contenuto degli insegnamenti sia segreto non solo perché i profani non ne sono degni, ma molte volte anche perché la conoscenza iniziatica non è esprimibile in un discorso coerente, “umano”, logico. L’iniziato ha visto trasformarsi il proprio essere, ha acquisito quella luce interiore che gli permette di conoscere per intuizione quelle realtà celesti che pertanto non sono comunicabili secondo un ragionamento logico-discorsivo.
La controversia fondamentale tra sunniti e sciiti è che i secondi riconoscono come legittimo successore di Maometto suo genero, che sposò la figlia del Profeta, di nome Fatima (secondo una catena di Imam che dura nei secoli), invece i sunniti fanno passare il testimone per elezione non legata al sangue. Rumi non parteggia né per i primi né per i secondi, e dice che non sono gli Imam i veri detentori della volontà di Dio ma “l’uomo di Dio”, cioè la persona ispirata da Dio stesso, quale essa sia.
Nella concezione dell’Uomo di Dio vediamo concentrata l’essenza del sufismo di Ibn Arabi: la unità di tutte le cose, tutto è Dio, invece per i sunniti Dio è radicalmente separato dagli uomini e dal resto del mondo. L’Uomo di Dio è Dio stesso, è il segno della unità divina. Pertanto Dio non è come voluto da certe scuole una materia impersonale bensì un essere personale, una Persona vera e propria, seppur coincidente con il Nulla. È questo il senso della espressione di Rumi (ode 6, Poesie mistiche, curate da Bausani, piccolo estratto dal Canzoniere): Ya hu, Ya man nu, “Oh Lui! O colui che è Lui!”, concentrazione in un punto luminosissimo della Realtà Assoluta, la Personalità di Dio.
È straordinaria questa lode all’Uomo di Dio, del Canzoniere, che riportiamo integralmente nella traduzione di Bausani (ode 1):
“L’Uomo di Dio è, senza vino, ubriaco,
l’Uomo di Dio è, senza cibo, sazio.
L’Uomo di Dio è pazzo e stupito,
l’Uomo di Dio non mangia e non dorme.
L’Uomo di Dio è re sotto il saio,
l’Uomo di Dio è, in diroccate rovine, tesoro.
L’Uomo di Dio non è d’aria né di terra,
l’Uomo di Dio non è di acqua né di fuoco.
L’Uomo di Dio è mare senza sponde,
l’Uomo di Dio piove perle senza bisogno di nube.
L’Uomo di Dio ha cento lune e cieli,
l’Uomo di Dio ha pur cento soli.
L’Uomo di Dio è per Realtà (divina) sapiente,
l’Uomo di Dio non ha dottrina di libro.
L’Uomo di Dio è oltre fede e non-fede,
l’Uomo di Dio è oltre il male e il bene.
L’uomo di Dio è cavaliere venuto dal Nulla,
l’Uomo di Dio è venuto su glorioso destriero.
L’Uomo di Dio è il Sole nascosto (il maestro di Rumi),
l’Uomo di Dio tu cerca e tu trova!”.
Bibliografia
- C. Baffioni, Filosofia e religione in Islam, Roma 1997;
- P. Basta, Mahloqet, Roma 2022;
- Buddhagoṣa, Padyacūḍāmaṇi. Il diadema dei versi, a cura di M. Franceschini, Milano 2010;
- M. Calzoli, La essenza dell’uomo, Lecce 2022;
- G. P. Carratelli (a cura di), Gli editti di Aśoka, Milano 2003;
- S. Kramrisch, Il tempio indù, Milano 2013;
- J. L. Kugel, The Idea of Biblical Poetry, New Haven 1981;
- A. Pelissero, Dizionarietto di sanscrito per filosofi, Brescia 2021;
- G. Ravasi, Il Cantico dei Cantici, Bologna 1992;
- Rumi, Poesie mistiche, a cura di A. Bausani, Milano 2022.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 49 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.