Però già avverto, con tutte le buone intenzioni,
che in petto torna a gemere l’insoddisfazione.
Perché deve inaridirsi così presto la corrente
e noi rimanere assetati?
Tanto spesso ne ho fatto esperienza.
Eppure, a questo vuoto si può dare compenso:
si impara quanto valgano le cose ultraterrene,
si cerca la Rivelazione
che mai più degna splende e più bella
come nel Nuovo Testamento.
J. W. GOETHE, Faust, 1210-1219.
Il canone (dal greco kanōn, “canna di misurazione”, quindi “norma, regola”) dei libri del Nuovo Testamento è stato fissato definitivamente, insieme a quello veterotestamentario, per il mondo cattolico, ad opera del Concilio di Trento, nel 1546. Gli ortodossi concordano con quello cattolico, invece i protestanti differiscono per l’inserimento di alcuni libri.
I protestanti non accettano: Lettera agli Ebrei, Lettera di Giacomo, Seconda Lettera di Pietro, Seconda e Terza Lettera di Giovanni, Lettera di Giuda, Apocalisse. Sono, per i cattolici, i testi cosiddetti “deuterocanonici” (cioè non ritenuti ispirati in alcuni tempi e in alcune comunità: i protestanti li chiamano “apocrifi”), di contro ai “protocanonici” (sui quali non ci furono mai dubbi sull’ispirazione), che sono tutti gli altri. Tuttavia, le edizioni protestanti della Bibbia li inseriscono, seppur a parte, per l’indubbio valore storico-culturale. Per quanto riguarda l’Antico Testamento, ricordiamo che i protestanti, in conformità al canone ebraico, non accettano i libri deuterocanonici veterotestamentari (detti anch’essi, allora, apocrifi), cioè Tobia, Giuditta, Primo e Secondo Libro dei Maccabei, Baruc, Siracide, Sapienza, alcuni brani di Ester e di Daniele.
Il primo autore ad usare l’espressione “Nuovo Testamento” fu Tertulliano; tuttavia, la prima lista dei testi accettati dalla comunità cristiana (di contro a quelli non accettati, detti “apocrifi”) risale alla fine del II secolo con il Frammento Muratoriano (che non presenta la Lettera agli Ebrei, la Lettera di Giacomo e quelle di Pietro). Invece nella lista di Origene si paventano dubbi sulla Seconda Lettera di Pietro e sulle due di Giovanni (mentre Eusebio informa che alcuni non credono all’ispirazione delle lettere di Giacomo e di Giuda; liste incomplete sono anche quelle di Ireneo e di Tertulliano). Il canone Claromontano (redatto dopo il Concilio di Ippona del 393) non accetta la Lettera agli Ebrei.
Alla fine del IV secolo il canone sarà completo: così nella lettera di Atanasio del 367, mentre la Vulgata sarà basata su un elenco completo di tutti gli scritti neotestamentari. In tal modo questo canone potrà essere riperso dal Concilio di Firenze del 1441 e infine dal Concilio di Trento che ne sancì la definitiva accettazione.
“Nuovo Testamento” si collega all’espressione greca kainē diathēkē, “nuova alleanza” (per es., presente due volte nella Lettera agli Ebrei: 8, 8; 9, 15), indicando l’alleanza che Dio ha fatto con gli uomini in Cristo, di contro all’antica alleanza, soprattutto quella del Sinai, ma pensiamo anche a quella con Abramo di Genesi 15, 18 o a quella con Davide nel Secondo Libro di Samuele, 7, 16. Il termine diathēkē, che nel greco classico equivale a “testamento”, è stato assunto dagli autori neotestamentari (con una presenza pari a 33 volte, delle quali circa la metà si riferiscono all’alleanza veterotestamentaria) secondo l’uso della Septuaginta, che vi traduce l’ebraico “berit “, “alleanza” (mentre Aquila usa sunthēkē) oppure anche (Paolo e Marco) con il senso di “disposizione”, imposizione della volontà divina nei riguardi degli uomini. L’aggettivo kainos, come nel greco classico, significa nella koiné una novità qualitativa (di contro a neos, che si riferisce a una novità quantitativa, cronologica, significando soprattutto “giovane” e “fresco”); non solo, ma la Lettera agli Ebrei (un testo scritto in un greco raffinato, ma anche con un forte afflato giudaico, costituendo nel complesso un midrash, cioè una particolare interpretazione di passi biblici come si era venuta costituendo nella letteratura giudaica) si collega a Geremia (31, 31 ), un profeta dell’Antico Testamento che parla di “alleanza nuova”: in ebraico l’aggettivo significa anche “perfetto” e “definitivo” (si noti la bellissima variatio che l’autore neotestamentario fa in 12, 24: dopo aver affermato che l’alleanza di Cristo è perfetta, dice anche che è giovane, fresca, spontanea, gioiosa, poiché usa l’aggettivo greco neà) . La traduzione latina è stata “novum testamentum”: il sostantivo latino (deverbale da “testor“ con il suffisso “–mentum“ che indica il prodotto o il risultato di un’azione) si riferisce allora al prodotto della dichiarazione di Dio della nuova alleanza, cioè il Nuovo Testamento.
I principali criteri di canonicità dei testi del Nuovo Testamento sono stati: origine apostolica, uso liturgico, ortodossia di dottrina, presenza nelle liste antiche del canone. Ben sapendo, però, che nessuno di essi, preso isolatamente, è bastato alla Chiesa per determinare la canonicità o meno di uno scritto.
Quindi il Nuovo Testamento è formato da 27 scritti con un totale di circa 140.000 parole greche.
Vangeli e Atti degli Apostoli. I Vangeli costituiscono un genere letterario nuovo: sono storie della vita e del messaggio di Gesù che, pur avendo indubbiamente alcuni punti in contatto con il filone biografico greco e romano (come le Vite parallele di Plutarco e il De viris illustribus di Svetonio), risultano innovative perché si rivelano come un modello letterario unico in cui storia e messaggio si fondono in un impasto omogeneo.
Sulla novità della Bibbia intera si consideri quanto E. Auerbach (Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino 1956) distingue nella letteratura, cioè due stili fondamentali, quello omerico e quello biblico, che da tempo ha preso il sopravvento: mentre il primo vuol dire tutto e ha un afflato totalizzante (come si vede nell’ “appiattimento sincronico“ delle similitudini), il secondo è costituito da allusività e progressione conoscitiva, vuole una reazione o cambiamento in chi legge e presenta personaggi con passioni e comportamenti contraddittori (“oscillazione pendolare“).
Mentre l’atteggiamento che in passato si riservava alla Bibbia è esemplificabile in quello di Giustino e di Agostino (di formazione pagana che, per questo, non si rivolsero, prima della conversione o quasi, alla lettura dei libri biblici perché, come ebbe a sostenere anche Taziano, erano considerati opere barbare), oggi si assiste a una rivalutazione della qualità letteraria della Bibbia, della “via pulchritudinis“ (Hans Urs von Balthasar) che brilla in essa, che si esprime secondo regole stilistiche vere e proprie, peculiari alla cultura ebraica e mediorientale in genere (cfr. L. A. Schōkel, Manuale di poetica ebraica, Brescia 1989; R. Alter, L’arte della narrativa biblica, Brescia 1990 ), pur allacciandosi, come ogni grande creazione letteraria e artistica in genere, alle corde profonde dell’animo umano di ogni tempo e nazione. Ovviamente non nel complesso: si va, infatti, da scritti modesti come le infinite e monotone elencazioni delle Cronache a opere di alta poesia come i Salmi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Isaia o alla prosa dei Vangeli – con quella secchezza tanto in voga oggi con lo stile giornalistico e quel guardare da lontano, non come disinteresse o non curanza, ma come vocazione alla memoria – o agli scritti di Paolo, intenso e magmatico.
Per questo i due Testamenti sono stati Il grande codice (Frye) della cultura occidentale, il punto di riferimento ineludibile. Basterebbe solo pensare alla pittura (dal Medioevo e dalla “Bibbia dei poveri“ che erano le decorazioni delle chiese a Marc Chagall), alla musica (Bach, il Requiem di Mozart, Verdi, Brahms), a opere letterarie come la Divina Commedia, il Faust di Goethe, il Paradiso perduto di Milton. Quindi ben al di là degli ambiti propri della religione cattolica, estesa sì ma pur circoscritta entro certi limiti: pensiamo solo all’influenza sul Corano o sulla filosofia ermetica (ad es., l’Asclepius o anche il Crater Hermetis di Ludovico Lazzarelli. Cfr. C. Moreschini, Storia dell’ermetismo cristiano, Brescia 2000).
Matteo, Marco e Luca (il quale ha scritto anche gli Atti, che sono un prolungamento del suo Vangelo) costituiscono i cosiddetti “sinottici“ perché hanno molti tratti in comune, mentre Giovanni si pone originalmente a parte. Anticamente si pensava che Marco fosse una specie di riassunto di Matteo e Luca, mentre l’esegesi moderna ritiene che Marco sia stato il primo a comporre un vangelo, al quale poi hanno attinto Matteo e Luca (le parti di questi ultimi che non si ritrovano in Marco, sarebbero ottenute da una fonte sconosciuta, detta Q o Quelle da Wernle nel 1899).
In realtà, il cosiddetto “problema sinottico“ è ben più complesso. Gli studi su questo filone problematico partirono dalla constatazione dell’esistenza di una “triplice tradizione” (materiale comune ai tre vangeli), di una “duplice tradizione“ (materiale che hanno in comune solo Marco e Matteo, o Marco e Luca, oppure Matteo e Luca), e di una “tradizione semplice” (peculiarità dei singoli vangeli). Pertanto si è arrivati alla conclusione che, posto Marco come la fonte comune a Matteo e Luca (“triplice tradizione”), questi ultimi si basarono per le parti ad essi comuni (come il Pater noster: Mt 6, 9-13 e Lc 11, 2-4 ) sulla fonte Q, mentre le peculiarità singolari (quasi assenti in Marco, più estese in Matteo, frequenti in Luca) si spiegano in linea di massima come visioni teologiche proprie (in buona sostanza, Marco ha il “segreto messianico”, Matteo presenta una fortissima ascendenza rispetto l’Antico Testamento, Luca ha tematiche proprie come la gioia, la misericordia, il viaggio –tutto il ministero di Gesù è visto come un cammino fino a Gerusalemme e da lì fino al Padre), pur ammettendo, particolarmente per Luca, l’esistenza anche di fonti proprie.
Giovanni invece ha utilizzato principalmente fonti proprie, cosa che lo differenzia notevolmente dagli altri evangelisti: alcuni individuano “fonte dei segni”, “fonte della passione“ e “fonte dei discorsi di rivelazione”, altri pensano al “documento C”.
Forse la difformità più eclatante di Giovanni rispetto ai sinottici è costituita dall’assenza della istituzione eucaristica. Fra le molte teorie nate per spiegare questa singolarità: Erganzungstheorie (Giovanni narra solo ciò che nei sinottici si trova omesso), Arcandisziplin (motivazioni misteriche), Loisy (pur presentando la Cena, Giovanni vuole proporre l’Istituzione in termini meno semplici dandone lo stesso significato al gesto della lavanda dei piedi, atto di amore totale), Dodd ( Giovanni non vuole porre l’accento sull’azione rituale-sacrificale, perché la salvezza non si ottiene già dalla redenzione, bensì dalla comunione con Dio, quindi sostituisce al pane della Cena il pane e il pesce del cap. 6 e al calice il racconto della vite del cap. 15), Bultmann (dato che per il teologo tedesco Giovanni non ha alcun interesse sacramentale, quest’ultimo semplicemente omette la istituzione eucaristica, presentando però nella preghiera sacerdotale del cap. 17 il tema centrale, giacché Gesù leva la voce per la chiesa sorta in base al sacrificio glorioso della croce).
Brown (The Gospel according to John, New York 1966-1970) sosteneva, in conformità alla maggior parte degli orientamenti esegetici contemporanei, che il Vangelo di Giovanni sia sorto in tappe successive, presupponendo sì la presenza di Giovanni, ma soprattutto entro la tradizione giovannea. In particolare, egli individua cinque tappe di formazione: 1) Giovanni che ha visto gli avvenimenti di Gesù (13, 23-25) e ha dato avvio alla tradizione orale; 2) raccolta scritta, non sistematica, di alcuni fatti salienti tramandati oralmente (tipo il Libro dei Segni, cioè il complesso dei sette miracoli di Gesù presenti nel Vangelo di Giovanni, cap. 1-12 ); 3) unione degli scritti precedenti in una prima edizione, sicuramente non compiuta dal Giovanni testimone oculare; 4) seconda edizione, consistente in ritocchi minimi, alcuni nemmeno coordinati perfettamente con il testo precedente (ad es., in 9, 22-23 si testimonia la prassi storica – ma che non sussisteva già ai tempi della vita di Gesù – della scacciata dei cristiani dalla sinagoga ); 5) ultima edizione, consistente soprattutto nell’aggiunta del secondo finale, il capitolo 21.
Bisogna notare che i Vangeli (e anche gli Atti degli Apostoli) non sono affatto una semplice cronaca degli avvenimenti di Gesù, trasmessi meccanicamente e asetticamente in tradizioni orali e poi fissati oggettivamente sulla carta da un evangelista. Perché la tradizione orale ha sicuramente influito (addirittura, la scuola esegetica detta Formgeschichte, uno dei più grandi rappresentanti della quale è Bultmann, sostiene che la trasmissione degli avvenimenti e del messaggio di Cristo abbia incanalato tutto il materiale in alcune forme letterarie – parabole, discorsi, detti lapidari, …- secondo un procedimento influenzato dal Sitz im Leben, dall’ambiente vitale entro cui la tradizione si muoveva: quindi, di Gesù, non possiamo conoscere con certezza né il messaggio, Was, né il modo in cui è vissuto, Wie, eccezion fatta per il Dass, il “che“, cioè che egli è vissuto) ma ha anche influito la penna dell’evangelista (secondo la scuola detta Redaktionsgeschichte), il quale ha offerto un profilo originale di Gesù e degli avvenimenti e del messaggio.
Quindi i Vangeli non sarebbero fotografie, ma quadri espressivi, tuttavia sempre basati su un fondo certo di verità storica, interpretata e selezionata in vista di tesi o, al minimo, visioni da offrire. Così Marco presenta un Gesù taumaturgo che stupisce i contemporanei, Matteo un Gesù dottore, che interpreta la legge non per abolirla ma per condurla a pienezza, quale Mosissimus Moses, Luca un Gesù profeta e salvatore, anche dei corpi, ma soprattutto delle anime, Giovanni un Gesù altissimo tanto uomo quanto Dio (“Oh Signore mio e Dio mio”, 20, 28), presentato in sette (nell’ambito semitico è numero simbolico che esprime totalità e perfezione) rivelazioni dal profondo afflato teologico e simbolico e proposto secondo un procedimento che tende a far trascolorare le coordinate spazio-temporali in una vicenda presentizzata in una escatologia perenne.
Lettere Apostoliche. Sono ventuno scritti, suddivisi nelle lettere di Paolo (secondo la cronologia divise a loro volta in: prime – le due ai Tessalonicesi, le due ai Corinzi, quella ai Galati e quella ai Romani –, lettere della prigionia – ai Filippesi, a Filemone, ai Colossesi e agli Efesini –, lettere pastorali – le due a Timoteo e quella a Tito; la Lettera agli Ebrei è considerata pressoché unanimemente non di Paolo) e nelle lettere cattoliche (la Lettera di Giacomo, le due di Pietro, quella di Giuda e le tre di Giovanni).
In estrema sintesi, sui problemi delle lettere paoline, possiamo dire che, secondo i principali orientamenti esegetici contemporanei, soltanto le lettere prime e quelle della prigionia sono da attribuire a Paolo. Le lettere pastorali non sarebbero dell’apostolo a causa del profondo cambiamento contenutistico (soprattutto in relazione alle indicazioni “pratiche“ e alla preoccupazione riguardo la struttura ecclesiale) e stilistico (una lingua più piana, meno veemente) rispetto alle altre lettere (da alcuni, però, giustificato in base all’invecchiarsi di Paolo); stesso discorso per la Lettera agli Ebrei , non accettata già dal Frammento Muratoriano. Si pensa però che siano comunque opere nate all’interno di comunità influenzate dallo spirito di Paolo, le quali, poi, hanno attribuito a lui gli scritti, secondo un’abitudine largamente testimoniata nella letteratura antica (dove, tra l’altro, non esisteva il concetto di “autore“ come quello contemporaneo). Allo stesso modo si pensa che siano falsamente attribuite anche tutte le lettere cattoliche: quella di Giacomo (anche se è difficile dire a chi Giacomo si voglia alludere, l’apostolo oppure l’episcopo di Gerusalemme presente negli Atti degli Apostoli), le due di Pietro (attribuite invece alla tradizione petrina. Cosa che si desumerebbe da un particolare schiacciante, se è vero che Babilonia era il nome con il quale si indicava la Roma imperiale a partire dal 70, sulla base della testimonianza dell’Apocalisse, composta probabilmente in quegli anni – e il luogo da dove scrive l’autore della Prima Lettera, della quale ha consapevolezza la Seconda Lettera – e se è vero che Paolo è morto nella persecuzione neroniana, fra il 63 e il 64), quella di Giuda (non si sa se si allude all’apostolo o a uno dei “fratelli di Gesù“ di Marco 6,3 ), le tre di Giovanni (attribuite invece alla tradizione giovannea e differenti: le ultime due sono vere e proprie epistole, la prima è una specie di omelia: interessante l’ipotesi secondo la quale è stata scritta per i monaci di Qumran, forse esseni, poiché alcuni temi della lettera – antitesi fra luce e tenebre, tema della comunità –, pur essendo anche giovannei, sono però tipici della comunità di Qumran).
Apocalisse. Anche questo scritto, come le lettere e anche il Vangelo, è ricondotto dagli studiosi non già a Giovanni quanto alla tradizione giovannea. Si tratta dell’unico esempio neotestamentario della cosiddetta “letteratura apocalittica“ (II a. C. – II d. C.), diffusissima in ambito mediorientale (basti solo pensare al Libro di Enoch, una specie di best-seller dell’antichità). Tuttavia bisogna notare che l’opera appartiene a un genere particolare, perché, se si definisce “rivelazione“, apokalupsis (1, 1), si dice anche “profezia“ (22, 7 ). Quindi, oltre ad essere una denuncia della Babilonia attuale nella speranza rivolta verso la Gerusalemme celeste (vena apocalittica, incentrata sul dualismo fra una realtà presente negativa ed una futura positiva), è anche una interpretazione dei segni di Dio nella realtà attuale (vena profetica). Quindi l’Apocalisse non è mai un’apocalisse, ma è un grande messaggio di speranza: nei riguardi del futuro, ma anche del presente nella consapevolezza della mano di Dio che guida sempre la storia umana. Del resto, l’Apocalisse non è mai nemmeno fantasia, sogno ad occhi aperti, perché è strettamente ancorata alla storia, pur adottando un linguaggio particolarissimo, non storico (come succede, invece, per esempio, negli Atti degli Apostoli). Il tratto, infatti, che fa di questa opera uno dei libri più affascinanti della Bibbia e sicuramente il più difficile del Nuovo Testamento è il linguaggio letterario: le varie tesi teologiche sono velate da una complicata foresta di simboli (assistiamo al lussureggiare del simbolismo cosmico, teriomorfo, antropologico, cromatico, aritmetico), cucite e implementate da una rete fittissima di citazioni dell’Antico e del Nuovo Testamento, ambientate e valorizzate in base a riferimenti continui alla liturgia ebraica e cristiana. Quindi non stupisce che lungo i secoli l’Apocalisse sia stata oggetto di letture anche opposte tra di loro: da quella profetica (“profezia” intesa come “chiaroveggenza”, quindi ben lungi dal genuino concetto biblico: allora il libro sarebbe una visione degli avvenimenti futuri) a quella che vi vede una rappresentazione della storia contemporanea per spiegarla a fini pastorali , da quella tesa a dimostrare che l’opera parli del passato (rilettura della storia sacra dall’Esodo alla seconda Pasqua) a quella che vi scorge un’interpretazione della chiesa contemporanea.
Qui allora si inserisce il problema della datazione, molto problematico come per quasi tutto il Nuovo Testamento. Diciamo solo che fin dai primi secoli l’Apocalisse era datata all’epoca di Domiziano (81-96). In seguito, si fece strada l’idea che fosse stata composta durante la persecuzione neroniana. Infine, altri propongono l’epoca di Traiano (98-117). Quindi possiamo dire che è databile a non prima del 70. Fatto sta che l’Apocalisse sembra ambientata durante la persecuzione di Nerone, anche se altri studiosi ritengono che si tratta di quella di Domiziano ma tratteggiata secondo elementi che richiamano quella neroniana.
Il Nuovo Testamento è stato redatto nel corso del I secolo a.C. (50-100). Ci è giunto totalmente in greco antico, nella variante detta koiné dialektos, la lingua comune ellenistica, l’ultima fase del greco antico. Secondo il vescovo Papia il Vangelo di Matteo venne scritto originariamente nella lingua parlata quotidianamente dagli ebrei di allora, cioè l’aramaico. Alcuni studiosi sostengono che i vangeli tutti dovettero essere redatti in aramaico e solo dopo tradotti in greco. Secondo gli studi di Carmignac, la lingua originale dovette essere un ebraico simile a quello testimoniato dai Rotoli di Qumran.
I primi scritti furono Giacomo, Galati e Tessalonicesi (intorno alla metà del I secolo). Seguì Marco e leggermente dopo Matteo, quindi più in là Luca, mentre Giovanni dovrebbe essere stato l’ultimo vangelo. Conclude il Nuovo Testamento l’Apocalisse. Ma questi dati non sono assoluti. Per la datazione del Vangelo di Giovanni ci si affida a un piccolo frammento di papiro identificato da uno studioso, Rylands, nel 1935 tra un insieme di papiri rinvenuti nel 1891 nell’Oasi di El-Fayyum, in Egitto. È un papiro di 8,9 per 6 cm, ha come sigla scientifica P. Ryl. 457 ed è la più antica testimonianza certa a noi giunta del Nuovo Testamento. Contiene i versetti 31-33 del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni nella facciata anteriore e i versetti 37-38 dello stesso capitolo in quella posteriore. Dato che è databile attorno al 125 e non oltre, il Vangelo di Giovanni è stato definitivamente redatto nel I secolo.
Nei vangeli è contenuta la preghiera che Cristo stesso ha insegnato ai suoi. Essa ha due versioni:
“Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male” (Matteo 6, 9-13).
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione” (Luca 11, 2-4).
Qui Gesù chiama i peccati con il termine “debiti”, secondo una locuzione aramaica. Gesù doveva parlare quotidianamente aramaico (l’ebraico era riservato alle cerimonie religiose) oppure i vangeli risentono della prima lingua di composizione che forse era l’aramaico. In ogni modo essi furono scritti originariamente in greco oppure tradotti solo dopo in greco: questo poiché tale lingua era quella della cultura; quindi, chi la adoperò voleva far conoscere gli scritti neotestamentari a quante più persone possibile.
Le parole del Pater noster sembrano a una lettura superficiale semplici e chiare. Tuttavia, questa preghiera, così come tutta la Bibbia, è un testo pieno di suggestioni e di richiami. Gli studiosi cercano di sviscerarne il senso recondito mediante analisi altamente sofisticate. Facciamo questo esempio. L’espressione greca aghiasthētō to onoma sou, “sia santificato il tuo nome”, deve essere spiegata. Gli ebrei di allora scrivevano in un modo ma pensavano secondo le categorie religiose espresse dalle lingue meglio conosciute, cioè l’ebraico e l’aramaico. Quindi il verbo “santificare” si rifà alla radice ebraica qadosh, “santo”, che etimologicamente vuol dire “separato”. Infatti, in Levitico 20, 26 si dice: “Sarete santi per me, perché io il Signore sono santo e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei”. Ora, il nome di Dio è nel mondo semitico la sua stessa persona. Pertanto, prescrivere di santificare il nome vuol dire, in buona sostanza, secondo la mentalità semitica, riconoscere che Dio è separato dalla umanità e dalla terra tutta, quindi vuol dire che occorre considerare la maestà divina, la signoria di Dio sulla storia e sull’uomo, pertanto seguire i suoi precetti, dati e garantiti per l’appunto da un Signore talmente grande. Il Pater qui si riferisce certamente al Salmo 8: “Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra”. Nella Bibbia ebraica la grandezza, in ebraico adir, può comportare una distinzione, una differenza, una separazione: quindi Dio (il nome) è grande in quanto separato dai mortali. P. Di Luccio, Il Padre dei piccoli e la pace del suo Regno, Napoli 2021.
Non bisogna mai leggere superficialmente la Bibbia. Questo per almeno due motivi. Bisogna dire che ogni libricino della Bibbia è scritta da un autore umano nel pieno possesso delle sue facoltà e da Dio che lo ispira parlando con le parole del primo ma per esprimere messaggi più alti. Dall’autore umano dipende il senso letterale, da quello divino quello spirituale. Il senso letterale va capito dal contesto storico, che non è mai evidente oggi: la Bibbia è stata scritta millenni fa e per comprenderla occorre conoscere molte cose del passato. In secondo luogo, è vero che Dio parla al cuore ma la Bibbia, per quanto attiene al senso spirituale, non va mai intesa privatamente, ma secondo lo Spirito, di cui la Chiesa è depositaria; pertanto, in ultima analisi è la Chiesa che deve interpretare autenticamente la Bibbia, comunicandone il senso pieno.
Per quanto riguarda il senso letterale, facciamo un altro esempio di lettura “studiata” e mai banale. I targumim sono le traduzioni aramaiche della Bibbia ebraica. Durante l’esilio di Babilonia (VII-VI a.C.) gli ebrei smisero di parlare quotidianamente l’ebraico e impararono l’aramaico, che era la lingua internazionale di allora, un po’ come l’inglese oggi: in seguito, ritornati in patria, tennero il secondo idioma per le faccende quotidiane tanto che i giovani ebrei smisero di capire l’ebraico, se non fossero stati sacerdoti, per questo sarebbero occorsi delle traduzioni della Bibbia ebraica (l’Antico Testamento) in aramaico. L’evangelista Giovanni, nella composizione del suo vangelo, si rifà molto spesso a queste traduzioni-commento, che dovevano essere molto note. Quando in 17, 24 l’evangelista proclama che Cristo desidera che quelli che il Padre gli ha dato siano con lui, “così che possano vedere la sua gloria”, ebbene questa espressione richiama Neofiti Gn 45, 13, dove Giuseppe dice ai suoi fratelli di riferire a suo padre tutta la sua gloria in Egitto. Oppure in 7, 18 Giovanni scrive che Gesù non ha cercato la sua gloria, ma la gloria del Padre suo: nel Targum palestinese il figlio obbediente è colui che ha considerazione per la gloria (‘iqar, “onore”) di suo padre. In Giovanni 14, 2ss è scritto: “Io vado a preparare un posto per voi”. In Esodo 33, 14 Dio promette a Mosè: “La mia presenza verrà con te e io ti darò riposo”; Neofiti parafrasa: “La gloria della mia Shekinah camminerà in mezzo a voi e preparerà un luogo di riposo”. M. McNamara, I targum e il Nuovo Testamento, Bologna 1978.
Luca 2, 48. “Figlio, perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre ti cercavamo”. Questa è una delle sette parole di Maria che i vangeli ci consegnano. Per la fede cattolica Maria è la Madre verginale di Cristo, quindi di Dio. È rimasta vergine prima, durante e dopo il parto. I cristiani orientali raffigurano Maria con tre stelle sul manto, proprio per indicare questi tre momenti. Nell’episodio evangelico Gesù si perde durante una visita a Gerusalemme e viene ritrovato dopo tre giorni nel tempio mentre si trova in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Gesù ha l’età di 12 anni. Lo sfondo storico, molto probabile, del brano evangelico è il bar mitzvah, “figlio del precetto”, come oggi è chiamato dall’ebraismo lo status del bambino che a 12/13 anni compie un cerimoniale in sinagoga durante il quale legge per la prima volta la Torah. Ma Luca cambia lo status di Cristo: egli non è un bambino normale, bensì il Figlio di Dio, quindi Dio stesso; pertanto, Gesù sta addirittura tra i maestri, che sono stupiti per la sua intelligenza e le sue risposte. G. Ravasi, Le sette parole di Maria, Bologna 2020. In filigrana si intravede quasi una dichiarazione della potenza di Dio che opera in Cristo, forse una allusione alla sua divinità.
I vangeli dichiarano espressamente che Cristo è Dio. Giovanni 1, 1: “In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”, che nell’originale greco suona en archēi ēn o Logos kai o Logos ēn pros ton theon kai theos ēn o Logos. Cristo è chiamato Logos, termine che ricorre solo nel prologo (1, 1-18) in tutto il Vangelo di Giovanni, cosa che fa supporre che il prologo innico di questo Vangelo sia una composizione autonoma, poi cucita assieme all’altro materiale e messa in ouverture al vangelo. Oggi i filologi sostengono che il prologo di Giovanni, che costituisce uno stupendo inno al Logos, si basi sulla elaborazione di un precedente Inno al Logos, molto probabilmente si tratta della Protennoia trimorfica (“Le tre forme del primo pensiero”), un’opera gnostica in lingua copta ritrovata tra i codici di Nag Hammadi (codice XIII, trattato I). Essa fu redatta dal gruppo dei barbelognostici, fu però successivamente elaborata sia dai sethiani che da autori cristiani. Fu composta nello stesso periodo dell’Apocrifo di Giovanni. Un brano di questa opera gnostica ha molto in comune con il prologo innico di Giovanni:
“Io sono Protennoia il Pensiero che abita nella luce
Colei che esiste prima di Tutto
Io mi muovo in ogni creatura
Io sono l’invisibile Uno all’interno del Tutto
Io sono percezione e Conoscenza, che pronuncia una Voce per mezzo del Pensiero
Io sono la vera Voce”.
Un’altra curiosità filologica. Il verbo greco ēn, “era”, imperfetto, non deve trarre in inganno, Giovanni non sta parlando al passato, il Logos non è confinato nel passato, essendo da sempre. Giovanni scriveva in greco ma pensava in aramaico: questo imperfetto greco dovrebbe essere la traduzione di un perfetto aramaico, che indica una azione iniziata nel passato ma che perdura in seguito.
Inoltre, gli studiosi discutono sul valore da dare all’espressione kai theos ēn o Logos, “e il Logos era Dio”. È che noi non conosciamo direttamente il greco antico, il quale viene ricostruito dai filologi. L’esatto valore dei casi, l’aspetto dei verbi, e quant’altro, sono argomenti tuttora oggetto di discussione. Così come gli articoli greci e la loro esatta funzione sintattica. Il greco “o” è l’articolo determinativo, caso nominativo, singolare maschile, traducibile con l’italiano “il”. Per alcuni il Logos di cui parla Giovanni non è come Dio Padre (che nel Vangelo è indicato così “o theos”, “il Dio”, “Dio”) bensì una potenza divina, distinta da Dio Padre (kai theos ēn o Logos: Giovanni utilizza il termine greco theos, “dio”, ma senza l’articolo “o”). Tuttavia, altri studiosi si richiamano alla regola sintattica nota come Granville Sharp Rule. In greco antico, se diciamo o basileus kai o egemon vogliamo dire “il re e il governatore”: intendendo entrambi i sostantivi come articolati, il re deve essere una persona separata dal governatore, quindi abbiamo due persone distinte. Se invece diciamo o basileus kai egemon togliendo l’articolo dalla seconda parola, intendiamo dire “il re e governatore”, cioè una sola persona che è re e anche governatore, spieghiamo o qualifichiamo meglio chi è questa persona. Quindi, ritornando a Giovanni, nell’espressione kai theos ēn o Logos, “e il Logos era Dio”, il primo sostantivo greco theos, “dio”, non ha l’articolo, mentre il secondo sostantivo greco, o Logos, ha l’articolo: pertanto, in base a tale regola sintattica, Dio e Logos sono la stessa entità.
In ogni modo pare che il Nuovo Testamento presenti una Trinità: Padre, Figlio (Cristo) e Spirito Santo. Per i cattolici Gesù vuole affermare che esiste un solo Dio in tre Persone perfettamente uguali ma distinte. Per altri il Nuovo Testamento rivela l’esistenza di un solo Dio, il Padre, mentre Figlio e Spirito sarebbero potenze divine subordinate all’unico vero Dio. In ogni modo, la Protennoia ha tre forme, ma anche il filosofo greco medioplatonico Numenio di Apamea parlava di una trinità di esseri divini, in parte ripresa dal neoplatonico Plotino (Bene, Intelletto, Anima, che i critici vedono rispettivamente come il Dio di Platone, il Dio di Aristotele e il Dio degli stoici). Che il Nuovo Testamento attinga a questi filoni di pensiero? Oggi l’esegesi a volte interpreta gli autori della letteratura cristiana antica anche in riferimento alla letteratura greca classica. Per esempio, MacDonald notava l’influenza di Omero sul Vangelo di Marco. Ancor prima Nietzsche sosteneva che il cristianesimo non sarebbe altro che un platonismo involgarito.
Ma, oltre alle molte dichiarazioni dirette, tutto il Nuovo Testamento è intarsiato altresì di continue allusioni linguistiche che ammiccano alla divinità di Cristo, le quali a quel tempo dovevano essere molto evidenti, ma oggi necessitano di essere spiegate. Facciamo un altro esempio di allusione, oltre a quella di Luca appena riportata. Quando in Giovanni 1, 14 si afferma che “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, il verbo “venne ad abitare” è in greco eskēnōsen, un aoristo, che significa letteralmente “pose la tenda” (skēnē, “tenda). Colui che nell’Antico Testamento abitava nella Tenda del Convegno, il santuario mobile costruito dagli ebrei durante la traversata del deserto, era YHWH, il Dio che li fece uscire dall’Egitto e che parlava con Mosè. Non solo, ma il verbo greco usato da Giovanni costituisce anche un gioco di parole, richiama infatti il termine ebraico rabbinico Shekinah, la Presenza di Dio nel tempio. Giovanni, quindi, sta ammiccando al fatto che Cristo è Dio. Come diciamo nel Credo ogni domenica, Dio da Dio, Luce da Luce.
Ma più chiaro ancora, è quando nel Vangelo di Giovanni Cristo afferma di essere Io sono, in greco egō eimi. Per esempio, in 8, 24 Cristo afferma: “… morirete nei vostri peccati se non credete che Io sono”, apothaneisthe en tais amartiais umōn ean gar mē pisteusēte oti egō eimi. Cosa significa? Gli studiosi hanno analizzato questa espressione nel contesto della più importante traduzione greca della Bibbia ebraica (la Septuaginta), ma non solo, e hanno scoperto che la ricorrenza di questa formula in Giovanni si spiega come traduzione greca di Esodo 3, 14, dove YHWH rivela il suo nome e dichiara di chiamarsi Io sono Colui che sono, in ebraico ‘Eye asher ‘eye. Abbiamo già detto che nel mondo semitico il nome è la persona stessa. Cosa significa dire che Dio è Io sono? Significa che Dio è sempre presente nelle vicende del popolo ebraico e di tutta la terra. Pertanto, se Cristo afferma di essere Io sono, vuol dire in sostanza che Egli è il Salvatore dell’umanità, cioè Dio-con-noi (Emmanuele), il Dio di sempre che scende tra gli uomini per salvarli e donare loro la vita eterna, liberandoli dalle opere del diavolo, tra cui in primis c’è la morte. È questa la Buona Novella, in greco euanghelion, donde la parola: Vangelo.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 50 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.

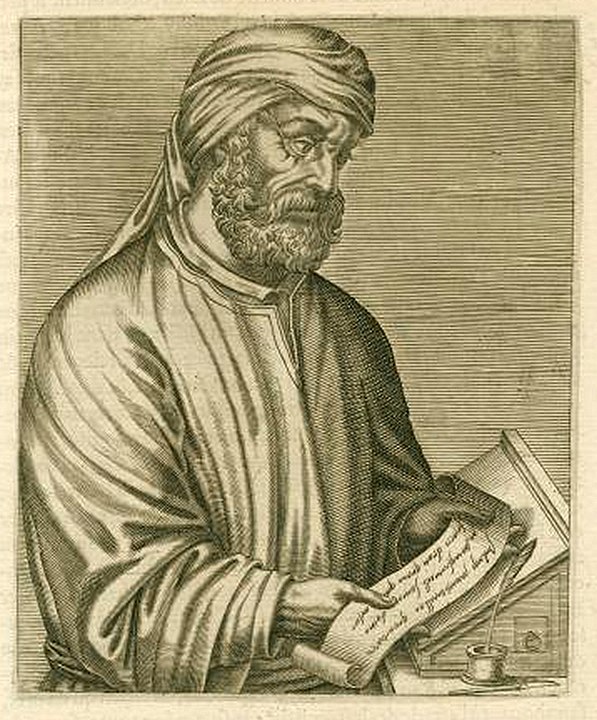






2 Comments