Il liberismo ha la sua ragione filosofica nel materialismo, la cui principale caratteristica sociale è l’individualismo. Poco alla volta, lungo i secoli, eroso il senso di unità che ordinava la Civitas, che dava rappresentazione del cosmo nel quale parlava la legge delle analogie, si è alla fine sfilacciato anche l’uomo, ridotto ad essere una monade, chiuso nella sua dimensione solo psichica se non addirittura preda delle sue parti infere. Così si è giunti alla creazione di una nuova entità: la massa. Questa entità non poteva che chiedere per sé una educazione di massa, una cultura di massa e un’arte di massa. Un qualcosa quindi che ha perduto la sua caratteristica fondamentale, ovvero l’aristocraticità, che, badate bene, va intesa qui come caratteristica dello spirito, come qualità che eleva e chiama a sé le facoltà più alte dell’uomo, facoltà che debbono venire educate.
Sarebbe quindi oltremodo limitato e fuorviante insistere nel considerare il liberismo terminale come un qualcosa che è circoscritto all’ambito economico e non invece come il precipitato sul piano economico di una degradazione dell’uomo, del pensiero e di tutta la società, al livello della materia e quindi del “numero”, perché come ricorda anche S. Tommaso «il numero è dalla parte della materia».
Certamente abbiamo avuto anche nell’epoca recente, esempi di grande espressione artistica. Ma se da un lato si debbono considerare come esempi sporadici e sganciati dalle dinamiche dell’insieme, è abbastanza evidente che negli ultimissimi decenni la crisi radicale dell’arte sia un fatto inequivocabile. Ed è dal fondo di questo pozzo in cui siamo schiacciati che dobbiamo osservare la realtà e il nostro tempo, e comprenderne i mali, ben oltre le stanche analisi che non sanno andare oltre una critica superficiale.
L’arte, per sua natura, è sacra. E tale è stata almeno sino alla fine del Medioevo. Un’epoca in cui non vi era arte che non fosse inserita nell’edificazione del Tempio cristiano. E successivamente, furono sempre le gerarchie ecclesiastiche o le aristocrazie a commissionare le opere agli artisti e anche a sollevare questi ultimi dalle strette incombenze materiali grazie al fenomeno del mecenatismo.
Frantumatasi poi però l’unità dell’Imperium, che vede lo sgretolarsi politico con la formazione degli Stati nazionali e quello sociale con il morire delle corporazioni delle arti e mestieri, si giunge infine a quello che è lo Stato moderno. Uno Stato che non riceve più legittimazione dall’alto e che, come tutta intera l’umanità, degenera sempre più fino ad arrivare alla deriva ultima di cui oggi siamo testimoni: la tirannide, esito scontato della democrazia. Platone docet.
Proprio l’apparato statale, diviene in questa fase ultima dell’era moderna, il presunto sostituto delle aristocrazie e delle gerarchie ecclesiastiche per il finanziamento e la promozione dell’arte. Ed in sé avrebbe ancora una sua ragion d’essere. Tuttavia, venendo a mancare ogni contatto con i princìpi soprannaturali, anzi partecipando ormai della quasi completa inversione di tali princìpi, il sostegno economico agli artisti è condizionato da tutte le ideologie e i falsi miti che sostanziano il tempo attuale.
Di parallelo e oltre l’appoggio istituzionale, vi è il mercato, unico giudice e “garante” dell’artista moderno. La società in cui siamo inseriti è infatti un connubio infernale di statalismo, ovvero di impersonale e tecnocratica burocrazia, e di liberismo, ovvero del dominio assoluto dell’ideologia che rende tutto oggetto di mercato, di semplice scambio. Questi due aspetti, solo apparentemente contrastanti, sono la risultante finale di quella nefasta ideologia che è il materialismo.
Il materialismo è orizzontalità, nel cui piano non può entrare qualcosa che lo superi. La spiritualità, laddove ancora essa persista, è infatti sempre più relegata alla sola sfera personale, fatta perlopiù di regole o di un sentimentalismo adolescenziale che la rende del tutto insignificante e innocua nei confronti del potere e della società in generale.
In questo grande mercato, anche l’arte, da libera, diventa schiava. Se ogni cosa si valuta per il potere di scambio, allora essa non può che autoconfinarsi in tale angusta cornice e cedere al ricatto di una presunta utilità sociale, di una “spendibilità”. Essere dipendente dal gusto della massa o anche delle “piccole masse” che si condensano nei gruppi identitari, persino di quelli che si ritengono “antagonisti”. Ma l’uomo di questa era manca, salvo rarissime eccezioni, delle categorie minime per poter apprezzare la vera opera d’arte, per saper applaudire il genio che scompagina le tavole fin troppo ben apparecchiate di questa esistenza piccolo borghese. Perché l’uomo di questa era è “tipicamente moderno”, anche se crede di non esserlo. Esso non sa pensare e vedere oltre la cornice che le categorie della modernità hanno assemblato. Egli prende posizione, si schiera, ma sempre dentro la cornice.
Perciò, non può che essere il numero a dettare legge. Con una spietatezza che solo il piano della materia conosce. Come per i professionisti, gli studiosi, a decretare il valore sono i titoli di studio, il successo professionale, il rispetto che se ne ha in certi ambienti, per l’artista contano i premi ricevuti, gli incassi in sala – se si parla di film – le copie vendute – per i dischi, e così via. Ma ancora più in generale, il riscontro di pubblico, la visibilità, seppur circoscritti come più volte abbiamo sottolineato, ad un particolare gruppo o ambiente. L’isolato, colui che vive a margine, che non può contare su alcun appoggio mediatico, che non è riuscito a costruire attorno a sé una vivace e chiassosa schiera di seguaci, è considerato un nulla, o poco più.
Non siamo più capaci di riconoscere la qualità profonda di un’opera, ma la giudichiamo attraverso tutti questi filtri quantitativi che ne deformano l’immagine, anziché renderla più chiara. Siamo schiavi inconsapevoli dell’apparenza, perché il veleno del “liberismo” scorre dentro di noi, e purtroppo non ce ne avvediamo.
Per le corporazioni medievali la pubblicità era considerata un mezzo sleale e coercitivo, mentre l’opera doveva affermarsi da sola per la sua intrinseca qualità. Ma qui è bene sostare. Parliamo infatti non semplicemente di un’altra epoca, ma di un altro uomo, o meglio dovremmo dire, di ciò che è veramente l’uomo, e che noi abbiamo tristemente perduto. Cosa siamo dunque diventati? I nostri occhi e le nostre menti sono, da generazioni, sempre più grossolane. L’evidenza è la sola cosa che conta. Ciò che non è sotto i riflettori, fossero pure due piccole luci malconce, non ha valore, addirittura non ha dignità. Il reietto è l’esemplificazione del suo fallimento umano. Non stupisce infatti che questa sia a tutti gli effetti un’epoca ormai anticristica, che cerca la gloria, seppur piccola, ma fugge la Croce, il tradimento dei “vicini”, la persecuzione. Vorremo sì la corona, ma non le spine.
Il mercato è poi legge di immediatezza. Il favore di un’opera deve essere visibile immediatamente. L’unico tempo concesso è il presente. Chi non lascia subito una traccia non merita i nostri sguardi. Rinnegata l’idea stessa di eternità, anche le opere dell’uomo, e quindi anche quelle artistiche, cedono alla sola esistenza materiale, mentre il loro reale valore si dispiega solo nel regno dell’immateriale. Ma chi oggi sa riconoscerlo e sarebbe disposto a lottare perché esso si imponesse? Chi oggi saprebbe spendersi per chi non ha spazio, non ha voce? Per una voce realmente profetica?
Nella storia, anche quella relativamente recente, abbiamo avuto ancora sussulti di vita, fermenti artistici di un certo valore. Ora però dobbiamo ammettere che siamo giunti quasi al capolinea di questa “idea di mondo” e le forze sembrano spente. Dalle ceneri non guizza più nessuna scintilla. Dobbiamo prima di tutto tornare a riconoscere il principio della responsabilità collettiva, come ci insegna la Tradizione, ovvero che la crisi dell’arte, così come di tutti gli altri aspetti del viver sociale, sono sintomi terminali di una umanità che nei secoli è andata sempre più schiacciandosi sul piano orizzontale. E oggi ne vive le ultime, naturali, conseguenze.
Per vincere il liberismo che è dentro di noi, bisogna prima di tutto ammetterne l’esistenza. Vedere e comprendere come esso sostanzia la nostra quotidianità, il modo con cui giudichiamo, misuriamo gli altri e le cose. Che poi è lo stesso metro con cui vogliamo essere a nostra volta giudicati. Riconoscere che a mala pena oggi si troverebbe qualcuno disposto a morire per difendere i propri diritti, ma forse non si troverebbe più nessuno disposto a morire per un’idea, per qualcosa che esiste nel regno dell’immateriale, dello spirito.
L’arte muore così, per assenza di veri uomini. Ma proprio da qui può risorgere: se torniamo a manifestare la nostra vera natura. Dal fondo in cui ci siamo gettati da soli, è però necessario uno sforzo fuori dal comune. E per prima cosa è necessario entrare in crisi. Una crisi che prelude ad una completa trasformazione della nostra mentalità moderna. Dall’Alto gli aiuti non mancheranno – le prove che stanno giungendo hanno proprio questo significato – ma il primo passo spetta a noi.







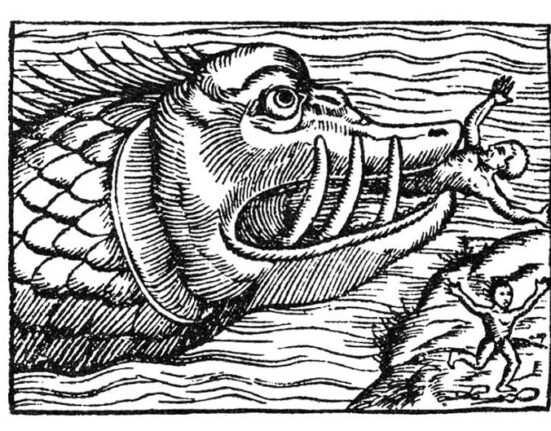
1 Comment