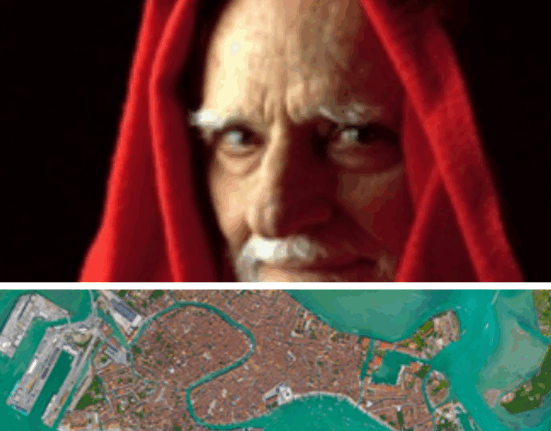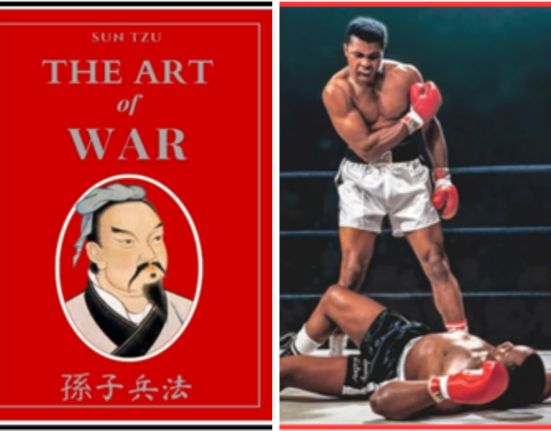“Abítuati a pensare che nulla è per noi la morte, poiché ogni bene e ogni male è nella sensazione, e la morte è privazione di questa “ Epistola a Meneceo, 124-127 (Epicuro)
“Cotidie morimur; cotidie enim demitur aliqua pars vitae” (Seneca) Quotidianamente si muore,ogni giorno infatti una qualche parte di vita ci lascia.
La legge di Lavoisier nota anche come legge di conservazione della massa afferma che nel corso di una reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. In altre parole, nel corso di una reazione chimica la materia non si crea e non si distrugge.
In copertina: Concetto di R.P. Confezionato da BING.
La morte può contrapporsi egualmente e sensatamente sia alla nascita che alla vita.
Qualora la vita si contrapponga alla morte l’opposizione è del genere contrarietà e presuppone tra gli opposti la continuità. Siamo nel contempo allora sia viventi che morenti.
Il vivere non ci esenta dal morire inteso come rischio e degrado.
Vita e morte costituiscono in tal caso il continuum di uno svolgimento di vita.
Si continua ad essere vivi fintantoché non si muore del tutto.
Se la morte invece si contrappone alla nascita l’opposizione è del genere della contraddizione.
Non si può morire se non si è nati.[1]
Ogni uomo morto era prima nato!
La nascita è una data e così la morte è una data che non possono essere la stessa data.
Non si nasce e non si muore nello stesso istante!
Tra la morte e la vita in quanto date vi è soluzione di continuità.
La data di nascita non può essere quella della morte. E’ come dicessimo che o si è nati o non si è nati e così è per la morte o si è morti o non si è morti.
Morte e vita sono l’alfa e l’omega di una vita.
Insomma o si è vivi o si è morti!
O si è nati vivi o non si è nemmeno nati.
O si è morti o non si è nemmeno morti.
Se la morte si contrappone alla nascita vita e morte vanno intese nella puntualità del momento.
E’ impossibile a priori cioè nel contempo essere vivi e morti.
Il momento della nascita manifesta tensione di contro al momento della morte che manifesta esaustione.
Né alla nascita, né alla morte s’interrompe propriamente la vita …
Ma di chi e di che cosa?
Quel che inizia o finisce non s’interrompe propriamente se non si colloca nell’ambito di un continuum alle estremità dello stesso, ma collocato agli estremi definisce il continuum senza però appartenervi.
Che cosa c’era prima della vita e che cosa dopo?
Chi eravamo prima di nascere e chi saremo dopo la morte? E se prima di nascere non eravamo perché mai dovremo essere sussistere dopo la morte?
Le opposizione di contrarietà presuppongono un tertium quid che è e mantiene la fusione degli estremi, dei termini che lo definiscono. Una volta che si costituisca un’opposizione di contrarietà come il bianco e il nero, il chiaro e l’oscuro o banalissimamente il caffè e il latte nel caffellatte occorre che si assuma uno dei due termini come soggetto oppure la loro mediazione o medietà.
Nel primo caso la continuità si esprime come diminuzione del soggetto per cui si definirà lo scuro come un meno chiaro e il nero come un meno bianco. Se si assume invece come soggetto non uno dei contrari ma la fusione, compresenza degli stessi si avrà il grigio e il caffellatte come soggetti del giudizio. Anche in questo caso il soggetto esprimerà una quantità suscettibile di crescita o diminuzione decrescita per cui si avrà un grigio che può crescere o diminuire e così un caffellatte sarà più o meno caffellatte a seconda del latte o del caffè nella miscela.
Il tertium quid del caldo freddo, la loro contrarietà contrapposta e fusa genererà il tiepido che potrà essere più o meno tiepido. Questa soluzione di assumere la medietà come soggetto comporta l’ambivalenza del giudizio.
Quel che è meno tiepido potrebbe essere o più caldo o più freddo del tiepido a seconda del punto di vista come si dice nel caso del bicchiere che è mezzo vuoto per il pessimista e mezzo pieno per l’ottimista, senza che si possa univocamente determinare o decidersi per la soluzione cioè per chi abbia ragione se il pessimista o l’ottimista.
Se diciamo che alla roulette è uscito un numero pari, questa è un’ informazione utile per chi avesse puntato sul pari o sul dispari ma non per chi avesse puntato su un cavallo cioè a dire su una coppia di numeri. E così il caffellatte sarà più o meno caffellatte sia che sia più caffè che latte o più latte che caffè.
La soluzione che nell’uso si adotta è quella di assumere uno dei due termini opposti come soggetto per cui si dirà non già che una nascita è più o meno lunga ma che una vita è più o meno lunga e così però anche di una morte che sarà più o meno lunga nel senso di agonica.
Nel caso che la vita si contrapponga alla morte nel senso della discontinuità ovverosia della contraddizione, sarà propriamente la nascita a contrapporsi alla vita come universale destino eguale per ciascuno degli individui in quanto individui, nel qual caso ogni vita in quanto nascita non distingue un vivente da un altro e così ogni morto non è diverso da un altro morto se si prescinde dalla sua vita vissuta.
Tutti i morti sono egualmente nati ed egualmente morti finora.
L’eguaglianza degli umani all’atto del nascere e del morire è la stessa per chiunque. Nascono e muoiono nello stesso modo ma vivono in modo diverso.
Se si stabilisce esservi discontinuità tra vita e la morte e si assumeranno i termini nell’ambito di una contraddizione sarà opportuno opporre piuttosto che la vita alla morte la nascita alla morte. La nascita contraddice la morte.
Perché mai si è nati infatti per poi dover morire?
Nel caso invece che diasi continuità tra gli estremi si contrapporrà la vita e non già la nascita alla morte. Epperò in questo caso dovrà necessariamente ritenersi la morte come la vita eguale cioè come un soggetto suscettibile di diminuzione e di crescita.
Se la nascita non può sensatamente prolungarsi – non ha senso dire che una nascita è più o meno lunga di un’altra – ma in quanto vitalità prolungarsi nel tempo, così la morte che le si oppone egualmente si prolungherà nella vita invadendola a mano a mano che si prolunga la vita. Più si vive e più subentra la morte.
Se la morte si contrappone alla nascita, la vita e la morte si escludono, se invece la vita si contrappone alla morte e non alla nascita vita e morte si compenetrano l’una nell’altra per la continuità dell’opposizione.
La vita e la morte contrapposte nella forma della continuità si comprendono l’una nell’altra e si distinguono soltanto per la misura dell’opposto che si assume come soggetto, per cui potrà dirsi conseguentemente addirittura che una vita è o può essere più o meno mortale siccome una morte può essere più o meno vitale.
Nel caso di una morte immatura si potrà dire che è stata una morte vitale, in qualche modo a insaputa del soggetto, siccome una morte matura definirà propriamente cioè esemplarmente una vita come mortale!
La soluzione non soluzione di discontinuità tra la vita e la morte costituì lo slogan di appagamento gratificante della morale epicurea per la quale non deve temersi la morte fintantoché si è vivi e non può aversi sensibile esperienza di morte. Ma in questo caso l’epicureo sembra confondere la nascita con la vita per contrapporla alla morte. Diversamente dall’epicureo lo stoico contrappone la morte non alla nascita ma alla vita e pertanto assume la vita come intrusione di morte fin dall’inizio per cui la vita e la morte insieme procedono verso un traguardo in cui la morte trionfante vivifica la vita di una pendolarità di ritorno dacché la vita e la morte in quanto inscindibili e fuse non possono prevalere l’una sull’altra ma si confondono in eterno secondo la legge di Lavoisier.
Renato Padoan
[1] Che ne è allora di un bambino nato morto o morto poco dopo la sua venuta al mondo?
Ci siamo rivolti per un tema così delicato all’IA ed è stata questa la sua risposta:
“È una domanda delicata e carica di emozione. In situazioni simili, spesso sulle lapidi vengono riportati il nome del bambino, la data di nascita e morte (che in questo caso sarebbero la stessa), insieme a un breve messaggio o una frase che esprime il dolore e l’amore della famiglia. Frasi come “Amato e mai dimenticato” oppure “Un angelo troppo presto volato via” sono comuni. A volte, i genitori scelgono un simbolo o un’immagine significativa, come un cuore, un angelo o un fiore, per rendere la lapide più personale”.