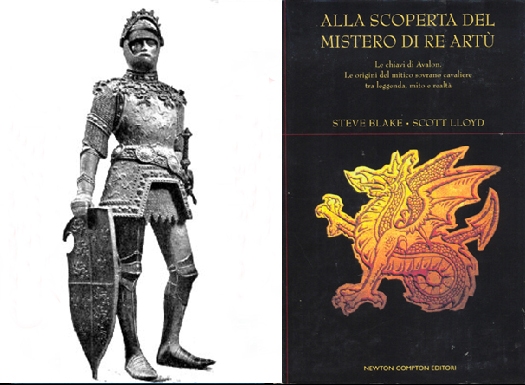Di Fabio Calabrese
Come vi ho già spiegato, la letteratura arturiana oggi è praticamente sterminata, un labirinto nel quale è assai arduo orizzontarsi, si tratta spesso di escogitazioni fantasiose quando non, come nel caso del Santo Graal di Baigent, Leigh e Lincoln, dettate da un vero e proprio pregiudizio ideologico. Io considero al riguardo una vera fortuna l’essermi imbattuto in un testo, Alla scoperta del mistero di re Artù di due autori inglesi, Steve Blake e Scott Lloyd, che hanno fatto una cosa molto naturale e ovvia ma che pare che prima di loro non sia venuta in mente a nessun altro: andare a verificare su quali fonti originali si basa la Historia Regum Britanniae di Geoffrey di Monmouth che, come sappiamo, è alla base di tutte le elaborazioni successive.
Il testo dei due autori inglesi è stato pubblicato in edizione italiana dalla Newton Compton nel 2005.
Questo libro è nato dal singolare sodalizio fra i due autori: Steve Blake è un appassionato biblofilo ed esperto di storia altomedievale che durante un’escursione nella parte antica di Chester assieme alla moglie, era capitato in una libreria che aveva da poco cambiato gestione.
“Seduto al posto [del vecchio proprietario] c’era un giovane non tanto alto dal singolare pizzetto caprino, la pelle scura per un’abbronzatura recente… Dopo averci lasciato curiosare per qualche minuto fra gli scaffali, il giovane si era alzato e si era presentato. Si chiamava Scott Lloyd… Parlando, scoprimmo non solo che Scott e io avevamo in comune la passione per i libri antichi, ma anche quella legata a un particolare momento della Storia, quello definito come Secoli Bui o, per essere più precisi, il primo Medioevo”.
Come libraio, Scott Lloyd deve essere decisamente fuori dal comune, apprendiamo infatti che era reduce da un viaggio in Tibet, e che la moglie, Jane Wolfe, oltre a essere una cantante di jazz, è un’esperta di storia sassone.
Non è possibile occuparsi di storia altomedievale delle Isole Britanniche senza imbattersi nel mito di re Artù di cui i due amici, Blake e Lloyd hanno deciso di verificare per quanto possibile la fondatezza storica, e per fare questo, hanno compiuto una scelta molto semplice che pure, per quanto possa sembrare strano, pare che dell’enorme quantità di persone che del mito arturiano si sono occupate in vario modo, pochissimi abbiano fatto, cercare per quanto possibile di risalire alle fonti originali.
I nostri due autori hanno perciò proceduto a un’attenta ricognizione delle fonti storiche e storico-letterarie.
E’ risaputo che Geoffrey di Monmouth si è preso delle libertà rispetto alle fonti gaeliche a cui è ispirata la Historia regum, che ad esempio il nome di Myrddin è stato tradotto in latino come Merlinus, perché Merdinus sarebbe suonato ridicolo, ma i fraintendimenti a cui quest’opera ha dato luogo sembrano essere di portata ben più vasta, eppure la chiave per risolvere il busillis, paradossalmente, è da sempre sotto gli occhi di tutti.
Nella dedica dell’opera, che è del 1136, al suo protettore Roberto conte di Gloucester, Geoffrey racconta che essa si basa su di un manoscritto antichissimo in lingua britannica, portatogli dalla Britannia dal suo amico Walter arcidiacono di Oxford.
Che il mito arturiano possa avere una base storica, è stato perlopiù escluso dai ricercatori in base al fatto che i luoghi della narrazione della Historia regum sembrano impossibili da localizzare con un minimo di credibilità, un caso tutto sommato analogo a quello di Atlantide; il mito platonico è stato respinto nel dominio delle leggende proprio per il fatto che la terra scomparsa è stata localizzata quasi in ogni luogo del nostro pianeta, da un polo all’altro, senza mai esiti convincenti.
Ma leggiamo con un po’ di attenzione la dedica di Geoffrey. Che senso avrebbe che egli parlasse di un manoscritto “portatogli dalla Britannia” se si trovava in Inghilterra? Anche il suo accenno alla lingua britannica da lui tradotta in latino fa pensare che egli parlasse di un idioma non familiare alla maggior parte dei suoi lettori. Appare chiaro, e questo è l’inciampo che deve aver buttato fuori strada tutti i ricercatori precedenti, che ciò che Geoffrey di Monmouth intendeva per “Britannia”, che ciò che si chiamava Britannia nel XII secolo, non doveva essere affatto l’Inghilterra.
Geoffrey traduce come Insula Britannia il gaelico Ynis Pridein. “Ynis” in gaelico può avere il significato di isola, ma anche di penisola o semplicemente di reame, e “Ynis Pridein” non è altro che il Galles, che dal punto di vista geografico è una penisola piuttosto tozza.
Gli autori raccontano di essere stati i primi a rimanere sconcertati da questa ipotesi:
“Quando scoprimmo quella nuova mappa una parte di noi sperò che ci fosse un errore. Perché se avevamo ragione, tutta la storia imparata a scuola era sbagliata”.
Qui “mappa” va intesa in senso metaforico, non si è trattato infatti di un’antica carta del reame di Camelot e nemmeno di un antico documento uscito all’improvviso dalle pagine di un vecchio libro, ma del risultato di una ricerca condotta su più piani, confrontando testi, prove archeologiche e ricerche sul campo. Indubbiamente, la riduzione di Artù da mito fondante dell’identità britannica a personaggio di vicende esclusivamente gallesi, ha per degli inglesi qualcosa di scioccante, ma una volta formulata l’ipotesi occorre vedere quali sono gli elementi a suo sostegno.
Ci sono le fonti storiche anteriori alla Historia regum; la più antica è De excidio Britanniae di San Gilda che sarebbe stata redatta attorno al 540, quindi contemporanea di Artù. San Gilda, il più antico santo gallese, sarebbe stato non solo contemporaneo di Artù, ma l’avrebbe odiato, poiché questi avrebbe fatto uccidere un fratello del santo monaco, ribelle o predone, la differenza fra le due cose era all’epoca molto sottile, poi i frammenti di san Beda il Venerabile risalenti circa al 730, la Historia Brittonum di Nennio dell’840, quell’importantissima raccolta di racconti gallesi noti come Mabinogion, tre dei quali riguardano o menzionano re Artù, quell’altra importante raccolta di testi bardici nota come Le tre serie o più comunemente Le triadi, e tutto questo materiale attribuisce alla storia di Artù un’ambientazione gallese, ma non è tutto, perché ora arriva la sorpresa più grossa. Il testo che è palesemente servito da base alla Historia Regum Britanniae, ossia alla traduzione latina di Geoffrey di Monmouth, si è conservato ed è giunto fino a noi sotto forma di ben una settantina di manoscritti, si tratta della cronaca conosciuta come Brut Y Brenhinedd, ossia (almeno nel titolo, la traduzione di Geoffrey è stata fedele) la “Storia dei re del Galles”.
E’ ben strano che la maggior parte dei ricercatori che hanno cercato di stabilire la fondatezza storica del mito arturiano non abbiano preso in considerazione un documento di fondamentale importanza come il Brut.
Non basta ancora, perché a questo punto i nostri autori sono ricorsi a una risorsa davvero, insolita per dei topi di biblioteca come sono molti loro colleghi, ossia due robuste paia di scarponi e zaino in spalla, percorrendo le campagne gallesi per identificare i luoghi degli eventi arturiani secondo la loro ipotesi, e anche qui le sorprese non sono mancate, e c’è da rammaricarsi che non abbiano potuto disporre di maggiori mezzi per compiere degli scavi archeologici.
Anche qui le sorprese non sono mancate, infatti, il confine orientale del Galles, il confine fra il Galles e la regione inglese della Mercia (il cui nome risale proprio probabilmente all’anglosassone-germanico Mark che significa “confine” è delimitato da due lunghi terrapieni di età sassone noti come argine di Wat e argine di Offa. In realtà questi due re sassoni non li avrebbero eretti ma ciascuno avrebbe solo restaurato la sezione a cui avrebbero dato il nome, di quello che era in origine un vallo romano, una costruzione non in muratura come quelli di Adriano e di Traiano, ma a terrapieno, tuttavia in compenso lungo ben 212 chilometri che tagliava l’Isola Britannica da nord a sud, dalla penisola di Wirral al canale di Bristol, escludendo a ovest quella parte dei Britanni che, come gli Scoti a nord i Romani non erano riusciti a sottomettere, e che sarebbero diventati i Gallesi, il vallo di Severo, oggi dimenticato. Le cronache locali riportano che da scavi effettuati sui due argini è emerso materiale, frammenti di vasellame e altro, di chiara origine romana.
Perché è importante questo? Perché nella saga arturiana ci sono diversi riferimenti al “vallo”, e molti commentatori, non conoscendo altro che il vallo di Adriano, hanno pensato bene di collocare il regno di Artù immediatamente a sud della Scozia, dove non trova nessuna corrispondenza né nella toponomastica né nelle tradizioni locali.
Un altro esempio ancora: Artù, secondo la leggenda, doveva erigere un monumento “agli eroi caduti”, in realtà nobili britanni massacrati a tradimento dai Sassoni e per farlo, su consiglio di Merlino, fece rubare le pietre di un monumento megalitico noto come “La danza dei giganti” che si trovava in Irlanda. La tradizione posteriore nata sul solco dell’Historia regum ha voluto identificare questo monumento con il celebre circolo megalitico di Stonehenge nel Wiltshire, sempre nell’arbitraria ipotesi che il suo regno si estendesse all’intera Isola Britannica. A parte il fatto che oggi sappiamo che Stonehenge risale all’età neolitica, riuscite a immaginare cosa dovrebbe significare smontare gli enormi sarsen, portarli per nave attraverso il mare d’Irlanda e rimontarli come se niente fosse nella piana di Salisbury? Basterebbe questo a togliere al mito arturiano qualunque pretesa di corrispondenza con una qualsivoglia realtà storica.
Blake e Lloyd invece avrebbero individuato questo monumento di risulta nella formazione che si trova nella piana gallese nota come Maes Mawr. Poiché per fortuna il libro è corredato di fotografie, possiamo vedere che si tratta di alcuni tumuli di pietre ammucchiate alquanto disordinatamente, che non hanno certo la grandiosità e la bellezza di Stonehenge, ma le cui dimensioni, almeno, risultano molto più ragionevoli in vista di un trasporto per mare. L’indizio fondamentale sarebbe dato dalla parola Maes che in gaelico significa “pietra sacra”.
Sulla base della premessa errata che il regno di Artù sarebbe stato esteso all’intera Isola Britannica, Geoffrey di Monmouth e coloro che sono venuti dopo di lui, hanno frainteso o falsato la topografia e la geografia dei luoghi, al punto da rendere impossibile o quanto meno arduo radicare la vicenda arturiana in un contesto concreto: le tre parti del regno di Artù: Cymru, Alban e Lloegyr sono state identificate rispettivamente con il Galles, la Scozia e l’Inghilterra, si tratterebbe invece del Galles settentrionale, della regione dei Powys e del Galles meridionale.
Questa ricerca ha permesso di identificare i luoghi arturiani, di cui sono state proposte le identificazioni più varie e meno credibili in ogni punto delle Isole Britanniche, con altrettante località gallesi. Citando a caso da un elenco piuttosto lungo, Camlan, luogo dello scontro finale fra Artù e Mordred, non sarebbe Camelford in Cornovaglia, ma Afon Gamlan, Keint, identificato con il Kent sarebbe invece la regione gallese del Gwent, Llundein identificata con Londra sarebbe invece Ludlow, e via discorrendo, anche se resta incerta l’ubicazione della mitica Camelot.
Se le cose stanno così, è possibile che dei meri errori materiali abbiano portato a un fraintendimento di questa ampiezza? Gli autori ritengono di no, si trattò invece di una falsificazione rispondente a un preciso disegno politico. Consideriamo il quadro storico. Le Isole Britanniche sono state abitate fino a tutta l’antichità da popolazioni celtiche, presentando un quadro etnico che non è stato sostanzialmente alterato dalla conquista romana. Con il ritiro dalla Britannia delle legioni di Roma, esse sono rimaste aperte alle invasioni barbariche rappresentate in questo caso dalle popolazioni germaniche degli Angli e dei Sassoni che dopo esservi sbarcate, hanno intrapreso la conquista dell’Isola Britannica, sottomettendola ad eccezione della Scozia (che neppure i Romani erano riusciti a piegare), del Galles, della Cornovaglia, e dando origine alla nazione che oggi conosciamo come Inghilterra (letteralmente, Terra degli Angli). Nel 1066, mezzo millennio più tardi, Harold, l’ultimo re sassone d’Inghilterra, fu sconfitto dal duca Guglielmo di Normandia, francese di origine vichinga, che a sua volta sottomise l’Isola ed è per questo ricordato come “il conquistatore”. Questo evento è considerato l’origine della monarchia che regge tuttora l’Isola e che fa risalire, attraverso complesse e intricate vicende dinastiche su cui non è ora il caso di soffermarsi, alla conquista del 1066 i suoi diritti sul trono inglese. Dopo poche generazioni, il trono britannico passò dai Normanni a un’altra casa francese, quella degli Angiò Plantageneti. Può sembrare strano, ma di tutte le case che si sono succedute sul trono britannico a causa del complesso gioco degli intrecci dinastici, solo i Tudor che hanno regnato nel XVI secolo per non più di tre generazioni da Enrico VII a Elisabetta I, erano effettivamente inglesi, tutti gli altri erano e sono stranieri.
Cosa fareste voi al posto dei sovrani Plantageneti dell’epoca di Geoffrey di Monmouth, stranieri e regnanti in ragione di titoli dinastici molto discutibili? Non avreste fatto di tutto per consolidare la vostra traballante legittimità?
Un personaggio chiave della vicenda è Roberto di Gloucester, il protettore di Geoffrey, che pare abbia avuto un’importanza tutt’altro che trascurabile nel suggerirgli di includere nella sua opera riferimenti a località inglesi che nulla avevano a che fare con il Galles e in ultima analisi a tradurre il Brut Y Brenhinedd in un certo modo. Roberto era un membro illegittimo della famiglia plantageneta, e il suo destino personale era strettamente legato a quello della corte di Londra. Potremmo dire quindi che Geoffrey di Monmouth lavorò sotto l’influenza diretta della Corona, vale a dire i re inglesi Enrico II e il suo successore Edoardo I “Gambalunga”.
Lo scopo che si proponevano i sovrani plantageneti era duplice: da un lato soggiogare anche psicologicamente il riottoso Galles usando le tradizioni di questa regione a conferma della loro legittimità, dall’altro presentare la dinastia Normanna-Plantageneta come la vendicatrice di quell’elemento gaelico il cui sangue continuava a scorrere nelle vene della maggior parte dei loro sudditi, e dare lustro alla propria casata di parvenu ricollegandola agli eroi della più antica tradizione dell’Isola Britannica.
Se c’è un luogo che gli appassionati del ciclo arturiano considerano sacro, e che non ha nulla a che fare con il Galles, è Glastonbury nel Somerset. Questa località è spesso identificata con l’Ynis Afallach, l’Isola delle Mele più volte citata dalle tradizioni bardiche collegate ad Artù, addirittura con la mitica Avalon, nonché con il luogo dove sarebbe sbarcato in Gran Bretagna Giuseppe d’Arimatea portando con sé il Santo Graal, dove forse a detta di alcuni il Graal sarebbe tuttora nascosto.
Quello che Blake e Lloyd hanno da raccontarci sarà forse deludente per alcuni, ma, stando alle loro ricerche, cos’ha a che fare Glastonbury con Artù? Detto senza giri di parole, nulla! Non esiste alcuna tradizione, alcun documento, alcun componimento bardico, alcun indizio di natura archeologica che colleghi Glastonbury al ciclo arturiano anteriore al 1181. In quell’anno l’abbazia di Glastonbury fu distrutta da un furioso incendio. Dovendo reperire i fondi necessari alla sua ricostruzione, l’abate pensò bene di mettere in circolazione la diceria che dai resti dell’abbazia distrutta sarebbero riemerse le sepolture di re Artù e della regina Ginevra e che da qualche parte lì vicino doveva essere nascosto il Santo Graal, allo scopo di attirare i pellegrini e con essi le offerte necessarie alla ricostruzione.
Informato della cosa, re Enrico II decise di fare la sua parte nella truffa che coincideva così bene con i suoi scopi. Fu organizzata una solenne cerimonia nel corso della quale, alla presenza del re, le presunte ossa di Artù e di Ginevra furono esumate ed esposte alla devozione popolare
Sfrondate dunque le fonti storiche dalle sovrastrutture posticce, ricondotta la vicenda arturiana nel suo naturale alveo gallese, si può istituire un interessante confronto fra quanto ci raccontano la tradizione bardica, il Mabinogion e le altre fonti originali e l’immagine di questo ciclo mitico che ci è più familiare e deriva dalle elaborazioni di Geoffrey di Monmouth, Chretien de Troyes, Thomas Malory. Troviamo un’ampia convergenza, ma anche delle differenze sorprendenti. Kay, ad esempio, il fratello adottivo di Artù, è ricordato come “un tipo rozzo e un po’ sempliciotto”. Ma guarda, perfino nella disneyana Spada nella roccia è rappresentato così. Ginevra è ricordata in diverse fonti come “la seconda moglie di Artù”; peccato che della prima non abbiamo nessuna notizia.
Un personaggio che i romanzi cavallereschi ispirati al ciclo arturiano sembrano avere letteralmente calunniato rispetto alla tradizione bardica, è quello di Morgana: essi ne hanno fatto l’incestuosa sorellastra di Artù, la madre del ribelle Mordred, colei che incanta e imprigiona Merlino. Nulla di tutto questo secondo i bardi: Morgana è una divinità o semi-divinità, la più potente delle nove sorelle che custodiscono l’accesso all’Annwn, l’aldilà celtico. Mordred/Medhrod che è semplicemente indicato come nipote di Artù, si ribella a quest’ultimo dopo aver sedotto Ginevra (in questo ruolo è stato poi sostituito da Lancillotto).
Desta una certa sorpresa leggere che, parlando dell’episodio legato al concepimento di Artù, che il re Uther Pendragon avrebbe avuto dalla bella Egyr (Igraine) da lui posseduta sotto le sembianze del marito di questa, Gorlois, vassallo che gli si era ribellato proprio per le attenzioni libidinose che il re aveva manifestato per la consorte, gli autori ne parlino come dell’unico episodio soprannaturale della saga, perché animali parlanti, teste che continuano a vivere e parlare dopo essere state spiccate dal busto, dee celtiche che si accoppiano con santi cristiani in un allegro e inestricabile sincretismo fra la vecchia e la nuova fede, pietre con infissa una spada che una sola persona può estrarre, che compaiono e scompaiono, rientrano nel comune e nell’ordinario.
Noi non dobbiamo dimenticare che parliamo di uomini con una mentalità diversa dalla nostra, con un’idea diversa rispetto a noi del normale e dello straordinario, per i quali il prodigioso intersecava continuamente la vita quotidiana.
Ma perché poi scomodare forze sovrannaturali là dove un buon travestimento e un abile trucco sarebbero bastati allo scopo? Tuttavia ho sempre avuto il sospetto che, sempre ammesso che la leggenda arturiana abbia una base storica, la verità sarebbe potuta essere un’altra, ancora più semplice. Volendo a tutti i costi la bella Igraine, re Uther si sarà trovato nella necessità di accettare anche il figlio che portava nel grembo, e avrà fatto mettere in circolazione la storia che conosciamo per far passare per proprio il figlio di Gorlois.
Altra sorpresa, Egyr-Igraine, a quanto riferisce la tradizione bardica, sarebbe stata pienamente d’accordo nell’occultare il piccolo Artù facendolo allevare da Cynyr (Hector) per metterlo al sicuro, poiché essendo stato concepito fuori dal matrimonio (se era figlio di Uther), era illegittimo (e a maggior ragione se, essendo figlio di Gorlois non era affatto un Pendragon), qualcuno a corte avrebbe potuto pensare di sciogliere l’imbarazzante nodo dinastico venutosi a creare, semplicemente eliminando il bambino.
In un altro episodio, di quelli che i poemi cavallereschi non menzionano, vediamo Artù adirato punire ingiustamente un suddito. Per un momento, commentano gli autori, lo vediamo uscire dalla dimensione mitica di sovrano ideale per tornare alla concretezza storica di capotribù gallese nemmeno troppo amato dai suoi sudditi.
Gli autori chiariscono anche l’ambiguo esito della battaglia di Camlan: Artù ferito a morte va “ad Avalon”, ma “Avalon” non è altro che l’Annwn, l’aldilà celtico. Qui probabilmente però la saga arturiana si è incontrata con un’altra tradizione, che sul continente è stata riferita ad esempio a Federico Barbarossa, quella del “re (o dell’eroe) che è stato e che sarà”, che non è morto ma si è addormentato in un sonno secolare, destinato a risvegliarsi quando il suo popolo avrà di nuovo bisogno di lui.
Le ipotesi di questo libro, soprattutto quella centrale, la riduzione del mito arturiano a saga puramente gallese, si possono accettare o no, e io stesso non metterei la mano sul fuoco, ma c’è una cosa che rende piacevole la lettura di questo libro: si vede che è stato scritto con passione, con amore e – direi – con gioia, non immergendosi solo nella lettura di antichi manoscritti, ma percorrendo la campagna alla ricerca dei luoghi di queste antiche vicende.
“Scott e io”, ci confida Steve Blake, “Abbiamo dedicato molto tempo a parlare con la gente dei posti che andavamo via via a visitare, a fare quattro chiacchiere sulla soglia di una porta o sul limitare di un cancello, appoggiati a un antico muro o vicino a un grande albero, ascoltando e facendoci raccontare leggende e tradizioni dalla voce di chi ancora le preservava nella memoria”.
E’, io credo, il tipo di ricerca al quale tutti noi vorremmo poterci dedicare, testimonianza di un amore e di una soddisfazione che non mancano di trasmettersi al lettore che scorre queste pagine nello spirito giusto.
Io penso che quella di Blake e Lloyd sia un’ipotesi da considerare con il massimo interesse, ma probabilmente non è la risposta definitiva, forse una risposta definitiva non esiste ma, al di là delle risposte, c’è bellezza e soddisfazione già nella ricerca.