Personalmente mi sono fatta inoculare vari tipi di vaccino, avendo bazzicato a lungo in paesi in cui molte vaccinazioni sono indispensabili, ma l’aura che circonda questo vaccino mi ha colta impreparata. Aerei e camion dell’esercito, scorte dalla polizia, l’onnipresente discorso pubblico, dosi agognate e mai sufficienti hanno riesumato nella mia memoria una storia vecchia come il mondo: quella del siero che salva, o allunga, la vita. Neppure nella più remota antichità la pozione miracolosa era alla portata di tutti.
 Presso le culture sciamaniche primordiali, ad esempio, l’uso di super-medicine e di funghi allucinogeni era un privilegio riservato agli «dèi», cioè ai diretti discendenti della stirpe originaria. Lo stesso uomo-Adamo, prototipo dell’«escluso» dal beneficio, non fece in tempo ad allungare le mani sul prezioso frutto dell’Albero della Vita che subito venne cacciato dal Paradiso Terrestre. Una sorte toccata ad altri personaggi leggendari, segno che in un dato periodo le trasgressioni erano all’ordine del giorno. Tra questi vi fu Adapa, il figlio che Ea-Enki «aveva fatto mortale» a causa di un’unione ibrida. Il suo mito si trova in un testo del XIV secolo a.C. ritrovato ad El-Amarna, in Egitto. Vagamente nominato come «uno degli Dèi», il mezzosangue in realtà non era un «dio» ma un super-dotato fisico con un’intelligenza fuori del comune. Tante qualità non sottrassero comunque alla derisione degli appartenenti alla Prima Razza, che si divertirono a fargli passare sotto il naso la droga di lunga vita senza dargliene neppure una goccia.
Presso le culture sciamaniche primordiali, ad esempio, l’uso di super-medicine e di funghi allucinogeni era un privilegio riservato agli «dèi», cioè ai diretti discendenti della stirpe originaria. Lo stesso uomo-Adamo, prototipo dell’«escluso» dal beneficio, non fece in tempo ad allungare le mani sul prezioso frutto dell’Albero della Vita che subito venne cacciato dal Paradiso Terrestre. Una sorte toccata ad altri personaggi leggendari, segno che in un dato periodo le trasgressioni erano all’ordine del giorno. Tra questi vi fu Adapa, il figlio che Ea-Enki «aveva fatto mortale» a causa di un’unione ibrida. Il suo mito si trova in un testo del XIV secolo a.C. ritrovato ad El-Amarna, in Egitto. Vagamente nominato come «uno degli Dèi», il mezzosangue in realtà non era un «dio» ma un super-dotato fisico con un’intelligenza fuori del comune. Tante qualità non sottrassero comunque alla derisione degli appartenenti alla Prima Razza, che si divertirono a fargli passare sotto il naso la droga di lunga vita senza dargliene neppure una goccia.
In via eccezionale poteva succedere che gli dèi decidessero di donare il segreto dell’elisir a un umano che non fosse di sangue blu, ma in questi rarissimi casi il beneficiario doveva sparire dal mondo, che, in ultima analisi, era un modo differente di morire. Accadde a Utnapishtim il «giusto», ad esempio, scampato all’inondazione che circa 5.500 anni fa alzò di tre metri il Golfo Persico sommergendo la piana di Sumer, il quale fu confinato con la consorte su un’isola misteriosa alla foce del Tigri e dell’Eufrate. Lì fu trovato da un affranto Gilgamesh, disperato per la perdita del compagno amatissimo Enkidu e sgomento davanti al mistero della morte. Utnapishtim indicò al re di Uruk un vegetale che cresceva sul fondo dell’Apsû, l’abisso d’acqua sotterraneo, il cui fiore era capace di ringiovanire enormemente il corpo. Il re lo trovò, ma posandolo un momento a terra per poter bere da una pozza d’acqua dolce se lo vide soffiare via da un serpente, che dopo aver ingerito la pianta uscì dalla sua vecchia pelle più splendido di prima e visibilmente ringiovanito. Il binomio sangue-longevità è una costante nei racconti più antichi. Il sangue di Adapa non era puro come non lo era quello di Gilgamesh, descritto come un lillu, un «uomo con caratteri demoniaci», che, tradotto in lingua corrente significa appunto «mezzosangue». Sua madre era una entu, una specie di dea, descritta come «altissima» e molto bella, mentre suo padre era Lugalbanda. Un nome quasi nordico, che ricorda vagamente quello del mitico eroe irlandese Lúg Lámfada. Il termine celtico Lug significa sia «verbo» che «luce». Parola e illuminazione. Ma due esseri umani straordinari non fanno un essere divino, e difatti i nostri eroi arrivarono a un passo dalla droga della longevità senza riuscire a farne uso. La strada di Adapa fu sbarrata da un Uccello-sciamano, quella di Gilgamesh fu deviata da un Serpente-sciamano. Entrambi i tutori dell’ordine tradiscono sotto la propria forma mitologica una natura primordiale. Un fatto che rivela la convinzione dei Sumeri, probabili autori di queste narrazioni, che i primi dèi-civilizzatori fossero realmente in possesso di un farmaco capace di allungare la vita, ma se ne riservassero l’uso esclusivo.
Ogni civiltà si è affidata ai suoi farmaci per prolungare la vita su questa Terra, che per brutta che sia è sempre meglio di niente. L’attuale stato dell’arte registra un raddoppio dell’aspettativa media di vita dei vermi Caenorhabditis elegans e la «scoperta» che nel DNA  degli islandesi, uno dei popoli meno meticciati della Terra, è presente un gene (battezzato «Matusalemme») che incide in modo significativo sulla durata media della vita di un essere umano. Non si sa come, né perché. Secondo la scienza popolare mangiare mele aumenterebbe l’aspettativa di vita del 10%. Quella ufficiale sottolinea invece la presenza di un moscerino della frutta che va matto per le mele, la Drosophila melanogaster, il quale sarebbe il portatore di un gene capace di raddoppiare la durata della sua vita. Il discorso non vale ovviamente per le mele insapori e inodori del supermercato, che sembrano (o forse sono) fatte di plastica, ma riguarda le «mele antiche», originarie, che potrebbero avere avuto particolari proprietà in grado di produrre effetti benefici sugli organismi viventi che le ingerivano. Siamo in presenza di una rivisitazione dell’adagio popolare “una mela al giorno toglie il medico di torno”? D’altronde, se venisse fuori che gli Antichi erano al corrente di «dettagli scientifici» a noi ignoti bisognerebbe riscrivere la Storia, e nessuno sembra intenzionato a farlo. Assumerebbero un nuovo significato anche tanti racconti tradizionali, a partire da quello legato alla mela del peccato di Eva, che altrimenti sembra una favola per bambini, ma i nostri remoti antenati non avevano l’abitudine di raccontare favole ai bambini.
degli islandesi, uno dei popoli meno meticciati della Terra, è presente un gene (battezzato «Matusalemme») che incide in modo significativo sulla durata media della vita di un essere umano. Non si sa come, né perché. Secondo la scienza popolare mangiare mele aumenterebbe l’aspettativa di vita del 10%. Quella ufficiale sottolinea invece la presenza di un moscerino della frutta che va matto per le mele, la Drosophila melanogaster, il quale sarebbe il portatore di un gene capace di raddoppiare la durata della sua vita. Il discorso non vale ovviamente per le mele insapori e inodori del supermercato, che sembrano (o forse sono) fatte di plastica, ma riguarda le «mele antiche», originarie, che potrebbero avere avuto particolari proprietà in grado di produrre effetti benefici sugli organismi viventi che le ingerivano. Siamo in presenza di una rivisitazione dell’adagio popolare “una mela al giorno toglie il medico di torno”? D’altronde, se venisse fuori che gli Antichi erano al corrente di «dettagli scientifici» a noi ignoti bisognerebbe riscrivere la Storia, e nessuno sembra intenzionato a farlo. Assumerebbero un nuovo significato anche tanti racconti tradizionali, a partire da quello legato alla mela del peccato di Eva, che altrimenti sembra una favola per bambini, ma i nostri remoti antenati non avevano l’abitudine di raccontare favole ai bambini.
Nella Grecia classica l’albero del melo, e non quindi il pesco o l’arancio, era sacro al dio iperboreo Apollo, che condivideva il suo gradimento con Nemesi e Artemide. L’usanza era scesa probabilmente dalle terre del Nord, dove la bella Idun, moglie del sommo poeta Bragi e dea di Asgard, custodiva le mele della giovinezza. Quando qualcuno degli Asi cominciava ad accusare i primi segni di decadenza, la dea apriva lo scrigno di legno di frassino e ne estraeva una mela d’oro capace di fermare il tempo. Non che le mele fossero davvero fatte d’oro, altrimenti gli dèi avrebbero dovuto avere i denti d’acciaio. Probabilmente si trattava di un’allegoria riferita all’Età dell’Oro, i cui racconti giunsero in discreta salute almeno fino al Ragnarök, a cui peraltro il segreto della sostanza miracolosa non sopravvisse. In seguito la ricetta dell’elisir di lunga vita rimase nell’immaginario collettivo solo sotto forma di ricordo, o immagazzinata in qualche cerimoniale. Esempi longevi furono certi riti legati al soma nell’India vedica, o i bouphonia di Atene, la cui funzione era sempre quella di rammentare e ravvivare i perduti tempi della sapienza divina.
Dalla Scandinavia alla Mesopotamia, dall’India proto-dravidica alla Cina, il farmaco prodigioso capace di allungare la vita assunse le forme più disparate, e talvolta non si trattava neppure di una droga in senso stretto. Il Mahābhārata parla ad esempio di «sorgenti che eliminano la vecchiaia», le malattie e la morte, rivelando in questo modo che l’allungamento della vita poteva derivare dall’utilizzo abituale di certe acque. Mentre in Irlanda il magico elisir era sinonimo di «birra di Goibniu», la bevanda che gli invasori Túatha Dé Danann consumavano nei loro banchetti per mantenersi giovani a lungo. In modo più raffinato la tradizione estremorientale identificò il nettare dell’immortalità con la rugiada. Gli stessi insegnamenti del Buddha nel Sutra Mahayana sono spesso paragonati a questa dolce acqua che non aveva uguali al mondo, non assomigliando né all’acqua di superficie né all’acqua piovana. Anche se i cercatori di elisir più accaniti furono senza dubbio i Cinesi.
Lo stesso taoismo, lanciato da Lǎozǐ tra i secoli IV e III a.C., si spese parecchio nel tentativo di mettere a punto strategie capaci di recuperare il segreto perduto. Si andava dalle tecniche respiratorie volte a raffinare il soffio vitale [qì] fino all’accoppiamento degli aspiranti matusalemme con ragazze giovanissime che dovevano tenere viva l’energia virile del ricercatore magico. Sebbene con poco godimento, dato che la ritenzione del seme era considerata un fattore imprescindibile per assicurarsi il prolungamento della vita. Ai mitici saggi che riuscivano a «raggiungere il paradiso», cioè ad ottenere il segreto dell’immortalità, venne dato il nome di xiān e una nobile collocazione tra geni e dèi che formavano il variegato pántheon taoista. Liberi dalle molteplici costrizioni del mondo materiale questi super-uomini potevano così librarsi nello spazio viaggiando su draghi e gru (chiari simboli astronomici), o volando direttamente per mezzo di ali (dello sciamano) su nuvole lontane oltre le quali si spalancava il «grande varco», l’«abisso senza ritorno» in cui le acque terrestri confluivano nella Via Lattea. Cronache cinesi relativamente recenti parlano addirittura di spedizioni organizzate da superbi imperatori e ricchi mercanti desiderosi di ritrovare le favolose isole degli xiān, custodi della ricetta del farmaco della longevità. Non si conoscono gli esiti di tali imprese, ma si sa che nel II secolo a.C. ci riprovò un megalomane autocrate unificatore del Zhōngguó, intenzionato ad impossessarsi del Tempo per vivere in eterno. Come un novello Ulisse uno dei suoi capitani fece ritorno dopo parecchi anni, raccontando che un enorme mostro marino gli aveva sbarrato la strada proprio sul più bello, impedendogli così di raggiungere le Montagne dei Beati.
Con un magistrale colpo di scena nel canto V dell’Odissea la ninfa Calipso offre a Ulisse la magica droga dell’eterna giovinezza in cambio del suo amore, ma l’eroe vagabondo respinge al mittente ciò che altri andavano ricercando per mare e per terra, e il significato di quel rifiuto ancora c’interroga. Ulisse libero da utopie e tentazioni di sfuggire alla sorte, oppure consapevole di una diversa verità?  Ci si sente «più umani», facendosi carico del proprio destino di mortali? E se la morte non fosse un dramma bensì una liberazione, come pensavano gli antichi più antichi? Su un punto tutte le tradizioni convergono: l’uomo non perse subito l’immortalità, da intendersi come estrema longevità, ma se la giocò strada facendo a causa di un temperamento instabile e allergico a qualsiasi tipo di regola. Non doveva mischiare il sangue della Prima Razza con quello di stirpi geneticamente inferiori, ma lo fece. Non doveva sperperare il patrimonio sapienziale ereditato dai Padri fondatori, ma lo disperse ai quattro venti. Non doveva allontanarsi dalla legge di corrispondenza che collega ogni cosa nell’Essenza universale, ma la dimenticò coscientemente con i risultati catastrofici che conosciamo. Il risultato fu l’insorgenza di una duplice realtà: da una parte «noi», la stirpe umana, dall’altra tutto quello che stava «al di fuori di noi», cioè il mondo. Sul cambio di prospettiva pesò una serie di fattori, il primo dei quali fu il graduale venir meno delle capacità percettive della specie. Facoltà basilari, visto che niente è in possesso di una vera e propria esistenza al di fuori della nostra percezione sensoriale animale. Neppure Spazio e Tempo, che sono modalità cognitive animali, possiedono realtà indipendenti, essendo semplici schemi interpretativi che appartengono alla logica mentale del nostro organismo animale, il quale può essere paragonato a un software che modella le percezioni in oggetti multidimensionali.
Ci si sente «più umani», facendosi carico del proprio destino di mortali? E se la morte non fosse un dramma bensì una liberazione, come pensavano gli antichi più antichi? Su un punto tutte le tradizioni convergono: l’uomo non perse subito l’immortalità, da intendersi come estrema longevità, ma se la giocò strada facendo a causa di un temperamento instabile e allergico a qualsiasi tipo di regola. Non doveva mischiare il sangue della Prima Razza con quello di stirpi geneticamente inferiori, ma lo fece. Non doveva sperperare il patrimonio sapienziale ereditato dai Padri fondatori, ma lo disperse ai quattro venti. Non doveva allontanarsi dalla legge di corrispondenza che collega ogni cosa nell’Essenza universale, ma la dimenticò coscientemente con i risultati catastrofici che conosciamo. Il risultato fu l’insorgenza di una duplice realtà: da una parte «noi», la stirpe umana, dall’altra tutto quello che stava «al di fuori di noi», cioè il mondo. Sul cambio di prospettiva pesò una serie di fattori, il primo dei quali fu il graduale venir meno delle capacità percettive della specie. Facoltà basilari, visto che niente è in possesso di una vera e propria esistenza al di fuori della nostra percezione sensoriale animale. Neppure Spazio e Tempo, che sono modalità cognitive animali, possiedono realtà indipendenti, essendo semplici schemi interpretativi che appartengono alla logica mentale del nostro organismo animale, il quale può essere paragonato a un software che modella le percezioni in oggetti multidimensionali.
Senza la percezione, legata alla subcoscienza, non possiamo raggiungere quella zona psichica occulta rispetto alla coscienza ordinaria, che è essenzialmente «natura». In assenza di un osservatore che «guarda con il cuore» e di un universo generoso che si «lascia guardare», esisterebbe solo uno stato indeterminato di onde di probabilità. Il «fuori» non è altro che l’estensione della logica spazio-temporale del Sé, e questo pensiero in un certo senso ci conforta. Se fossimo solo corpi dovremmo morire con loro ma se siamo la nostra subcoscienza, le nostre esperienze, le nostre sensazioni ed emozioni, allora non possiamo morire con il corpo. Questo nucleo di forze può essere espresso in maniera sequenziale ma, in ultima istanza, non è limitato da alcun confine.
Un mucchio di tempo e un sacco di fatica per scovare l’elisir di lunga vita, e alla fine si scopre che «l’immortale» è già dentro di noi. Sembra una beffa del destino. La stessa toccata ad Adapa e Gilgamesh. Può succedere, quando l’uomo vive per troppo tempo all’insegna dell’inganno e dell’occultamento. E oggi più che mai, visto che manca persino il tempo per pensare. Sono sparite le sane pause di ozio, tutto fugge via e l’attenzione si è abbassata al livello di quella di un pesce rosso. Mentre qualcosa d’importante accade solo quando la mente si prende una pausa, quando scappa dalla sua cella fatta di abitudini verbali, nervose e capricciose, quando si sposta in un’area più intima e riservata. Negli ultimi secoli ci siamo «mentalizzati» troppo. Sappiamo con un alto livello di precisione che Marte ruota su se stesso in 24 ore, 37 minuti e 23 secondi ma abbiamo perso completamente di vista l’insieme. Cerchiamo instancabilmente il pelo nell’uovo, senza pensare che l’Universo non è affatto quel gioco arido di miliardi di palline che sbattono una contro l’altra come insegnano a scuola, mentre il Big Bang, nella migliore delle ipotesi, è solo una descrizione parziale di un singolo evento all’interno di un continuum probabilmente senza collocazione temporale.
Nel complesso le nostre teorie sul mondo fisico sono limitate. Non che la scienza sia rimasta al palo per secoli, sarebbe ingeneroso sostenerlo, ma la bellezza di un tramonto, il miracolo dell’innamoramento, il gusto di un pasto delizioso rimangono per i suoi schemi degli eventi inafferrabili. Eppure il mondo incognito chiaramente correlato al processo biologico è il fulcro della comprensione dell’intero Universo. Ci sarà pure un motivo se le leggi universali sembrano formulate apposta per rendere possibile la nascita della vita animale, se le sue costanti fondamentali – non previste da alcuna teoria fisica – sembrano essere state scelte accuratamente, spesso con altissima precisione, proprio per permettere l’esistenza della vita biologica. Si direbbe che l’evoluzione delle specie sia funzionale al miglioramento dell’intero sistema. Nel mio piccolo non saprei dire quale grandioso architetto abbia realizzato un simile progetto, ma tutto questo è stato fatto. Esiste. E chissà se l’antenato delle Origini possedeva qualche informazione in più al riguardo.
Rita Remagnino

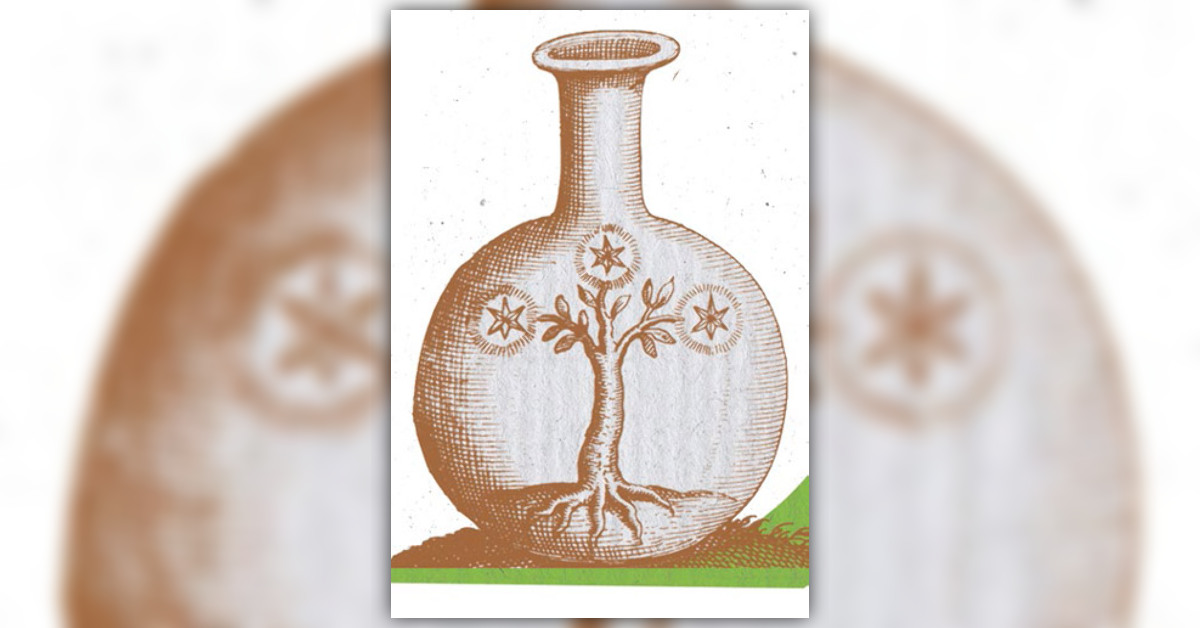

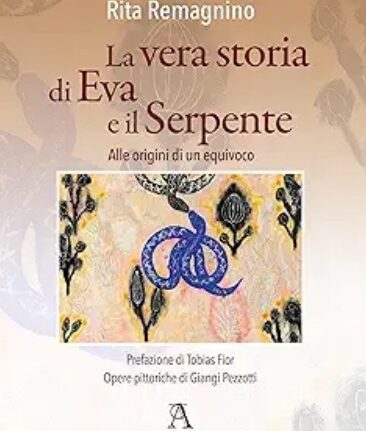



4 Comments