Il Paradiso dantesco ha dato filo da torcere a molti lettori, in particolare a quelli che pretendevano di comprendere con la ragione l’ideale di ordine e di armonia dell’universo ispirato dalle influenze celesti. Un’idea irrealizzabile nel Luogo dello Spirito per eccellenza, dove la causa iniziale e finale di ciò che accade è dio, cioè “l’amor che muove il sole e le altre stelle” (Pd XXXIII 145).
La terza cantica è molto diversa dall’Inferno e del Purgatorio, che, in fondo, sono due mondi opposti ma speculari, quasi fossero i coni di una clessidra, o i triangoli dell’Albero del Mondo. Qui le parole chiave sono “move” e “virtù” corrispondenti rispettivamente al movimento costante delle sfere e all’influsso esercitato da ogni singolo cielo sia sui cieli sovrastanti sia su quelli sottostanti, e di conseguenza anche sulla Terra che invece sta ferma.
O, almeno, così si credeva nel Medioevo.
Per creare l’atmosfera di questo non-luogo dove si percepisce ovunque la presenza di dio, il poeta impone ai versi un «movimento» spiraleggiante che di Cielo in Cielo solleva il canto verso l’alto fino a renderlo etereo. Come in Purgatorio anche qui il cammino procede in verticale ma in modo impercettibile, senza alcuna fatica. Una circostanza inattesa in uno spazio cosmico dominato dal movimento sotto forma di canti e danze dei beati, luci guizzanti, schiere angeliche che scorrono come fotogrammi sul gigantesco schermo universale.
Per quanto riguarda l’«influsso» la questione è più lineare, nel senso che i commentatori l’hanno risolta riconducendo la visione dantesca alla concezione del cosmo contenuta nell’Almagestum di Tolomeo. Il quale, però, non contempla il nono cielo che Dante avrebbe tratto dal Liber de motibus celorum di Alpetragio per il tramite di Alberto Magno. A quanto sembra una volta ri-scoperta la precessione degli equinozi, il Medioevo europeo ha avvertito la necessità di porre una nona sfera oltre la Stellata al fine di regolare il moto diurno degli astri da Oriente ad Occidente.
Sicuramente la materia «celeste» risultava più comprensibile quando l’astronomia e l’astrologia erano indistinguibili e costituivano la base da cui gli esseri umani partivano per formulare un qualsivoglia ragionamento, ma lo strapotere dello «specialismo» ha liquefatto il Tutto in fiumi tumultuosi di parole affermate e smentite, complicando ogni ragionamento.
Il Medioevo si pone a metà strada fra il prima e il dopo, motivo per cui Dante gode ancora della visione di un cosmo abitato da nove sfere concave concentriche che ruotano intorno alla Terra, immobile al centro dell’universo. Non per sempre, come già ribadito in Purgatorio, in quanto il globo terrestre è formato dai quattro elementi, cioè da materia corruttibile.
All’opposto i Cieli fatti d’etere sono eterni, immortali. Visti da quaggiù appaiono nell’ordine la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno. Sopra di essi vi sono il cielo delle Stelle Fisse e il Primo Mobile, o Cristallino, che, velocissimo, non contiene alcun astro ma muovendosi per primo a partire dall’alto, come suggerisce l’aggettivo che lo accompagna, imprime a tutti gli altri la “virtù”.
Anche nella cosmologia indiana il punto da cui comincia la creazione è la «cima del mondo» (lokkagge) che lo spirito in cerca di libertà raggiunge dopo avere attraversato i sette cieli planetari. La vetta rappresenta il movimento più «vecchio», il primo, l’Origine da cui discende tutto il resto; come si vede la dote di Dante proviene dalla poderosa cultura eurasiatica.
Il Decimo Cielo è l’Empireo che però non ha una forma sferica, o comunque definita, essendo pura luce. Nell’insieme la struttura fa pensare al Regno dei Cieli come a un’immensa macina che sopporta da tempo immemorabile la violenza proveniente dal caldo amore di carità e dalla viva speranza del suo perno (dio), dimostrandosi tuttavia in grado di vincere la volontà divina; ma solo perché questa vuole essere vinta. E comunque vince con la bontà delle sue intenzioni, nulla di simile alle piccole e miserabili beghe del mondo terreno in cui un uomo tenta di sopraffarne un altro per primeggiare. “Regnum celorum vïolenza pate / da caldo amore e da viva speranza, / che vince la divina volontate: / non a guisa che l’omo a l’om sobranza, / ma vince lei perché vuole esser vinta, / e, vinta, vince con sua / beninanza” (Pd XX 94-99).
Più vicina alla nostra «aiuola» la Luna ha meno “virtù” rispetto agli otto cieli superiori (Pd XXVIII 46-78). Il poeta si chiede quante intelligenze angeliche la muovono; alla fine, però, non lo dice. Descrive solo il Primo Cielo come una nube lucida, spessa, solida e pulita, simile a un diamante colpito dal sole. Lui e Beatrice vi giungono come un raggio di luce che fende l’acqua. Da non credere; come ha potuto il suo corpo solido penetrare in un altro corpo contravvenendo alle leggi della fisica?
In realtà il poeta potrebbe fare a meno di chiederselo, ben sapendo che la ragione basata sull’esperienza sensibile non è in grado di spiegare molte cose. Ma evidentemente ha bisogno di un pretesto per esporre alcune leggi sulla propagazione della luce di influenza araba, se pure innestate sulla teoria della luce di matrice averroistica esposta dal Grossatesta nel De Luce, dove il nostro satellite viene visto come “prima forma corporalis”.
Immagina così che i beati risentano ancora dell’influenza terrestre e li descrive come sagome dai contorni vagamente umani, quasi corpi riflessi nell’acqua. E le macchie lunari, domanda subito dopo alla sua guida, dipendono dal fatto che la luce del sole attraversando le zone di più alta densità viene frenata, creando il chiaroscuro?
Beatrice boccia in pieno la teoria esposta dal suo pupillo; se così fosse, dice, nelle eclissi di sole la Luna dovrebbe apparire di diverso spessore: “esto pianeto, o, sì come comparte / lo grasso e ’l magro un corpo, così questo/ nel suo volume cangerebbe carte” (Pd II 76-78). Inoltre se le macchie dipendessero dalla densità della Luna e delle stelle fisse, i due estremi degli otto cerchi mossi dal nono (il Primo Mobile) avrebbero una sola “virtù“, per cui non vi sarebbero differenze fra loro.
Ne consegue che le macchie lunari sono causate dalle differenti “virtù” infuse in esse dalle influenze angeliche, ovvero dall’energia che viene generata dalle reazioni termonucleari che si susseguono nello spazio cosmico: le stelle fisse trasmettono le forze ricevute dal primo mobile ai sottostanti cieli, “di grado in grado che di su prendono e di sotto fanno” (Pd II 122-123), così da un pianeta all’altro fino al nostro satellite, che, essendo l’ultima ruota del carro, riceve una luminosità inferiore rispetto ai Cieli sovrastanti e dunque è chiazzato.
Soddisfatto di avere stabilito l’origine metafisica delle macchie lunari, correlate alla maggiore o minore capacità della Luna di recepire la “virtù”, o principio, degli influssi celesti, il poeta non aggiunge altro. Ma, d’altronde, neppure i ricercatori moderni dicono granché sull’argomento. Alludono a presunti impatti cometari, però è difficile arrivare a conclusioni attendibili attraverso la riduttiva visione logocentrica fondata sul rapporto causa-effetto.
Per il momento non si può pretendere di più, siamo in fondo «spiriti difettivi» come i beati del Primo Cielo nei quali è ancora visibile l’ombra della Terra, nonostante trapeli da essi un non so che di divino. Quando Dante chiede a Picarda se si ritenga appagata dal più basso grado di felicità eterna, quella sorride davanti a tanta ingenuità.
A prescindere dall’intensità della luce circostante, spiega, il livello di carità raggiunto in Paradiso implica l’accettazione del posto assegnato e placa ogni ulteriore desiderio. Aspirando a qualcos’altro i beati andrebbero contro la volontà di dio che li ha collocati in una determinata posizione, ma questo è impossibile perché dio è il termine ultimo che muove tutte le creature dell’Universo.
Non è poi tanto male stare sulla Luna, affettuosa madre della galassia, dominatrice delle acque e regina delle foreste. Paziente e comprensiva essa osserva ciò che avviene sulla Terra da tempo immemorabile e davanti alle follie dei terrestri allargherebbe volentieri le braccia, se solo le avesse. Sarà forse per questo motivo che ai nostri occhi essa appare costantemente triste e assorta, debole e remissiva, quasi fosse un oggetto inerte da possedere.
Riproponendo questi concetti il poeta ricorda al lettore ciò che gli Antichi hanno sempre detto: l’uomo è inserito in un insieme di relazioni. Minerali, piante, animali, uomini, colori, suoni, stelle e pianeti sono anelli di una catena che non può essere spezzata nemmeno con la morte fisica di uno di questi elementi. E’ assurdo pensare che l’attività planetaria agisca nello spazio in modo meccanico mentre noi la osserviamo passivamente «da fuori».
I movimenti e gli influssi celesti riguardano direttamente il nostro essere profondo poiché il campo di forze trova un’adeguata cassa di risonanza nel nostro corpo (fatto d’acqua). Persino il supponente pensiero scientifico moderno ha dovuto ammettere che il mondo astronomico e quello delle particelle elementari appartengono ad un unico organismo cosmico nel quale ogni parte è collegata. Ciò nonostante l’attuale umanità, la più ignorante di sempre, progetta la «conquista» della Luna e pensa pure di riuscirci.
La prima colonia lunare dovrebbe essere realizzata entro il 2040. Dovendo scegliere tra la costruzione di uno «scudo planetario» capace di agire come un «trattore gravitazionale» sugli asteroidi che minacciano continuamente la Terra e quella di un villaggio extraterrestre, il lungimirante essere umano del XXI secolo ha giudicato quest’ultima più conveniente per i suoi affari.
Il Moon Village dovrebbe ospitare una base per attività scientifiche volte all’estrazione mineraria oltre ad alcune strutture adatte al turismo interstellare, ovviamente ristretto al pugno di ricconi che già oggi spendono milioni di dollari per fluttuare quattro minuti in una situazione di microgravità nel viaggio di andata e ritorno (100 Km circa) dalla Terra fino alla linea di Karman.
Tralasciando qualsivoglia considerazione di ordine logico, morale, filosofico, politico, economico e geostrategico che spedirebbe noi per primi nel buio della galassia, lasciamo parlare la saggezza antica. E’ entrato nella leggenda l’incontro avvenuto in una regione desertica dell’ovest degli Stati Uniti tra un anziano nativo americano e gli astronauti dell’Apollo 11 mandati ad addestrarsi in vista della presunta spedizione sulla Luna (1969).
– Cosa fate qui? – chiese il vecchio.
– Facciamo parte di una spedizione di ricerca che andrà a esplorare la Luna.
Il vecchio tacque per qualche minuto, poi chiese: – Potreste farmi un favore.
– Che cosa vorresti?
– La mia tribù crede che i sacri spiriti vivano sulla Luna, mi domando se voi potreste portare loro un importante messaggio da parte della mia gente.
– Che tipo di messaggio? – domandarono gli astronauti.
Il vecchio mormorò qualcosa nella lingua della sua tribù e poi chiese agli astronauti di ripeterlo più e più volte finché non l’ebbero imparato a memoria.
– Che cosa significa? – vollero sapere Armstrong e Aldrin.
– Non posso dirvelo, è un segreto che solo alla nostra tribù e agli spiriti della Luna è consentito conoscere.
Pensando che il vecchio fosse un po’ matto, gli astronauti se ne andarono. Per curiosità una volta tornati alla base si misero però a fare delle ricerche, trovando infine qualcuno che conosceva il linguaggio tribale. Ma non appena costui sentì pronunciare la frase memorizzata dai due ignari messaggeri, scoppiò in una fragorosa risata.
– Cosa c’è da ridere? – vollero sapere gli astronauti.
– Le parole che avete accuratamente imparato significano: “non dovete credere a nessuna parola che questi due vi dicono, sono venuti a rubare la vostra terra.” E giù di nuovo a ridere.
L’aneddoto suggerisce alcune riflessioni elementari. Come possono avere una «visione cosmica» individui che vivono dentro giardini recintati, o in claustrofobiche megalopoli ipertecnologiche? Al posto di andare a colonizzare la Luna, o Marte, o qualsivoglia sasso orbitante, non sarebbe più sensato tenere in ordine la propria casa? Qualcuno crede davvero di potersi elevare plasmando nuovi «tipi umani», cioè superuomini e subumani?
L’uomo capace di proiettarsi nell’avvenire non è certo il conquistatore che parte all’arrembaggio della Luna in tuta spaziale (peraltro, ancora in fase di progettazione) bensì colui che sa più cose avendo conservato una più lunga memoria, che può contare su radici profonde e ramificate, che è saldamente piantato nel terreno delle sue tradizioni, che coltiva la propria aiuola spirituale.
Nella chiusa allo scritto La bomba atomica e l’avvenire dell’uomo, Karl Japers parlando delle sciagure degli Ebrei in Egitto mette in bocca a Geremia queste parole: “Che significa questo? Significa che dio è, ciò basta. Se tutto svanisce, dio è: questo è l’unico sostegno, l’unico punto fermo per noi.” Qualora tutte le cose svanissero rimarrebbe comunque la certezza della Trascendenza, ciò significa che per inquadrare al meglio il movimento e l’influsso, come ha fatto Dante, bisogna prima mettere l’eternità del bene al disopra della finitezza del male. Il resto è un intermezzo ricreativo.

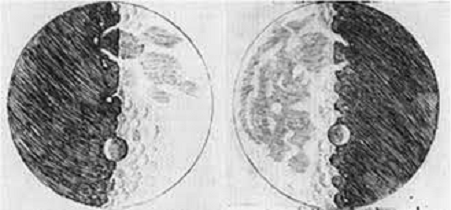

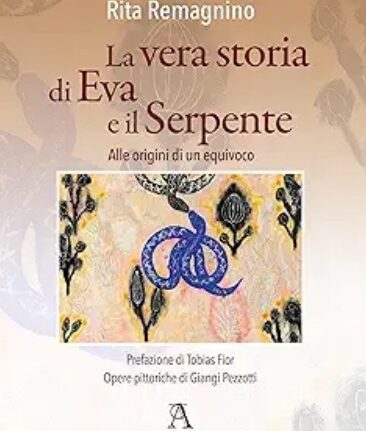



4 Comments