Durante il Neozoico, o Quaternario, cioè nell’Era in cui viviamo, vi furono ben quattro glaciazioni intervallate da fasi interglaciali con relative variazioni delle temperature e del livello delle acque oceaniche.
Nella fase glaciale Wisconsin/Würm (detta Tioga), giunta al culmine attorno ai 21.000 anni fa, gli sconvolgimenti idrogeologici connessi allo scioglimento delle calotte toccarono il 60° parallelo nord, coinvolgendo le più avanzate culture del pianeta. Ciò significa che il padre del realismo geopolitico Nicholas Spykman (1893-1943) ribadì un’ovvietà scrivendo in The Geography of the Peace che il «centro dell’attività politica del mondo» si trovava nella fascia continentale compresa tra il 25° e 60° parallelo nord, stando così le cose da tempo immemorabile.
I ritrovamenti di ornamenti personali e artefatti di dimensioni portatili, unitamente a oggetti e immagini di complesso valore simbolico, rivelano l’esistenza nella fascia suddetta di una società ben strutturata intorno ai 30mila anni fa; periodo in cui, ad ogni modo, la cultura uscita dal centro polare primordiale non era più un movimento unitario bensì un’intricata matassa di popoli dotati ciascuno di peculiari personalità.
Già allora lo spazio geografico determinava le differenze sociali, ovvero culturali, mentre la maggiore estensione delle masse continentali accorciava le distanze, permettendo all’umanità civile di affrontare lunghi viaggi. L’oceano più grande del mondo, il Pacifico, sfoggiava un ampio mantello maculato di terre emerse e arcipelaghi. Interminabili ponti di terra collegavano la Scandinavia all’Islanda. La Groenlandia settentrionale e l’isola di Baffin risultavano libere dalla calotta glaciale.
Fu così che i Siberiani e gli Atlanti si misero in movimento, esportando saperi e tecniche un po’ dappertutto, Europa inclusa, sebbene gli occidentali moderni ricordino soltanto gli ultimi, come se i primi non fossero mai esistiti.
Un atteggiamento riconducibile in primo luogo alla presenza della vasta tundra (poi inabissatasi) chiamata Doggerland, che assicurò i contatti e gli scambi tra l’area scandinava e il Mediterraneo per tutta la preistoria. Non ultime le testimonianze greche che ebbero occhi e orecchie soltanto per il Centro Sacrale nordatlantico, o iperboreo, da dove partivano per il tempio di Apollo gli omaggi degli Atlanti sotto forma di offerte avvolte in paglia di grano (E. Ebers, La grande era glaciale, Sansoni, 1963).

Si dice che il dio in persona lasciasse ogni anno Delfi per svernare nell’isola posta “al di là del vento”, dove il clima mite garantiva raccolti abbondanti e un’incredibile varietà di specie arboree. Da lassù Eracle avrebbe importato il primo albero di olivo che fu trapiantato sull’Olimpo; finché l’eterna primavera divenne un pessimo inverno e gli scambi cessarono (Erodoto, Le Storie, trad. Luigi Annibaletto, Milano, Mondadori, 1956).
Segnati in profondità dal pregiudizio ancestrale, tuttora gli eurasiatici formano un’infelice coppia di separati in casa. Nell’immaginario collettivo l’est continua ad essere l’est, ossia il coraggio e l’indomabilità, la selvatichezza; mentre adagiato sugli allori del passato l’ovest non riesce a togliersi di dosso i panni dell’ordinatore del mondo (“tu regere imperio populos, Romane, memento”), fingendo di non sapere che il termine regere significa anche imporre, sfruttare, derubare, togliere di mezzo in modo brutale gli oppositori del sistema imposto dall’egemone.
Il buon senso suggerirebbe di ricucire lo strappo al più presto onde evitare danni peggiori; ma purtroppo solo una mente educata è in grado di comprendere un pensiero diverso dal proprio senza doverlo necessariamente accettare (Aristotele), e l’attuale conformismo impedisce all’uomo tecnologico di opporsi alle cattive maniere del sistema che lo imbozzola.
Il ponte levatoio della Preistoria
Mentre i ricordi relativi alla Patria Nordatlantica, o iperborea, attecchirono piuttosto bene nel Peloponneso grazie alle migrazioni dei Micenei, soppiantati in seguito dai Dori, quelli riguardanti la Patria Siberiana rimasero là dov’erano.
A nord-est il clima mite durò fino al VI millennio a. C., come testimoniano i ritrovamenti degli ultimi mammut nella penisola di Tajmyr, offrendo alla società locale la possibilità di continuare a coltivare sul posto gli insegnamenti tradizionali. Anche lo stadio culturale paleolitico terminò molto tardi, quando nel continente europeo già fioriva il mesolitico che le popolazioni siberiane neppure conobbero (G. Bailey e P. Spikins, Mesolithic Europe, Cambridge, University Press, 2008).
Finché l’onda lunga del disgelo lambì la tundra artica, spostandola ancora più a est; lentamente gli abeti rossi e le betulle diffusero ampie zone boschive (la taiga), gli animali di grossa taglia si estinsero e ai cacciatori del lago Bajkal rimasero soltanto le prede più piccole. Essi riattivarono così le piste degli antenati che portavano al continente opposto attraverso la penisola di Kamčatka (tuttora abitata dai loro discendenti ciukci, coriachi, nivchi, itelmeni, jukaghiri e ket).
Alcuni scavi effettuati in quell’area hanno portato alla luce i resti di una bambina di tre anni vissuta circa 11.500 anni fa e appartenuta al gruppo arcaico dei «Beringi», parenti stretti dei popoli della valle di Tunkinskaya, stabilmente stanziati nei territori adiacenti al ponte-Beringia.
Il dentro/fuori dall’acqua della passerella artica occupò quasi tutto il Quaternario, cioè il periodo più recente della storia geologica della Terra, quello in cui andò delineandosi la linea evolutiva culminata nell’uomo moderno. Attualmente il «ponte» si trova sotto il Mare di Laptev, il Mare Siberiano Orientale, il Mare dei Ciukci e il Mare di Beaufort, ma non è sempre stato così.
In tempi preistorici esso «appariva» quando il clima si raffreddava, ingenti quantità di acqua sottratte al mare dal processo di evaporazione venivano convertite in immense masse di ghiaccio sulla terraferma e gli oceani si abbassavano; oppure «scompariva» sott’acqua quando le temperature si rialzavano e lo scioglimento dei ghiacci rialzava il livello dei mari [immagine 1].
Il collegamento fu attivo fino a circa 37.000 anni fa, e poi ancora tra i 26.000 e gli 11.000 anni fa, periodo in cui s’inabissò di nuovo. Nel frattempo le conifere avanzarono e si ritirarono più volte nel senso della latitudine, cavalli e cammelli americani raggiunsero l’Asia mentre mammut, bisonti dalle grandi corna e cervidi migrarono in Nordamerica.
L’ultima sparizione del ponte fu determinata dal rialzo delle temperature e dalla loro successiva stabilizzazione. Le enormi dighe di ghiaccio contenenti l’acqua di scioglimento delle antiche calotte cedettero, anche il grande lago glaciale Livingston si riversò nell’Atlantico (circa 14mila anni fa), il livello dei mari salì di 13-14 metri in pochi anni e la geografia mondiale assunse un nuovo aspetto.
I geologi sostengono che se domani, per ipotesi, un’ondata di gelo dovesse abbassare il livello del mare di soli 50 metri, la Beringia tornerebbe a collegare la Siberia all’Alaska con un ponte naturale largo circa 500 chilometri. Nel caso in cui l’abbassamento fosse ancora più consistente, l’istmo si trasformerebbe in un’area continentale di 1500 chilometri tra l’Arcipelago Aleutino e l’Oceano Artico.

La scoperta dell’America
In Alaska i cacciatori del lago Bajkal sostarono a lungo, non tanto per libera scelta quanto più per lo sbarramento costituito dalle due grandi masse di ghiaccio, quella occidentale (Cordilleran Ice Sheet) e quella orientale (Laurentide Ice Sheet), che ostruiva ogni possibile accesso [immagine 2].
Solo il disgelo permise agli esploratori di fare ulteriori passi avanti, e, nonostante la vera storia del popolamento americano non sia ancora stata scritta, sembrano essere tutti d’accordo nel distinguere almeno quattro importanti ondate migratorie:
- la prima, antichissima, fu quella dei marinai e pescatori fuegini (l’ultimo discendente dei quali è morto nel 1999), spinte successivamente dalle tribù autoctone fin giù nella Terra del Fuoco;
- la seconda ondata, quella che formerà gli «americani» veri e propri, risale a 13.000 anni fa. Tracce genetiche e culturali dei riposizionamenti di quell’epoca sono rimaste nelle tradizioni degli Apache Chiricahua (https://camnnation.org/history/chiricahua-origins/);
- la terza ondata, quella dei Na-Denè avvenuta via mare dal Pacifico circa 11.000 anni fa, diede origine a gruppi come i Navajos, gli Athabaska, i Tlingit ed altre popolazioni stanziate nel nord-est del continente;
- riguardo alla quarta ondata sarebbe più indicato parlare di «migrazione fantasma», in quanto le ricerche genetiche evidenziano una parentela americana con gli australoidi e alcune tribù amazzoniche, ma ancora non è chiaro quando e come gli incontri interetnici siano avvenuti.
Nel continente verticale i Siberiani introdussero l’elemento primordiale e unitario del ceppo «caucasoide arcaico» rilevato tra i Nativi. Occhi obliqui (vagamente serpentiformi), zigomi alti, pelle bianca o giallastra, corporatura resistente alle fatiche, al forte freddo e al forte caldo. Marcatamente eurasiatici appaiono inoltre i legami tra certi riti siberiani eseguiti sotto il simbolo dell’Albero e del Cigno e lo «sciamanesimo primordiale» dei Pellerossa, mentre le stime di carattere glottologico degli idiomi americani mostrano diverse affinità linguistico-grammaticali con alcune lingue ungro-finniche e dell’Altaj.
La genetica pone comunque altre questioni. Se infatti precise caratteristiche (D9S1120 – 9RA) provano che i Siberiani emigrarono in Alaska attraverso il ponte-Beringia (K.B. Schroeder et al., in Molecular Biology and Evolution, XXVI, pp. 995-1016, 2009), resta il fatto che tra l’Alaska e la Terra del Fuoco sono stati individuati ben cinque aplogruppi ancestrali: A, B, C, D e X.
Per esempio l’aplogruppo X (più precisamente mtDNA X2), rilevato solo nella zona nord-orientale del continente americano, risulta assente negli altri pool genici ma presente negli Europei (nella mutazione X2), soprattutto francesi e spagnoli, e in certune etnie nordafricane, mediorientali e centro-asiatiche (R. Gruhn e A. Bryan, in Peuplements et préhistoire en Amériques, CTHS, Paris, 2011, pp.17-30).
Evidentemente l’Eurasia scoprì le Americhe in tempi e modi differenti sia percorrendo il cammino beringiano sia navigando sulle acque basse dell’Atlantico. Nel secondo caso, stando agli studi di Stanford e Bradley, gli arrivi sarebbero avvenuti tra i 23.000 e i 19.000 anni fa. (D.J. Stanford e B.A. Bradley, Across Atlantic ice. The origin of America’s Clovis culture, University of California Press, Berkeley, 2012).
Nel periodo glaciale non era un’avventura impossibile partire dall’area islandese e groenlandese per andare a gettare l’ancora nell’isola di Anticosti, attuale accesso al Grand Fleuve del Canada, un enorme specchio di cristallo verde che suscita tuttora un sacro timore reverenziale.
Probabilmente le esplorazioni via mare avvennero a più riprese, cioè prima e dopo la stabilizzazione degli Atlanti in Europa, un fatto confermato anche dalla discreta quantità di foche e animali marini presenti nelle pitture rupestri francesi.
Pochi dubbi permangono sull’origine europea degli Ichigua, parenti stretti della cultura solutreana diffusa nel sud-ovest della Francia, nonché in Spagna e Portogallo.
Lontane dagli altri idiomi usati dai Nativi ma vicine al basco appaiono inoltre le forme espressive algonchine, un tempo diffuse nella regione dei Grandi Laghi ed oggi ridotte a poche centinaia di soggetti parlanti [immagine 3].

Presunti privilegi
Quanto detto conferma l’attualità della Preistoria, che lungi dall’essere una materia superata smonta attraverso i fatti il castello narrativo eretto dal totalitarismo contemporaneo per dimostrare l’invulnerabilità dell’«isola maggiore» (l’America), la quale non può affatto dirsi al sicuro tra i due oceani, essendo stata penetrata fin dai primordi sia dal Pacifico che dall’Atlantico.
S’illude chi sentendosi «al riparo» da interferenze esterne spera di occultare i propri problemi interni impicciandosi a distanza di quelli altrui. Una visione di chiara matrice evangelico-coloniale consolidatasi nel continente verticale tra le due guerre mondiali, intorno al 1937, e destinata ad attribuire un vantaggio geo-strategico a «isole» come Gran Bretagna e Stati Uniti, ovvero a giustificare l’arrembaggio del mondo da parte dell’«uomo bianco» mascherato da corsaro.
Queste cose appartengono però al passato. La filosofia navale vecchio stampo è ormai inefficace, non fanno più impressione come un tempo le grandi portaerei detentrici del «potere di mare», né i carri armati emblemi del «potere di terra». Oggi i missili ipersonici celebrano il «potere dell’aria», mentre la bomba che scatenerà la terza guerra mondiale potrebbe deflagrare nell’atmosfera, da dove partiranno le gigantesche onde di impulsi elettromagnetici che paralizzeranno popoli e nazioni, annientandoli.
Gli istituti di ricerca e think tank specializzati nelle relazioni internazionali dovrebbero dunque modernizzarsi. O per meglio dire, antichizzarsi visto che tutto ciò che serve al futuro è già contenuto nella pre-geopolitica, impermeabile al tradizionale confronto Mare vs Terra e pertanto aperta a qualsiasi opportunità di evoluzione e progresso individuale, sociale, politico, morale e spirituale.
Il Mare non è mai stato un elemento divisivo, ma, anzi, ha dimostrato in molteplici occasioni di essere una formidabile cinghia di trasmissione. Per questa ragione i nostri più remoti antenati non furono «puri» nomadi di mare o di terra, bensì entrambe le cose a seconda delle circostanze.
In tempi di acque basse essi si dedicarono alle navigazioni d’alto mare, ma poi, non appena il livello marino saliva, tornavano ad essere individui stanziali dimoranti tra le radici umide degli alti fusti, in mezzo a sorgenti e paludi, a caccia di cibo tra i rami bagnati di pioggia degli alberi.
Se ne deduce che la geografia non assegna privilegi a nessuno, e, qualora desse l’impressione del contrario, non va dimenticato che il destino dell’assoluto è sempre quello di diventare relativo, come intuì lo stesso mentore del potere talassocratico moderno, rivisitazione dell’antica visione predatoria del Falco (A. T. Mahan, The interest of America in Sea Power, Boston, 1917, p.53).
Anche Nicholas Spykman ammise quanto fosse fuorviante immaginare uno Stato fondato esclusivamente sulla «potenza del mare», o sulla «potenza della terra». I tempi e le situazioni cambiano, gli equilibri si modificano, la morfologia dei territori assume caratteristiche inedite, come del resto le richieste del mercato e le necessità strategiche delle nazioni.
Meglio dunque accantonare le teorie e stare alla larga dalle cortine fumogene create dai padroni della narrazione. I fatti raccontano che nel corso del tempo l’uomo ha potuto salvare se stesso solo mantenendo un profilo basso, operando in ambiti ristretti e accontentandosi di avanzare a piccoli passi, che è l’equivalente di un esercizio spirituale. Ci sarà tempo più avanti per immaginare la luna e le stelle.




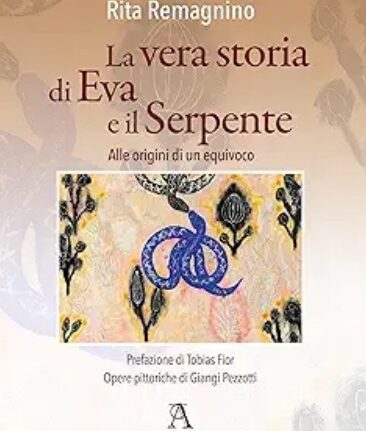


14 Comments