Il sette è un numero sacro nella quasi totalità delle tradizioni eurasiatiche. Sette sono i doni dello Spirito Santo nel Cristianesimo; sette sono i peccati capitali ed i sigilli la cui rottura annuncerà la fine del mondo nell’Apocalisse di Giovanni; sette sono le braccia della menorah ebraica; sette sono gli attributi fondamentali di Allah, i cieli da lui creati, i versi della prima sura del Corano ed i gradi delle interpretazioni esoteriche del Libro. Sette erano i dormienti di Efeso; sette gli Imam della tradizione ismailita. Sette erano i Rishi (i “cantori ispirati” dei Veda) e sette erano i Saggi dell’Antica Grecia.

Uno di loro, Biante di Priene, affermò: “οἱ πλειστoι κακoί” (i più sono cattivi). Un’affermazione all’apparenza semplice ma che, al contrario, nasconde tutta la profondità di quel pensiero iniziale della Grecità capace di racchiudere in una sentenza ciò che nella Modernità necessita volumi interi di introspezione psicologico-filosofica sulla natura umana. Sette, di fatto, sono anche le Nazioni bombardate durante i due mandati dell’amministrazione Obama-Biden: Afghanistan, Iraq, Pakistan, Libia, Siria, Yemen e Somalia. Nel solo 2016, gli Stati Uniti hanno sganciato 26.172 bombe tra questi sette Paesi. Nel 2015, alcune della bombe umanitarie del Premio Nobel per la Pace caddero sull’ospedale di Kunduz in Afghanistan uccidendo 42 civili. Bisogna riconoscere che in questa corsa al massacro, l’amministrazione Trump-Pence non è stata da meno. Senza considerare la totale distruzione della cittaà siriana di Raqqa nel 2017 (capitale del sedicente “Stato Islamico”), miliziani e civili compresi, il “Presidente che non ha iniziato nuove guerre” (sic!), nel solo 2019 ha sganciato più bombe su Afghanistan e Yemen dei suoi predecessori, con il picco di 7.423 ordigni nel solo Paese centroasiatico. Anche la nuova amministrazione Biden-Harris sembra aver iniziato con i migliori propositi. Negli ultimi giorni di febbraio, infatti, dopo aver affermato “America is back!” e “diplomacy is back!”, il nuovo Presidente USA ha ordinato un bombardamento “mirato” contro le postazioni di alcune milizie siriane colpevoli, a suo dire, di aver minacciato le truppe nordamericane che occupano (illegalmente) la parte nord-orientale del Paese, e che si dedicano attivamente al saccheggio delle risorse naturali ed alla distruzione dei campi di grano per allontanare ad infinitum ogni potenziale ricostruzione e pacificazione della Siria.
Ora, sorvolando per un istante sul fatto che un Presidente degli Stati Uniti d’America (una Nazione fondata sul genocidio), anche nel remoto caso in cui possa avere ragione, non può comunque dare dell’assassino a nessuno (il presunto cattolico Biden, in questo caso, sembra non vedere la trave nel proprio occhio), affermare “diplomacy is back!” e dopo qualche giorno accusare il Presidente della seconda potenza mondiale (in termini militari) di essere un “killer” non sembra esattamente una fine strategia diplomatica. Senza considerare che sembra essere in linea con le assai colorite espressioni utilizzate da Donald J. Trump per definire gli avversari a seconda del momento: dal “foe” (nemico) nei confronti dell’Europa, al “rocketman” (uomo razzo) per Kim Jong-un, fino al raffinato “son of a bitch” (la traduzione si lascia al lettore) per il Generale Martire iraniano Qassem Soleimani. Tuttavia, per chi sa leggere tra le righe, il messaggio (e soprattutto lo scopo) dell’uscita di Biden risulta essere più chiaro di quanto si possa immaginare.

Chi scrive ha spesso sostenuto la tesi della sostanziale continuità geopolitica tra le diverse amministrazioni nordamericane. Almeno dagli anni ’50 del XX secolo, quando la Cina, a seguito dell’intervento nella Guerra di Corea, è emersa come terza potenza tra i due principali competitori ideologici della Guerra Fredda, la strategia geopolitica nordamericana si è concentrata sulla ricerca di una sponda (o da parte sovietica o da parte cinese) per mettere all’angolo ed isolare alternativamente uno dei due rivali. Tale strategia ha funzionato sia in chiave anti-cinese tra la fine degli anni ’50 e la fine degli anni ’60, sia in chiave anti-sovietica con la distensione sino-americana dei primi anni ’70. Questa distensione venne determinata dal fatto che in quel preciso momento storico, la Cina maoista, economicamente e tecnologicamente ancora debole, non rappresentava una particolare minaccia per gli Stati Uniti ben più interessati al contenimento dell’URSS ed alle risorse mediorientali. Non bisogna dimenticare, infatti, che la stessa Cina, anche prima della nascita della Repubblica popolare, veniva considerata dagli Stati Uniti (insieme all’India, magari non divisa dalla partizione) come un elemento fondamentale per fermare la proiezione geopolitica sovietica sul continente asiatico.
Oggi, la situazione sembra essersi capovolta. Il Medio Oriente non ricopre più un’importanza centrale nella strategia nordamericana essendo stato sostituito dall’area del Mare Cinese Meridionale, potenzialmente ricca di risorse naturali e divenuta centro del commercio globale nel XXI secolo. La Cina, tecnologicamente, economicamente e militarmente sempre più forte e capace di proiettare la propria influenza attraverso dinamiche che si pongono come alternativa rispetto ai modelli della globalizzazione neoliberale (dal rapporto istituzionale diretto tra i governi e non tra governi e corporazioni multinazionali alla non imposizione di riforme strutturali di stampo neoliberista agli Stati con i quali si stabiliscono rapporti commerciali), costituisce la più grave minaccia alla declinante egemonia globale degli Stati Uniti.
Alla luce di questo fatto, diversi (presunti) strateghi e analisti geopolitici nordamericani (più o meno accostabili ad entrambi gli schieramenti), ormai con una certa costanza da diversi anni, sostengono la necessita di un avvicinamento alla Russia in chiave anti-cinese. Tale avvicinamento, tuttavia, almeno secondo la corrente “democratica”, dovrebbe presupporre prima di tutto un allontanamento dal potere di Vladimir Putin. E tale allontanamento presuppone in primo luogo l’imposizione di una pressione costante nei confronti della Russia (volta anche alla destabilizzazione interna per mezzo di una “quinta colonna” composta da oligarchi, pseudoliberali ed agitatori di varia natura), soprattutto nel momento in cui questa, attraverso una sapiente “diplomazia vaccinale” (data anche dal fatto che lo Sputnik V, non sorprendentemente, sembra essere più efficace rispetto ai vaccini prodotti dalle multinazionali farmaceutiche “occidentali”), si sta riproponendo su scala globale e continentale rompendo la “nuova cortina di ferro” posta ai confini occidentali della Federazione.
L’ossessione “democratica” per Vladimir Putin non è di certo una novità ed in qualche modo fa da contraltare all’ossessione repubblicana per la Cina. Recentemente, a questo proposito, sarebbe stato prodotto un nuovo rapporto sulle presunte interferenze russe (volte a portare alla rielezione di Donald J. Trump) nelle recenti elezioni nordamericane. Allo stesso tempo, secondo il suddetto rapporto, l’Iran avrebbe interferito per far eleggere Biden, mentre la Cina avrebbe mantenuto una posizione di sostanziale non interferenza. Senza entrare nel merito di questi rapporti presentati alternativamente con scadenza elettorale da entrambi gli schieramenti politici nordamericani (e senza giudicare la presunzione e l’ipocrisia con la quale il Paese principe nell’interferenza esterna muove certe accuse), appare evidente che l’uscita piuttosto infelice di Joe Biden, oltre che dalla volontà di mettere in guardia la colonia Europa da eventuali ripercussioni per il “crimine” di fare affari con la Russia (il cappio sanzionatorio attorno alla costruzione del Nord Stream 2 è l’esempio emblematico), potrebbe essere stata determinata anche da questo fattore.
Dunque, se è vero che il messaggio, forte e chiaro, è rivolto in primo luogo a mantenere alto il sentimento russofobico tra le schiere dei collaborazionisti europei, è altrettanto vero che questo è rivolto anche all’ambito interno. La crisi pandemica, infatti, oltre a mettere in luce globalmente gli inganni del neoliberismo, ha ulteriormente ampliato le linee di faglia interne alla società nordamericana. Questa, profondamente divisa economicamente, razzialmente e geograficamente, viene mantenuta unita solo ed esclusivamente dall’idea del “destino manifesto” che viene declinata alternativamente in senso messianico evangelico o laico a seconda di chi occupa i vertici del potere.
L’individuazione di un nemico è sempre utile a rinvigorire il senso di presunta superiorità morale posto a fondamento del logos esistenziale statunitense, soprattutto in un momento in cui la rabbia per il declino del suo status egemonico (per la fine dell’istante unipolare) sta rapidamente montando e gli stessi USA non riescono più ad imporre (se non ai più accondiscendenti) un modello strategico impostato sul mero utilizzo della forza per negoziare da posizioni di vantaggio. Meglio ancora se tale nemico si presta ad una criminalizzazione individuale che possa consentire l’utilizzo di schemi pseudo-umanitari (più o meno gli stessi che negli ultimi giorni hanno portato la Gran Bretagna, protagonista nella fornitura di sostegno logistico e militare ai tagliagole che hanno distrutto la Siria, ad accusare Asma al-Assad di crimini di guerra).
Di fronte ad una simile situazione, e preso atto che nel campo delle relazioni internazionali non ci sono santi (e che “i più sono cattivi” come affermò Biante di Priene), sembra comunque doveroso riportare alcuni passaggi della risposta di Vladimir Putin al Presidente nordamericano:

“Voglio ricordare che gli Stati Uniti sono l’unico Stato al mondo che ha impiegato la bomba atomica contro un altro Stato, privo di questa arma, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki non vi era assolutamente nessun senso militare, si è trattato solo di puro sterminio diretto della popolazione civile. Noi sappiamo che gli Stati Uniti sono interessati ad avere con noi determinati rapporti e solo sulle questioni che a loro convengono e alle loro condizioni. Noi siamo diversi, noi abbiamo un altro codice genetico e un altro codice morale, tuttavia noi sappiamo difendere i nostri interessi e collaboreremo con gli Stati Uniti, ma solo in quei campi e alle condizioni che a noi convengono, dovranno fare i conti con questo, nonostante tutti i loro tentativi di fermare il nostro sviluppo, nonostante tutte le loro sanzioni e insulti”.
Daniele Perra






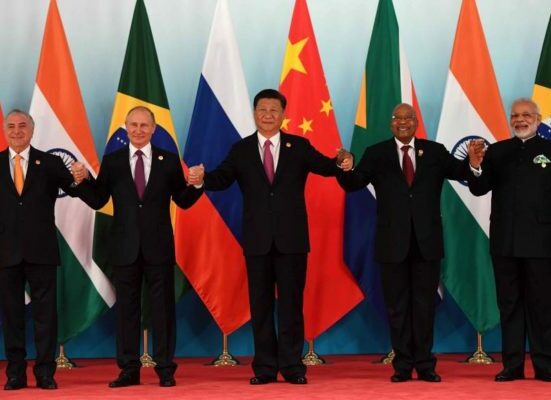

2 Comments