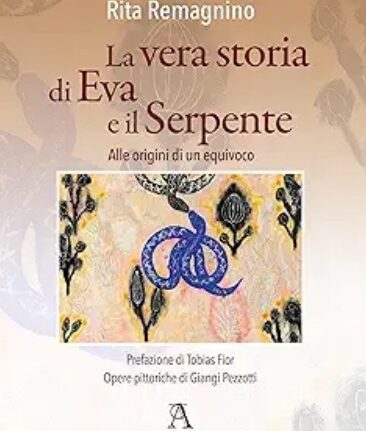Dante inaugura il Purgatorio con una denuncia non nuova: le virtù cardinali hanno abbandonato la terra a causa delle ingiustizie che gli uomini stanno compiendo dai tempi di Adamo. La Chiesa è corrotta, tutte le città italiane sono piene di tiranni e ogni bifolco che si metta a capo di una fazione politica diventa subito un «marcello». “Ché le città d’Italia tutte piene / son di tiranni, e un Marcel diventa / ogne villan che parteggiando viene” (Pg VI 124-126).
Versi che suonano tristemente attuali. Tuttavia, dice il poeta, all’inefficienza della giustizia terrena corrisponde la perfezione della giustizia divina, da cui dipendono numerose salvezze inattese. Ne è un esempio la presenza nell’Antipurgatorio dello scomunicato Manfredi (figlio illegittimo di Federico II), dipinto dalla feroce pubblicistica guelfa come un Anticristo ma beneficiario della Grazia in virtù del suo sincero pentimento in punto di morte (Pg III 103-145).
Altri scomunicati si sono rivolti in extremis a dio e hanno visto accolto il loro pentimento. L’uomo però non tenti d’interpretare questi eventi perché vani sarebbero tutti i suoi sforzi, pensi piuttosto a comportarsi bene nel quotidiano e come le anime del Purgatorio attenda con fiducia il verdetto di dio, che è il “segnore de la giustizia” (Pg XIX 77, XXII 4).
Così discorrendo il poeta precisa che la Giustizia si muove in parallelo con un elemento altrettanto incomprensibile, la Verità, solo vagamente intuibile da una creatura mortale. L’uomo dunque abbassi la cresta e scenda a più miti consigli; in concreto: 1) accetti così com’è la giustizia divina, tanto non la capirà mai; 2) accetti il proprio destino e lo assecondi operando nel migliore dei modi; 3) accetti il prossimo, trattandolo con cortesia e gentilezza.
Il consiglio vale tanto per gli umili quanto per i sovrani, i quali non s’illudano di possedere alcunché poiché al massimo possono ricoprire per un tempo limitato il ruolo di «aiutanti di dio», occupandosi in via estemporanea del bene comune. D’altronde se gli uomini sapessero veramente esercitare la Giustizia, o fossero depositari della Verità, sarebbero dèi essi stessi.
Simili argomentazioni appaiono perfettamente in linea con il motto zoroastriano “buoni pensieri, buone parole, buone opere“, una massima aurea che in misura variabile ha influenzato tutte le fedi successive con una serie di concetti prima di allora sconosciuti quali il premio e la condanna, ovvero il Giudizio, e quindi la presenza di un giudice supremo, cioè celeste.
I testi iranici attribuivano questa funzione al dio Rašn, incaricato di pesare il Bene e il Male compiuto dall’anima del trapassato sull’estremità superiore del ponte Cinvat che univa con il suo arco gigantesco la Terra al Cielo. Il collegamento era descritto come alto da far paura, lungo nove lance e sottile come una spada affilata, pur tuttavia ben visibile da lontano affinché la sua presenza incutesse il giusto timore.
Nel migliore dei casi si affiancava all’Anima in attesta di giudizio una figura angelica in sembianze di bella fanciulla, che rendeva possibile l’attraversamento del ponte. Ad attenderla dall’altra parte c’era un San Pietro in salsa persiana, che chiedeva: “Come hai fatto a venire da quel mondo pieno di pericoli, di paure, di disgrazie, in questo mondo senza pericoli e non toccato da influssi demoniaci?”. L’interpellato/a non faceva neppure in tempo ad aprire la bocca che già di fronte a lui appariva il dio venuto a soccorrerlo/a: “Non domandargli nulla! Poiché egli si è separato dal suo corpo prezioso ed è arrivato passando per la via dei terrori.”
Una sorte completamente diversa attendeva l’Anima di chi in vita non aveva ben parlato né ben agito. Un’orribile donna l’accompagnava sul Cinvat, durante l’attraversamento la passerella diventava sottile come una lama di rasoio e cedeva di colpo, l’Anima precipitava giù di sotto e le fiamme infernali facevano il resto.
Combinazione anche Dante inserisce nel suo poema sotto forma di visione sia la bella fanciulla che gli fa bere l’acqua del Lete (Lia/Matelda) sia l’orrenda “antica strega” (la femmina balba/sirena), rispettivamente emblemi della Verità e della Menzogna, della Realtà e dell’Apparenza. Gli incontri avvengono sul Sacro Monte del Purgatorio, cioè a cavallo di ciò che unisce l’umano al divino, che poi sarebbe l’equivalente della Montagna Cosmica zoroastriana.
Entrambe le rappresentazioni appaiono come «mete provvisorie», immagini figurative che evidenziano prospettive ascendenti e discendenti, non costituendo tuttavia alcun fine ultimo. Sulla cima della montagna iranica si trova il fatidico ponte che fa tremare le anime in transito, mentre sulla vetta purgatoriale c’è il Paradiso Terrestre dove Dante rischia di perdere la strada a causa dell’apparire di un fiume inatteso e del fogliame talmente fitto da non lasciar trapelare alcuna luce, né diurna né notturna (Pg XXVIII 28-33).
Sia il ponte iranico sia la sommità del monte purgatoriale si elevano verso il cielo richiamando, per analogia, la spinta tendenziale dell’Anima a fare ritorno alla casa del Padre. Quassù si svolge la processione mistica che simboleggia il cammino dell’umanità dopo il peccato originale (Dante), e sempre in vetta si consuma l’eterna battaglia cosmica tra le due forze avversarie, il Bene e il Male (Zoroastro/Zarathustra), dalla quale in seguito alla sconfitta degli Angeli caduti avrebbe dovuto uscire il mondo migliore che ancora stiamo aspettando.
Va detto che prima della narrazione iranica nessuno si era mai sognato di pensare che il Bene dovesse vincere sul Male a causa di un fantomatico «senso di giustizia», essendo il nero e il bianco due differenti aspetti dello stesso basilare principio unitario di polarità. Storicamente tale pensiero è emerso in un’epoca in cui l’umanità era già uscita dalla narrazione cosmogonica, e, non trovando appigli migliori, ha poi deciso di consegnarsi con mani e piedi legati alla Giustizia. A poco a poco è penetrato così nel tessuto religioso e civile il tarlo del concetto teologico «di parte» che innumerevoli danni ha arrecato, e continua ad arrecare, alla società umana.
Dividere, contrapporre, separare, sono azioni disgreganti che mettono zizzania nella società provocando conflitti che avvantaggiano solo chi vuole dominarla (divide et impera). Ma, purtroppo, l’uomo si fa fregare ogni volta dimenticando così che la Giustizia è essenzialmente armonia: non solo non deve provocare divisioni a livello sociale ma va intesa come fattore sinergico tra pensatori, guerrieri e artigiani (Platone).
A questa visione di chiara matrice indoeuropea Dante si associa senza esitazioni. Chi ha detto che «regola» è sinonimo di «coercizione»? Inserita nel giusto contesto essa può servire, anzi, a raggiungere la perfetta armonia della vita morale, realizzabile ogniqualvolta la prudenza guida la ragione, la temperanza tiene a bada gli appetiti del concupiscibile, la forza è frenata dal cuore.
Naturalmente il discorso riguarda le «regole condivise» che poggiano su una solida base sociale, mentre quelle calate dall’alto possono essere tranquillamente infrante qualora mettano a rischio la massima aurea “buoni pensieri, buone parole, buone opere“. Noè, ad esempio, si guadagnò l’appellativo di «giusto» proprio rifiutando di associarsi alle scelte sbagliate dei suoi contemporanei.
In buona sostanza «stare dalla parte giusta» significa stare dalla parte indicata da dio, non dagli uomini. Se ne faccia una ragione il giustiziere contemporaneo che nella sua follia uniformatrice invoca costantemente obblighi tassativi, leggi liberticide e punizioni esemplari, dimostrando così di non conoscere né la storia dei suoi antenati, né il buon senso, né il famoso motto di Pascal “la vera morale se ne infischia della morale!”
Là dove non c’è Verità non può esserci Giustizia, e l’assoluta mancanza di «evidenze» in ogni ambito del XXI secolo ne segna l’inesorabile destino. E’ impensabile che un mondo alla rovescia possa dettare legge; motivo per cui è totalmente campata in aria l’idea di una società aperta, acquariana, priva di genere, verdeggiante e implicitamente scientifica, dove persino coloro i quali dovrebbero giudicare gli altri si contraddicono in continuazione screditandosi a vicenda con argomentazioni per lo più di basso profilo.
La situazione era già compromessa nel Trecento. Lo stesso Dante è una vittima dell’ingiustizia, un perseguitato politico che soffre di ripetuti soprusi, un letterato costretto ad ammantare di mistero la propria scrittura per non vederla ridotta in cenere tra le fiamme di un rogo. Tuttavia la fuga mundi non gli si addice, e infatti non demorde, tiene duro confidando nel tempo ciclico che alla fine rimetterà le cose in ordine. Prima o poi la giustizia tornerà alla prima età dell’uomo e dal cielo scenderà una nuova progenie: “(…) Secol si rinova; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenie scende da ciel nova” (Pg XXII 70-72).
Solidali con lui anche noi siamo in trepida attesa, ma per il momento non c’è traccia dei «buoni monarchi» (Pg X 93), né dei saggi amministratori, né dei giudici integerrimi. Anzi: sparito dio, e di conseguenza la Giustizia, ultimamente s’è fatta strada un’antropologia inedita che ha attribuito all’essere umano una «natura astratta» totalmente dissociata dalla sua esistenza concreta.
Niente panico, suggerisce Dante, quando il carro starà per rovesciarsi penserà dio a prendere in mano le redini. Secondo la legge universale ciò che ha avuto un inizio avrà anche una fine e dunque nessuna civiltà, per quanto possa credersi potente, può dirsi immortale. Parole vere; con la differenza che noi Ultimi dovremo faticare parecchio a tracciare nuove mappe di senso attorno a cose esclusivamente materiali, per cui si prevede un passaggio drammatico.
Anche per questo vorremmo farla pagare ai disonesti opportunisti che ci hanno cacciati in questo guaio. Prova lo stesso sentimento Dante verso quanti hanno perso tempo in quisquiglie di ordine materiale, ovvero gli avari e i prodighi della Quinta Cornice, che d’istinto mette proni sul terreno con il volto all’ingiù. Poi, però, ritratta: non spetta a lui giudicare, solo la giustizia divina è in grado di «distribuire» premi e castighi, trovando sempre la giusta proporzione tra il peccato e la pena.
Prendendo come esempio il dogma della Trinità anche Virgilio ribadisce che le motivazioni del giudizio non sono alla portata dell’uomo, solo i matti possono pensare di poter comprendere con il ragionamento i misteri della fede. “Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone” (Pg III 34-35).
Come fa allora l’uomo a sapere se sta operando dalla parte del torto anziché della ragione? Esiste realmente la categoria degli «uomini giusti», o si tratta di un ideale irraggiungibile? Secondo Dante i Giusti sono più numerosi fra quelli che vivono senza eccessi, sapendo che il troppo stroppia ma il troppo poco mortifica. Astrologicamente parlando sono da considerarsi «spiriti giusti» quanti hanno operato sulla Terra sotto gli influssi del pianeta Giove (“l’aguglia di Cristo”), ovvero i beati che appaiono sotto forma di luci dorate nel Sesto Cielo del Paradiso.
Essi si stagliano sullo sfondo argenteo del pianeta (canto XVIII) formando la scritta “diligite iustitiam qui iudicatis terram” (amate la giustizia, o voi che giudicate la Terra). In una complessa figurazione simbolica disegnano la lettera ‘M’, prima di trasformarsi in un giglio araldico e completare la coreografia nell’insegna dell’Aquila imperiale, l’uccello sacro a Giove che Dante si augura possa assicurare al mondo la giustizia terrena nel rispetto del volere di dio.
Dispiace doverlo contraddire ma purtroppo la Storia insegna che sotto il segno dell’Aquila sono state fatte, e tuttora vengono commesse, le peggiori nefandezze. Basandosi tuttavia sulla corposa letteratura eurasiatica che lo ha preceduto è comprensibile che il poeta immagini l’Aquila come un nucleo di forze eccezionali, un concentrato di anime che ad un tratto iniziano a parlare come se fossero una sola persona per raccontare come sulla Terra abbiano operato con giustizia (canto XIX). Poi la voce diventa un coro che intona un canto criptico, ma non si tenti di capire, sappiamo quanto sia impenetrabile per l’intelletto umano l’ineffabile giustizia di dio (canto XX). Dopo la sfilata dei Giusti più importanti del passato dentro la pupilla del poeta, tutto finisce.
L’immagine non è affatto una creazione poetica bensì il risultato del profondo radicamento culturale dell’autore. Per i popoli indoeuropei l’Aquila era il simbolo del fuoco e della luce, l’unico volatile capace di fissare «negli occhi» il Sole senza perdere la vista. Spesso la si ritrova raffigurata con lo sguardo minaccioso e un fulmine tra gli artigli; da qui, probabilmente, il famoso detto “che dio ti fulmini!”
Un’esclamazione che calza a pennello su Dante, che nel suo iter Oltremondano si rivela un giustiziere nato, una specie di predicatore incline a parlare cento volte di più del «dio terribile» che del «dio buono», ovvero sempre pronto ad antepone la punizione ai malvagi alla ricompensa dei giusti (Pd XIX 13). In questo atteggiamento c’entra indubbiamente la mentalità medioevale tesa a vedere soprattutto nella Giustizia l’attributo di Dio che «fulmina» sui due piedi i peccatori che hanno fatto male ad altri. Ma soprattutto c’entrano le influenze provenienti dalla primeva cultura indoeuropea che impregnano quasi tutte le religioni diffuse in Eurasia, dove l’elemento-fuoco e il fuoco perpetuo (il Sole) sono difficilmente distinguibili ma ugualmente basilari.
Si pensi al dio tempestario Indra che impugnava il fuoco incandescente in forma di vajira, l’antichissima arma-scettro del mondo ario-indiano poi divenuta uno dei suoi simboli iconografici più diffusi nel continente. Disponevano di un analogo equipaggiamento il Narto Batraz, il nordico Thor, il greco Zeus, il baltico Perkúnas, posto in cielo dal fabbro Teljavel, il mitico forgiatore del disco solare. Numerosi furono comunque gli esseri divini che gestirono la giustizia nel mondo umano impugnando una folgore, un’«arma spirituale» ben più potente e persuasiva della spada.
Uscirono da questo mondo di fuochi e fiamme gli auguri etruschi e romani, i quali non a caso consideravano i cieli settentrionali costantemente bersagliati dai tuoni e dai fulmini quelli sotto cui vivevano i «santi», o «giusti». La stessa Asgard veniva immaginata sul monte-perno da cui il mondo degli uomini era visibile sia di giorno che di notte per via della luce costante. Nel Kalevala, il grande poema epico finlandese, la dimora del dio supremo viene chiamata Tähtelä, ossia il luogo di Tähti, la stella polare: il fuoco celeste che indicava agli uomini la dritta via.
Non è un caso che Dante chieda proprio alle stelle di «fulminare» con un castigo esemplare il sangue di Alberto il tedesco (Pg VI 120 e 100), reo di avere abbandonato il giardino-Italia per starsene in Germania. Una storia che sembra non avere fine. A parte ciò il poeta si ritrova spesso ad evocare l’intervento celeste, o divino, in forma di Giustizia Vendicativa, o repressiva, al fine di ristabilire la potenza sovrana che punisce i malvagi e premia i Giusti.
Si tratta dopotutto di una persona nata sotto il segno zodiacale dei Gemelli, che un tempo veniva rappresentato con due righe, due paletti, due bastoncini, ossia i primi strumenti utilizzati per produrre il fuoco. Questo perché ai primordi il fuoco era assimilato al cerchio che passando per i Gemelli si estendeva nell’universo dopo avere attraversato i poli celesti e i punti equinoziali. Al «suo» segno il poeta dedicherà comunque parole di ringraziamento nel canto XXII del Paradiso.
La visione incendiaria di Dante comprende la rivoluzionaria convinzione che sia stata una giusta vendetta anche la decisione di dio di punire gli uomini con la crocifissione di un Innocente. “La pena dunque che la croce porse / s’a la natura assunta si misura, / nulla già mai sì giustamente morse” (Pd VII 40-42). Il carattere «punitivo» dell’operazione sarebbe confermato dal fatto che Cristo subì la passione in conseguenza del verdetto di Pilato, un pessimo amministratore della giurisdizione affidatagli dall’imperatore (Mn II XI 4-6).
Ma come, non s’era detto che dio è buono? Lo è, infatti; proprio per questo usa il fuoco come agente purificatore. Eraclito da Efesto, colui che introdusse nella cultura europea la prima rivelazione dell’Essere, condensò le riflessioni sul tema nel concetto di «isorropia», cioè di equilibrio armonico rappresentato dal fuoco. L’ideale politico doveva coincidere con l’ordine universale (Frammenti, 30), era praticamente impossibile perseguire la Giustizia senza il fuoco, il quale non era un elemento fisico (come affermato da Aristotele) bensì un principio razionale che ordinava il mondo secondo la sua maggiore o minore intensità.
Come un perpetuo temporale il Fuoco sempre era (passato), sempre è (presente) e sempre sarà (futuro) attraversando la natura e la società. Mutando da fermo il Fuoco costituiva il simbolo perfetto della fonte energetica di trasformazione che tutto cambia rimanendo immobile, e quindi perpetua (Frammenti, 84a).
Nella visione del filosofo greco la parola chiave è «armonia», cioè complementarietà tra gli opposti (Frammenti, 8, 51 e 54). Egli critica infatti Omero, per il quale solo la pace è buona, critica il dualismo radicale fra i contrari di Pitagora, ma, soprattutto, critica Esiodo incapace di comprendere che il giorno e la notte sono “una cosa sola”.
Non esiste secondo Eraclito un negativo assoluto o un positivo assoluto poiché tutto ricade nel principio di complementarietà. Bisognerebbe ricordarlo ai moderni che hanno fatto del concetto di Bene e Male il proprio cavallo di battaglia, mettendo di conseguenza sull’altare il principio di Giustizia, come se da solo questo postulato potesse stare in piedi senza la Verità.
Grazie a simili sviste l’Età Ultima è scivolata nel Regno della Mediocrità, un posto lugubre dominato dal visionarismo gnostico-anabattista di orientamento tecnologico dei Padroni Globali, la cui visione poggia sulla fragile base della «suprema bontà» delle tecnoscienze.
Viene da chiedersi come possa una cosa tanto «buona» richiedere sacrifici così grandi, a cominciare dalla distruzione di tutto ciò che è stato e di tutto ciò che è. Persino l’annientamento della persona umana sarebbe «giusto», però non è chiaro quale «giudice supremo» in possesso della Verità lo abbia deciso, né come possa un gesto arbitrario del tutto umano mettere al vertice della piramide valoriale il Male anziché il Bene, o viceversa.
L’unica buona idea che può venire in mente alla persona ligia alla massima “buoni pensieri, buone parole, buone opere” è quella di provare a girare la medaglia. Visto il fallimento su tutta la linea del lato A, rivolgiamoci al lato B operando una poderosa trasvalutazione di tutti i valori in essere. In teoria il cosiddetto Male dovrebbe trasformarsi nel cosiddetto Bene, l’ingiusto diventerebbe giusto, il falso diventerebbe vero, il brutto diventerebbe bello, il nero diventerebbe bianco. Sarà sorprendente scoprire che le guerre umanitarie sono guerre in piena regola, le esclusioni sociali per giusta causa sono autentiche emarginazioni, i feroci dittatori sono i difensori del proprio popolo e della propria cultura, la realtà irreale proposta dagli autonominati professionisti dell’informazione è pura e semplice propaganda, i benefattori sono criminali, e così via. Cosa abbiamo da perdere, che già non sia andato perduto?