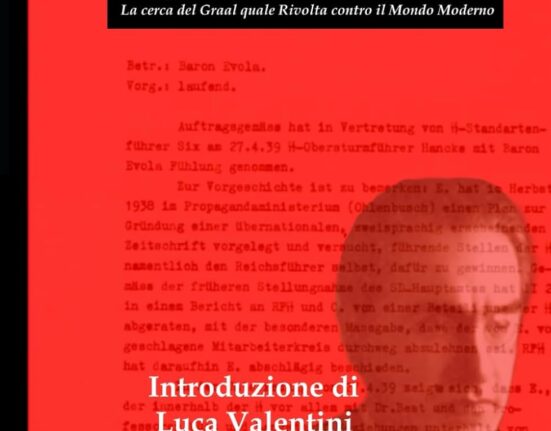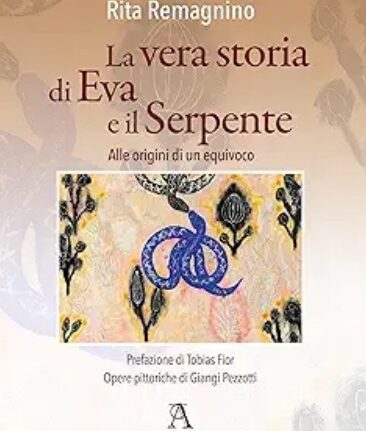Dopo la pubblicazione del libro “Alla ricerca delle origini” di Fabio Calabrese (Edizioni Ritter, anno 2020) nel quale il nostro caro amico aveva raccolto i tanti articoli che nel corso degli anni erano stati pubblicati su Ereticamente.net, è notizia recente l’uscita di un suo secondo lavoro, “Ma davvero veniamo dall’Africa?”, edito da “Aurora Boreale”.
Con la preziosa prefazione di Eugenio Barraco, vengono qui ripresi molti dei temi toccati nel precedente libro, ora però focalizzandosi soprattutto sulla critica alle teorie afrocentriche relative all’origine di Homo Sapiens. Inutile sottolineare che la nuova fatica di Calabrese è, come la precedente, assolutamente da consigliare per tutti coloro che desiderino approfondire il tema delle nostre origini secondo una chiave di lettura distante dal “politicamente corretto”, purtroppo ormai imperante. Con grande piacere, quindi, raccolgo nuovamente il suo gentile invito per un commento del libro, che non riuscirò di certo a riassumere in tutti gli argomenti trattati – visto che vengono toccati i più disparati temi attinenti alla weltanschauung dell’Autore, dalla politica, alla storia, alla fisica – ma del quale cercherò almeno di sottolineare i passaggi più direttamente collegati al focus principale, permettendomi anche di aggiungere qualche integrazione a margine.
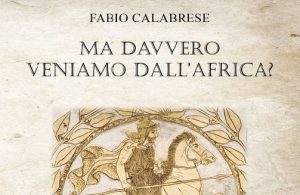
Il filo conduttore di Calabrese è certamente quello di una rigorosa critica alla scienza di regime. E ciò, non sicuramente nelle mere ed inoppugnabili evidenze dei dati, ma soprattutto nell’interpretazione che, di questi, viene presentata al pubblico non specialista: interpretazione che purtroppo, come detto, molto spesso paga un pesantissimo tributo al “politicamente corretto” di questi tempi. Una scienza – giustamente rileva Eugenio Barraco nell’introduzione – che quando affronta il tema delle origini umane, è prigioniera del pregiudizio evoluzionistico e completamente chiusa ad ogni possibile riflessione attorno alle concezioni tradizionali di ogni popolo del pianeta: e sono concezioni che, cosmologicamente, ricordano invece una provenienza dell’umano non certo dalla bassa animalità ma da ambiti ben più elevati – essenzialmente sovra-individuali e sovra-biologici – della manifestazione universale. E che, anticipiamo già ora, geograficamente mai ricordano l’Africa come sede primigenia dell’umanità (nota 1). Strano a dirsi, ma la ricerca odierna è piena di “dogmi” ed uno dei più importanti è quello dell’inesistenza delle “razze umane”, che può rappresentare un buon punto di avvio delle nostre considerazioni.
In effetti, potremmo anche concordare con una certa critica portata all’antropologia fisica che, nel corso della sua lunga storia, ha proposto un ventaglio piuttosto variegato di classificazioni razziali; ma da questo a concludere che, di conseguenza, qualsiasi concetto relativo alle identità di gruppo sia destituito di ogni fondamento, il salto logico ci sembra francamente inaccettabile. L’Autore ricorda infatti le conclusioni di Richard Lewontin, che sostenevano questa posizione, secondo le quali la parte nettamente predominante della variabilità molecolare umana andrebbe ricercata a livello individuale e non a quello di gruppo. Ricordiamo però che si tratta di tesi sottoposte a stringente critica già da Anthony William Fairbank Edwards che ne contestò la visuale troppo limitata alla variazione dei singoli fattori ed avulsa da ogni analisi di quelle che, invece, sono le più ampie strutture di correlazione dei dati (nota 2) utilizzando le quali emergerebbe invece in modo molto chiaro l’appartenenza di ogni individuo ad una data popolazione radicata ad una precisa area geografica del pianeta. Nella stessa direzione andrebbero anche le analisi di Marcus Feldman su 377 siti del genoma umano, dalle quali verrebbe confermata la suddivisione dell’umanità in cinque grandi sotto-insiemi, localizzati in Africa, Eurasia occidentale (Europa, Medio oriente ed India), Asia orientale, Oceania ed Americhe (nota 3).
D’altronde, si potrebbe anche aggiungere che la stessa, banalissima, osservazione esterna è in grado di fornirci un’indicazione evidente del gruppo di appartenenza delle varie persone, e quindi appare piuttosto sconcertante il contrasto tra l’ordinario…“buonsenso” – che ci dice chiaramente se, ad esempio, un individuo è un Nativo americano, un Orientale, un Europeo o un Subsahariano – e l’assunto, tanto astratto quanto politicamente corretto, che “le razze non esistono”: suggerendo quindi che l’aspetto esteriore rappresenti un dato del tutto trascurabile nell’analisi della variabilità umana. Un dato che invece, paradossalmente, viene evidenziato con molta enfasi quando ritenuto utile ad attaccare le visuali euro-identitarie: tipici casi, ad esempio, le interessate e deformanti ricostruzioni melanodermiche dell’uomo di Cheddar (le cui frequenze genetiche indicherebbero come la pigmentazione, immaginata relativamente scura, ne sarebbe solo uno dei possibili esiti fenotipici, in un ventaglio ben più ampio) o quella, forse ancora più assurda e risibile, degli Etruschi “negroidi”, chiaramente destituita di ogni fondamento da tutte le testimonianze scritte ed iconografiche del tempo. Se questo è lo stato attuale della divulgazione scientifica, possiamo dire di essere ancora inchiodati alla rappresentazione di quello che a suo tempo era stato erroneamente definito il “negroide” di Grimaldi, reperto di età gravettana del litorale ligure, che analisi successive hanno invece riportato pienamente nell’alveo morfologico cromagnoide, quindi “caucasoide” a tutti gli effetti (nota 4). In definitiva, una buona analogia sul metodo da impostare in merito al tema dell’esistenza, o meno, delle “razze umane” potrebbe essere quello di chiedersi, ad esempio, quante colline vi siano in Istria (mi si conceda un affettuoso rimando alla terra dei miei genitori): è chiaro che la risposta dipenderà dall’altezza-limite che attribuiamo alla collina-tipo. Analogamente, il numero delle “razze umane” dipenderà dal grado di raggruppamento che sceglieremo in partenza, e tre, quattro, cinque, sei o più saranno tutte risposte ragionevoli alla nostra domanda a seconda del presupposto iniziale. Ovvero, il fatto che si possano stabilire a priori dei criteri arbitrari per definire il “valore-soglia” a partire dal quale, nell’ambito di un certo insieme, vogliamo che un dato elemento diventi significativo, non significa che all’interno di questo insieme non esista già, di per sé, una discontinuità in qualche modo misurabile, degli elementi statisticamente definibili come “discreti” ed individuati da picchi e gradienti quantitativi: situazione completamente diversa da quella di un “continuum”, dove le grandezze si modificano con andamento perfettamente lineare da un estremo all’altro del quadro, come in un piano dalla pendenza costante. In caso contrario sarebbe come pensare che, siccome in Istria possiamo arbitrariamente definire “collina” un rilievo alto, ad esempio, più di 200 metri, oppure 300, oppure 400 ecc… (decisione dalla quale, chiaramente, alla fine dipenderà il numero di colline che conteremo), allora sia corretto concludere che tale arbitrarietà implichi la totale convenzionalità del concetto stesso di “collina”, arrivando quindi a dire che in Istria le colline… non esistono! Una deduzione evidentemente illogica e, a prescindere da qualsiasi “valore-soglia” possa essere stato preimpostato per rispondere alla nostra domanda iniziale, contraria alle più elementari evidenze dell’osservazione diretta e alla realtà fattuale.
Ebbene, più o meno lo stesso processo logico viene proposto dal “pensiero unico” in merito al tema dell’esistenza, o meno, delle razze umane.
Comunque, come ci ricorda Calabrese citando lo storico australiano Greg Jefferys, è proprio il tentativo di rimozione del concetto di razza che ha prodotto, soprattutto a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, un’importante ricaduta nel campo della ricerca delle origini umane, con l’enucleazione sempre più insistente e pervasiva del mito “Out of Africa” (nel prosieguo, per brevità, OOA), ovvero quella teoria che, secondo la parte maggioritaria dell’attuale ricerca accademica, vedrebbe la culla iniziale della specie Homo Sapiens in Africa, dalla quale sarebbe poi uscito – appunto “out of Africa” – per andare a popolare tutti gli altri continenti del pianeta e così differenziandosi nelle sue varietà locali (quelle che, secondo il “politicamente corretto”, non esisterebbero…).
Cercheremo di ripercorrere, in ordine logico, le considerazioni critiche che l’Autore espone in merito ai vari punti presentati dall’OOA a sostegno della propria costruzione teorica, come detto integrandola con qualche ulteriore e, speriamo, utile annotazione.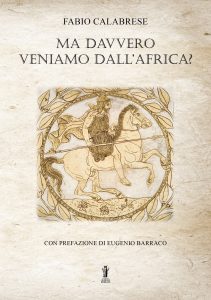
La prima può essere quella relativa alle specie ominidi ritenute precedenti ed originanti Homo Sapiens e la cui presenza, rilevata soprattutto in Africa, secondo i sostenitori dell’OOA costituirebbe un forte indizio per radicare nel continente nero anche le nostre origini prime (nota 5). Potremmo intanto sottolineare come già l’assunto di partenza sia influenzato – lo ricordavamo sopra – da un chiaro pregiudizio evoluzionistico che, oltre ad ignorare completamente qualsiasi forma di sapienzialità tradizionale (ma questo, purtroppo, lo diamo per scontato), trascura comunque tutta una serie di elementi che sosterrebbero invece la grandissima antichità della forma Sapiens, quindi difficilmente inquadrabile come linea umana derivata da specie ominidi considerate più antiche (ad esempio Homo Habilis, Erectus, Neanderthalensis…). Ora non possiamo dilungarci troppo, ma basti dire che, da un lato, vi è tutta una serie di reperti che presentano una morfologia stranamente “moderna” pur attinenti a contesti stratigrafici di elevatissima antichità, quali ad esempio quelli rinvenuti nell’isola di Giava a Trinil, in Argentina a Miramar, a Buenos Aires e sul Monte Hermoso, in California a Calaveras e Table Mountain, in Inghilterra a Foxhall e Ipswich, in Francia a La Denise e Abbeville, in Svizzera a Delemont, in Spagna a Atapuerca, in Italia a Castenedolo e Savona, nella stessa Africa, in Kenia nei pressi del lago Turkana (cranio “KNM-ER 1470”) ed in Tanzania, con le famose impronte di Laetoli (nota 6) e dei quali la paleoantropologia ufficiale parla piuttosto malvolentieri proprio perché inspiegabili nel suo orizzonte evoluzionista; e dall’altro vi è l’osservazione della netta specializzazione morfologica osservabile nelle linee Habilis, Erectus e Neanderthal, e tanto più nelle scimmie antropomorfe (nota 7), quasi a testimonianza di percorsi laterali e senescenti rispetto ad una posizione più “centrale”, cioè proprio quella Sapiens, dai caratteri invece biologicamente molto più generici ed a-specializzati (ad esempio il cranio sferoidale, la sua posizione in rapporto alla colonna vertebrale, il cervello particolarmente voluminoso, la piccola dimensione dei denti, la conformazione della mano e delle falangi del piede…) e quindi più prototipici, embrionali ed “originari” (nota 8). È una riflessione, questa, che in realtà ha radici lontane – ma non per ciò meno degne di nota – e che prende le mosse dal Protagora, dialogo platonico nel quale si narra il mito della creazione dell’uomo da parte dei due fratelli Titani, Prometeo e Epimeteo: quest’ultimo crea le diverse specie animali dotandole di vari organi di difesa, ma inavvertitamente lascia l’uomo nudo e inerme. Temi simili vennero successivamente toccati da Pico della Mirandola, Herder e Schopenhauer fino ad arrivare alla più recente “antropologia filosofica” di Max Scheler e di Arnold Gehlen: l’uomo vi appare come un essere morfologicamente svincolato dall’ambiente circostante (con pochi appigli da offrire alla selezione naturale, tanto importante per la teoria evoluzionista), quindi “carente”, “manchevole” ed “a-specializzato”, di contro all’animale che invece vi è intrinsecamente condizionato (nota 9). Vedute che non rimasero confinate alla sola riflessione filosofica, ma trovarono in Louis Bolk il tentativo di una sistematizzazione scientifica (nota 10) – arrivando ad influenzare anche lo stesso Konrad Lorenz (nota 11) – con la definizione di quello che pare essere un processo peculiare della nostra specie, la “neotenìa”, ovvero la conservazione anche in età adulta di certe caratteristiche fetali (nota 12).
Comunque – a parte questa digressione di carattere più antropologico-generale – anche a voler ignorare gli elementi indicanti un’elevatissima antichità di Homo Sapiens per cercarne, evoluzionisticamente, la radice in stirpi ominidi ad esso precedenti, Calabrese giustamente sottolinea la grossa differenza concettuale che vi è tra due diverse declinazioni della teoria OOA, e cioè quella che colloca nel continente nero direttamente l’origine Sapiens (OOA II) e quella che invece lo fa solo per la specie che, in ipotesi, lo avrebbe successivamente originato, cioè Homo Erectus (OOA I): una forma che quindi sarebbe uscita dalla culla africana centinaia di migliaia di anni prima ed avrebbe popolato tutti gli altri continenti del pianeta (escluse le Americhe), solo nei quali si sarebbe poi verificato l’evento di speciazione verso il Sapiens, con modalità separate e in larga parte indipendenti tra loro. È il tema, già toccato nella recensione del precedente “Alla ricerca delle origini” (nota 13), del dibattito tra la visuale “polifiletica – multiregionale” (quest’ultima) e quella “monofiletica – a candelabro” (la OOA II, dove il “candelabro” starebbe a rappresentare la totale sostituzione dei Sapiens africani nei confronti di tutte le coeve linee umane sorte nelle altre aree geografiche, e quindi venute ad estinguersi). E’ un punto sul quale non è quindi opportuno dilungarci nuovamente, se non per esprimere il personale parere che anche se la OOA I può apparentemente presentare il vantaggio di togliere all’Africa il podio di culla Sapiens primigenia ed unitaria, dall’altro però ci costringe ad assumere una posizione che si potrebbe definire “iper-evoluzionista”: ciò, in quanto postula una speciazione verificatosi non solo una, ma addirittura più volte ed in luoghi diversi, ovvero in concomitanza con la “razziogenesi” umana, che avrebbe cioè visto la nascita separata di un Sapiens caucasoide, di un Sapiens mongoloide, di un Sapiens negroide, di un Sapiens australoide, ecc… in sostanziale accordo con quanto ipotizzato a suo tempo, pur con formulazioni ed accenti lievemente diversi, da ricercatori quali Franz Weidenreich, Carleton Coon, Alan Thorne e Milford Wolpoff.
Ma molto opportunamente Calabrese segnala anche quegli elementi che sembrerebbero porre in seria difficoltà pure alla teoria OOA I, che presuppone una posizione privilegiata del continente africano in relazione alla buona presenza di reperti pitecoidi ed ominidi considerati “pre-Sapiens”: un presupposto che però, soprattutto in tempi recenti, è stato quanto meno posto in seria discussione con una serie di ritrovamenti, guarda caso europei, come ad esempio il dente-fossile di 9 milioni di anni fa rinvenuto in Germania, nei pressi della città di Eppelsheim (nota 14), i reperti greco-bulgari attribuiti al Graecopithecus Freybergi, ribattezzato “El Greco” e stimati a circa 7,2 milioni di anni fa (nota 15), o le impronte di piedi rinvenute a Creta, Trachilos, e datate a 5,7 milioni di anni fa (nota 16).
Per quanto invece riguarda la OOA II, focalizzata sui reperti prettamente Sapiens e sulla loro presupposta maggior antichità nei contesti africani rispetto al resto del pianeta, Calabrese mette giustamente in luce qualche altro elemento emerso di recente e che rende sempre meno lineare e sempre più problematica l’ipotesi di una culla originaria della nostra specie nel continente nero, almeno secondo le cronologie che si erano consolidate negli ultimi tempi. A tale proposito, potremmo ad esempio ricordare che, come segnala Cavalli Sforza, fino a una quindicina di anni fa sembrava abbastanza condivisa un’ipotesi di uscita di Homo Sapiens dall’Africa in un momento piuttosto recente, grossomodo tra i 50.000 e i 60.000 anni fa (nota 17); era una stima basata su vari elementi, tra i quali la ridatazione del reperto australiano di Lago Mungo (nota 18) e le estrapolazioni genetiche di Francois Balloux (nota 19). Un quadro cronologico che, a dire il vero, già non riusciva a spiegare adeguatamente i reperti Sapiens di Skuhl e Qafzeh in Palestina, risalenti a circa 100.000 anni fa e noti da tempo, ma ciò non aveva comunque impedito di raccogliere, attorno a questa ipotesi, un certo consenso in ambito accademico. Tuttavia, le fragili basi teoriche di questo modello, hanno successivamente spinto i ricercatori ad articolarlo ulteriormente, ipotizzando una migrazione non più singola ma avvenuta in “doppia fase”, con un’ondata più antica che, tra 100.000 e 50.000 anni fa, si sarebbe mossa soprattutto lungo la via costiera verso l’Asia meridionale e l’Australia, ed una seconda più recente e centro-euroasiatica, passata attraverso il Levante, dispiegatasi entro i 50.000 anni da oggi (nota 20); senza però rendersi conto che nemmeno questa nuova formulazione riusciva a spiegare adeguatamente i reperti di Skuhl e Qafzeh e, come poi venne messo in luce almeno per il suo ramo centro-euroasiatico, non collimava nemmeno con le stime genetiche sull’incrocio tra i Sapiens e i neandertaliani, che suggerivano tempistiche molto più profonde (nota 21).
L’impressione generale, quindi, è che i reperti fossili “scomodi” o vengano ignorati, o comunque assestino dei colpi piuttosto pesanti alla narrativa OOA di volta in volta consolidatasi nella sua ultima, provvisoria, versione. Uno di questi, come giustamente segnala Calabre, è l’eccezionale ritrovamento greco di Apidima 1, databile addirittura a circa 210.000 anni fa (nota 22), il quale presenta numerose caratteristiche Sapiens mai prima accettate, per il nostro continente, dalla ricerca accademica e che, tra l’altro, indica come la consueta narrativa di un’Europa compattamente “terra Neanderthal”, che avrebbe pertanto bloccato l’arrivo Sapiens verso nord-ovest per molte decine di millenni (così, inizialmente, costringendone il flusso verso traiettorie più austroasiatiche) sia in verità molto fragile: Apidima 1 è infatti il testimone di una popolazione che avrebbe chiaramente preceduto quella neandertaliana, della quale invece apparirebbero evidenti le caratteristiche nel successivo reperto di Apidima 2, databile a circa 170.000 anni fa.
I teorici dell’OOA non possono quindi fare altro che riconsiderare ogni volta il momento di uscita dell’ipotetico flusso Sapiens dall’Africa, spostando all’indietro date che però, fino a quel momento, consideravano ragionevolmente sicure: un approccio che dimostra come le prove non conciliabili con il precedente quadro cronologico non vengano mai accolte come utile spunto per cambiare totalmente paradigma e ripensare ad altre ipotesi, ma siano affannosamente “reclutate” solo ed unicamente nel quadro di una nuova narrativa OOA riscritta. In questo modo, però, costringendosi a contorsioni e rimaneggiamenti sempre più macchinosi ed articolati. Perché, se non è l’europeo Apidima 1, a scompaginare le carte in tavola sono di volta in volta i reperti arabi di Jebel Faya di 120.000 anni fa (nota 23), o quelli cinesi di Daoxian e Liujiang che potrebbero anch’essi toccare, e forse superare i 120.000 anni (nota 24), o quelli australiani di Kununurru che potrebbero arrivare anche a 174.000 anni fa (nota 25) e quindi, comunque, difficilmente compatibili anche con la stima della migrazione austroasiatica più antica.
Inoltre, anche quando le caratteristiche Sapiens dei reperti non sono chiare, o appaiono stranamente frammiste a morfologie diverse (non diremo “arcaiche” perché, come accennato sopra, la nostra linea interpretativa presuppone un Sapiens di per sé antichissimo e non derivato da specie ominidi precedenti) la loro stessa presenza in contesti molto datati, pongono comunque più di un interrogativo all’ipotesi OOA II classica: parliamo ad esempio dei ritrovamenti spagnoli di Atapuerca, con il cosiddetto “Homo Antecessor” di almeno 780.000 anni fa che nel volto e nel cranio denota già tratti sorprendentemente moderni, evidenziando quindi il fatto che la forma encefalica così caratteristica dei Neanderthal, da sempre considerata arcaica, sarebbe invece un tratto derivato, sviluppatosi cioè in un’epoca successiva (nota 26). Ma vi sono pure i reperti cinesi di Dali – di 260.000 anni fa (nota 27) – o quelli ancora cinesi di Harbin, che potrebbero superare anche i 300.000 anni (nota 28), entrambi non facilmente conciliabili con la OOA II, e tale è uno dei motivi per i quali, ad esempio, la grandissima maggioranza degli antropologi cinesi rifiuta l’idea di una discendenza degli attuali orientali dagli ipotetici Sapiens africani (nota 29). Il problema, infatti, è che queste strane compresenze di caratteri Sapiens e non Sapiens nei reperti extra africani, nella migliore delle ipotesi potrebbero avallare quelle teorie non afrocentriche che avevamo definito “iper-evoluzioniste”, di impostazione “polifiletico – multiregionale” alla Thorne/Wolpoff, ma in quella più radicale potrebbero invece suggerire un quadro dalle dinamiche marcatamente meticciatorie, con la presenza di varie linee Homo tra loro coeve (quindi, notiamo bene, anche la Sapiens) che si sarebbero incrociate a più riprese, portando quindi ai fenotipi “misti” di cui sopra. In questa seconda direzione, ad esempio, si potrebbe interpretare la recente scoperta nei reperti neandertaliani (nota 30) di frammenti del cromosoma Y, trasmesso solo in linea maschile, provenienti dallo stock Sapiens e definitivamente incamerati nel genoma dei nostri cugini già tra 200.000 e 300.000 anni fa: ma se consideriamo che il Neanderthal, a parte certe caratteristiche riconoscibili nel reperto marocchino di Jebel Irhoud, non è mai stato rinvenuto in Africa (e forse potremmo addirittura azzardare che sia giunto proprio dall’Europa), ne consegue che, molto più probabilmente, l’incrocio con Homo Sapiens possa essersi verificato nella porzione settentrionale dell’Eurasia, con la conseguenza che quest’ultimo, al tempo, doveva evidentemente già trovarsi dalle nostre parti. E, magari, anche un po’ prima di 300.000 anni fa se ammettiamo un ragionevole lasso di tempo perché il cromosoma Y Sapiens venisse a fissarsi definitivamente nel DNA neandertaliano…
In ogni caso, è evidente come sia la prospettiva “iper-evoluzionista”, sia quella “meticciatoria”, si distacchino in modo vistoso dalla classica narrativa OOA II. Narrativa che, appunto, poco può giovarsi del summenzionato reperto marocchino di Jebel Irhoud di circa 300.000 anni fa (nota 31), sia perché come detto questo evidenzia, nella forma cranica, rilevanti caratteristiche neandertaliane (nota 32) – quindi derivate e non così schiettamente Sapiens da porlo in netto anticipo rispetto a tutto il resto del pianeta – sia perché rinvenuto in un’area molto lontana da quella che finora l’OOA II ha sempre proposto come culla originaria della nostra specie, ovvero invariabilmente a sud del Sahara, dal Corno d’Africa fino alle aree più meridionali del continente nero. Quindi, oltre l’aspetto cronologico, anche quello geografico sembra mettere l’OOA II sotto la luce di una certa aleatorietà: sempre che non si voglia passare completamente al di sopra del fatto che una località a qualche centinaio di chilometri da Gibilterra non sia esattamente assimilabile al deserto del Kalahari in Sudafrica, praticamente gli antipodi continentali.
Se dunque le evidenze primatologiche, paleoantropologiche e paleogenetiche delle specie estinte a noi più vicine non sembrano fornire conferme univoche alla narrativa OOA II, un altro ambito che la ricerca accademica segnala come fortemente indicativo di un’origine umana nel continente nero è quello delle frequenze molecolari rilevate nelle attuali popolazioni africane. Constatando, in queste, una fortissima eterogeneità genetica, si è cioè ipotizzato che il fenomeno dovrebbe significare una maggior antichità del primo nucleo Sapiens comparso nell’area, da dove si sarebbe poi staccato un gruppo più ridotto per dirigersi verso gli altri continenti; nel frattempo i Sapiens rimasti in loco, secondo questa teoria, avrebbero avuto il tempo di continuare a differenziarsi ulteriormente al loro interno, arrivando oggi ad evidenziare tale eterogeneità nelle attuali popolazioni subsahariane. Un dato che, in quest’ottica, sarebbe quindi maturato in modo endogeno ed unicamente in funzione del fattore tempo. Ciò anche in conseguenza di un assunto logico impostato a priori nella costruzione di molti alberi filogenetici, assunto che in verità, come ammesso dallo stesso Cavalli Sforza, è del tutto ipotetico ed assai discutibile (nota 33), ovvero quello di un tasso di mutazione molecolare dalla velocità costante e dalla distribuzione omogenea nel genoma di tutte le popolazioni del pianeta: in tale ottica, i “rami” più lunghi, corrispondenti appunto alle genti subsahariane e dimensionati in proporzione alla maggior quantità di mutazioni rilevate in queste, starebbero quindi ad indicarne, analogamente, una maggiore antichità e, quindi, una loro ancestralità (o, meglio, una loro derivazione diretta dalla popolazione ancestrale protoafricana) rispetto a tutti gli altri Sapiens mondiali.
Su questo versante, uno studio pionieristico fu quello di Alan Wilson dell’Università di Berkeley, che ebbe come oggetto il DNA mitocondriale, cioè non il DNA del nucleo cellulare vero e proprio ma quello dei mitocondri (organelli ereditati solo per via femminile e presenti nel citoplasma con funzioni essenzialmente di produzione di energia); un lavoro che portò, negli anni ’80 del secolo scorso, alla costruzione del primo albero filogenetico globale basato sulla distribuzione delle mutazioni intervenute in questo DNA tra varie popolazioni umane. Venne infine individuato in Africa un’unica capostipite femminile di tutte le linee riscontrate che fu ben presto ribattezzata – anche con un certo effetto mediatico – “Eva mitocondriale” e si può dire che moltissima della successiva narrativa OOA prese spunto proprio da questa ricerca.
Bisogna però rilevare che le conclusioni di Alan Wilson, assieme a quelle dei collaboratori Rebecca Cann e Mark Stonecking, si prestarono fin da subito ad una raffica di critiche piuttosto serie e portate da diverse angolature, in parte anche sovrapposte, che senza dilungarci troppo passiamo in rapidissima rassegna: dal tipo di campione scelto, che per le popolazioni subsahariane fu rappresentato quasi del tutto da individui afroamericani, quindi probabilmente traendo soprattutto dal loro meticciamento il summenzionato fattore dell’eterogeneità genetica (nota 34); al fatto che questa potrebbe essere anche il risultato di una distorsione statistica indotta dalla storia demografica del continente nero, almeno in tempi relativamente recenti più popolato di altri, quindi ricettacolo di un maggior numero di diversificazioni molecolari che, al contrario di altre aree del pianeta, avrebbero impiegato molto più tempo per estinguersi (nota 35); alla difficoltà di ancorare gli “orologi biochimici”, collegati all’ipotetico “ritmo” delle mutazioni, a dei chiari snodi evolutivi, con il risultato che le relative estrapolazioni finali potrebbero esserne risultate distorte addirittura di centinaia di migliaia di anni (nota 36); all’assunto teorico di partenza, ovvero il discutibile “principio di parsimonia” che minimizza l’ipotesi delle mutazioni intervenute dall’inizio della storia evolutiva e individua preferenzialmente il percorso più semplice per la ricostruzione della storia filogenetica (nota 37); alla conseguenza che l’albero finale non fu l’unico prodotto grafico proposto dall’elaborazione dei dati, ma venne scelto tra un’infinità di altri possibili, molti dei quali non presentavano affatto una radice primaria collocata in Africa ma in Asia (nota 38), soprattutto quando il criterio di partenza passava dal tasso costante di mutazione genetica all’area con le frequenze molecolari più vicine alla media di tutte le popolazioni mondiali (nota 39).
Senza dimenticare che anche l’analisi di alcune frequenze mitocondriali extra-africane, come ad esempio quella del reperto paleolitico di Lago Mungo in Australia (nota 40), o quelle di alcune attuali popolazioni melanesiane (nota 41) – ma anche l’analoga scoperta, in un asiatico, di una linea particolarmente antica di un gene coinvolto nel metabolismo dello zucchero (nota 42) – hanno evidenziato un andamento talmente deviante e senza riscontri in altre aree del pianeta, da porre seriamente la questione di come queste possano rientrare nel quadro OOA, ovvero, in altri termini, di come gli aplotipi (cioè i gruppi che condividono le stesse mutazioni) ai quali appartengono possano essere considerati dei “sottoinsiemi” e delle derivazioni mutate degli aplotipi africani, che in teoria dovrebbero essere quelli “fondanti” ed originari.
Perché, in buona sostanza, il problema delle ricostruzioni storiche basate sulle evidenze genetiche, parte dalla mappatura dei tanti aplotipi ai quali appartengono le popolazioni odierne e soprattutto dal tentativo di identificarne la filogenesi, cioè i reciproci rapporti di derivazione – la questione del “chi deriva da chi?” – domanda alla quale non è però assolutamente semplice dare una risposta certa. Il fatto di stabilire se, ad esempio, l’aplotipo X è ancestrale all’aplotipo Y (e quindi che Y rappresenta una derivazione, mutata, di X) è chiaramente di fondamentale importanza per provare a delineare, alla fine, una storia generale delle varie popolazioni: e tanta parte della narrazione OOA si appoggia proprio su di una filogenesi di questi che è stata costruita in un certo modo. Ma che, appunto, molto spesso rappresenta una mera costruzione ipotetica, condizionata da alcuni assunti “a priori” che pongono più o meno arbitrariamente alcuni tipi come ancestrali e, di conseguenza, inquadrano gli altri come successivi e derivati (nota 43). Il tema comunque non riguarda solo il DNA mitocondriale, di esclusiva trasmissione femminile, ma anche quello di eredità maschile, cioè legato al cromosoma Y (Y-DNA), che rappresenta un altro importante settore di ricerca paleogenetica: anche se questo, come sopra ricordato da Cavalli Sforza, è proprio il versante di studio che ha portato alla stima di uscita Sapiens dall’Africa appena tra i 50.000 e i 60.000 anni fa (nota 44) poi però duramente scontratasi con tutte le evidenze che abbiamo visto. Non può quindi sorprendere che la conseguente presa d’atto di una ricostruzione ancora molto aleatoria della filogenesi degli aplotipi Y-DNA, abbia spinto alcuni genetisti a tentare delle vie alternative di indagine: è ad esempio il caso, opportunamente ricordato da Calabrese, dei russi Klyosov e Rozhanski, che nel 2012 hanno pubblicato una ricerca (nota 45) nella quale, attraverso una profonda revisione delle precedenti ipotesi di reciproca derivazione degli aplotipi Y-DNA mondiali, sono giunti a negare decisamente – in totale contrasto con la teoria OOA II – la possibilità che gli attuali aplogruppi “tipicamente africani” potessero essere filogeneticamente ancestrali a quelli extra-africani, propendendo invece per una comune discendenza da un gruppo ancora precedente ad entrambe le popolazioni e, oltretutto, ben difficilmente collocabile nel continente nero. Il quadro disegnato da Klyosov e Rozhanski, cioè, conferma la netta separazione genetica tra gli africani da un lato e tutte le altre popolazioni mondiali dall’altro – dato sottolineato anche da Cavalli Sforza (nota 46) – ma non ne fa motivo di ancestralità dei primi sui secondi. Una spiegazione alternativa di tale netta biforcazione potrebbe invece basarsi su almeno un paio di elementi generali: un diverso ancoramento geografico dell’albero filogenetico mondiale ed un diverso substrato che questi avrebbero incontrato nella loro prima colonizzazione planetaria.
Faremo qualche ulteriore riflessione su questi due punti, e su tutto il resto del libro di Fabio Calabrese, nella seconda parte di questo scritto.
Continua…
NOTE
- Nota 1: Maurizio Blondet – L’Uccellosauro ed altri animali (la catastrofe del darwinismo) – Effedieffe – 2002 – pag. 116
- Nota 2: Giovanni Monastra – Rileggere l’antropologia della preistoria europea – in: “Il mistero dell’Occidente. Scritti su archeologia, preistoria e Indoeuropei 1934-1970”, Julius Evola, a cura di Alberto Lombardo, postfazione di Giovanni Monastra, Quaderni di testi evoliani n. 53, Fondazione Julius Evola, 2020 – pag. 164
- Nota 3: Nicholas Wade – All’alba dell’Uomo. Viaggio nelle origini della nostra specie – Cairo Editore – 2006 – pag. 236
- Nota 4: AA.VV. (a cura di Fiorenzo Facchini) – Paleoantropologia e Preistoria. Origini, Paleolitico, Mesolitico – Jaca Book – 1993 – pag. 306; Renato Del Ponte – Miti e simboli della Liguria “esoterica” in Evola – in: Arthos, n. 16 – 2008 – pag. 24
- Nota 5: Bryan Sykes – Le sette figlie di Eva. Le comuni origini genetiche dell’umanità – Mondadori – 2003 – pag. 121
- Nota 6: Maurizio Blondet – L’Uccellosauro ed altri animali (la catastrofe del darwinismo) – Effedieffe – 2002 – pag. 100; Michael Cremo – Le origini segrete della razza umana – OM Edizioni – 2008- pagg. 25 e segg.; Michael Cremo / Richard Thompson – Archeologia proibita: la storia segreta della razza umana – Gruppo Editoriale Futura – 1997 – 181 e segg.; Giovanni Monastra – Le origini della vita – Il Cerchio – 2000 – pag. 63; Harun Yahya – L’inganno dell’evoluzione – Edizioni Al Hikma – 1999 – pag. 99
- Nota 7: Bjorn Kurten – Non dalle scimmie – Einaudi – 1972 – pag. 3; Franz Weidenreich – Scimmie, giganti e uomini – Casa Editrice Renzo Cortina – 1956 – pag. 27
- Nota 8: Antonio Bonifacio – La caverna cosmica. La potenza dello shamanismo nell’arte rupestre paleolitica – Simmetria edizioni – 2005 – pagg. 27 e 28; Alain de Benoist – Le idee a posto – Akropolis – 1983 – pag. 95; Alain de Benoist – Uomini e animali. Il posto dell’uomo nella natura – Diana Edizioni – 2014 – pag. 52; Roberto Fondi / Giuseppe Sermonti – Dopo Darwin. Critica all’evoluzionismo – Rusconi – 1980 – pagg. 287-289; Arnold Gehlen – L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo – Mimesis – 2010 – pag. 171; Giovanni Monastra – Le origini della vita – Il Cerchio – 2000 – pag. 62; Giuseppe Sermonti – Dimenticare Darwin. Ombre sull’evoluzione – Rusconi – 1999 – pagg. 71, 73, 74, 75; Giuseppe Sermonti – La Luna nel bosco. Saggio sull’origine della scimmia – Rusconi – 1985 – pagg. 60-63, 85
- Nota 9: VV. (a cura di Maria Teresa Pansera) – Il paradigma antropologico di Arnold Gehlen – Mimesis – 2005 – pag. 76; Riccardo Martinelli – Uomo, natura, mondo. Il problema antropologico in filosofia – Il Mulino – 2004 – pag. 218 (nota); Eric Voegelin – Razza, storia di un’idea – Medusa – 2006 – pag. 179
- Nota 10: Adolf Portmann – Le forme viventi. Nuove prospettive della biologia – Adelphi Edizioni – 1969 – pag. 295
- Nota 11: Konrad Lorenz (a cura di Alain de Benoist) – Intervista sull’etologia – Il Labirinto – 1979 – pag. 66
- Nota 12: Louis Bolk – Il problema dell’ominazione – DeriveApprodi – 2006 – pagg. 51, 52; Raffaele Menarini / Gabriella Neroni – Neotenia, dalla psicoanalisi all’antropologia – Borla – 2009 – pagg. 6, 51; Franco Prattico – Eva nera – Codice Edizioni – 2007 – pag. 30
- Nota 13: Michele Ruzzai – Recensione a “Alla ricerca delle origini” di Fabio Calabrese – https://www.ereticamente.net/2020/07/recensione-a-alla-ricerca-delle-origini-di-fabio-calabrese-a-cura-di-michele-ruzzai.html
- Nota 14: Dente-fossile di 9 milioni di anni fa potrebbe «riscrivere la storia dell’umanità» – Il Corriere della Sera – 21/10/2017 – https://www.corriere.it/cronache/17_ottobre_21/germania-dente-fossile-9-milioni-anni-fa-potrebbe-riscrivere-storia-dell-umanita-c7057e04-b64d-11e7-9989-18155f38f5a5.shtml
- Nota 15:2-million-year-old pre-human remains found in the Balkans – ScienceDaily – 23/5/2017 – https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170523083548.htm
- Nota 16: Matteo Marini – Scoperte a Creta impronte di forma umana risalenti a 5,7 milioni di anni fa – Repubblica – 3/9/2017 – https://www.repubblica.it/scienze/2017/09/03/news/orme_umane_su_creta_5_7_milioni_di_anni_fa-174544294/
- Nota 17: Luigi Luca Cavalli Sforza – Il caso e la necessità. Ragioni e limiti della diversità genetica – Di Renzo Editore – 2007 – pag. 84; Spencer Wells – Il lungo viaggio dell’uomo. L’odissea della nostra specie – Longanesi – 2006 – pag. 85
- Nota 18: Nicholas Wade – All’alba dell’Uomo. Viaggio nelle origini della nostra specie – Cairo Editore – 2006 – pag. 47
- Nota 19: Guido Barbujani – Europei senza se e senza ma. Storie di neandertaliani e di immigrati – Bompiani – 2008 – pag. 117; Guido Barbujani – L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana – Bompiani – 2006 – pag. 124
- Nota 20: Penny Tweedie – Out of Africa, le due migrazioni dei primi umani – Le Scienze – 22 aprile 2014 – http://www.lescienze.it/news/2014/04/22/news/migrazioni_primi_esseri_umani_africa-2108921/?ref=nl-Le-Scienze_25-04-2014)
- Nota 21: Più di 100.000 anni fa l’incrocio tra Sapiens e Neanderthal – Le Scienze – 18/2/2016 – http://www.lescienze.it/news/2016/02/18/news/incrocio_homo_sapiens_uomo_di_neanderthal-2975946/?ref=nl-Le-Scienze_19-02-2016)
- Nota 22: Apidima Cave fossils provide earliest evidence of Homo sapiens in Eurasia – Nature – 10/7/2019 – https://www.nature.com/articles/s41586-019-1376-z?fbclid=IwAR3tDxx9oTagDu0BwN3xCFRLX5L3ccCivDuuALUY0xQLaCwsdHCY7ZDBUdg ; Homo sapiens in Europa già 210.000 anni fa – Le Scienze – 11/7/2019 – https://www.lescienze.it/news/2019/07/11/news/presenza_homo_sapiens_eurasia-4477190/?fbclid=IwAR3STVR76EJmOMpV_GQfo5c5kCx_CNyk5bnrB2A8nsFkK9720ibXwIPSVW4)
- Nota 23: 125.000 anni fa l’esodo dall’Africa dell’uomo moderno – Le Scienze – 28/01/2011 – http://www.lescienze.it/news/2011/01/28/news/125_000_anni_fa_l_esodo_dall_africa_dell_uomo_moderno-553223/ ; Christine Dell’Amore – Sapiens d’Arabia – National Geographic – 28/01/2011 – http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/28/news/uomo_via_dall_africa_era_glaciale-175550/
- Nota 24: Elisabetta Intini – I Sapiens in Asia già 100 mila anni fa? – Focus – 15/10/2015 – https://www.focus.it/cultura/storia/i-sapiens-fuori-dallafrica-gia-100-mila-anni-fa ; L’uomo che viene dalla Cina – Le Scienze – 15/1/2003 – http://www.lescienze.it/news/2003/01/15/news/l_uomo_che_viene_dalla_cina-588640/
- Nota 25: Mario Giannitrapani – Il destino dell’Uomo non è racchiuso nella spirale meccanicistica del Dna – L’Umanità – 22/11/1996
- Nota 26: Homo antecessor, così lontano, così vicino – Le Scienze – 2/4/2020 – https://www.lescienze.it/news/2020/04/02/news/homo_antecessor_tratti_viso-4707705/; Marco Respinti – Processo a Darwin – Piemme – 2007 – pag. 138
- Nota 27: Nuovo studio: il cranio di Dali ha 260 mila anni. L’Homo Sapiens ha 100 mila anni in più – Epoch Times – 24/11/2017 – https://www.epochtimes.it/news/il-cranio-misterioso-risalente-a-260-mila-anni-fa/
- Nota 28: Il ‘Dragon Man’ potrebbe riconfigurare l’albero genealogico dell’uomo – National Geografic – 7/7/2021 – https://www.nationalgeographic.it/storia-e-civilta/2021/07/il-dragon-man-potrebbe-riconfigurare-lalbero-genealogico-delluomo ; Elisabetta Intini – “Uomo-drago”: un nuovo parente stretto dell’Homo sapiens? – Focus – 28/7/2021 – https://www.focus.it/scienza/scienze/uomo-drago-nuovo-parente-homo-sapiens
- Nota 29: Steve Olson – Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei nostri geni – Einaudi – 2003 – pag. 141
- Nota 30: Nel DNA dei Neanderthal c’è il cromosoma Y dei Sapiens – Le Scienze – 28/09/2020 – https://www.lescienze.it/news/2020/09/28/news/neanderthal_incrocio_sapiens_sostituzione_cromosoma_y-4805879/?fbclid=IwAR2pRgb g8oN3akgOtCilk2w-DDtiCsFSWZpEwWDk-CqjOuvjLC4OZ8I80FM
- Nota 31: Retrodatata l’origine di Homo Sapiens – Michael Greshko – National Geographic Italia – http://www.nationalgeographic.it/scienza/2017/06/08/foto/i_nostri_antenati_300mila_anni_fa_ci_assomigliavano-3560100/1/?fbclid=IwAR1VCtbOBBA0lSfkhLvZ9DiHXR2AXX9YwrpWrqxk3fROx14D3Rbj-agv3Sk
- Nota 32: Phillip Valentine Tobias – Paleoantropologia – in: “VV. (a cura di Fiorenzo Facchini) – Paleoantropologia e Preistoria. Origini, Paleolitico, Mesolitico – Jaca Book – 1993” – pag. 55
- Nota 33: Luigi Luca Cavalli Sforza – Geni, popoli e lingue – Adelphi – 1996 – pag. 137; Luigi Luca Cavalli Sforza – Il caso e la necessità. Ragioni e limiti della diversità genetica – Di Renzo Editore – 2007 – pag. 69; Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – pagg. 58, 61, 62 e 175
- Nota 34: Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – pag. 160; Richard G. Klein – Il cammino dell’Uomo. Antropologia culturale e biologica – Zanichelli – 1995 – pag. 276
- Nota 35: Paul Jordan – Neandertal. L’origine dell’uomo – Newton & Compton Editori – 2001 – pag. 208; Steve Olson – Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei nostri geni – Einaudi – 2003 – pag. 35
- Nota 36: Francesco Fedele – Idee vecchie e nuove sulle nostre origini vicine – in: Le Scienze, Quaderni, n. 73 “L’evoluzione dell’uomo” – Settembre 1993 – p 78-79; Bryan Sykes – Le sette figlie di Eva. Le comuni origini genetiche dell’umanità – Mondadori – 2003 – pag. 166; Alan G. Thorne / Milford H. Wolpoff – Un’evoluzione multiregionale – in: Le Scienze, Quaderni, n. 73 “L’evoluzione dell’uomo” – Settembre 1993 – pag. 91
- Nota 37: Fabrizio Ardito / Daniela Minerva – La ricerca di Eva – Giunti – 1995 – pag. 185
- Nota 38: Roger Lewin – Le origini dell’uomo moderno. Dai primi ominidi a Homo Sapiens – Zanichelli – 1996 – pag. 104
- Nota 39: Christopher B. Stringer – La comparsa dell’uomo moderno – Le Scienze – Febbraio 1991 – pag. 78
- Nota 40: Gianfranco Biondi / Olga Rickards – Uomini per caso. Miti, fossili e molecole nella nostra storia evolutiva – Editori Riuniti – 2004 – pag. 264
- Nota 41: La straordinaria diversità del melanesiani – Le Scienze – 28/2/2007 – http://www.lescienze.it/news/2007/02/28/news/la_strordinaria_diversita_dei_melanesiani-583318/
- Nota 42: Gianfranco Biondi / Olga Rickards – Uomini per caso. Miti, fossili e molecole nella nostra storia evolutiva – Editori Riuniti – 2004 – pag. 213
- Nota 43: Veronique Barriel – L’origine genetica dell’uomo moderno – Le Scienze – Aprile 2000 – pag. 85
- Nota 44: Luigi Luca Cavalli Sforza – Il caso e la necessità. Ragioni e limiti della diversità genetica – Di Renzo Editore – 2007 – pag. 84
- Nota 45: Anatole A. Klyosov e Igor L. Rozhanski – Re-Examining the “Out of Africa” Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids) in Light of DNA Genealogy – Scientific Research – https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=19566
- Nota 46: Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – pag. 176