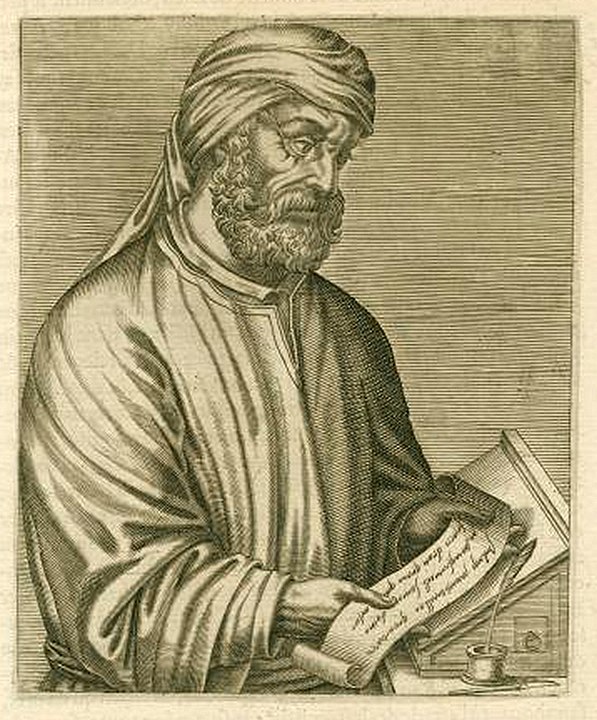Uno degli assunti cardine di alcune scuole marcatamente diffusioniste del secolo scorso sostiene che “una cultura può essere acquisita solo per via di contagio, e che l’uomo è un animale imitativo” (1) . Tuttavia, troppo spesso si è esagerato, a bella posta o inconsapevolmente, l’apporto di tale contagio, sottovalutando per contro il “sistema immunitario” delle culture che tale contagio investe. Nel caso degli studi sulla letteratura greca antica, e in generale delle analisi dedicate alle culture di area indo-europea, si è sempre propagata una narrativa dei fatti storici e mitici(che potrebbe essere assommata dall’espressione proverbiale ex Oriente lux) che risente di un bias ideologico per così dire “iperdiffusionista”, teso a considerare le opere di genio delle culture europee come frutto, quando va bene, di una “media ponderata” tra i prodotti dello spirito stesso dei popoli indoeuropei (speculativo per natura, ma considerato isterilito dalla distanza incalcolabile della Urheimat dal mare e dai centri mondiali del commercio preistorico) e il frutto delle culture mediorientali della Mezzaluna Fertile (e non solo). Lo studio della letteratura antica, poi, è il luogo dove tutte le empasse, cagionate magari dalla penuria di ritrovamenti archeologici o dalle analisi possibilmente scoraggianti di linguisti e genetisti, possono essere agevolmente aggirate. Bastano pochi “sintomi” di quel “contagio”, per eradicare una tradizione dal suo substrato, e asserire con ingiustificato trionfalismo, come fa West, che “la letteratura greca è letteratura medio-orientale” (2) (West, 1978).
Nonostante che, per fare un esempio, i grandi complessi megalitici europei, da Stonehenge alle Orcadi fino a Malta, siano notevolmente più antichi delle piramidi egizie e delle ziggurat babilonesi, gli assertori della primazia culturale dell’Oriente sul mondo europeo continuano a deprezzare i prodotti culturali della nostra antichità, quasi che il nostro continente non sia stato, quantomeno fino all’exploit della cultura classica, che un promontorio romito dell’Asia…
Nella congerie di materiale rivelante la macchinosità di chi vuol ricondurre tutto alla Mezzaluna Fertile, spicca sicuramente l’irascibilità di degnissimi autori quali Walter Burkert, scolarca dell’orientalismo moderno, autore, nel 1997 de “La rivoluzione orientalizzante”. Autori di tal calibro hanno da tempo tacciato gli indoeuropeisti di avere “eretto una barriera contro il Semitico”, accusando ripetutamente non solo il mondo dei linguisti, ma anche quello degli archeologi di conclamate “politiche di contenimento (3) “. Burkert e i suoi allievi sottendono a quest’invettiva che la posizione di chi vede ancora il mondo greco arcaico come espressione pura e autosufficiente di sé (specie l’emergere inatteso di Omero dalle tenebre del medioevo ellenico) altro non è che la spia di un’insicurezza argomentativa dinanzi alle possibilità di giudizio conferite dal “nuovo” panorama culturale prospettato già nel XIX secolo dalla scoperta dell’Oriente e dell’Egitto a monte della decifrazione del cuneiforme e dei geroglifici. A sedare i sussulti di tanta intellighenzia d’Oltralpe, chiamerei in causa l’argomentazione storica sulla scrittura antica brillantemente esposta da Robert Graves, studioso sicuramente alieno dai pregiudizi “nordicisti” che Burkert ravvisa nei grecisti dell’ 800:
“Un alfabeto greco formato da tredici, e poi quindici consonanti e cinque vocali sacre alla dea e avente origine a Creta era in uso nel Peloponneso prima della guerra di Troia. Fu portato in Egitto (forse solo nel porto di Faro) e qui adattato all’uso semitico dai mercanti fenici che alcuni secoli dopo lo riportarono in Grecia, quando ormai i Dori avevano pressochè distrutto la civiltà micenea. I caratteri con il loro nome semitico furono quindi adattati all’esistente sistema epicarmico rappresentato dai cosiddetti “caratteri pelasgici”, di solito chiamati “cadmici”, forse perché in uso in Beozia. In seguito, l’alfabeto cadmico venne modificato da Simonide, seguace di Dioniso, in conformità con qualche teoria religiosa.”
La prima cosa che noto nel leggere questo stralcio è che Graves nega di fatto l’ “orientalità” di Cadmo (da tempo considerata alla stregua di un dogma dagli orientalisti) e lo fa senza passare dai presupposti ideologici eurocentrici della “barriera” che Burkert ravvisa intempestivamente nei suoi colleghi. Lo storico francese Gustave Glotz (che Graves chiama erroneamente “Eustace”), autore de “La civilization egéenne” (1923), arguisce che i nomi dei caratteri fenici dell’alfabeto non sono di fatto riconducibili a nessuno degli oggetti rappresentati né nei geroglifici egizi, né nelle scritture degli idiomi affratellati al fenicio; ma che, piuttosto, quantomeno la loro forma è chiaramente derivata dai sillabogrammi e dagli ideogrammi della lineare A cretese, di fatto rinforzando i capisaldi dell’argomentazione di Graves.
Martin Bernal (grecista non meno stravagante di Burkert), definisce “radicalismo” quello del grecista tedesco, proprio in una recensione a La rivoluzione orientalizzante (1996, Boston University). Sempre Bernal asserisce che Burkert esageri notevolmente il ruolo dei “craftsmen”, cioè degli artieri orientali itineranti, nell’ambito della diffusione di artefatti e temi provenienti dall’area orientale. La frequente ricchezza di tali artefatti all’interno dei santuari greci, provenienti perlopiù dalle antiche scuole manufatturiere delle coste siro-libanesi, non troverebbe dunque spiegazione, argomenta giustamente Bernal, (solamente) nell’apporto di una grande scuola di maestri girovaghi, ma in fattori completamente diversi, come, per esempio, il frequentissimo invio di doni e monili ai santuari e agli oracoli panellenici da parte di opulenti monarchi orientali tra il 750 e il 550 a.C., come ci informa Erodoto (4). Bernal, implacabile, ritiene che nel discorso burkertiano ci siano due debolezze principali:
1. Vi si riscontra il tentativo di condensare tutta l’influenza orientale degna di nota sull’Ellade (pena l’impossibilità di fare apparire quella orientalizzante come una “rivoluzione”) nel secolo compreso tra il 750 e il 650 a.C.
2. L’omissione totale degli apporti culturali provenienti dall’Egitto (cui invece Graves tributa la giusta importanza). Per convalidare il primo punto, Burkert è quindi penosamente costretto a posdatare l’introduzione dell’alfabeto in Grecia alla seconda metà dell’VIII secolo, il che è del tutto impossibile, in quanto la datazione accertata dai semitisti per l’introduzione dei caratteri fenici in Grecia risale almeno al IX secolo a.C…
Altro punto focale dell’opera burkertiana consiste nel tracciamento della pratica dell’epatomanzia, cioè della divinazione dei fegati degli animali sacrificali, che, stando all’accademico tedesco, ricondurrebbe all’Oriente parte del bagaglio esperienziale della cospicua pratica divinatoria greca. Arguendo che “le corrispondenze fra Oriente e Occidente (circa questa pratica) possono essere difficilmente accidentali”, Burkert rimanda, per analogia con la sua teoria cardinale dei craftsmen orientali, a una traslazione geografica di tal pratica dovuta ai viaggi di “specialisti” dell’aruspicina. D’altronde, anche nella branca etrusco-latina dell’epatomanzia si riscontra questa “cessione di competenze” dal mondo sacerdotale tirrenico a quello romano prisco. Burkert sostiene che questa tecnica divinatoria sia già osservabile nell’Iliade, o quantomeno nella versione finale dell’Iliade, che egli data alla fine dell’VIII secolo (datazione peraltro clemente, visto che si suole postulare anche una stesura definitiva financo nel VII secolo): personaggi come Calcante, chiaroveggente di corte di Agamennone, ci indicano l’importanza di queste pratiche (e il prestigio economico-sociale dei loro addetti). L’aruspicina, per Burkert, è però menzionata solo nel XXIV libro dell’Iliade (ove i suoi addetti vengono chiamati θυοσκόοι), e riecheggia poi nell’Odissea, nella figura del proco Leodes. Burkert ritiene deducibile che il non meglio specificato sacrificio di questa figura fosse l’epatomanzia, argomentando correttamente ex silentio. Cade però nel rimandare il termine θυοσκόος all’etimo di “Tusco” (id est “Etrusco”), rivelando nondimeno grande clemenza nel raccogliere la suggestione di un autore inaffidabile come Dionigi di Alicarnasso. Come avverte Matthew Dillon, “ci sono molti aspetti di un sacrificio, aldilà delle bestie sacrificale, che possono essere esaminati, come per esempio il fuoco che si leva, o la forma delle fiamme; e questo sarebbe potuto parimenti essere il ruolo dei θυοσκόοι.” L’etimologia di “Tusci”, derivata a Burkert dal passo di Dionigi, non ha valore reale. In greco non è neppure presente (al di fuori, ovviamente del calco riportato da Dionigi) la forma Τυ(ρ)σκός. “Tusci” deriva infatti dall’umbro Turskum, probabilmente derivato dall’endoetnonimo etrusco Rasna, cioè semplicemente “le genti”. Peraltro, invece di riferirci alla fonte tarda di Dionigi, dovremmo piuttosto far capo a testimonianze più pristine, come quella del Reso euripideo, in cui μάντέις e θυοσκόοι vengono usati in modo intercambiabile e indifferenziato; segno, questo, che i Greci avevano evidentemente dimenticato le diversificazioni specialistiche all’interno dell’arte divinatoria. Ad ogni modo, se pure un libro recenziore come il XXIV risentisse di una influenza (come abbiamo visto indimostrabile) da parte delle élites clericali dell’Est, dovremmo collocare allora i collegi dei θυοσκόοι in un’epoca ampiamente precedente alla “rivoluzione orientalizzante” di Burkert; epoca in cui l’epatomanzia sarebbe fluita prepotentemente da Oriente.
Nel 1877 fu scoperta nei pressi di Piacenza la riproduzione di un fegato di montone, istoriato coi nomi delle divinità dell’anno etrusco, un vero e proprio vademecum per l’aruspicina. Benchè l’etrusco sia considerato un idioma pre-indoeuropeo, il fegato di Piacenza presenta un notevole range di influenze indoeuropee. Come afferma Dumezil: “La contrapposizione tra il rosone (inscritto nel lobo sinistro del fegato) e le caselle rettangolari del lobo destro aveva certamente un valore che ci sfugge; il fondamento di tale contrapposizione ricorda certamente quello della contrapposizione indoeuropea del cerchio e del quadrato… Nella formulazione vedica (e romana, nota mia), il cerchio è questo mondo, e il quadrato è il mondo celeste (5).” Continua Dumezil: “Le analogie con l’oriente, dalle analisi di Renè Lebat e Jean Nougayrol, restano di carattere generale (ibidem)… Difatti, i fegati mesopotamici non presentano l’elemento essenziale del fegato di Piacenza, cioè un’evidente corrispondenza fra il cosmo e la superficie del modello. In nessuna delle loro caselle compare un nome divino… In conclusione, l’Etruria non prolunga una provincia anatolica dell’aruspicina mesopotamica.”

Lo stesso etimo di “aruspicina” (peraltro strutturalmente vicino al latino auspex) ha echi indoeuropei, aldilà della radice caudale da spicio: “haru-” è infatti collegato alla radice greca καρδ-. L’Online Etymology Dictionary non ha dubbi: “il primo elemento viene dalla radice protoindoeuropea *ghere, fegato, interiora.” Lo stesso Burkert sembra rendersene conto: “Si potrebbe addirittura dimostrare come sia i modelli assiri sia quelli etruschi divergano dalla natura in modo affine; essi sono, cioè, derivati non direttamente dall’osservazione, ma da una tradizione comune.” Inoltre, come è possibile sostenere la derivazione orientale tout court dell’aruspicina, quando questa è riscontrabile in territori di popolazione indoeuropea a ben vedere irraggiungibili dall’Oriente, come per esempio la Russia europea? Lo “sviatki”, il periodo dell’anno slavo che va dal Natale all’Epifania, era il tempo in cui le predizioni sulla severità dell’inverno venivano tratte dall’ispezione della milza e del fegato dei volatili domestici.
Ancora una volta, la questione della “promanazione dall’Oriente”, “culla della Civiltà” (di nessuna, invero, se non della sua propria), si arena, penosamente, lontano dalla realtà dei fatti.
Stefano Manza*
dai boschi dell’Ithilien
NOTE E BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:
- Malinowski, The Life of Culture, Norton & Company Inc., 1927.
- West, Theogony, Oxford, Oxford / Sandpiper, 1997.
- “… Gli elementi stranieri rimangono oggetto di politiche di contenimento.”
- Erodoto era solito peregrinare per i santuari della Grecia, e molte delle informazioni che riporta circa la ricchezza di questi donativi deriva dall’autopsia dei suoi viaggi. Altra fonte importante è quella di Teopompo (citato in Aten. 6, 20, 231), che conferma la presenza di interi templi repleti solo di artefatti orientali; non solo statue, ma anche lebeti per le abluzioni e tripodi bronzei. Inoltre, sempre stando alla preziosa testimonianza di Teopompo, i primi artefatti d’oro in assoluto in un tempio greco devono la loro presenza alla richiesta spartana di oro a Creso per ornare il volto di Apollo Amicleo.
- La religione romana arcaica, p. 553. Cfr. Giandomenico Casalino, Il nome segreto di Roma. Metafisica della Romanità, Edizioni Mediterranee, 2003, p. 193: “La forma urbis, essendo un mandala (dunque un cerchio), rappresenta l’invocazione della forza Amor-Venere nella fissazione della qualità quadrata… cioè il Lar Martis, quale forza rivitalizzata e guerriera.”
*Nota sull’Autore
Stefano Gabriele Manza è un giovane neo laureato da tempo interessato alle tematiche della Tradizione. Appassionato di Indoeuropeismo e Mitica Occidentale è sensibile alla Cultura Greca Arcaica e alle immaginazioni tolkeniane