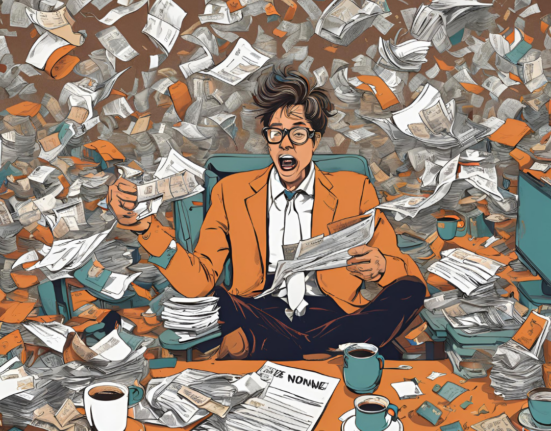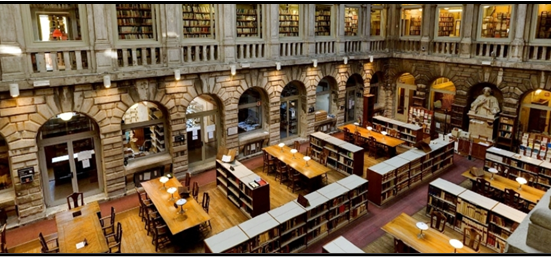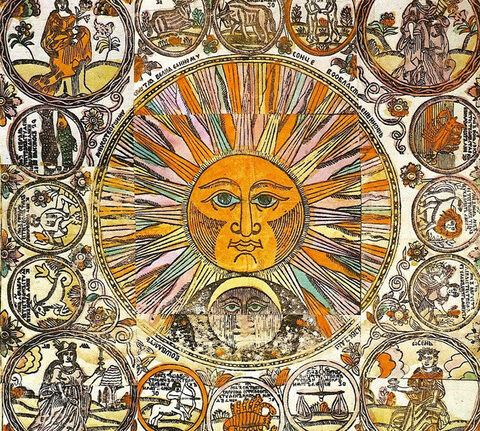(prosegue…)
Dando per scontato che il lettore conosca l’andamento, non solo dell’intera storia medievale, ma anche della rimanente storia occidentale, accennerò (come ho già detto) agli snodi salienti di essa, ma con riferimento (almeno per il momento) al destino sia del potere ecclesiastico che di quello imperiale (in quanto le vicende di Chiesa e impero risultano quindi per lo più collegate). Se, grossomodo, con gli imperatori sassoni – e in particolare con Ottone I – la Chiesa visse forse il suo momento di maggiore subalternità all’impero (fallimentare fu, fra l’altro, il suo tentativo di opporsi a quest’ultimo sostenendo la grande feudalità italica e re Arduino nel loro tentativo di svincolarsi dal potere della casa di Sassonia). Se la successiva dinastia di Franconia perpetuò, in tutto e per tutto, la linea politica seguita dagli Ottoni, gli esiti dello scontro tra papato e impero furono tuttavia, stavolta, gradualmente favorevoli alla Chiesa. Certamente, con Corrado il Salico, l’alta aristocrazia risultò sconfitta e indebolita. Ma già con l’arcivescovo milanese Ariberto d’Intimiano la grande feudalità italiana (guidata in particolare da quest’ultimo) potette quantomeno tenere tenacemente testa all’impero. Ma fu contro gli ultimi due esponenti della casata di Franconia, Enrico IV ed Enrico V, che la Chiesa potette addirittura raggiungere l’apice del suo potere, sia spirituale che temporale. Al primo di questi due personaggi si legano le note vicende di papa Gregorio VII e della ‘cattolicissima’ marchesa di Toscana Matilde di Canossa (alta aristocratica fedelmente a servizio dell’anzidetto papa): la scomunica di Enrico IV produsse un’estesa rivolta alto-aristocratica (con il beneplacito, per giunta, del popolo), in Germania e in Italia. Ma è con il concordato di Worms che la forza, che il potere, condizionante della Chiesa non verrà, storicamente, mai più eguagliato (la soggezione, l’obbedienza, la subalternità di Enrico V e del suo impero al papato fu fortissima).
 Con il ‘Barbarossa’ si riaffermò il tentativo, da parte dell’impero, di ricostituirsi quale entità politica più importante del mondo (allora) conosciuto (successivamente al suo forte indebolimento ad opera del suddetto concordato): Federico I volle dunque riportare in auge la linea politica seguita dapprima (dunque piuttosto vittoriosamente) dagli imperatori sassoni, e successivamente dagli imperatori franconi (il cui potere fu invece gradualmente declinante). In un primo momento il papato gli diede tuttavia sostegno, sia contro il ‘libero comune’ milanese (con le sue guerre di espansione a danno di altre città), sia contro l’eretico Arnaldo da Brescia, che aveva reso Roma anticlericale (per via della corruzione e dell’ipocrisia della Chiesa del tempo) e liberale (i ceti emergenti e più dinamici lo appoggiarono); il suddetto eretico anticipò il protestantesimo (o perlomeno alcuni tratti di esso). Ma i tempi non erano ancora maturi per l’affermazione duratura di regimi ‘repubblicani’, per cui Arnaldo fece, in breve tempo, la stessa fine che fecero tutti coloro che intrapresero un analogo progetto politico. Ma con Alessandro III la politica del papato nei confronti dell’impero mutò radicalmente. Per via del prevalere dell’impero sulla Chiesa, l’anzidetto papa decise di appoggiare – con alta probabilità – ‘strumentalmente’ i comuni del nord Italia in funzione anti-imperiale: lo scopo era ovviamente quello di limitare il potere dell’impero. L’esito dello scontro tra Federico I e la Lega Lombarda coincise con un compromesso: alcune libertà economico-commerciali anticorporative che i liberi comuni della Lega si erano date, vennero mantenute, in cambio tuttavia (in primo luogo) del riconoscimento della loro sottomissione politica al Regno d’Italia, e dunque al ‘Sacro Romano Impero Germanico’ (cui i comuni del nord dovevano quindi una certa obbedienza, nonché l’adempimento di alcuni doveri politici). Fu Innocenzo III a nominare Federico II imperatore. Prima di parlare (brevemente) di quest’ultimo, discutiamo dell’anzidetto papa. Ora, la Chiesa non ha mai avuto lo scopo di distruggere l’impero, ma unicamente quello di subordinarlo ai suoi dettami ideologici. Anzi, alla luce di ciò che si è appena concluso di dire, più l’impero era esteso, maggiore era l’influenza pacificatrice che il cattolicesimo avrebbe potuto esercitare all’interno dei confini di esso. Ebbene, Innocenzo III incarnò forse, più di ogni altro papa, tale desiderio, tale ideale, del mondo cattolico. E fu molto influente: laddove l’impero non giungeva, i sovrani indipendenti da quest’ultimo avrebbero dovuto comunque essere obbedienti alla Chiesa. E Innocenzo fu piuttosto autorevole anche presso le corti di Spagna (per la quale promosse, fra l’altro, la ‘Reconquista’), Francia e Inghilterra.
Con il ‘Barbarossa’ si riaffermò il tentativo, da parte dell’impero, di ricostituirsi quale entità politica più importante del mondo (allora) conosciuto (successivamente al suo forte indebolimento ad opera del suddetto concordato): Federico I volle dunque riportare in auge la linea politica seguita dapprima (dunque piuttosto vittoriosamente) dagli imperatori sassoni, e successivamente dagli imperatori franconi (il cui potere fu invece gradualmente declinante). In un primo momento il papato gli diede tuttavia sostegno, sia contro il ‘libero comune’ milanese (con le sue guerre di espansione a danno di altre città), sia contro l’eretico Arnaldo da Brescia, che aveva reso Roma anticlericale (per via della corruzione e dell’ipocrisia della Chiesa del tempo) e liberale (i ceti emergenti e più dinamici lo appoggiarono); il suddetto eretico anticipò il protestantesimo (o perlomeno alcuni tratti di esso). Ma i tempi non erano ancora maturi per l’affermazione duratura di regimi ‘repubblicani’, per cui Arnaldo fece, in breve tempo, la stessa fine che fecero tutti coloro che intrapresero un analogo progetto politico. Ma con Alessandro III la politica del papato nei confronti dell’impero mutò radicalmente. Per via del prevalere dell’impero sulla Chiesa, l’anzidetto papa decise di appoggiare – con alta probabilità – ‘strumentalmente’ i comuni del nord Italia in funzione anti-imperiale: lo scopo era ovviamente quello di limitare il potere dell’impero. L’esito dello scontro tra Federico I e la Lega Lombarda coincise con un compromesso: alcune libertà economico-commerciali anticorporative che i liberi comuni della Lega si erano date, vennero mantenute, in cambio tuttavia (in primo luogo) del riconoscimento della loro sottomissione politica al Regno d’Italia, e dunque al ‘Sacro Romano Impero Germanico’ (cui i comuni del nord dovevano quindi una certa obbedienza, nonché l’adempimento di alcuni doveri politici). Fu Innocenzo III a nominare Federico II imperatore. Prima di parlare (brevemente) di quest’ultimo, discutiamo dell’anzidetto papa. Ora, la Chiesa non ha mai avuto lo scopo di distruggere l’impero, ma unicamente quello di subordinarlo ai suoi dettami ideologici. Anzi, alla luce di ciò che si è appena concluso di dire, più l’impero era esteso, maggiore era l’influenza pacificatrice che il cattolicesimo avrebbe potuto esercitare all’interno dei confini di esso. Ebbene, Innocenzo III incarnò forse, più di ogni altro papa, tale desiderio, tale ideale, del mondo cattolico. E fu molto influente: laddove l’impero non giungeva, i sovrani indipendenti da quest’ultimo avrebbero dovuto comunque essere obbedienti alla Chiesa. E Innocenzo fu piuttosto autorevole anche presso le corti di Spagna (per la quale promosse, fra l’altro, la ‘Reconquista’), Francia e Inghilterra.
In occasione della guerra tra la Francia di Filippo Augusto e l’Inghilterra dei Plantageneti si prodigò affinché, quantomeno, essa venisse combattuta con onore e lealtà da parte di entrambe le potenze. Promosse inoltre una crociata contro i Selgiuchidi (e l’obbiettivo delle crociate in ‘Terra Santa’ era stato, sin dall’origine, quello di deviare le inarrestabili pulsioni belliche dei sovrani europei verso l’Oriente degli ‘infedeli’, anche e soprattutto per fare in modo che nel ‘vecchio continente’ regnasse la pace). Papa Innocenzo, quale forse astuto e acuto conoscitore dell’ ‘animo umano’, ben sapeva che la natura carnale e peccatrice degli uomini (e in particolare dei vari sovrani europei) non sarebbe mai stata del tutto raffrenata dai suoi poteri meramente ideologico-propagandistici. Non avrebbe potuto, dunque, far altro che ‘temperarla’ il più che gli era possibile. E, ciò nonostante, i lati più oscuri e ferini del loro carattere non avrebbero ‘mai taciuto’. Motivo per cui, non c’era da far altro che incanalarli in direzione di eretici, pagani e musulmani (dei miscredenti in genere, i quali venivano considerati come dei veri e propri ‘mostri’, come degli ‘esseri immondi’), verso i quali essi avrebbero potuto dar sfogo a tutta la loro ferocia e crudeltà, senza alcun freno (i contenuti della Chanson de Roland sono molto indicativi in tal senso). Il suddetto papa si pose anche a capo della Santa Inquisizione (affidandola successivamente ai domenicani): essa era uno strumento (sia pure troppo crudele) da rivolgere contro le peggiori pulsioni borghesi, dunque smisuratamente egoistiche, le quali avrebbero potuto produrre – ‘allo stato libero’ – caos politico e disordine sociale. Infine, vedremo successivamente il perché abbia dato sostegno anche al rimanente ordine mendicante (specialmente per le città), ossia quello dei francescani.
Ora, nonostante tutti gli sforzi di papa Innocenzo rivolti a mantenere, a conservare, un ordine – sia pure di tipo, per così dire, ‘tipicamente medievale’ – in Europa, con Federico II il potere imperiale riceverà, subirà, un colpo tale da farlo ‘vacillare mortalmente’: i comuni avranno fortemente ragione sia di Federico che dei suoi parenti e successori (appartenenti alla casa di Svevia). Il sud Italia diverrà inoltre un possesso angioino e la carica imperiale già diverrà una mera onorificenza priva del suo precedente potere (del suo precedente, effettivo, peso politico). Quando Rodolfo d’Asburgo diverrà infatti imperatore (qualche decennio dopo la morte di Federico II), uno scenario europeo anticipatore dei primissimi tempi moderni già si sarà costituito.  E così, Rodolfo si interessò unicamente (o perlomeno principalmente) delle vicende della Mitteleuropa, non avendo già, forse, neanche troppo potere e tanta autorità presso i vari nobili germanici (la Germania già allora somigliava – e forse neanche troppo poco – alla successiva Germania luterana, politicamente – di fatto – frammentata, anti-imperiale e anticattolica): siamo dunque verso la fine del tredicesimo secolo, ma il medioevo appare già ‘al tramonto’. Ma torniamo, per un momento, a parlare di Innocenzo III: ebbene, quando propose a Filippo Augusto di prender parte alla crociata contro gli Albigesi, costui non acconsentì. Tale episodio, non solo dimostra che l’influenza che tale – pur autorevole – papa esercitava sui sovrani era comunque limitata (ma non assente, dunque), ma mostra anche qual’era la mentalità dei vari sovrani europei dell’età di mezzo. La crociata guidata da Simone di Montfort, non solo estirpò, annientò, l’eresia catara, ma assestò anche un duro colpo alla cultura provenzale (e, più in generale, occitanica); molto più avanti parlerò anche di detta cultura, ponendola in relazione anche con la mentalità dei sovrani d’Europa.
E così, Rodolfo si interessò unicamente (o perlomeno principalmente) delle vicende della Mitteleuropa, non avendo già, forse, neanche troppo potere e tanta autorità presso i vari nobili germanici (la Germania già allora somigliava – e forse neanche troppo poco – alla successiva Germania luterana, politicamente – di fatto – frammentata, anti-imperiale e anticattolica): siamo dunque verso la fine del tredicesimo secolo, ma il medioevo appare già ‘al tramonto’. Ma torniamo, per un momento, a parlare di Innocenzo III: ebbene, quando propose a Filippo Augusto di prender parte alla crociata contro gli Albigesi, costui non acconsentì. Tale episodio, non solo dimostra che l’influenza che tale – pur autorevole – papa esercitava sui sovrani era comunque limitata (ma non assente, dunque), ma mostra anche qual’era la mentalità dei vari sovrani europei dell’età di mezzo. La crociata guidata da Simone di Montfort, non solo estirpò, annientò, l’eresia catara, ma assestò anche un duro colpo alla cultura provenzale (e, più in generale, occitanica); molto più avanti parlerò anche di detta cultura, ponendola in relazione anche con la mentalità dei sovrani d’Europa.
Con Bonifacio VIII si ebbe un momento storico di degradazione ecclesiastica. Appoggiò l’oligarchia borghese fiorentina capeggiata dai Donati, ovvero i cosiddetti Guelfi Neri, che espulsero dalla città i Guelfi Bianchi (la borghesia emergente); i ghibellini erano già stati scacciati da Firenze. Il corporativismo quale strumento di protezionismo di poche famiglie magnatizie, prefigura il successivo affermarsi della varie signorie italiane. Il suddetto papa si scontrò inoltre con Filippo il Bello, in quanto la corona francese aveva deciso – con il beneplacito degli Stati Generali – di tassare gli ecclesiastici, dichiarando, inoltre, che il suo potere proveniva direttamente da Dio. Il suddetto re di Francia aveva autolimitato il proprio potere regale, favorendo ogni rappresentante degli Stati Generali – borghesia compresa dunque – lasciandola inoltre piuttosto libera di esercitare i suoi affari. E da essa riceveva introiti piuttosto cospicui (anche se, magari, la tassazione nei suoi confronti non era eccessivamente alta). Impose, quindi, tasse ragionevoli anche all’alta aristocrazia: con ciò, aveva portato dalla sua parte l’intero popolo francese. Filippo fece dunque della Francia il primo esempio di coesa nazione moderna, la quale non andava tanto ad anticipare l’assolutismo monarchico dei primi del cinquecento (di cui parlerò), quanto piuttosto una realtà politica più evoluta rispetto al moderno assolutismo, quale è stata (addirittura) quella dell’Inghilterra di Elisabetta Tudor (sovrana che aveva analogamente limitato i propri poteri in favore sia della Camera dei Lord che della Camera dei Comuni). Poco tempo dopo la morte di papa Bonifacio vi furono due tentativi fallimentari di riportare in auge l’impero, l’uno da parte di Arrigo VII, l’altro da parte di Ludovico il Bavaro. Con l’emanazione della Bolla d’Oro da parte Carlo di Lussemburgo si ebbe l’ufficializzazione della fine dell’universalismo imperiale. Ma, d’altra parte, il papa cessava di ratificare l’elezione imperale. Con la ‘cattività avignonese’ del papato, la Chiesa visse forse il periodo di maggiore degradazione in età medievale. Essa la si ebbe tra gli inizi del trecento e i suoi ultimi decenni: i papi e i licenziosi prelati (soprattutto) francesi si diedero ad un cinico e più o meno lecito affarismo. Imponevano inoltre tasse molto alte a chi dipendeva dalle loro proprietà, in modo tale da poter vivere nello sfarzo e nel lusso sfrenato. Ciò determinò, in particolare, l’allontanamento del popolo più umile dai precetti ecclesiastici: forse, se la Chiesa si fosse mantenuta più morigerata, episodi quali le jacquerie francesi, il ‘tumulto dei ciompi’ a Firenze, le rivolte dei lollardi in Inghilterra, non si sarebbero probabilmente verificati (o comunque, sarebbero stati meno tumultuosi e dilaganti). Lo scisma d’occidente che seguì il periodo della ‘cattività’, servì proprio a moralizzare nuovamente la Chiesa (perlomeno quella con la sede a Roma). Ma il popolo minuto ‘tornò all’ordine’ pienamente, soltanto alla metà del quattrocento (diversi anni dopo il concilio di Costanza): fu solo allora, infatti, che il processo di rimoralizzazione della Chiesa si effettuò (se non altro) con la massima compiutezza possibile.
Altro momento di profonda decadenza ecclesiastica lo si ebbe con Rodrigo Borgia (siamo tuttavia già in età moderna): il papa che gli succedette (Giulio II) riporterà ordine e moralità all’interno dello Stato Pontificio. Ma con il suo successore, il mediceo Leone X, si apre una nuova fase di decadenza: fu in particolare la ‘vendita delle indulgenze’ da parte di quest’ultimo ad offrire a Lutero il maggior pretesto (l’appiglio) per criticare la Chiesa, denunciandola in particolare per la sua ipocrisia. Ma con ciò, ha anche inizio il processo di graduale sfaldamento critico dell’Humanitas medievale e dell’ ‘oggettività’ ad essa inerente, in nome di un libertarismo che diverrà sempre più egoistico: dapprima esso evolverà nell’illuminismo (che, come vedremo, ebbe anche – ovviamente – degli aspetti positivi), per poi degenerare nella post-modernità capitalistica (la quale, la stiamo ancora vivendo). Contemporaneo alle figure di Lutero e del suo nemico mediceo, fu l’imperatore asburgico cattolico Carlo V. L’impero, per l’ultima volta nella storia d’Occidente, riesumerà la sua vocazione universalistica, ma anche – al contempo – il sogno di riaffermare l’universalismo cattolico. L’esito fu ovviamente fallimentare (i tempi erano ormai cambiati): Carlo aveva già speso molto denaro per farsi eleggere ‘imperatore’, e contrasse ulteriori debiti con le banche (soprattutto) tedesche nel corso della sue varie campagne militari. Condusse quindi lo stato asburgico alla bancarotta, al dissesto (o tracollo) finanziario. La Germania per lo più luterana resistette ai tentativi da parte di Carlo di privarla della sua ampia autonomia (se non, addirittura, della sua ‘indipendenza di fatto’) dall’impero. Verso la fine della sua vita, l’imperatore asburgico abdicò in favore di suo fratello Ferdinando (che avrebbe controllato la Mitteleuropa) e di suo figlio Filippo (che ereditò, quindi, i restanti domini asburgici). Il calvinismo conobbe la sua prima importante affermazione (a livello europeo) quando il figlio e successore di Enrico VIII al trono inglese, promosse la contaminazione dell’anglicanesimo con molteplici aspetti della dottrina di Calvino (dottrina liberale e, al pari del luteranesimo, cautamente libertaria o permissiva). Ma con Enrico VIII, la Chiesa cattolica risiedente in Inghilterra, aveva già perduto i suoi privilegi di natura sia giuridica, giudiziaria, che tributaria, fiscale. Se dopo Carlo d’Asburgo nessuno sognò più di restaurare l’universalismo imperiale, di stampo dunque tipicamente medievale, dalla Controriforma in poi la Chiesa non fu probabilmente più la stessa (ossia, ciò che era stata nei suoi momenti più e meno ascendenti in età medievale). Nel Concilio di Trento – ad esempio e in primo luogo – la dottrina della vendita delle indulgenze non verrà posta in discussione.E i Gesuiti si proporranno quale ordine (sia pure molto cautamente) ‘progressista’, anche se più ‘conservatore’ rispetto ad ogni culto cristiano riformato. Insomma, a partire dalla Controriforma la Chiesa, per sopravvivere lungo i secoli a venire, si adatterà sempre più ai mutamenti e alle evoluzioni dei nuovi tempi (moderni), tempi in cui la borghesia, sia finanziaria che imprenditoriale, tenderà (fino ai nostri giorni) ad affermare ascendentemente il suo potere. Tuttavia il primo fenomeno storico-politico che si ebbe in età moderna fu l’assolutismo monarchico (appunto) ‘moderno’. Esempi tipici di tale fenomeno furono (ad esempio) Enrico VII Tudor e Ferdinando il Cattolico. Se il primo esautorò il Parlamento inglese (non convocandolo mai), il secondo – analogamente – esautorò le ‘Cortes’ (il parlamento spagnolo, gli ‘stati generali’ iberici). Entrambi i regimi assolutistici traevano tuttavia il grosso dei loro profitti da una borghesia lasciata il più possibile libera (per quanto quei tempi, ancora prematuri per un puro liberismo, lo consentissero) di esercitare le sue attività, in un contesto di libera (eppure – vi è quindi da ritenere – al contempo moderata) concorrenza. Ma la borghesia, crescendo economicamente, andava ad impoverire l’inoperosa alta aristocrazia; ciò da un lato. Dall’altro lato, il re, grazie alle piuttosto cospicue finanze che riceveva dal ceto mercantile-imprenditoriale, poteva mantenere un forte e grande esercito con cui poteva ben tenere a bada la grande nobiltà nei suoi eventuali tentativi di rivoltarsi contro di esso.
stata nei suoi momenti più e meno ascendenti in età medievale). Nel Concilio di Trento – ad esempio e in primo luogo – la dottrina della vendita delle indulgenze non verrà posta in discussione.E i Gesuiti si proporranno quale ordine (sia pure molto cautamente) ‘progressista’, anche se più ‘conservatore’ rispetto ad ogni culto cristiano riformato. Insomma, a partire dalla Controriforma la Chiesa, per sopravvivere lungo i secoli a venire, si adatterà sempre più ai mutamenti e alle evoluzioni dei nuovi tempi (moderni), tempi in cui la borghesia, sia finanziaria che imprenditoriale, tenderà (fino ai nostri giorni) ad affermare ascendentemente il suo potere. Tuttavia il primo fenomeno storico-politico che si ebbe in età moderna fu l’assolutismo monarchico (appunto) ‘moderno’. Esempi tipici di tale fenomeno furono (ad esempio) Enrico VII Tudor e Ferdinando il Cattolico. Se il primo esautorò il Parlamento inglese (non convocandolo mai), il secondo – analogamente – esautorò le ‘Cortes’ (il parlamento spagnolo, gli ‘stati generali’ iberici). Entrambi i regimi assolutistici traevano tuttavia il grosso dei loro profitti da una borghesia lasciata il più possibile libera (per quanto quei tempi, ancora prematuri per un puro liberismo, lo consentissero) di esercitare le sue attività, in un contesto di libera (eppure – vi è quindi da ritenere – al contempo moderata) concorrenza. Ma la borghesia, crescendo economicamente, andava ad impoverire l’inoperosa alta aristocrazia; ciò da un lato. Dall’altro lato, il re, grazie alle piuttosto cospicue finanze che riceveva dal ceto mercantile-imprenditoriale, poteva mantenere un forte e grande esercito con cui poteva ben tenere a bada la grande nobiltà nei suoi eventuali tentativi di rivoltarsi contro di esso.
Ora, non saprei dire se l’azione dei borghesi andasse ad impoverire anche la piccola nobiltà, in quanto non più protetta nella sua proprietà, come un tempo, da uno stato monarchico di tipo basso-medievale. Ma tornando a parlare del ceto baronale, credo che, di fronte alle richieste fiscali del monarca, non potesse opporsi più di tanto, e proprio per i motivi suddetti (ossia per il fatto che contro il suo esercito non avrebbe potuto far nulla, o – al limite – avrebbe potuto fare ben poco). Grazie alle scoperte geografiche ebbe inizio per la borghesia europea (soggetta ovviamente a stati colonialisti) un processo di graduale rafforzamento del suo potere economico (e, dunque, anche del suo peso politico). Tantoché, in un contesto (sia pure assolutistico) come quello della Francia di Luigi XIV, essa (o parte di essa, quella che era riuscita ad abbattere ogni relativo concorrente) era cresciuta ad un livello tale che lo stato iniziò a proteggerla anche e soprattutto attraverso dei dazi doganali. In tal modo l’oligarchia industriale nazionale, non avendo concorrenti, poteva incassare, percepire, consistenti introiti, mantenendo inoltre i prezzi delle merci da vendere piuttosto alti. Ma anche l’occupazione, il lavoro, dei salariati alle loro dipendenze era, al contempo, protetto. I beni e le risorse mancanti alla nazione (nello specifico, dunque, dell’esempio che si sta svolgendo, a quella francese) venivano procacciati attraverso la promozione di guerre di conquista: risorse (anche agricole) e beni che se ne traevano, venivano posti soprattutto nelle mani della suddetta oligarchia magnatizia, in modo tale da farla crescere ulteriormente. Il ‘Re Sole’, in alleanza con i maggiorenti borghesi, poteva riscuotere da questi ultimi tasse (quasi certamente) non alte, eppure gli introiti derivanti da ciò erano comunque cospicui, per via di tutto ciò di cui l’alta borghesia disponeva. Ma in tal modo il suo personale esercito era assai potente: lo poteva rivolgere, sia contro i suoi nemici esterni (magari in una guerra d’aggressione e di conquista), sia contro i suoi nemici interni (la piccola e la grande nobiltà) in caso del loro malcontento. E le tasse che imponeva all’insieme dei nobili francesi erano consistenti (andavano a potenziarlo ulteriormente da un punto di vista economico e, dunque, anche militare).
Quando, tuttavia, il potere della ricca borghesia si rafforzerà ulteriormente, andrà a ritorcersi anche contro il sovrano. E così (ad esempio e in primo luogo), Luigi XVI sarà costretto a ristabilire uno stato monarchico (sia pure assolutistico) in cui la proprietà della piccola e grande nobiltà sarà garantita contro il suo restringimento ad opera della ‘corrosiva’ azione della borghesia. La ristabilita alleanza con la totalità dell’aristocrazia francese, in funzione dunque antiborghese, comportò certamente una diminuzione del prelievo fiscale nei confronti di essa tutta. E i soldi necessari al mantenimento della macchina statale (per compensazione) venivano ora letteralmente estorti al ‘Terzo Stato’, i cui rappresentanti erano quindi costretti ad un salato versamento di tributi. Ciò condurrà ovviamente allo scoppio della rivoluzione francese, la quale, tuttavia (anche prima della presa del potere da parte di Napoleone, il ‘diciotto Brumaio’ del 1799), si stabilizzerà (dopo aver vissuto l’audace, avanzato, liberal-radicale – eppure necessariamente effimero, anche per via della prematurità dei tempi in cui fu attuato – esperimento politico del ‘terrore’ giacobino) in un sistema (perlomeno ‘di fatto’, anche se non ‘formalmente’) di tipo monarchico-costituzionale (o se non altro fondato sul compromesso tra la più ricca borghesia nazionale e l’intero mondo aristocratico dello stato d’oltralpe). Ora, tenendoci al caso circoscritto della rivoluzione francese, se quella borghesia che ne è stata la principale protagonista e fautrice, ma anche (a lungo andare) la maggiore beneficiaria, ha agito per i soli propri interessi, ha tradito il popolo minuto, ma non ‘se stessa’ (persino nei compromessi che dovette accettare, almeno momentaneamente, prescindendo cioè dalle sue successive affermazioni o vittorie politiche). L’egoismo, il solo proprio tornaconto, la volontà di supremazia, è difatti la cifra che la caratterizza nella sua tipica purezza.
Gli ideali illuministici e massonici che ha abilmente e fruttuosamente propagandato presso il ceto medio e (almeno) presso una parte del popolo più subalterno (trascinandoli nelle sue lotte, oppure facendo in modo che gli dessero almeno, sia pure dunque inattivamente, appoggio politico), diedero tuttavia luogo a ciò che possiamo definire ‘sinistra borghese’. Di quest’ultima ne parlerò più avanti (valutando, sia pure non troppo espressamente, i suoi ‘pro’ e i suoi ‘contro’). Per il momento farò riferimento ad uno dei presunti valori dell’alta borghesia, ovvero al ‘garantismo’, in modo tale da coglierne la reale ed effettiva portata. Portiamoci tuttavia in un contesto diverso da quello francese, ossia nell’Inghilterra degli Stuart, ma poco prima che venisse attuata la rivoluzione orangista. È già in tale contesto che nasce la figura politica del ‘Whig’, il quale non era in origine, necessariamente, un liberale borghese. ‘ Whig’, poteva essere anche un ricco aristocratico anglicano opposto al centralismo monarchico (propugnato dalla dinastia scozzese e cattolica degli Stuart). Ora, mettiamo che il monarca d’Inghilterra abbia preteso sacrosantamente dall’anzidetto Whig un necessario versamento tributario, necessario in quanto da destinare al funzionamento (mettiamo) di uno stato efficiente, ovvero tale da proteggere il benessere di ogni suo membro. Pertanto, se tale ipotetico Whig si rifiuta di pagare ‘il dovuto’ allo stato, in quanto da egli arbitrariamente ritenuto ‘un prezzo troppo alto’, il monarca lo farà (magari) anche arrestare, imprigionare. Ebbene, uno degli ‘act’ emanati nel periodo cui ci si sta ora riferendo, proibiva che a tale tipo di prigioniero venisse inflitto un qualsiasi tipo di maltrattamento. Concludendo, è ovvio dunque che le (presunte) ‘riforme’ che un potere forte (o abbastanza forte) concede a se stesso (alla sua categoria sociale), siano meri modi per – innanzitutto – salvaguardarsi. Ecco, dunque, a cosa si riduce il ‘garantismo’ (e – ma ciò sarà chiaro in seguito – per così dire, ‘nella quasi migliore delle ipotesi’). Prima di parlare dei vari caratteri, della varie tendenze, della ‘sinistra borghese’, parlerò della differenza tra la borghesia imprenditoriale e quella finanziaria. Alla prima dovrò accennare abbastanza concisamente, per non dilungarmi troppo. Della seconda ne discuterò invece in modo ben più approfondito.
Whig’, poteva essere anche un ricco aristocratico anglicano opposto al centralismo monarchico (propugnato dalla dinastia scozzese e cattolica degli Stuart). Ora, mettiamo che il monarca d’Inghilterra abbia preteso sacrosantamente dall’anzidetto Whig un necessario versamento tributario, necessario in quanto da destinare al funzionamento (mettiamo) di uno stato efficiente, ovvero tale da proteggere il benessere di ogni suo membro. Pertanto, se tale ipotetico Whig si rifiuta di pagare ‘il dovuto’ allo stato, in quanto da egli arbitrariamente ritenuto ‘un prezzo troppo alto’, il monarca lo farà (magari) anche arrestare, imprigionare. Ebbene, uno degli ‘act’ emanati nel periodo cui ci si sta ora riferendo, proibiva che a tale tipo di prigioniero venisse inflitto un qualsiasi tipo di maltrattamento. Concludendo, è ovvio dunque che le (presunte) ‘riforme’ che un potere forte (o abbastanza forte) concede a se stesso (alla sua categoria sociale), siano meri modi per – innanzitutto – salvaguardarsi. Ecco, dunque, a cosa si riduce il ‘garantismo’ (e – ma ciò sarà chiaro in seguito – per così dire, ‘nella quasi migliore delle ipotesi’). Prima di parlare dei vari caratteri, della varie tendenze, della ‘sinistra borghese’, parlerò della differenza tra la borghesia imprenditoriale e quella finanziaria. Alla prima dovrò accennare abbastanza concisamente, per non dilungarmi troppo. Della seconda ne discuterò invece in modo ben più approfondito.
Ebbene, riprendendo il discorso relativo alla storia occidentale da dove lo avevo interrotto, possiamo affermare (per farla molto breve) che la borghesia mercantile-imprenditoriale ha dovuto accettare tutta una serie di compromessi (è passata ad esempio attraverso il fenomeno storico del ‘dispotismo illuminato’) che l’hanno però, alla fine, condotta (in un’ascesa graduale) ad affermare il massimo delle sue potenzialità nei tempi più attuali (è in particolare dopo la seconda guerra mondiale, con il prevalere un po’ ovunque, nel ‘mondo occidentale’, delle più moderne repubbliche liberali, che essa è giunta ad affermarsi quasi definitivamente. E con il ‘crollo del comunismo’ la sua affermazione è stata definitiva). Ma ancora oggi, per sopravvivere, non può che attuare degli espedienti (ne è costretta) per i quali autolimita il proprio sfrenato egoismo sopraffattore: persino le più ricche multinazionali entrerebbero in crisi se non vi fossero grandi stati in cui deve vigere un certo grado di onestà, di giustizia, di intelligenza, di bravura, di laboriosità ed efficienza; inoltre anche esse hanno bisogno che ‘in basso’ viga un certo grado di benessere, che deve essere inoltre piuttosto esteso (avendo ovviamente bisogno di ‘consumatori’). Ora, se l’attività imprenditoriale è pressoché necessariamente soggetta, per così dire, a ‘oscillazioni’, ossia a momenti di guadagno, ma anche a momenti di perdita, l’attività finanziaria (se svolta con diligente serietà e con costante – con la massima – attenzione) è tale da non essere soggetta ad alcun rischio. L’abile banchiere vede crescere progressivamente i suoi guadagni: certamente, in alcune congiunture, possono crescere meno, in altre più. Ma non andrà mai ‘in perdita’. Dal momento che il mio discorso è incentrato soprattutto sul medioevo, esaminiamo il fenomeno della finanza occidentale in età medievale. Ed è proprio con la ‘rinascita comunale’, con la ‘rifioritura delle città’, che, ovviamente, risorge anche l’attività bancaria.Ora, è altamente probabile (se non addirittura certo), che (perlomeno) alcuni di coloro che si sono dedicati all’attività bancaria nelle prime fasi del basso medioevo, siano riusciti a protrarre tale loro attività – quindi con crescente successo – addirittura fino ai giorni nostri, andando a costituire il ceto dell’ ‘altissima finanza mondiale’. Era costume dei banchieri, infatti, quello di cambiare nazionalità, e persino ‘cognome’, trasferendosi laddove potevano svolgere al meglio la loro attività di prestatori a interesse di denaro, facendo dunque nuovi e più remunerativi affari (alcune realtà politiche infatti, una volta fiorenti, decadevano, e altri stati emergevano economicamente, andando a soppiantare le anzidette realtà politiche. E così, ad esempio, banchieri che avevano risieduto in Toscana o a Venezia, trasferiranno le loro sedi dapprima – mettiamo – in Inghilterra e, infine, negli Stati Uniti).
Teoricamente, per aprire un’attività bancaria, non serve neanche un capitale iniziale: ci si deve procacciare dei ‘risparmiatori’. Essi metteranno il loro denaro in banca in modo tale da ricevere una somma di denaro maggiore rispetto a quella che vi hanno depositato. Chi invece chiede un prestito, lo riceverà solo a patto di disporre di più, rispetto alla somma di denaro richiesta: se, in tal modo, fallirà (non potendo restituire il denaro erogatogli dalla banca), il banchiere ci avrà comunque guadagnato (gli confischerà infatti la ‘garanzia’ grazie alla quale è riuscito ad ottenere il prestito). Un banchiere che prestava ad un sovrano del denaro con cui fare una guerra, otteneva in cambio da esso soprattutto delle terre nel caso in cui la guerra non andasse a buon porto (il monarca, viceversa, in caso di vittoria, avrebbe praticamente ‘depredato’ la somma da restituire al banchiere con, in più, gli annessi interessi). Ora, teoricamente, il banchiere avrebbe potuto anche ‘svendere’ le suddette terre del re, ma ci avrebbe comunque guadagnato (proprio in quanto il valore di esse era comunque maggiore rispetto al prestito erogato al re). Ma il problema (sempre a livello teorico) è che, nel medioevo, chi avrebbe comprato la terra era per lo più un mercante (gli aristocratici non si interessavano infatti molto di ‘compravendite’). E in un’economia di tipo corporativo, non è che il mercante poteva acquisire tutto ciò che voleva (a suo piacimento): era anzi economicamente soggetto (lo si è, perlomeno in parte, visto) a molti vincoli. Ecco, allora, che, come contraccambio dei prestiti ai monarchi, i banchieri iniziano a richiedere, innanzitutto, inizialmente, l’ ‘allentamento della maglie’ del corporativismo: l’economia tenderà quindi a liberalizzarsi progressivamente; già agli inizi dell’età moderna l’attività mercantile-imprenditoriale si sarà marcatamente liberalizzata, perlomeno rispetto all’età comunale.
Chiedono poi al monarca più tolleranza nei confronti di chi esprimeva idee economicamente più liberiste rispetto a quelle in voga durante il medioevo, esprimendo inoltre (annessamente) idee moralmente più libertarie ed egoistiche (e dunque affaristiche) rispetto a quelle dell’allora dominante cultura (di tipo anche e soprattutto scolastico, e quindi ecclesiastico): ciò segna la nascita del protestantesimo e la sua progressiva affermazione, sempre nel corso dell’età moderna. Chiedono inoltre, sempre ai monarchi, che la scienza (e con essa, più o meno indirettamente, che la tecnica) possa venire sviluppata: se già durante il medioevo alcuni scolastici vengono così lasciati liberi di prodigarsi per la sua nascita, con l’avvento dell’età moderna i personaggi che tenderanno a farla sorgere saranno molti (vari filosofi rinascimentali, che, non casualmente, si interesseranno molto alla ‘magia’). La tecnologia è infatti utile soprattutto al borghese (le ‘scoperte mediche’, ad esempio e in primo luogo, sono invece utili per tutti): serve infatti, principalmente, ad ottimizzare sempre più le sue attività, in modo tale da veder aumentati i suoi introiti valutari. Incitano infine i monarchi a promuovere nuove scoperte geografiche (in Inghilterra, ad esempio, ciò avvenne circa un secolo prima dei tempi dei viaggi di Colombo). Anche i banchieri, ovviamente, ben conoscevano il fenomeno (in particolare) del colonialismo greco, e ben sapevano che il colonialismo arricchisce, prima di tutto, i borghesi, cui infatti veniva assegnato il compito di controllare le risorse che scoprivano, che trovavano, nelle colonie.
Insomma, l’impulso disgregatore del medioevo giunge in primo luogo dal mondo della finanza (prescindendo da essa, dunque dal suo ‘ruolo storico’ così come lo si è descritto e definito fino ad ora, non si potrebbe individuare – perlomeno a mio parere – altro tipo di ‘motore storico’ della ‘modernità’, nel suo continuo o ininterrotto ‘sviluppo’): la finanza è comunque in dialettico contrasto (sia pure latentemente) con i monarchi, ancora di più lo è con le aristocrazie subalterne ai sovrani (soprattutto in quanto ‘non producono moneta’), massimamente lo è nei confronti della Chiesa, della sua cultura (come si vide) ‘ragionevole’ (o ‘di buon senso’), ossia ‘oggettivistica’ (che sarà dunque soggetta ad un progressivo sfaldamento ‘soggettivistico’, e dunque ‘egoistico’). E la Chiesa fu avversa (lo si è visto) sia al progresso conoscitivo che alla mobilità sociale (e dunque all’evoluzione – o per meglio dire allo ‘sviluppo’ – di tipo storico in senso – se non propriamente ‘progressista’ – comunque ‘moderno’: mi sto riferendo quindi ai mutamenti storci che si sono verificati fino ad oggi, fino ‘ai nostri giorni’). In un momento successivo la finanza promuove il protezionismo delle industrie nazionali (dunque la creazione di ristrette oligarchie industriali nazionali) da parte di una certa monarchia. Svolgendo un discorso (per comodità espositiva) astratto e schematico, è in tal modo, infatti, che i prezzi si innalzano e di lavoro se ne crea, tutto sommato, poco: la concentrazione di grandi capitali nelle mani di ‘pochi’, distrugge innanzitutto il ceto medio (medio-piccolo e medio-alto). Ma una società senza ceto medio non può ‘tenersi in piedi’ (essendo destinata a disgregarsi).
A questo punto va da sé che, se un ipotetico sovrano non vuole, nel peggiore dei casi, addirittura, perire, deve concedere almeno che l’economia venga liberalizzata. In tal modo i prezzi si abbassano e si creano molti nuovi posti di lavoro (il lavoratore, ora, ‘se la passa bene’, o diciamo pure ‘decentemente’: và ora a costituire il ‘ceto medio-piccolo’. Il ceto medio-alto è invece costituito dai tanti ‘piccoli imprenditori’ che sono sorti). Il denaro, prima concentrato quindi nelle mani di pochi, ora si è distribuito nelle mani di una maggiore fetta di popolazione rispetto, dunque, alla (economicamente protezionistica) situazione di partenza. Ebbene, la società che in tal modo si è costituita, potrebbe anche perpetuarsi in modo duraturo. E in questa società ipotetica vige – mettiamo – il ‘voto censitario’ (ovvero la ‘parassitaria’ aristocrazia – oltreché il monarca – in essa hanno ancora ‘voce in capitolo’): la monarchia è di tipo ‘costituzionale’. Ma questo ‘ai banchieri’ non basta. Dall’aristocrazia non ricevono infatti ‘il becco di un quattrino’ (e il ‘puro banchiere’ è interessato a trattare unicamente ‘denaro’, non essendo interessato a possedere altro). Bisogna creare una ‘repubblica’. Solo così il parassitario ceto aristocratico non avrà più voce in capitolo e l’intera agricoltura verrà industrializzata (o ‘imborghesita’ – mi si passi l’espressione). Si è detto, infatti, che il banchiere accumula capitale monetario solo con la borghesia. Ecco allora che la finanza escogita la ‘sinistra borghese’ (cui ci si è sopra riferiti) quale mezzo per ottenere – prima o poi – un regime repubblicano (quindi – in altre parole – un sistema politico a economia ‘totalmente borghese’).
Le parole d’ordine della sinistra liberale più radicale sono le seguenti: ‘libertà di parola e di stampa’ (il che non corrisponde ad altro che alla possibilità di ‘propagandare’ la ‘mera ideologia’ della sinistra borghese), suffragio universale, divisione dei poteri, garantismo, libertà di associazione (con la creazione di sindacati, di cooperative agricole e industriali, di banche popolari, di società di mutuo soccorso), progressismo, ma anche nazionalismo o (in alternativa) federalismo (assieme però, in entrambi i casi, al ‘pacifismo’). Agli antipodi della ‘sinistra borghese’ vi è la ‘sinistra comunista’, la quale, storicamente e nella sua purezza, presenta invece tali caratteri: livellante e piena statalizzazione dell’economia (sia agricola che industriale), concentrazione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario, propagandistico o ideologico, nelle mani di un leader, però ‘umanista’, ‘giustizialismo’, rivoluzione (anche nei confronti del leader se perde la sua ‘umanità’, divenendo un’ ‘animalesco egoista’ che inizia a curare soltanto i propri interessi), internazionalismo e (annesso) ‘centralismo democratico’. Anche la ‘sinistra comunista’ svolgerà, in pro delle banche, la sua funzione (ma ciò lo vedremo più avanti). Ovviamente, a ‘metà strada’, tra la pura sinistra borghese e quella ‘più puramente’ comunista, vi è il ‘socialismo’ nelle sue varie forme (laburismo, sandinismo, bolivarismo, nasserismo ecc.). Ma l’aspetto politico più rilevante condiviso dalle ‘due diverse sinistre’ è il seguente: ovvero l’aspirazione a fare una ‘riforma agraria’, ‘forzata’ per i comunisti, ‘remunerata’ per i liberali radicali. In una certa nazione non vige ancora il ‘diritto di sciopero’. Se dunque uno ‘scioperante’ verrà incarcerato, qualora i liberali più moderati di quella nazione abbiano già ottenuto una legge che impone il garantismo, a quel manifestante ‘non verrà torto’, in prigione, ‘neanche un capello’: il potere giudiziario è dunque già indipendente dai restanti poteri.
Attraverso una serie di efficaci scioperi, alla fine la prassi politica in questione diviene legale: ciò è possibile per via della separazione del ‘legislativo’ dai poteri rimanenti (a votare la legge sul diritto di sciopero è stato in particolare il partito – sia pure minoritario – che rappresenta in parlamento i ‘contestatori di piazza’). Grazie alla libertà di parola e di stampa, la ‘sinistra borghese’ è riuscita infine a convincere una grande fetta di elettori ad eleggerla quale partito di governo. Ed è grazie, in particolare, al ‘suffragio universale’ che ciò è stato possibile (avendo ‘preso molti voti’ anche da parte del popolo più subalterno, e proprio in virtù del ‘diritto di voto’ esteso all’intera nazione). A coronamento di varie riforme liberali di sinistra (che hanno fatto progredire man mano la nazione), ecco che giunge quella più importante: attuare una riforma agraria ‘totale’ che spazzi via definitivamente, che liquidi definitivamente, il ceto aristocratico dell’ipotetica nazione cui ci si sta riferendo. Tutte le terre nobiliari vengono comperate da chi ora governa, e vengono ridotte in piccole e in più grandi proprietà agricole, da sfruttare e gestire però (perlomeno queste ultime) ‘imprenditorialmente’, e da parte di chi le ha ricevute gratuitamente (o a prezzi vantaggiosissimi). Portandoci per un momento al concreto, nel secondo dopoguerra, parte dei fondi del Piano Marshall vennero destinati alla compera di terre nobiliari (presso tutte le repubbliche liberaldemocratiche formatesi quindi nel secondo dopoguerra). E i più piccoli appezzamenti verranno (in un secondo momento) unificati, andando a creare delle ‘industrializzate’ cooperative agricole (a gestione quindi ‘borghese’, ‘capitalistica’ o ‘imprenditoriale’ che dir si voglia). Ora, la propaganda di ‘nuove idee’ (quindi ‘moderne’), quali (innanzitutto) il suffragio universale e la divisione dei poteri, costituiscono gli aspetti politici (quelli però principali, non, dunque, i soli) che hanno reso il vecchio mondo regale-aristocratico del tutto indesiderabile e obsoleto: le società del secondo dopoguerra sono state (in tempi relativamente brevi) completamente industrializzate (e, con ciò, sono state rese appetibili a tutto il popolo). Ciò a cui dunque l’altissima finanza aspirava, si è ora realizzato (anche se non ‘completamente’: tuttavia, con il passare del tempo, si ‘progredirà’ ulteriormente e sempre di più).
Il liberalismo radicale è nazionalista: il provare dei ‘sentimenti’ (il che non corrisponde ad essere dei superficiali ‘sentimentalisti’) viene rivolto primariamente alla propria famiglia, secondariamente ai propri compatrioti o connazionali: con le nazioni straniere si stabiliranno tutt’al’più relazioni di pacifica coabitazione. Tale il ‘nazionalismo’, se però considerato nella sua ‘purezza’ concettuale (nella sua più appropriata ‘definizione’). Ma si disse che la summenzionata tendenza politica può anche essere federalista: i propri ‘sentimenti’ verranno riservati (anche in tal caso) innanzitutto alla propria famiglia, poi ai propri corregionali: una maggiore noncuranza viene tuttavia rivolta alla restante popolazione dell’ipotetica nazione federalista cui ci si sta (astrattamente) riferendo. Ciò, a livello politico, corrisponde al seguire una linea politica piuttosto egoistica da parte di un comprensorio di uno stato federalista. E così, ad esempio, tra le autonomie di cui gode una certa regione, vi è quella di decidere – disponendo quindi, detta regione, di un certo grado di libertà – la linea economica da seguire (a livello regionale quindi). Oppure, si desidera che le proprie tasse vadano a finire nelle casse dello stato federalista solo entro certi limiti (in base a tale principio: ciò che, in virtù di una mia libera iniziativa economica, mi sono guadagnato, deve restare soprattutto nelle mie mani).
Vedremo più avanti come tale tipo di ‘Humanitas’, tendente, per così dire, all’ ‘individualismo’ (o ‘mescolata, amalgamata, con l’egoismo’ – mi si passi la formula), convenga, se applicata in alcuni contesti, all’altissima finanza globale. Per il momento mi limiterò a dire come l’ ‘internazionalismo’ sia ‘umano’ nel modo più pieno, contrapponendosi dunque, in larga misura, agli ideali nazionalistici e federalistici. E l’internazionalismo si lega alla pratica politica del ‘centralismo democratico’. Se gli ideali internazionalistici emergerebbero già nella Bibbia (perlomeno nel Pentateuco, in quanto nelle rimanenti parti di essa emerge anche una morale di tipo aristocratico più o meno pura), essi emergerebbero anche nei Vangeli (i quali sono, tuttavia, moralmente ‘nonviolenti’ rispetto ad alcune usanze bibliche, precedenti, com’è ovvio, rispetto ai dunque ‘più miti’ costumi evangelici). Gesù che afferma (ad esempio e in primo luogo) di voler ‘separare i padri dai figli’ (ecc.), vuole assai probabilmente contrapporsi al ‘familismo’. L’ ‘internazionalista’ può inoltre sentirsi più vicino a un indigente nero della sfruttatissima Africa, piuttosto che a un proprio ricco conterraneo. Ma anche il ‘sacrosanto’ (perlomeno a mio parere) internazionalismo (‘terzomondista’ nell’esempio appena svolto), non sfugge dal venire sfruttato delle grandissime banche: persino esso può favorirle, se applicato in certi contesti. Parlando dell’ ‘altrettanto sacrosanto’ (sempre a mio parere) ‘centralismo democratico’, ecco in cosa pressappoco consiste: ogni comprensorio di una nazione deve essere costretto a sfruttare quelle sole risorse di cui dispone, senza avventurarsi in iniziative private dettate da decisioni prese in autonomia (che potrebbero, fra l’altro, lì per lì favorirlo, ma che, più o meno a lungo termine, potrebbero anche arrecare svantaggio). E la tassazione di uno ‘stato centralista’ deve essere tale: le regioni, per così dire, ‘più fortunate’ vanno tassate maggiormente rispetto alle restanti. Ma non solo: alle regioni più bisognose và destinato maggior denaro rispetto alle rimanenti. Insomma, una ‘democrazia centralista’ promuove e produce un’equa ed equilibrata distribuzione di beni all’interno di una nazione.
Se fino ad adesso mi sono riferito ad ipotetiche e generiche situazioni politiche, farò ora riferimento al concreto, esaminando quattro realtà politiche in cui era necessario che il mondo inattivo, parassitario, improduttivo (anche e soprattutto di denaro), eppure numericamente piuttosto ampio nonché alquanto possidente dell’aristocrazia, venisse meno. Negli Stati Uniti la rivoluzione aveva ‘spazzato via’ (anche per averlo, a rivoluzione compiuta, ‘messo al bando’) l’intero ceto aristocratico (inglese) residente in America. A rivoluzione compiuta venne instaurata una repubblica (per così dire, ‘a tutti gli effetti’) in cui l’agricoltura, anche se per lo più schiavistica, veniva però gestita con metodi manageriali. Inoltre l’America è sia vastissima che ricca ‘di ogni ben di Dio’ (anche ‘alimentare’). Non si aveva dunque nessun interesse affinché in essa fiorisse e attecchisse (se non altro ‘più del dovuto’) una ‘sinistra’ (qualsiasi ne fosse la tipologia). Le sue crisi sociali venivano dunque risolte soprattutto da un’opposizione ‘liberal’ moderata.  Tale grande nazione era in origine ultraprotezionista e (‘di fatto’) fortemente (presentando addirittura alcuni tratti autoritari) ‘centralistica’ (anche se, esteriormente, era – lo è tutt’ora – una federazione di stati, così come, del resto, sempre esteriormente, lo era l’Urss, anche – e soprattutto – ai tempi di Stalin). Ma, ad essere precisi, l’estesissimo paese era ‘economicamente’ centralista: si liberalizzerà però sempre più (se non altro fino ai tempi di F. D. Roosevelt). Nel caso invece dell’Inghilterra ai tempi della ‘seconda rivoluzione industriale’, nonostante in essa già vigesse un’economia piuttosto concorrenziale, abbastanza liberista, non ci si era tuttavia ancora liberati della sua influente aristocrazia (da nazione monarchico-costituzionale che era l’Inghilterra. E anche se lo è tutt’ora, lo è solo ‘nominalmente’, essendo ‘di fatto’ un paese industrializzato e democratico a tutti gli effetti). L’aristocrazia faceva dunque ‘circolare poco denaro’. Coloro che riuscirono a sfruttare le innovazioni tecnologiche nei processi di produzione (dunque quelle imprese che erano già le più abbienti), guadagnarono ingenti quantità di denaro. Anche in tal caso, la grande concentrazione di capitali nelle mani di poche industrie, non poteva che venire risolto in una qualche maniera, onde evitare un’esplosione sociale che avrebbe abbattuto la monarchia (sia pure quindi ‘parlamentare’) britannica.Ebbene, contrariamente a ciò che si verificò in America, c’era interesse che fossero dei ‘laburisti’ a dare avvio ad un processo di equa redistribuzione della ricchezza (ora concentrata quindi nelle mani di pochissimi) fra la popolazione britannica. L’ ‘ideologia’ spregiudicatamente progressista delle ‘Trade Unions’ avrebbe preso, man mano, sempre più piede (con i laburisti che diverranno addirittura ‘partito di governo’, però in una ‘politica di alternanza’), fino a rendere l’Inghilterra un paese interamente industrializzato e moderno, in cui attualmente l’essere aristocratici si riduce al rivestire una carica meramente onorifica (priva dunque di consistenti poteri politici, nonché sprovvista di rilevante peso economico).
Tale grande nazione era in origine ultraprotezionista e (‘di fatto’) fortemente (presentando addirittura alcuni tratti autoritari) ‘centralistica’ (anche se, esteriormente, era – lo è tutt’ora – una federazione di stati, così come, del resto, sempre esteriormente, lo era l’Urss, anche – e soprattutto – ai tempi di Stalin). Ma, ad essere precisi, l’estesissimo paese era ‘economicamente’ centralista: si liberalizzerà però sempre più (se non altro fino ai tempi di F. D. Roosevelt). Nel caso invece dell’Inghilterra ai tempi della ‘seconda rivoluzione industriale’, nonostante in essa già vigesse un’economia piuttosto concorrenziale, abbastanza liberista, non ci si era tuttavia ancora liberati della sua influente aristocrazia (da nazione monarchico-costituzionale che era l’Inghilterra. E anche se lo è tutt’ora, lo è solo ‘nominalmente’, essendo ‘di fatto’ un paese industrializzato e democratico a tutti gli effetti). L’aristocrazia faceva dunque ‘circolare poco denaro’. Coloro che riuscirono a sfruttare le innovazioni tecnologiche nei processi di produzione (dunque quelle imprese che erano già le più abbienti), guadagnarono ingenti quantità di denaro. Anche in tal caso, la grande concentrazione di capitali nelle mani di poche industrie, non poteva che venire risolto in una qualche maniera, onde evitare un’esplosione sociale che avrebbe abbattuto la monarchia (sia pure quindi ‘parlamentare’) britannica.Ebbene, contrariamente a ciò che si verificò in America, c’era interesse che fossero dei ‘laburisti’ a dare avvio ad un processo di equa redistribuzione della ricchezza (ora concentrata quindi nelle mani di pochissimi) fra la popolazione britannica. L’ ‘ideologia’ spregiudicatamente progressista delle ‘Trade Unions’ avrebbe preso, man mano, sempre più piede (con i laburisti che diverranno addirittura ‘partito di governo’, però in una ‘politica di alternanza’), fino a rendere l’Inghilterra un paese interamente industrializzato e moderno, in cui attualmente l’essere aristocratici si riduce al rivestire una carica meramente onorifica (priva dunque di consistenti poteri politici, nonché sprovvista di rilevante peso economico).
(continua…)
Umberto Petrongari