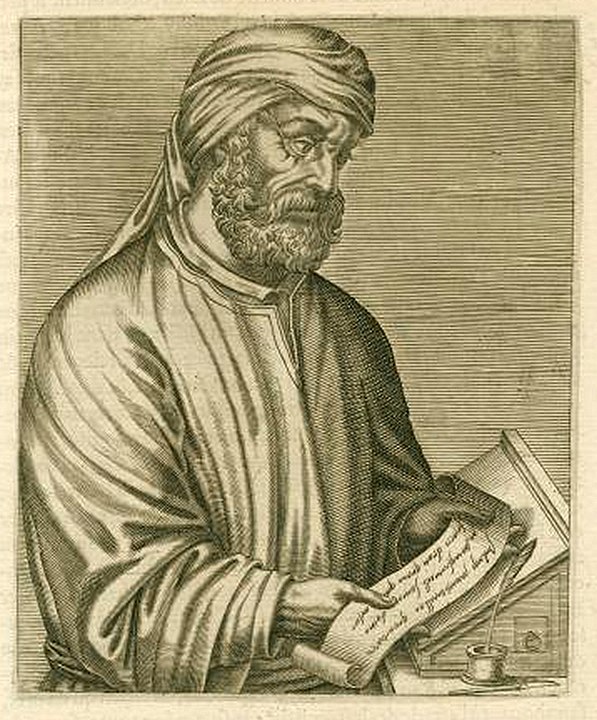“C’erano tre uomini che venivano da occidente, per tentare la fortuna / e questi tre uomini fecero un solenne voto / John Barleycorndeve morire (…) Loro avevano assoldato uomini con falci veramente affilate per tagliargli via le gambe / l’avevano avvolto e legato tutto attorno, trattandolo nel modo più brutale /avevano assoldato uomini con i loro forconi affilati che avevano conficcato nel [suo] cuore (…)Assoldarono uomini con bastoni uncinati per strappargli via la pelle dalle ossa / e il mugnaio lo trattò peggio di così / perché lo pressò tra due pietre (…)”
Le strofe sopra riportate sono tratte da una celebre ballata anglosassone che evoca la morte di John Barleycorn, incarnazione dello spirito dell’orzo destinato alla distillazione. Una raccolta folklorica del Seicento ripescò la lirica dalla tradizione orale del Medio Evo, ma tutto fa pensare a un’origine ben più antica. E non dubito che gli amanti del rock abbiano già fatto i debiti collegamenti con l’indimenticabile “John Barleycorn Must Die” dei Traffic (1970), non tralasciando naturalmente le versioni di SteeleyeSpan, Martin Carthy, John Renbourn ed altri. Il testo della canzone riassume le fasi di una remota usanza diffusa fino al secolo scorso in alcune zone agricole della Scozia e del Devonshire. Il mietitore che finiva per ultimo di lavorare nel giorno del solstizio d’estate veniva legato e addobbato come un covone (proprio come nei disegni tradizionali di John Barleycorn) prima di essere simbolicamente ucciso con brutalità dai suoi compagni. Il taglio delle gambe rappresentava il culmine del sacrificio ed era accompagnato dalle grida rituali degli altri mietitori, che dovevano essere sentite a miglia di distanza (fino alle orecchie degli dèi) per annunciare ai quattro venti il compimento della missione. Anche per quell’anno, il patto era stato rispettato. Ora non è un caso che nella versione del poeta scozzese Burns ((1759-1796) si parli apertamente di «bere il sangue di John Barleycorn», che è uno Spirito della vegetazione, poiché «bere o mangiare il dio» per acquisirne la forza equivaleva nelle civiltà contadine dell’antichità a potenziare la fertilità dei campi, ossia ad avere buoni raccolti per la propria famiglia e la propria comunità. Il rituale potrebbe essere il retaggio di qualche «raduno sacro»infrannuale celebrato dai Celti nelle radure delle allora vaste foreste europee, dove i druidi pronunciavano formule ancestrali alla luce dei fuochi mentre le loro voci, coperte dalle note di canti e musica, rivelavano verità immutabili nell’intreccio di tele mitologiche. Gli invasori Romani non capirono mai bene il significato profondo di simili celebrazioni, e a scopo prevalentemente denigratorio fecero molte chiacchiere su certe pratiche sanguinarie che sarebbero state in uso presso le tribù celtiche.Giulio Cesare (De Bello Gallico, VI, 16) confermò i pettegolezzi attraverso la descrizione del sacrificio umano realizzato dai druidi mediante il rogo di un’enorme figura di vimini riempita di uomini «offerti» agli dèi per il bene della collettività. Ma «dimenticò» di aggiungere che si trattava di casi rarissimi,e neppure si degnò di risalire alle radici di un’usanza proveniente dall’abisso dei tempi.
Nonostante le numerose ricerche sul campo, sono insignificanti le prove archeologiche capaci di confermare la pratica del sacrificio umano in seno a quella che viene definita l’«ultima Razza dello Spirito». Nella logica di “una vita in cambio di una vita”, è possibile tuttavia che il cruento gesto rituale si sia reso necessario in casi eccezionali per rafforzare la richiesta del gruppo davanti alla divinità. Le vittime erano di solito prigionieri di guerra o malfattori, ma molte volte si trattava di appartenenti alla classe druidica che offrivano se stessi per il rituale di morte. Un dono che ben s’inserisce nella mentalità di sprezzo del pericolo e assenza di paura tipica delle genti celtiche.
Dal sublime al superstizioso
Nella logica della conservazione attardata di un rito sicuramente indoeuropeo, i sacrifici umani in Eurasia erano rari e corrispondevano a una richiesta di aiuto al dio per affrontare problemi di vitale importanza quali, ad esempio, un’annata agricola disastrosa o un esercito impari di forze. Alcuni popoli vi rinunciarono prima mentre altri, come ad esempio i Balti, seguitarono a celebrarli fino al Medioevo. Nelle terre fredde del nord sferzate sovente dalla neve, al termine di una battaglia i vincitori legavano come un salame il prigioniero più grande e grosso, gli ficcavano la testa tra le ginocchia, aprivano con la spada la sua schiena e,dopo avergli tirato fuori le scapole a mo’ di ali, esaminavano il getto del sangue che colava giù per colonna vertebrale cercando di divinare il «risultato della guerra».
 Anche i Greci sacrificavano giovani vergini prima della battaglia e, in caso di calamità, lapidavano a morte un mendicante trascinandolo fuori dalle mura dopo averlo nutrito e vestito sontuosamente per un anno. Credevano ingenuamente di potersi disfare delle proprie sventure insieme al poveraccio. Per favorire la partenza verso Troia della flotta bloccata da una persistente bonaccia, Agamennone giunse al punto di offrire la figlia Ifigenia. Il pietoso intervento degli dèi impedì la realizzazione del progetto, ma fu un salvataggio tra centinaia di altre stragi andate a buon fine. A quell’epoca non era infrequente il ricorso al sacrificio umano finalizzato alla «salvezza» della comunità, del regno, della guerra, della stirpe. Omero stesso non ne fece mistero. Achille uccise dodici giovani Troiani presso la pira di Patroclo e il fatto che quei giovani venissero immolati in occasione di un funerale mostra il carattere sacrificale, e non militare, dell’offerta. Non si trattava di una crudeltà bellica bensì di un rituale religioso. Sono noti anche i sacrifici dei discendenti di Atamantesul Monte Liceo. In caso di grave carestia «il dono» era spesso lo stesso re, o uno dei suoi figli, poiché il responsabile del tempo atmosferico e dei raccolti era il sovrano, che doveva pagare con la vita l’inclemenza dell’uno o la scarsità degli altri. Ancora nel VI secolo, cioè in piena età storica, nelle colonie ioniche dell’Asia Minore si celebravano sacrifici annuali pubblici a carattere purificatorio in cui la vittima (sempre meno consenziente) era un essere umano. Diffusi in tutta l’area mediterranea erano anche i culti del «re sacro» in cui il vecchio re veniva ucciso per far posto ad un giovane sovrano che doveva rappresentare la fecondità del popolo con la sua forza e la sua salute. In memoria del sacrificio originario del Gigante antropocosmico, il corpo del defunto veniva poi sottoposto allo smembramento rituale, e talvolta le sue carni finivano in pentola. Sacrifici umani erano praticati anche dai Persiani. E’ noto che il re Serse fece seppellire vivi nove giovani traci per propiziare il successo della sua campagna militare contro la Grecia, mentre la moglie Amestri sacrificava quattordici ragazzi di nobile stirpe a un dio sotterraneo.
Anche i Greci sacrificavano giovani vergini prima della battaglia e, in caso di calamità, lapidavano a morte un mendicante trascinandolo fuori dalle mura dopo averlo nutrito e vestito sontuosamente per un anno. Credevano ingenuamente di potersi disfare delle proprie sventure insieme al poveraccio. Per favorire la partenza verso Troia della flotta bloccata da una persistente bonaccia, Agamennone giunse al punto di offrire la figlia Ifigenia. Il pietoso intervento degli dèi impedì la realizzazione del progetto, ma fu un salvataggio tra centinaia di altre stragi andate a buon fine. A quell’epoca non era infrequente il ricorso al sacrificio umano finalizzato alla «salvezza» della comunità, del regno, della guerra, della stirpe. Omero stesso non ne fece mistero. Achille uccise dodici giovani Troiani presso la pira di Patroclo e il fatto che quei giovani venissero immolati in occasione di un funerale mostra il carattere sacrificale, e non militare, dell’offerta. Non si trattava di una crudeltà bellica bensì di un rituale religioso. Sono noti anche i sacrifici dei discendenti di Atamantesul Monte Liceo. In caso di grave carestia «il dono» era spesso lo stesso re, o uno dei suoi figli, poiché il responsabile del tempo atmosferico e dei raccolti era il sovrano, che doveva pagare con la vita l’inclemenza dell’uno o la scarsità degli altri. Ancora nel VI secolo, cioè in piena età storica, nelle colonie ioniche dell’Asia Minore si celebravano sacrifici annuali pubblici a carattere purificatorio in cui la vittima (sempre meno consenziente) era un essere umano. Diffusi in tutta l’area mediterranea erano anche i culti del «re sacro» in cui il vecchio re veniva ucciso per far posto ad un giovane sovrano che doveva rappresentare la fecondità del popolo con la sua forza e la sua salute. In memoria del sacrificio originario del Gigante antropocosmico, il corpo del defunto veniva poi sottoposto allo smembramento rituale, e talvolta le sue carni finivano in pentola. Sacrifici umani erano praticati anche dai Persiani. E’ noto che il re Serse fece seppellire vivi nove giovani traci per propiziare il successo della sua campagna militare contro la Grecia, mentre la moglie Amestri sacrificava quattordici ragazzi di nobile stirpe a un dio sotterraneo.
Nella terra dominata da Yahweh vigeva invece il precetto sulla consegna dei primogeniti finalizzato al loro utilizzo nei sacrifici. Il Signore se li faceva consegnare quando avevano otto giorni, esattamente come i cuccioli degli altri animali, e pretendeva che fossero bruciati per lui, come afferma egli stesso in Ezechiele. L’odore di affumicato sprigionato dalle carni da latte gli rilassava i nervi. Naturalmente la dottrina non ha mai accettato questa versione dei fatti e il dibattito filologico sul termine ebraico nichoach[odore del riposo, o riposo della cenere?] è tuttora in corso, nonché oggetto di accesi dibattiti. Tuttavia i sacrifici umani nella società ebraica delle origini erano presenti e proseguirono almeno fino al 622 a.C., altrimenti il re Giosia non avrebbe avuto bisogno di varare una riforma che imponeva di sostituire ai neonati gli agnelli, premurandosi nel contempo di cancellare il ricordo delle pratiche precedenti.
La Roma imperiale avvolse i suoi sacrifici in un alone d’imbarazzata segretezza. Ciò nonostante Plutarco cita, nell’atmosfera di terrore determinata dall’invasione dei Galli Insubri, il sacrificio di vittime umane per propiziarsi gli dèi. Calando un velo pietoso sullo spettacolo del Circo, con i gladiatori che si massacravano a vicenda o venivano fatti sbranare da fiere affamate per divertire il pubblico. Anche per i Germani la «più bella delle vittime» era l’uomo. E se qualcuno crede che gli orientali fossero estranei a certe usanze, sappia che si sbaglia. Vero è che a una prima occhiata l’India narrata dal Rigveda sembra essere lontana dalle pratiche cruente, ma non bisogna dimenticare che i figli dell’Eurasia escono tutti dalla medesima matrice culturale. E difatti in Aitareya-Brahmanasi afferma il principio secondo cui «la prima e la migliore delle vittime sacrificali è l’uomo». Come surrogati si potevano accettare, in ordine decrescente: il cavallo, il bove, la pecora e la capra. I riti a base di sangue presenti nella civiltà indoaria si estesero fino alla potente casta sacerdotale dei Magi, il cui nome era già appartenuto a una tribù dei Medi, che fin dal suo esordio si distinse per il sangue, cioè per l’atto di uccidere. Un’inclinazione che a quei tempi non aveva uguali né in Egitto né in Grecia. Narrava Erodoto che l’atto sacrificale con spargimento di sangue era per i Magi l’azione suprema. Il celebrante uccideva con le sue mani qualunque creatura vivente, tranne il cane e l’uomo. Allo squartamento delle carni seguiva la cottura, dopo di che s’intonava il canto che evocava «la nascita degli dèi, come loro dicono che sia avvenuta».
Idee da esportazione
In sintesi le cose sono andate così per parecchio tempo, procedendo di male in peggio. Ma forse è inevitabile che allontanandosi dall’Origine le paure umane (in primis quella della morte) diventino sentimenti terrificanti capaci di generare a loro volta dei mostri orrendi. Non fece eccezione il sacrificio umano, che da azione rara e finalizzata alla sopravvivenza del gruppo si trasformò gradualmente in una sanguinosa catena di montaggio a cui non furono estranee le superstizioni, né le perversioni. Per millenni il sangue umano fu ritenuto l’espressione massima del vincolo eterno che legava l’uomo a dio. Anche i pitagorici lo consideravano «la sede dell’anima», che cominciando dal cuore giungeva al cervello. Mentre i ragionamenti, invisibili come l’etere, erano da ritenersi i «respiri dell’anima». Ad un certo punto, però, si cominciò a credere che la divinità reclamasse tutta per sé la «parte migliore dell’uomo» e che questi fosse tenuto a fargliene dono. Non «a gratis», s’intende, ma in cambio di qualcosa. I sacerdoti preposti al rito s’ingegnarono così per velocizzare la «restituzione dell’anima» e facilitare il ricongiungimento famigliare di uomini e dèi. Ma se il tempo presenta una successione di stati degeneri, figurarsi cosa può succedere quando un’idea viene esportata in contesti culturali e ambientali lontanissimi da quelli che l’hanno vista nascere. Una circostanza inevitabile, visto che l’uomo sedentario è solo un intermezzo tra due poli in movimento. Gli spostamenti furono particolarmente intensi nel periodo che chiuse l’ultima Era Glaciale. Un’epoca tribolata, come rivelano le cicatrici geologiche impresse sulla scorza coriacea della Terra. Dopo tre episodi di temporaneo raffreddamento, detti Dryas, attorno agli 8mila anni fa venne una fase climatica piuttosto calda. Crollò definitivamente anche la Laurentide, cioè la calotta glaciale posta a nord-est del Canada, l’ultima a sparire dalla faccia della Terra, e i livelli marini salirono addirittura di 25 metri in poche centinaia d’anni. Per completare l’opera di riassetto dell’emisfero settentrionale, una formazione rocciosa grande quanto l’Islanda si staccò dalla costa della Norvegia tra Bergen e Trondheim, scivolando nelle profondità marine. Onde alte venti metri s’infransero sulle coste dell’arcipelago, distruggendo buona parte delle terre nordatlantiche. Tra le tante terre colpite vi fu anche una vittima eccellente: la «Siria primitiva» o «terra solare» messa da Omero «al di là di Ogigia», a sua volta collocata da Plutarco “a cinque giorni di navigazione dalla Britannia, in direzione occidente … più oltre si trovano altre isole, poi c’è il grande continente che circonda l’oceano … dove il sole in estate su un arco di trenta giorni scompare alla vista per meno di un’ora per notte, anche se con tenebra breve, mentre un crepuscolo balugina ad occidente.” In realtà «Ogigia» è un aggettivo, come riconobbe Wilamowitz, che significa «primordiale». Storicamente parlando, ci troviamo dunque nella dimensione a-temporale che precedette la Storia. Dal punto di vista geografico, siamo invece sul tetto del mondo. Presumibilmente in prossimità di un’isola nordatlantica sparsa tra le Fær Øer, comprese nel Paleolitico Superiore in una vasta area di terre emerse che si stendeva tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia.
Da Tula all’eternità
In lingua sanscrita la «terra siria»veniva chiamata Varahi, dalla radice var, o vri, che ha il significato di «coprire», «proteggere», «nascondere». Cosa? Probabilmente le conoscenze superiori appartenute ai Padri fondatori, cioè un sapere capace di difendere il mondo con la sua influenza invisibile. Da chi? Dai barbari delle generazioni successive e dal declino della Storia. Il termine «terra siria» andrebbe esteso dunque alle «colonie» nordatlantiche messe sotto chiave da generazioni di iniziati allo scopo di salvare il salvabile. Ne consegue che le «terre», o isole, erano più d’una, nonostante gli Antichi ritenessero che la sola «fatta a immagine e somiglianza del Centro Primordiale» fosse la mitica Tula, o Thule iperborea. A una colonia nordatlantica ritenuta una tarda immagine del Centro Spirituale polare alluderàanche la cultura ellenica,che tramandò fino a noi il mito dell’isola leggendaria degli Iperborei, gli uomini che abitavano “al di là del vento del Nord”.Il nome «Iperborea»fu appunto un’idea dei Greci, i quali presero in prestito dalle lingue nordiche la radice del termine «cinghiale», che era bor, da cui -borea. Quando il loro mondo venne spazzato via dalla furia dell’oceano, i discendenti diuna civiltà che godeva da millenni di una consolidata tradizione navale cercarono una via di fuga in mare. Spostandosi dall’area islandese giunsero così in Groenlandia, per poi gettare l’ancora nell’isola di Anticosti, accesso all’attuale Grand Fleuve del Canada, un enorme specchio di cristallo verde che continua ad ispirare un sacro timore reverenziale. Da qui, costeggiare il Nordamerica per scendere fino al Messico era una strada tutta in discesa. Per secoli e secoli l’Islanda deve essere servita da «ponte» naturale,e chissà quante navi di solari «civilizzatori piumati» avranno lambito le sue coste, o si saranno infrante sulle sue scogliere, prima di proseguire verso l’ignoto o in direzione dell’Aldilà. Il ricordo di quelle scorribande marine si impresse a tal punto nella memoria degli aborigeni islandesi, che ancora oggi da quelle parti si crede che nei vulcani alberghino tutti gli spiriti e le ombre dei marinai annegati. Certi giorni le loro figure spettrali si presentano così ben definite da rendere impossibile distinguerle dai vivi. Ma purtroppo svaniscono prima che, incontrandole, si possa stringere loro la mano.
Sulla scia del sangue
Provenendo da un’isola vulcanica come l’Islanda, i navigatori nordici della preistoria avranno accolto come un vecchio amico il senso arcano che aleggiava sopra i coni fumanti del Sudamerica. Viste da lontano le vette incappucciate di neve del Popocatépetl e delloIztaccihuatl non erano poi tanto diverse dall’Eyjafjölle dal Vatnajökull, mentre il profumo di fresco che emanava dal verde ondulato steso ai loro piedi invogliava i visitatori nordici a restare.  Oggi la costruzione di Teotihuacan, Palenque, Tikal, Cahokia e Chaco Canyon viene attribuita con convinzione ai popoli toltechi, nei miti dei quali s’incontra appunto il ricordo nostalgico di una «patria primordiale» nordatlantica. Tuttora la comunità amerindia dei Kuna (o Guna), ridotta ormai a circa 40.000 unità, conserva nelle sue tradizioni il nome di Thule/Tula mentre sulla bandiera degli Indiani di San Blas sventola la swastica solare, da loro chiamata kikire interpretata come il simbolo della forza vitale. Proprio i Toltechi potrebbero avere esportato in Mesoamerica l’uso dei sacrifici umani, non immaginando certamente che le popolazioni amerinde avrebbero poi personalizzato il progetto, portandolo alle sue estreme conseguenze. Gli storici hanno calcolato che all’inizio del XVI secolo il numero delle vittime sacrificali in tutto l’impero azteco viaggiava al ritmo di circa duecentocinquantamila l’anno. Sembra che lo scopo di questa maniacale distruzione di vite umane fosse quello di preservare la vita del Quinto Sole, ritardando così la fine del mondo, già avvenuta quattro volte in precedenza. Interpretando in modo distorto chissà quale astruso concetto ereditato dai civilizzatori toltechi, gli Aztechi promuovevano in continuazione «guerre giuste» allo scopo di nutrire le divinità con il cuore e il sangue dei prigionieri. In effetti l’idea che l’uomo fosse il dono prediletto dagli dèi era presente tanto nella mentalità eurasiatica quanto in quella amerinda, ma il modo di realizzarla risultò completamente diverso perché nel frattempo le cosiddette «motivazioni spirituali» erano venute meno. Si racconta che Ahuitzotl, l’ottavo e più potente imperatore della dinastia azteca, “celebrò la consacrazione del tempio di Huitzilopochtli a Tenochitlán facendo condurre quattro file di prigionieri accanto a squadre di sacerdoti, le quali impiegarono quattro giorni per ucciderli. Quella volta, nel corso di un unico rito, furono trucidati in ben ottantamila”. A prescindere dal numero di squadre all’opera, fossero una, quattro o quaranta, ogni gruppo di sacrificatori era in grado di «trattare» una vittima più o meno ogni due minuti. C’erano sempre elementi imponderabili che in alcuni casi potevano far durare l’estrazione del cuore e la macellazione del resto qualche secondo in più o in meno, ma in media l’operazione richiedeva due minuti. Ne consegue che ogni squadra uccideva trenta vittime all’ora. Così si racconta, almeno. Ma per fare il verso a Manzoni: tra gente smaliziata si sa far la tara ai comunicati ufficiali. Se Giulio Cesare e i Romani si sperticarono per denigrare i popoli celti di Britannia che intendevano sottomettere e derubare della terra, i preti cristiani impegnati nella conversione di massa del Nuovo Mondo non furono da meno raccontando ogni sorta di nefandezze a carico dei «selvaggi» che pretendevano di catechizzare. Al primo posto ci furono naturalmente i popoli più avanzati, cioè gli Aztechi, che chiamavano loro stessi con il nome di «mexica», da cui il moderno nome di Messico.
Oggi la costruzione di Teotihuacan, Palenque, Tikal, Cahokia e Chaco Canyon viene attribuita con convinzione ai popoli toltechi, nei miti dei quali s’incontra appunto il ricordo nostalgico di una «patria primordiale» nordatlantica. Tuttora la comunità amerindia dei Kuna (o Guna), ridotta ormai a circa 40.000 unità, conserva nelle sue tradizioni il nome di Thule/Tula mentre sulla bandiera degli Indiani di San Blas sventola la swastica solare, da loro chiamata kikire interpretata come il simbolo della forza vitale. Proprio i Toltechi potrebbero avere esportato in Mesoamerica l’uso dei sacrifici umani, non immaginando certamente che le popolazioni amerinde avrebbero poi personalizzato il progetto, portandolo alle sue estreme conseguenze. Gli storici hanno calcolato che all’inizio del XVI secolo il numero delle vittime sacrificali in tutto l’impero azteco viaggiava al ritmo di circa duecentocinquantamila l’anno. Sembra che lo scopo di questa maniacale distruzione di vite umane fosse quello di preservare la vita del Quinto Sole, ritardando così la fine del mondo, già avvenuta quattro volte in precedenza. Interpretando in modo distorto chissà quale astruso concetto ereditato dai civilizzatori toltechi, gli Aztechi promuovevano in continuazione «guerre giuste» allo scopo di nutrire le divinità con il cuore e il sangue dei prigionieri. In effetti l’idea che l’uomo fosse il dono prediletto dagli dèi era presente tanto nella mentalità eurasiatica quanto in quella amerinda, ma il modo di realizzarla risultò completamente diverso perché nel frattempo le cosiddette «motivazioni spirituali» erano venute meno. Si racconta che Ahuitzotl, l’ottavo e più potente imperatore della dinastia azteca, “celebrò la consacrazione del tempio di Huitzilopochtli a Tenochitlán facendo condurre quattro file di prigionieri accanto a squadre di sacerdoti, le quali impiegarono quattro giorni per ucciderli. Quella volta, nel corso di un unico rito, furono trucidati in ben ottantamila”. A prescindere dal numero di squadre all’opera, fossero una, quattro o quaranta, ogni gruppo di sacrificatori era in grado di «trattare» una vittima più o meno ogni due minuti. C’erano sempre elementi imponderabili che in alcuni casi potevano far durare l’estrazione del cuore e la macellazione del resto qualche secondo in più o in meno, ma in media l’operazione richiedeva due minuti. Ne consegue che ogni squadra uccideva trenta vittime all’ora. Così si racconta, almeno. Ma per fare il verso a Manzoni: tra gente smaliziata si sa far la tara ai comunicati ufficiali. Se Giulio Cesare e i Romani si sperticarono per denigrare i popoli celti di Britannia che intendevano sottomettere e derubare della terra, i preti cristiani impegnati nella conversione di massa del Nuovo Mondo non furono da meno raccontando ogni sorta di nefandezze a carico dei «selvaggi» che pretendevano di catechizzare. Al primo posto ci furono naturalmente i popoli più avanzati, cioè gli Aztechi, che chiamavano loro stessi con il nome di «mexica», da cui il moderno nome di Messico.
Il fiero pasto
Non sempre ma abbastanza spesso, dopo l’estrazione del cuore gli amerindi mettevano «il resto» in pentola con cacao e peperoncino. Non che fossero dei buongustai che avevano scoperto la ricetta perfetta, visto che l’intento era quello di acquisire la forza dell’altro mangiandone le carni. Ma, se proprio bisognava … Memore della tradizione indoeuropea anche il prete «finge di mangiare» il corpo di Cristo in chiesa durante l’Eucarestia. E’ nota l’idea di «transustanziazione» con cui avverrebbe «la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo di Cristo, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del Suo Sangue». Per fortuna in questo caso non c’è alcun spargimento di sangue, ma neppure gli antropofagi rituali dell’antichità erano posseduti dall’aspetto malvagio del cannibalismo. Un uomo integro e originario come Kronos, il grande sciamano che vedeva nel futuro, non si sarebbe mai sognato di mettersi a mangiare i figli se non avesse saputo che un giorno la sua stessa prole lo avrebbe detronizzato, cancellando così l’antico mondo dalla faccia della Terra.  Zeus non mangiò per puro sfizio la prima moglie e il feto che portava in grembo, lo fece solo dopo aver saputo che Metis, dea dell’astuzia e dell’intelligenza, stava per dare alla luce il figlio che lo avrebbe spodestato, creando un nuovo mondo. In questo caso il vantaggio fu duplice: in un colpo solo il re dell’Olimpo scongiurò il pericolo della rivoluzione e inglobò le caratteristiche della consorte. Tuttavia i tempi erano molto cambiati dall’Era originaria di Kronos, la specie si era notevolmente indebolitae neppure gli dèi erano più quelli di una volta. Dopo il fiero pasto Zeus cominciò così a stare male. Venne chiamato Efesto, il fabbro divino la cui fucina si trovava nelle viscere dell’Etna, che con un colpo d’ascia gli aprì la testa dolente da cui Atena uscì fuori già adulta. Narrazioni dal forte significato iniziatico come quelle citate rivelano il più struggente dei desideri umani: radunare i pezzi sparsi, ricongiungersi all’androgino boreale, ripristinare l’unità primigenia. A questo scopo nella remota antichità ci si mangiava l’uno con l’altro, e fa specie che la nostalgia del femminino albergasse persino nell’animo di uomini-dèi bellicosi dediti all’arte della guerra. Nessun popolo si è mai cibato dei suoi simili per il semplice gusto di farlo. Sebbene non si possa escludere completamente la possibilità che durante i 100mila anni di gelo dell’ultima Era Glaciale il bisogno di acidi grassi omega-3 per il cervello, scarsamente rintracciabili in animali che non siano pesci, abbia spinto alcune tribù delle pianure e delle montagne verso il cannibalismo.
Zeus non mangiò per puro sfizio la prima moglie e il feto che portava in grembo, lo fece solo dopo aver saputo che Metis, dea dell’astuzia e dell’intelligenza, stava per dare alla luce il figlio che lo avrebbe spodestato, creando un nuovo mondo. In questo caso il vantaggio fu duplice: in un colpo solo il re dell’Olimpo scongiurò il pericolo della rivoluzione e inglobò le caratteristiche della consorte. Tuttavia i tempi erano molto cambiati dall’Era originaria di Kronos, la specie si era notevolmente indebolitae neppure gli dèi erano più quelli di una volta. Dopo il fiero pasto Zeus cominciò così a stare male. Venne chiamato Efesto, il fabbro divino la cui fucina si trovava nelle viscere dell’Etna, che con un colpo d’ascia gli aprì la testa dolente da cui Atena uscì fuori già adulta. Narrazioni dal forte significato iniziatico come quelle citate rivelano il più struggente dei desideri umani: radunare i pezzi sparsi, ricongiungersi all’androgino boreale, ripristinare l’unità primigenia. A questo scopo nella remota antichità ci si mangiava l’uno con l’altro, e fa specie che la nostalgia del femminino albergasse persino nell’animo di uomini-dèi bellicosi dediti all’arte della guerra. Nessun popolo si è mai cibato dei suoi simili per il semplice gusto di farlo. Sebbene non si possa escludere completamente la possibilità che durante i 100mila anni di gelo dell’ultima Era Glaciale il bisogno di acidi grassi omega-3 per il cervello, scarsamente rintracciabili in animali che non siano pesci, abbia spinto alcune tribù delle pianure e delle montagne verso il cannibalismo.
Nel sito di Cheddar, in Gran Bretagna, sono state rinvenute delle tazze-cranio che confermano l’usanza di mangiare carne umana con finalità rituale, non certamente alimentare. Si apprende da un racconto di Erodoto (II, 26) poi ripreso da Pomponio Mela (II, 29) che gli Issedoni, un popolo dislocato a nord degli Sciti, avevano la consuetudine di fare a pezzi i cadaveri dei genitori e di consumarli durante banchetti rituali insieme con carne di pecora, così da non perdere la loro «essenza». Nel nostro piccolo, anche noi diciamo a un bambino o a un amante “ti mangerei di baci”. Di fatto non c’è niente di più profondo, intimo e intenso che si possa esprimere nell’ambito dell’amore. E proprio per un travisato sentimento d’amore i nostri antenati finirono per mangiarsi a vicenda. Amavano dio, si amavano l’uno con l’altro, amavano la propria comunità. Forse amavano troppo, e comunque la necessità non c’entrava con i loro rituali a base di sangue. Notoriamente la nostra carne è di gran lunga meno nutriente di quella di un cervo, di un rinoceronte o di un mammut, non c’è alcun motivo di mangiarla.
Teste parlanti
Il legittimo disgusto moderno per certe pratiche ritualistiche non deve mettere in secondo piano il profondo significato spirituale del sacrificio umano. Il che, ovviamente, non può in alcun modo giustificarlo. Più in generale il sangue delle vittime era ritenuto il corrispettivo dell’anima, che da dio era venuta e a dio doveva fare ritorno. Con tutti gli onori esso veniva infatti raccolto e offerto alla divinità mentre il corpo, ormai privo del suo contenuto sacrale, poteva essere tranquillamente abbandonato all’appetito insaziabile degli uccelli e degli animali del bosco. Oppure, finire in pentola. Pensiamoci su, prima di arricciare il naso. Al netto dei semanticismi politicamente corretti, la violenza ideologica e le torture dei Tribunali dell’Inquisizione erano più «rispettabili» dei rituali pagani? Senza il manto di altruismo che le abbiamo messo addosso, cosa sarebbe la nostra regola del «silenzio assenso» che dichiara morta una persona dalla curva cerebrale piatta (ma con il cuore battente)?
Certe azioni rituali del passato, per lo meno, erano supportate da una visione cosmica di ampio respiro. Il gigante norreno Ymirnon fu fatto a pezzi per donare 5-10 anni di vita a Tizio, ma per permettere alla stirpe umana emergente di trarre il nuovo mondo dall’abisso. Il suo corpo servì a modellare la Terra, con le sue ossa furono innalzate le montagne, i denti crearono pietre e massi, il cervello fu scagliato in aria per disegnare le nubi. Addirittura, la volta del cielo non avrebbe potuto nascere senza il suo immenso cranio. Un fatto che diede la stura a varie congetture. Se il destino dell’uomo era scritto nel firmamento, allora voleva dire che lo si poteva leggere anche nella sfera ossea che all’inizio dei tempi era servita a costruire la sfera celeste. Partendo probabilmente da questo assunto, in Eurasia i crani montati in oro (come nel kintsugi giapponese) venivano usati come tazze e spesso svolgevano una funzione oracolare. Un esempio sublime di questa usanza ci viene offerto dal mito di Orfeo, dio degli Inferi, la cui testa mozzata continuò a «cantare» anche dopo essere stata gettata nelle acque del fiume Ebro, e fino all’arrivo a Lesbo, dove venne raccolta dalle locali sacerdotesse che la misero in una caverna per farne un oracolo. Finché un serpente (un «concorrente» magico?) non tentò di divorarla. Ma il più antico tra gli Antichi,Apollo, impedì lo scempio tramutando la testa in pietra. L’utilizzo dei teschi umani per scopi oracolari si protrasse grosso modo dal Neolitico fino ai Sabei di Harran, i «figli delle stelle», fra gli ultimi ad avvalersi delle «teste parlanti» a scopo divinatorio. Sebbene ogni tanto la nostalgia del passato assalisse qualcuno, come ad esempio Clemente di Sparta che conservava la testa di Arconide nel miele per consultarla prima di intraprendere qualsiasi impresa importante.
Si fa quel che si può
Non è intenzione di queste righe mettersi ad analizzare dal punto di vista psicologico il desiderio divorante nascosto nell’animo di ciascuno. Né tantomeno soffermarsi sulla rinascita di riti iniziatici ispirati alle forme d’istinto legate al «principio di vita», di crescita e di sviluppo. Sappiamo tutti che questa storia è vecchia come il mondo: si toglie l’energia all’altro per farla propria, oppure se ne fa dono al Superiore. Non sempre, tuttavia, il gesto sacro e straziante dell’offerta di vite umane che rinnovail sacrificio primigenio del Gigante antropocosmico ha qualcosa a che fare con il dottor Hannibal Lecter. E poi, chi siamo noi per giudicare? L’uomo religioso della preistoria cavava il sangue dal corpo dei suoi simili per donarlo alla divinità, l’individualista moderno preleva gli organi da uno per donarli all’altro. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, come si dice, e non è il caso d’illudersi che i posteri saranno con noi più indulgenti di quanto noi lo siamo con i nostri predecessori. C’è infine il tema della sopravvivenza. Come sappiamo in casi estremi gli uomini sono capaci di tutto, anche di divorarsi a vicenda e di bere il sangue dei propri simili, pur di non morire di fame e di sete. Ne abbiamo avuto una riprova in occasione di disastri aerei e navali che hanno allontanato per mesi le persone dalla cosiddetta «società civile». Molti non sono disposti ad arrivare a tanto, tuttavia la scelta di sopravvivere anche uccidendo e divorando i propri compagni di sventura appartiene alla maggioranza. E chi rifiuta di aderire ad azioni cruente, trovandosi in minoranza, spesso non può impedire che esse avvengano, ma solo andare incontro alla morte piuttosto che venir meno alla voce della propria coscienza. Corre l’obbligo quindi di rispolverare uno dei dogmi teologici fondamentale di Lutero: il libero arbitrio non esiste.
Rita Remagnino