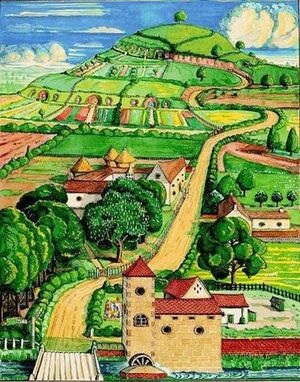Intervento di LUCA CANCELLIERE al seminario “Euro. Pro e contro della moneta unica” (Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche – Cagliari, 23/01/2015)
Il progetto dell’unione monetaria europea, iniziato con lo S.M.E. alla fine degli anni ’70 e proseguito con il Trattato di Maastricht del 1992, apparve sin dall’inizio un errore economico e politico e un’assurdità scientifica. La gravissima recessione degli ultimi anni ha ampliato notevolmente lo spazio dedicato ai temi economici. Per esempio Alberto Bagnai, professore di Economia presso le Università di Pescara e di Rouen (Francia), ha acquisito vasta notorietà come sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’Euro. Nei suoi due libri “Il tramonto dell’euro. Come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa” (Imprimatur, Reggio Emilia 2012) e “L’Italia può farcela. Equità, flessibilità e democrazia. Strategie per vivere nella globalizzazione” (Il Saggiatore, Milano 2014), Bagnai ha compiuto una meritoria opera di divulgazione. La critica alla moneta unica si basa non solo sulla teoria delle “aree valutarie ottimali” di Robert Mundell (Premio Nobel 1999), ma anche sulle affermazioni di altri celebri economisti, soprattutto di area anglosassone, quali Milton Friedman (Premio Nobel 1976), James Mirrlees (Premio Nobel 1996), Amartya Sen (Premio Nobel 1998), Joseph Stiglitz (Premio Nobel 2001), Paul Krugman (Premio Nobel 2008), Christopher Pissarides (Premio Nobel 2010), oltre a Martin Feldstein (Harvard), Wynne Godley (Cambridge, morto nel 2010), Nicholas Kaldor (Cambridge, morto nel 1986) e Dominick Salvatore (Fordham N.Y.C.). Nell’Europa continentale, i maggiori critici dell’Euro sono stati il tedesco Rudiger Dornbusch (M.I.T. Boston, morto nel 2002), i francesi Brigitte Granville (Queen Mary Londra), Jacques Sapir (Moskovskaya Shkola Ekonomiki) e Jean-Pierre Vesperini (Rouen) lo spagnolo Antoni Soy (Barcellona), gli italiani Claudio Borghi Aquilini (Cattolica Milano), Emiliano Brancaccio (Benevento), Sergio Cesaratto (Siena), Giuseppe Di Taranto (LUISS Roma), Luca Fantacci (Bocconi), Antonio Maria Rinaldi (Pescara), Paolo Savona (già LUISS Roma), Gennaro Zezza (Cassino), Luigi Zingales (Chicago).
Determinante è stato lo studio condotto, sulla scorta delle teorie di Minsky sul ciclo economico e di Mundell sulle aree valutarie ottimali, dall’economista argentino Roberto Frenkel. Il “ciclo di Frenkel” nasce dallo studio comparato di 10 unificazioni monetarie (con adozione di moneta unica o cambi fissi): Cile (1982), Italia (1992), Messico (1994), Thailandia e Corea (1997), Russia (1998), Brasile (19 99), Argentina e Turchia (2001), Eurozona (2010). Le fasi del “ciclo di Frenkel” sono le seguenti: 1) si istituisce un’area valutaria, caratterizzata da un’unica valuta comune o da due o più valute con un tasso di cambio rigido, di tipo “non ottimale” (con economie fortemente differenziate dal punto di vista macroeconomico) e vengono liberalizzati i movimenti di capitali; 2) i capitali esteri sono attirati nella “periferia” dell’area valutaria dagli alti rendimenti nel settore privato dal venir meno del rischio derivante dal cambio flessibile; 3) il suddetto afflusso di capitali provoca crescita e inflazione nella periferia dell’area valutaria, il cui il debito pubblico si riduce; 4) l’ulteriore aumento dell’inflazione finisce per arrestare la crescita della periferia; 5) coloro che hanno investito nella periferia, a fronte del blocco della crescita della periferia, ritirano i propri investimenti; 6) gli Stati della periferia, per evitare l’emorragia degli investimenti esteri, alzano i tassi d’interesse dei titoli del debito pubblico e intervengono a sostegno delle banche private; la crescita del c.d. “spread” fa esplodere il debito pubblico degli Stati della periferia.
99), Argentina e Turchia (2001), Eurozona (2010). Le fasi del “ciclo di Frenkel” sono le seguenti: 1) si istituisce un’area valutaria, caratterizzata da un’unica valuta comune o da due o più valute con un tasso di cambio rigido, di tipo “non ottimale” (con economie fortemente differenziate dal punto di vista macroeconomico) e vengono liberalizzati i movimenti di capitali; 2) i capitali esteri sono attirati nella “periferia” dell’area valutaria dagli alti rendimenti nel settore privato dal venir meno del rischio derivante dal cambio flessibile; 3) il suddetto afflusso di capitali provoca crescita e inflazione nella periferia dell’area valutaria, il cui il debito pubblico si riduce; 4) l’ulteriore aumento dell’inflazione finisce per arrestare la crescita della periferia; 5) coloro che hanno investito nella periferia, a fronte del blocco della crescita della periferia, ritirano i propri investimenti; 6) gli Stati della periferia, per evitare l’emorragia degli investimenti esteri, alzano i tassi d’interesse dei titoli del debito pubblico e intervengono a sostegno delle banche private; la crescita del c.d. “spread” fa esplodere il debito pubblico degli Stati della periferia.
Più recentemente la fallacia delle politiche monetarie e di bilancio imposte dall’Europea è stata evidenziata da altre e più recenti ricerche. Nel 2012 Nicoletta Batini, Giovanni Callegari e Giovanni Melina, per conto del F.M.I., hanno individuato nelle politiche di austerità la causa del peggioramento del rapporto debito/P.I.L.. Il famoso articolo del 2010 di Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, che evidenziava l’esistenza di una correlazione tra un alto rapporto debito/PIL (maggiore del 90%) e la bassa crescita, è stato clamorosamente smentito nel 2013 (oltre che dai casi dell’Irlanda e della Spagna, paesi colpiti dalla crisi ancorchè a basso debito pubblico), da uno studio di Thomas Herndon, Michael Ash e Robert Pollin dell’Università del Amherst (Massachusetts). Nel 2012 i brasiliani Ilan Goldfajn e Sergio Ribeiro da Costa Werlang (Rio de Janeiro) hanno dimostrato – come del resto è ben noto a noi Italiani in base all’esperienza storica dell’uscita dallo S.M.E. dell’agosto-settembre 1992 – che un’eventuale svalutazione avrebbe effetti molto contenuti dal punto di vista quantitativo sulla crescita del tasso di inflazione (tesi confermata dagli analisti di Merryl Lynch nel 2013). Nel 2012 l’economista britannico Roger Bootle ha vinto il “Wolfson Economic Prize” con “Leaving the Euro: a practical guide”, studio che illustra una possibile strategia di uscita dall’Euro, in piena sicurezza e senza effetti collaterali negativi, per i paesi in crisi come il nostro. Persino esponenti di spicco della nomenklatura europea, come l’ex commissario U.E. Frederik Bolkenstein o il vicepresidente della B.C.E. Vítor Constâncio, hanno dovuto ammettere il fallimento dell’Eurozona e delle politiche di bilancio imposte dalla Commissione. Il vicepresidente portoghese della BCE, in particolare, ha chiarito che la crisi non dipende dal debito pubblico degli Stati, ma dagli squilibri insorti nel mercato finanziario privato a causa dell’asimmetria tra economie profondamente diverse unite nella stessa area valutaria, in un contesto mondiale di deregolamentazione della finanza privata a seguito dell’abrogazione, avvenuta negli anni ’90, di norme come il “Glass-Steagall Act” americano o la legge bancaria italiana del 1936.
La genesi dell’unificazione monetaria europea, come è noto, deve essere rinvenuta nel “pactum sceleris” intercorso tra Mitterrand e Kohl alla fine degli anni ’80. In cambio del via libera della Francia alla riunificazione tedesca, i Tedeschi rinunciarono al Deutsche Mark, ottenendo però che l’Italia, principale concorrente economico della Germania, fosse inclusa in un’unione valutaria che ne avrebbe pregiudicato le esportazioni. Come ricordò l’ex m inistro Vincenzo Visco nel 2012, “Un’Italia fuori dall’Euro, visto il nostro apparato industriale, poteva fare paura a molti, incluse Francia e Germania che temevano le nostre esportazioni prezzate in lire”. Il “metodo europeo”, con cui è stato imposto l’Euro è stato quello del “dispotismo illuminato” (Tommaso Padoa Schioppa 1999) e dello scatenamento di crisi economiche per indurre cessioni di sovranità: “I passi avanti dell’Europa sono cessioni di sovranità. I cittadini possono essere pronti a queste cessioni solo quando c’è una crisi in atto” (Mario Monti 2011). Luigi Zingales, non ha caso, ha riconosciuto che “L’aspetto criminale dei fondatori dell’Euro era che la crisi era premeditata” (19 dicembre 2012). L’Italia e la Germania, nel 2000 rispettivamente in attivo e in passivo nel saldo delle partite correnti, 12 anni dopo vedevano le proprie posizioni diametralmente invertite per effetto delle dinamiche del sopra citato “ciclo di Frenkel”. Come ricorda Andrea Papetti della Stockholm School of Economics, “Oggi risulta chiaro che la crisi dell’eurozona è una crisi di bilancia dei pagamenti”. Questa crisi deriva dall’eliminazione dei cambi flessibili all’interno di un’area valutaria non ottimale e dalla politica mercantilista della Germania, che nei primi anni 2000 ha finanziato la compressione della quota salari delle proprie imprese con aiuti di Stato mai perseguiti dalla Commissione Europea, comprimendo la propria domanda interna e generando surplus della bilancia commerciale in aperta violazione dell’art. 121.2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che dispone una procedura di infrazione (mai applicata, ovviamente, alla Germania) per gli Stati con un saldo positivo superiore al 6% del P.I.L. nella media di tre anni.
inistro Vincenzo Visco nel 2012, “Un’Italia fuori dall’Euro, visto il nostro apparato industriale, poteva fare paura a molti, incluse Francia e Germania che temevano le nostre esportazioni prezzate in lire”. Il “metodo europeo”, con cui è stato imposto l’Euro è stato quello del “dispotismo illuminato” (Tommaso Padoa Schioppa 1999) e dello scatenamento di crisi economiche per indurre cessioni di sovranità: “I passi avanti dell’Europa sono cessioni di sovranità. I cittadini possono essere pronti a queste cessioni solo quando c’è una crisi in atto” (Mario Monti 2011). Luigi Zingales, non ha caso, ha riconosciuto che “L’aspetto criminale dei fondatori dell’Euro era che la crisi era premeditata” (19 dicembre 2012). L’Italia e la Germania, nel 2000 rispettivamente in attivo e in passivo nel saldo delle partite correnti, 12 anni dopo vedevano le proprie posizioni diametralmente invertite per effetto delle dinamiche del sopra citato “ciclo di Frenkel”. Come ricorda Andrea Papetti della Stockholm School of Economics, “Oggi risulta chiaro che la crisi dell’eurozona è una crisi di bilancia dei pagamenti”. Questa crisi deriva dall’eliminazione dei cambi flessibili all’interno di un’area valutaria non ottimale e dalla politica mercantilista della Germania, che nei primi anni 2000 ha finanziato la compressione della quota salari delle proprie imprese con aiuti di Stato mai perseguiti dalla Commissione Europea, comprimendo la propria domanda interna e generando surplus della bilancia commerciale in aperta violazione dell’art. 121.2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che dispone una procedura di infrazione (mai applicata, ovviamente, alla Germania) per gli Stati con un saldo positivo superiore al 6% del P.I.L. nella media di tre anni.
Nel 1981 il “divorzio Banca d’Italia – Tesoro” eliminò l’obbligo della Banca Centrale di acquistare i Titoli di Stato invenduti e costrinse il Tesoro a remunerare gli investitori privati con tassi d’interesse molto alti, causando l’esplosione della spesa pubblica per interessi passivi. Il rapporto debito/P.I.L. crebbe così dal 56,86% del 1980 (con una spesa pubblica in rapporto al P.I.L. del 41,1,%, la più bassa d’Europa) al 105,20% del 1992, nonostante un bilancio statale addirittura in avanzo primario almeno dai primi anni ‘90. La progressiva rinuncia alla sovranità monetaria e l’iniqua distribuzione del reddito degli ultimi 30 anni – la crescita dei salari è stata inferiore alla crescita della produttività, a fronte di una crescente remunerazione del capitale finanziario – hanno portato l’Europa alla recessione più grave della sua storia. Oltre al ritorno alla valuta nazionale, pertanto, si renderebbe necessario anche il ripristino dell’obbligo per la Banca d’Italia di acquistare i Titoli di Stato invenduti (abolito nel 1981) e di fornire anticipazioni al Tesoro (abolito nel 1993). Non è sicuramente sufficiente, invece, che la B.C.E. lanci una politica di “quantitative easing” assumendo il ruolo di prestatore di ultima istanza, che già fu delle Banche Centrali. Una politica fiscale espansiva in regime di unione monetaria, infatti, come dimostrato da Alberto Bagnai, aggraverebbe ulteriormente il saldo della bilancia dei pagamenti della “periferia” europea nei confronti della Germania. L’unica soluzione in grado di garantire la ripresa economica, pertanto, è il ritorno all’emissione della valuta nazionale con una contestuale politica di sostegno alla domanda aggregata.
LUCA CANCELLIERE