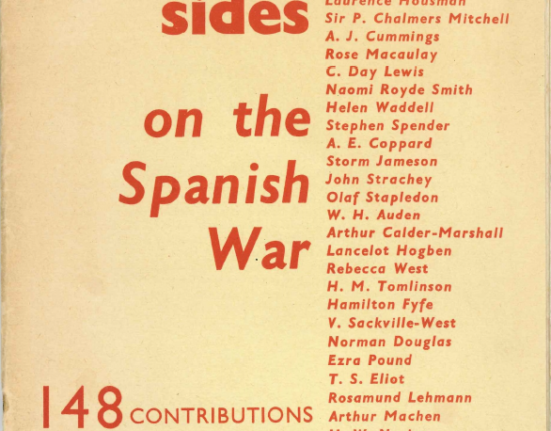Di Franca Poli
Il desiderio di scrivere brevemente la storia della famiglia Govoni nasce dal fatto che recandomi nella biblioteca comunale del mio paese, non solo non ho trovato libri che ricordassero la vicenda dei sette fratelli, ma ho dovuto scontrarmi per l’ennesima volta con il muro di omertà eretto dalla sinistra dopo la guerra verso le vicende di sangue e gli orrori commessi dal partigianato locale contro cittadini innocenti. Infatti la direttrice nel comunicarmi che non c’erano libri inerenti l’eccidio di Argelato, ha candidamente ammesso, minimizzando, che non conosceva assolutamente l’avvenimento, stringendosi nelle spalle, come se non fosse mai successo. Mi avvarrò dunque nel raccontare, per date, nomi e riferimenti precisi, di quanto letto più volte nei testi di Giorgio Pisanò.
Gli unici sette fratelli martiri noti e di cui si potevano trovare molteplici pubblicazioni in biblioteca, sono i fratelli Cervi per i quali, al contrario, nel corso degli anni le onorificenze si sono sprecate. A Campegine, la loro casa è stata trasformata in “museo della resistenza”, ogni 25 aprile le organizzazioni di partito da settant’anni a questa parte incessantemente hanno convogliato in visita comitive di cittadini provenienti da ogni parte d’Italia, intere scolaresche al fine di ottenebrare i giovani cervelli degli studenti con le menzogne apologetiche che hanno raccontato e che continuano a propinare. I capi di stato si sono susseguiti nella visita “obbligata” a rendere omaggio agli eroi della campagna emiliana e Pertini ebbe a sottolineare come la storia dei Cervi aiuti a divenire antifascisti avvalendosi dei valori “più elementari ed essenziali: l’amore per l’uomo, il culto della famiglia, la passione per il lavoro dei campi”.
Dimenticava, il presidente più amato dagli Italiani, che poco lontano da quel paese, nella stessa fetta di pianura padana, esattamente a Pieve di Cento, vivevano altri sette fratelli, allevati anch’essi nel culto della tradizione popolare, ragazzi con grande passione per il lavoro, fedeli alla Patria e devoti alla famiglia. Dimenticavano volutamente lui e tutti gli altri di ricordarli e di far conoscere l’inutile massacro che subirono solo perchè due di loro erano fascisti, avevano osato dunque schierarsi “dalla parte sbagliata”, pertanto scrittori e giornalisti non hanno riportato storie e articoli commoventi sulla triste vicenda di questa famiglia poiché ancora oggi, non merita pietà, né rispetto chi ha vestito la camicia nera.
Andando in visita al loro paese non troverete musei, né monumenti e nemmeno allegre comitive di compagni in gita di istruzione, nessuna indicazione stradale con scritto “casa dei fratelli Govoni”, nei luoghi del loro martirio nemmeno un semplice cartello con la dicitura “qui morirono sette innocenti, che, a guerra finita, prelevati dalle mura paterne, furono ingiustamente e senza nessun motivo trucidati” eppure è successo, è tutto vero, era l’11 maggio 1945.
Il conflitto che aveva insanguinato l’Italia e l’Europa era finito da poco, ma gli spargimenti di sangue non erano ancora terminati, anzi stava cominciando la stagione delle vendette, della prevaricazione, dell’odio di parte, dei delitti di civili innocenti. La famiglia Govoni, abituata ai sacrifici, si era rimboccata le maniche e aveva ricominciato di buona lena a lavorare il terreno, una sera di primavera nella campagna bolognese, tutto intorno profumo di fieno appena tagliato, nella loro casa colonica fecero irruzione in cucina alcuni uomini, sedicenti eroici partigiani, che prelevarono l’unico dei fratelli trovato in casa a quell’ora: Marino. Gli altri erano in giro per il paese, i più giovani addirittura erano andati a ballare, perchè non avevano niente da temere, infatti proprio pochi giorni prima, dopo l’arrivo delle truppe angloamericane, erano stati arrestati, interrogati e ovviamente rilasciati poichè nulla era emerso a loro carico. Non sospettavano di essere stati inseriti, senza colpa alcuna, in “una lista nera” redatta da una banda che da quando era finita la guerra spadroneggiava in quella zona e che, approfittando del caos di quei tristi giorni, sostituendosi alle autorità, si era assunta persino il ruolo di forza di polizia, e che compì orrendi crimini di cui peraltro si era già macchiata durante i mesi della RSI. Era la “2a brigata Paolo” guidata da Marcello Zanetti ,detto “Marco”, vicecomandante e commissario politico era Vittorio Caffeo “Drago”; a seguire ne fecero parte Adelmo Benini detto “Gino”, Vitaliano Bertuzzi , detto “Zampo” e a capo della polizia partigiana fu invece Luigi Borghi, detto “Ultimo” un esponente dei GAP bolognesi, la formazione terroristica che nella sola città capoluogo fu artefice di centinaia di uccisioni. L’infame lista, come poi risultò dagli atti processuali fu stilata dal comunista Caffeo, che godeva di grande quanto inquietante ascendente sui suoi gregari. La sede della banda era proprio San Pietro in Casale, il paese della famiglia Govoni.
La sera stessa sul tardi, tornarono a casa Govoni e trovarono tutti gli altri figli: Dino, Emo, Giuseppe, Augusto e Primo. Li caricarono su un camion e li portarono via, alle angoscianti domande della madre che, con terrore, ne chiedeva il motivo, quegli uomini senza scrupoli risposero che i suoi figli sarebbero stati interrogati e rilasciati, che era una semplice “misura di Polizia”. Amara fu la scoperta di trovare già sul camion anche la sorella Ida. La più piccola di loro, sposata da poco tempo, era stata prelevata dalla sua casa dove viveva col marito Angiolino Cevolani, e dove aveva dovuto lasciare Paola la sua piccola bambina di appena due mesi. L’unica a salvarsi era stata l’altra sorella Maria anch’essa sposata, che viveva però ad Argelato e che non erano riusciti a rintracciare. Già perchè nei progetti della banda c’era il disegno di ucciderli tutti in quanto era risaputo in paese che i fratelli Govoni erano uniti, affiatati e, se si fosse reso necessario, anche coloro che non si erano mai interessati di politica, non avrebbero perso tempo per schierarsi in difesa di qualsiasi familiare si fosse trovato in difficoltà.
Di antico ceppo contadino costituivano col padre Cesare e la madre Caterina una delle famiglie più numerose del paese: sei maschi e due femmine.
Voglio citarli uno ad uno, non per stilare uno sterile elenco, ma per ricordarli tutti chiamandoli per nome e pronunciando un virtuale PRESENTE.
Il primogenito era Dino 41 anni, falegname artigiano sposato e padre di due figli, dopo l’8 settembre, si era iscritto al Partito Fascista Repubblicano; poi veniva Marino 33 anni, sposato con una bambina, combattente d’Africa anch’egli aderì alla RSI, ma non avevano mai dato modo a nessuno di puntare il dito verso la loro condotta; la terza era Maria l’unica scampata al massacro; il quarto figlio di 32 anni era Emo, anch’egli falegname, viveva ancora coi genitori e poco più giovane di lui Giuseppe, 30 anni, coniugato, divenuto padre da tre mesi, era dedito all’agricoltura e viveva al podere; entrambi non avevano mai aderito al PFR. Venivano poi i due fratelli più giovani Augusto di 27 anni e Primo di 22, erano ancora celibi facevano i contadini insieme al padre al podere e non avevano mai fatto politica. L’ultima era la giovane Ida che al momento dell’irruzione in casa propria, invano aveva pregato i banditi di non essere costretta ad abbandonare la sua piccola.
“Drago” “Zampo” “Ultimo” e la loro gang non furono che gli esecutori materiali di un piano preordinato: le direttive del PCI erano di seminare il terrore e ottenere facile sottomissione. Le sparizioni, gli omicidi gettarono la popolazione di molte zone dell’Emilia Romagna nello sconforto e nella cieca paura, tanto che nessuno denunciava i crimini e solo molti anni più tardi si cominciarono ad aprire inchieste e a ottenere dolorose e scomode verità.
La mattanza era cominciata subito dopo l’abbandono del fronte da parte di tedeschi e soldati della RSI, i partigiani della “2a brigata Paolo” con la violenza avevano preso possesso del territorio occupando Pieve di Cento, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Argelato, assassinando tutti coloro che avevano per qualche ragione avuto a che fare coi fascisti, parenti, amici, vicini, ma anche proprietari terrieri, professionisti, persone innocenti che venivano indicate per la loro condizione sociale “nemici del popolo e della democrazia”. Un ben strano e crudele concetto di democrazia che d’altronde animò tutte le “repubbliche democratiche” instaurate dai comunisti nel dopoguerra nei vari paesi da loro occupati.
Dunque all’insegna di questa “pulizia” prima dei fratelli Govoni erano stati effettuati altri massacri. Un prelevamento con conseguente eccidio di dodici persone era avvenuto l’8 maggio. Uno dei sequestrati fu salvato dal fratello che inseguendo l’auto dei partigiani giunse al covo e perorando la causa del familiare, tirò in ballo l’amicizia con il sindaco comunista del paese e riuscì nell’intento di riportare a casa il congiunto, ma nonostante avesse visto cosa succedeva nel casolare e sapesse chi erano gli artefici, ne fuggì talmente terrorizzato che trovò il coraggio di raccontare la verità solo molti anni più tardi.
Così pochi giorni dopo, i sette fratelli Govoni si trovarono rinchiusi nella casa di campagna di un contadino che aveva avuto un figlio ucciso dai fascisti e scelta dai partigiani come luogo per l’esecuzione perchè, sicuramente, il proprietario sarebbe stato un complice fidato e omertoso. Quando gli aguzzini iniziarono il loro macabro processo farsa, tutti furono seviziati, malmenati senza esclusione di colpi, anche la ragazza ebbe uguale trattamento nessun privilegio, nessun trattamento di favore. Solo uno dei partigiani provò a prendere le parti della giovane madre, ma ottenne soltanto di non assistere all’esecuzione, fu rimandato a casa e minacciato di morte se avesse osato parlare dell’accaduto. Tutte queste verità uscirono solo molti anni dopo, durante il processo verso i responsabili.
Il giorno successivo alla sfortunata famiglia si aggiunsero altri dieci paesani. Tutte persone note per la loro onestà e rettitudine, contro di loro non si potevano sollevare accuse di nessun genere se non quella di essere anticomunisti e tanto bastò per sentenziare la condanna a morte. Erano Alberto Bonora, catturato col figlio Cesarino e il nipote Ivo di soli diciannove anni; Guido Pancaldi; Alberto Bonvicini;Vinicio Testoni; Guido Mattioli; Giovanni Caliceti e Ugo Bonora, lascio per ultimo Giacomo Malaguti perchè costui merita due parole a parte. Si trattava di uno studente universitario sottotenente degli alpini che dopo l’8 settembre era passato con l’esercito del Sud e che al comando del suo plotone nella VIII Armata alleata, aveva combattuto contro i tedeschi sul fronte di Cassino, restando anche ferito. Avrebbe dovuto essere dunque considerato un alleato dai partigiani, avevano, a loro dire, lo stesso obiettivo e gli stessi nemici, ma fin dal suo ritorno in paese aveva suscitato solo rabbia e invidie. Vedendolo ammirato e rispettato dalla popolazione per aver avuto il coraggio di combattere faccia a faccia e non di nascondersi e scappare, era stato più volte preso di mira dai comunisti che intendevano annullare i valori di integrità, il rispetto per l’onore e la divisa che la guerra civile non aveva ancora completamente cancellato. In una prima occasione, parlando con alcuni cittadini che si lamentavano dei soprusi subiti dalla polizia partigiana, rispose fiducioso “Comanderanno ancora una ventina di giorni” a significare che presto sarebbe stato ricostituito l’ordine. Per aver pronunciato questa frase, offensiva della dignità degli eroici partigiani fu arrestato, detenuto, interrogato e minacciato. Poche sere più tardi gli fu impedito di partecipare a una festa in paese, venne malmenato e buttato fuori dalla balera in malo modo, ciononostante egli non sospettò mai di essere stato incluso nella lista delle persone “indesiderabili”, che significava morte sicura, stilata dalla “2a Brigata Paolo”. Egli fino all’ultimo momento, col sorriso sulle labbra, cercò di tranquillizzare gli altri che in breve sarebbero stati liberati e che si trattava di uno spiacevole equivoco.
Alla fine della giornata erano 17 le persone raccolte nel casale e quello che successe in realtà non è dato saperlo per certo, però dalle risultanze delle autopsie, avvenute soltanto molti anni dopo, si poté stabilire che nessuno era morto per colpi di arma da fuoco, quando i poveri resti furono esaminati si accertò che tutti presentavano ossa rotte e incrinate, è facile dunque immaginare la sofferenza, lo strazio, le grida, il dolore che precedettero la morte dei prigionieri.
Si era sparsa la voce che si stava “tenendo una festa” così molti partigiani accorsero per godersi lo spettacolo e per dividersi il misero bottino, ai derelitti furono tolti tutti gli averi, per esempio a Caffeo toccò l’anello d’oro di Testoni, insomma macabri trofei da esibire in pubblico quale fregio per la valorosa impresa. La cose di poco valore come pettini, chiavi e altro furono gettate nel pozzo e durante le indagini, là vennero rinvenute a conferma di quanto raccontato dai testimoni. Già i testimoni oculari, coloro che accorsi sul posto avevano assistito all’orrendo massacro e che per tanto tempo non avevano avuto il coraggio di rompere il silenzio.
Altri quattro anni e più durò il terrore che si era impadronito degli abitanti della zona e nessuno rispose alle disperate domande dei familiari che chiedevano almeno di sapere il luogo di sepoltura dei loro cari. I genitori dei fratelli Govoni non smisero mai di girare le campagne, casa per casa chiedendo pietà, pregando chi sapeva di parlare, ma nessuno ascoltò le loro richieste, anzi spesso furono cacciati, insultati e derisi.
 Nell’estate del 1949 mamma Caterina, che aveva allora già 70 anni, in paese si avvicinò a Filippo Lanzoni, un ex partigiano che si vantava in giro di essere bene informato sulla fine dei fratelli Govoni, lo guardò dritto negli occhi e disse “se è vero che lo sai, dimmi solo dove li avete seppelliti, ho il diritto di saperlo” l’uomo, senza nessuna pietà rispose che le sarebbe bastato un bravo cane da tartufo per ritrovare i suoi figli. La povera donna si mise a urlare e lui, vigliaccamente, chiamò a gran voce la moglie e una nipote del sindaco comunista di Pieve di Cento che si trovavano nei pressi e gliele aizzò contro. Le due si avventarono come iene, la buttarono a terra e la picchiarono selvaggiamente, fu l’intervento di una nuora della Govoni, la vedova di Dino, che passando in bicicletta si precipitò come una furia contro le assalitrici e le mise in fuga, ovviamente anche il vigliacco che aveva istigato il gioco fuggì vergognosamente.
Nell’estate del 1949 mamma Caterina, che aveva allora già 70 anni, in paese si avvicinò a Filippo Lanzoni, un ex partigiano che si vantava in giro di essere bene informato sulla fine dei fratelli Govoni, lo guardò dritto negli occhi e disse “se è vero che lo sai, dimmi solo dove li avete seppelliti, ho il diritto di saperlo” l’uomo, senza nessuna pietà rispose che le sarebbe bastato un bravo cane da tartufo per ritrovare i suoi figli. La povera donna si mise a urlare e lui, vigliaccamente, chiamò a gran voce la moglie e una nipote del sindaco comunista di Pieve di Cento che si trovavano nei pressi e gliele aizzò contro. Le due si avventarono come iene, la buttarono a terra e la picchiarono selvaggiamente, fu l’intervento di una nuora della Govoni, la vedova di Dino, che passando in bicicletta si precipitò come una furia contro le assalitrici e le mise in fuga, ovviamente anche il vigliacco che aveva istigato il gioco fuggì vergognosamente.
Il racconto di ciò che era successo fece in poche ore il giro del paese e sollevò grande indignazione, rabbia, disgusto, c’è chi dice che proprio quella scintilla fece scatenare l’incendio delle confessioni. Di lì a poco alcuni cittadini cominciarono a parlare, a liberare le coscienze che per tanto tempo avevano soffocato il rimorso e aiutarono a far luce su fatti che stavano in qualche modo venendo allo scoperto.
Alla fine del 1949 i carabinieri denunciarono per i delitti del 9 maggio un primo gruppo di partigiani. Il secondo eccidio, quello che comprendeva i sette fratelli Govoni era strettamente collegato al primo e il 24 febbraio 1951 si conclusero tutte le indagini con il ritrovamento delle fosse comuni in cui erano stati sepolti alla meno peggio.
Al termine dell’istruttoria 27 ex appartenenti alla “2a brigata Paolo” e alla “7a GAP” furono rinviati a giudizio per sequestro di persona, omicidio premeditato, rapina aggravata, occultamento di cadavere e altri reati minori.
Ce n’era abbastanza per sbatterli dentro e buttare via la chiave, ma quando nel 1953 il processo terminò nessuno, dico nessuno, pagò per le sue colpe. Molti dei responsabili erano fuggiti in Cecoslovacchia grazie all’aiuto logistico fornito dal PCI, e risultarono quindi latitanti, gli arrestati usufruirono dell’amnistia Togliatti poiché i giudici stabilirono di poter applicare tale beneficio, secondo cui i delitti commessi dai partigiani durante e dopo la guerra civile, erano da considerarsi giustificabili dal movente politico e per conseguenza non punibili, quindi delle 29 persone uccise nelle due terribili giornate incriminate, il paradosso volle che solo l’uccisione di uno di loro fosse perseguibile. Solo per l’omicidio dell’ufficiale degli alpini Giacomo Malaguti, l’unico che doveva essere considerato loro alleato, mai stato fascista e che anzi aveva combattuto contro i tedeschi, tutti i partigiani in blocco furono considerati colpevoli e condannati all’ergastolo.
Il Giudice della corte d’Assise di Bologna si legge nella sentenza “riconosce la soppressione dei sette fratelli Govoni e dei prelevati di San Giorgio, ad eccezione del S.Tenente Malaguti Giacomo, fu determinata da motivi di lotta contro il nazifascismo” e ancora che Dino e Marino erano fascisti, mentre Ida era di “sentimenti fascisti” mancando concretamente addebiti verso gli altri quattro fratelli il Giudice concluse che forse la soppressione di tutti fu probabilmente causata dal fatto che i partigiani stessi, non sapendo con certezza quali di essi fossero i fascisti “decisero di ucciderli tutti per avere così la certezza di avere eliminato i responsabili”. Parole che si commentano da sole.
Inutile dire che dopo pochi anni, il ricorso in Cassazione, le amnistie e i condoni vari, tutti gli appartenenti alla banda della morte furono liberati.
Il terribile massacro dei fratelli Govoni non ottenne mai giustizia e costituisce una delle pagine più orrende della storia italiana, una delle più vergognose e ancora oggi dopo settant’anni, non si vuole rendere loro un po’ di dignità.
I fratelli Cervi, erano tutti e sette ferventi comunisti e antifascisti, che furono arrestati, con le armi in pugno, dopo un conflitto a fuoco, probabilmente denunciati da un ex disertore della Milizia. Vennero fucilati dopo circa un mese di detenzione per rappresaglia in seguito all’uccisione da parte dei partigiani del segretario comunale di Bagnolo in Piano. La loro morte, per quanto triste, fu dunque conseguenza diretta di una scelta consapevole, era il 27 dicembre 1943.
A loro sono state intestate strade, piazze e scuole in ogni parte d’Italia, sono stati decorati con sette medaglie d’argento al valor militare. Pietro Calamandrei ha dedicato loro una famosa “Epigrafe” e “A fratelli Cervi, alla loro Italia” è anche il titolo di una poesia di Quasimodo. Il padre Alcide, ricevette l’onorificenza di una medaglia d’oro creata dallo scultore Mazzacurati e uno dei nipoti porta avanti la memoria della famiglia impegnandosi politicamente.
Ai genitori dei sette fratelli Govoni, non fu tributato nemmeno una minima parte di tanto onore, essi ebbero riconosciuto nel 1961 dallo Stato italiano, come unico risarcimento per la grande ingiustizia subita, il diritto a una pensione di sette mila lire mensili: umiliante il calcolo di mille lire per ogni figlio.
Il presidente del consiglio, quest’anno, nella ricorrenza del 25 aprile si è recato a Marzabotto e per, parole sue “contribuire a costruire una memoria condivisa” ha cantato “bella ciao” insieme alle scolaresche e a quelli dell’ANPI, sono passati settant’anni ancora e ancora solo e soltanto una parte viene ricordata, oggi vorrei che tutte le persone di ogni colore politico, dopo tanto tempo avessero il coraggio e la forza di prendere atto della verità, di fare un passo verso la vera pacificazione nazionale ancora così lontana, posando idealmente un fiore su queste tombe dimenticate e provare a ricordare anche quel padre che concluse la sua esistenza, mai un giorno senza dolore, con tanta dignità, oltraggiato, senza nessun riconoscimento, ma con tenacia e coraggio.
Il mio desiderio è di chiudere queste pagine insanguinate, non di strapparle dai libri di storia, rileggendole un’ultima volta senza falsità e non è retorica visto che ancora nel 2012 il manifesto commemorativo affisso dalla famiglia Govoni nel 67° anniversario venne imbrattato con scritte offensive e disegni di falce e martello.
Con questo intento per ricordare i sette fratelli Govoni userò proprio le parole del padre dei fratelli Cervi:
“Dopo un raccolto ne viene un altro, andiamo avanti…”