La nozione marxista di Forza/Lavoro riguarda le facoltà semantiche/comportamentali di un corpo umano che non ha realtà ma che è in potenza (Dynamis). Riguarda quindi anche il pensiero verbale.
La nozione di cooperazione è la principale forza produttiva e rappresenta l’organizzazione di un lavoro al cui interno risiede la F/L. Il lavoro è diventato essenzialmente linguistico.
Il lavoro immateriale è il prodotto non distaccato dall’atto che produce. Il lavoro produttivo è un’opera indipendente dall’atto o dal produttore. Il parlare è l’attività senza opera per eccellenza. I singoli che agiscono insieme hanno il compito di migliorare il proprio operare. La cooperazione soggettiva è linguistica ed è composta da attività senza opere.
Il capitalismo linguistico è lavoro linguistico che produce per esempio cura. Essere bravi con le parole. Ma ogni attività è in realtà linguistica e soprattutto performativa. Utilizzo della “chiacchiera” per vendere o acquistare. Fare le cose con le parole. Dal basso, lavoro vivo. Il potere si serve dell’immaginazione. Non si può quantificare il lavoro linguistico. Le parole non possono essere quantificate perché non hanno prezzo. Si smetterà di lavorare? Significherebbe smettere di parlare! Non smetto di lavorare nemmeno quando taccio e viceversa.

Nel lavoro tradizionale il linguaggio c’è o prima o dopo. Tutto il lavoro produttivo richiede l’attività verbale. Il linguaggio potenza anche l’uso degli strumenti poiché incide su chi è dedito alle imprese tecniche. Linguisticizzazione del lavoro.
Il linguaggio prevale nella sfera politica e viene meno anche la suddivisione tra linguaggio linguistico e non linguistico. Lo sfruttamento del lavoro è a partire dalla linguisticità.
Il linguaggio è produzione. Nel nostro parlare c’è sia un valore d’uso (significante) che un valore di scambio (significato). Quindi parlare è produrre.
La modernità fa diventare un fatto storico quello che è nella nostra specie cioè la potenzialità, l’insieme delle possibilità di un corpo, inattuali e non presenti di un corpo-mente.
Per Marx l’uomo vive nella relazione (in TRA): è centrale nella natura umana. Quindi l’uomo vive nel linguaggio.
Principio di individuazione: il punto di partenza è un insieme di possibilità e proprio la molteplicità può scatenare una singolarità.
Dobbiamo considerare anche il linguaggio come un lavoro ovvero come una risposta ad un bisogno. Il linguaggio è un Modo D’Essere ed è un’attività sociale e collettiva. Tuttavia non esiste la possibilità che la facoltà del linguaggio permetta l’articolazione della storia. Il linguaggio infatti è un prodotto integralmente storico. Inoltre il lavoro linguistico non può essere spiegato tramite categorie. Non possiamo nemmeno parlare di alienazione linguistica poiché l’alienazione è una produzione di non-sensi.
Compito del marxismo è una critica intransigente dell’introspezione (del suo primato), occorre dare posto alla psicologia ma alla psicologia oggettiva: al di fuori del materiale segnico non c’è nulla. La psiche, per sua natura, si localizza tra l’organismo e il mondo esterno. Non è interna all’organismo ma è sul confine. L’organismo e il mondo si incontrano nel segno. L’esperienza interiore non solo può essere espressa solo tramite il segno ma non esiste al di fuori del segno stesso! La filosofia del segno serve sia per la psicologia che per l’ideologia. La psiche “individuale” è per sua natura sociale al pari dell’ideologia.
Le leggi della lingua sono specifiche di connessioni e sono oggettive in relazione a qualsiasi coscienza soggettiva. Le connessioni linguistiche specifiche non hanno nulla in comune con i valori ideologici. Nessun motivo ideologico fonda gli eventi della lingua. Tra parola e significato non c’è né legame naturale né artistico. Gli atti del parlare sono infrazioni e variazioni causali, deformazioni di forme normativamente identiche. Tra il sistema della lingua e la sua storia non c’è legame.
Volosinov critica Saussure. Critica l’oggettivismo astratto. Il sistema si presenta come una indiscutibile preliminare realtà solo per un ipotetico parlante isolato (è quasi dispotico). La coscienza soggettiva del parlante non lavora con la lingua come sistema di forme normativamente uguali. Per il parlante conta L’USO. Uso come centrale per l’esperienza del parlante. Applicazione di una forma identica ad un contesto concreto (è questo l’uso). Il centro di gravità è nel significato concreto nuovo che la forma riceve nel contesto dato. Per il parlante è importante l’aspetto linguistico che diventa segno adatto alla situazione. Forma linguistica importante non come immutabile segnale ma come mutevole segno.
Viene introdotta la nozione di Ideologia quotidiana, che può essere equiparata in parte al Senso Comune (di cui parla Wittgenstein), cioè tutte le cose che diamo per scontate. Volosinov dice che gli enunciati dell’ideologia quotidiana godono, almeno in parte, di innegabilità. I sistemi tuttavia complessi retro-agiscono su ciò che ha costituito sul Senso Comune attraverso l’influenza di ritorno. Il senso comune (ideologia quotidiana) è costituito da diversi strati, per esempio strati superficiali (casuali e momentanei, fluidi e mutevoli) sono esperienze del nostro mondo interiore, pensieri casuali, futili (non solidi, non inutili). Essi sono nati prematuri, incapaci di sopravvivere, “romanzi senza eroi, rappresentazioni senza pubblico”.
La realtà effettiva della lingua-linguaggio è l’evento sociale dell’interazione verbale, realizzato dall’enunciazione. L’interazione verbale come realtà basilare. Il dialogo è solo una delle tante forme dell’interazione (certamente la più importante). Anche un libro è scambio verbale.
La comprensione cerca nella parola del parlante una contro-parola (attrito, lotta, non armonica). Nella comprensione effettiva (non di lingue morte o straniere) si cerca un equivalente. Il significato si trova TRA la parola, non nella parola. Il significato è l’Effetto dell’interazione tra due parlanti.
Sebbene la parola riguardi l’uso che almeno due parlanti fanno, esistono anche degli usi stereotipati, e sono le collocazioni. Partire lancia in resta è una collocazione, cioè un modo di dire, un uso cristallizzato.
Nonostante il termine “collocazione” si sia affermato in area romanza più tardi, la nozione era in parte già presente nella teoria semantica di Eugenio Coseriu, più precisamente nelle cosiddette solidarietà lessicali.
“Una solidarietà lessicale può essere definita come una determinazione semantica di una parola attraverso una classe, un arcilessema o un lessema che funzionano come caratteristica distintiva della parola considerata”.
Per classe si intende l’insieme dei lessemi che sono accomunati da un tratto distintivo in comune. I lessemi che appartengono alla stessa classe si comportano in maniera analoga da un punto di vista grammaticale o lessicale
È un lessema ogni unità che compare in una lingua sotto forma di parola. Un arcilessema è un’unità semantica che equivale al contenuto unitario di tutto un campo lessicale, ossia di un paradigma lessicale che raccoglie varie unità(parole) che si oppongono l’una all’altra per tratti distintivi minimi.
Le solidarietà lessicali sono formate da un lessema determinante (il lessema il cui contenuto è implicato come tratto distintivo in un altro lessema) e un lessema determinato (il lessema che riceve questi tratti distintivi). Il lessema determinato implica il lessema determinante ma non viceversa. Coseriu, in base a questa spiegazione da lui fornitaci, distingue due tipi di solidarietà lessicali:
- Le solidarietà unilaterali: sono caratterizzate da determinazione interna, perché la caratteristica del lessema determinante incluso nel lessema determinato non ha valore oppositivo nell’asse paradigmatico.
- Le solidarietà multilaterali: sono caratterizzate da determinazione esterna, perché il tratto distintivo del lessema determinante si aggiunge al contenuto del lessema determinato, rendendo possibile l’opposizione con altri lessemi sull’asse paradigmatico.
Le solidarietà del primo tipo funzionano solo sintagmaticamente, mentre quelle del secondo tipo costituiscono dei paradigmi. Inoltre, nelle solidarietà unilaterali il lessema determinante è – di solito – assente. Nel caso delle solidarietà multilaterali il lessema determinante è di solito espresso, anche se la sua presenza non è necessaria per capire di cosa si sta parlando.
Coseriu distingue, inoltre, in base ai lessemi determinanti, tra affinità, selezione e implicazione:
- Affinità: La classe del lessema determinante funziona come tratto distintivo.
- Selezione: L’arcilessema dei lessemi determinanti funziona come tratto distintivo.
- Implicazione: Un lessema determinante funziona come determinazione del contenuto di un lessema determinato.
Interessanti sono le osservazioni di Coseriu sull’USO METAFORICO delle solidarietà. Nelle solidarietà si produce – automaticamente – una metafora. Le collocazioni e le solidarietà differiscono, inoltre, sul piano della frequenza, infatti la frequenza è un tratto fondamentale dello studio sulle collocazioni di Corpas. Per Coseriu, invece, la frequenza non ha niente a che fare con le solidarietà lessicali e non è la prova della loro esistenza.
Josef Hausmann propone una definizione di collocazione molto più elegante rispetto a quella elaborata dai contestualisti e, successivamente, dalla linguistica computazionale. L’autore fa emergere alcune caratteristiche essenziali delle collocazioni sia dal punto di vista formale che semantico.
Hausmann dà innanzitutto una definizione: la collocazione è composta da due parole piene. Si tratta di una precisazione assolutamente non scontata dato che solo pochi autori si sono preoccupati di limitare a DUE il numero dei componenti delle collocazioni; tuttora infatti molti parlano di “combinazioni di due o più parole” (come Corpas). Per cui ogni collocazione lessicale si compone, per Hausmann, esclusivamente di due elementi lessicali – non grammaticali – eventualmente intercalati da elementi funzionali quali preposizioni o articoli. In questo modo Hausmann restringe il dominio delle collocazioni, distinguendole da molti enunciati: le collocazioni hanno dunque la dimensione di un sintagma→ ciò significa escludere tutte le espressioni, fisse o libere, che superino la dimensione del sintagma, come proverbi, clichés, e moltissime locuzioni.
Secondo Hausmann il criterio di frequenza introdotto da Bally, poi ripreso da Firth e dai suoi successori, non porta a identificare esclusivamente collocazioni. Dunque per Hausmann la frequenza non rappresenta certo una prova dell’esistenza delle collocazioni.
Dal punto di vista strutturale Hausmann indica sei possibili combinazioni collocazionali, e ne propone degli esempi in tre lingue:
- Sostantivo+aggettivo (epiteto): confirmed bachelor (trad. scapolo incallito)
- Sostantivo+verbo: his anger falls (trad. la sua rabbia si è placata)
- Verbo+sostantivo(oggetto): to withdrow money (trad. ritirare il denaro)
- Verbo+avverbio: it is raining heavily (trad. piovere pesantemente)
- Aggettivo+avverbio: seriously injured (trad. gravemente ferito)
- Sostativo+(preposizione)+sostantivo: a gust of anger (trad. una ventata di rabbia)
- Verbo+preposizione+sostantivo : faire de la temperature (trad. fare la temperatura).
Uno dei problemi cruciali nell’analisi del lessico è quello di stabilire cosa significano le parole. Lo studio di questo aspetto va sotto il nome di semantica lessicale, il compito sembra semplice ma in realtà è molto complesso per due motivi :
- perché la maggior parte delle parole acquistano un significato diverso in dipendenza del contesto in cui si trovano, si usa riferirsi a questo problema come al problema della variabilità contestuale del significato o della polisemia delle parole
- perché il significato delle parole è l’elemento a partire del quale costruiamo il significato delle frasi ma ciò nonostante il significato delle frasi raramente è dato dalla somma del significato delle singole parole.
Quest’ultimo non è proprio l’oggetto di studio la semantica lessicale ma quello della semantica frasale che si occupa di chiarire come si forma il significato delle frasi a partire dalle parole che lo compongono.
I due ambiti sfumano uno nell’altro perché se da un lato le parole contribuiscono con il loro significato a costruire quello della frase, il contesto in cui una parola si trova influenza il suo significato.
Una definizione di contesto è l’insieme di elementi linguistici adiacenti ad una parola quindi l’insieme degli elementi che la precedono o la seguono. Una definizione invece più scrupolosa distingue fra contesto sintattico e contesto semantico, e contesto situazionale e contesto pragmatico. Il contesto sintattico l’insieme degli elementi adiacenti a una parola visti dal punto di vista delle loro proprietà sintattiche. In base all’analisi di queste proprietà è possibile stabilire se il contesto sintattico di una parola sia di tipo nominale verbale o aggettivale. Poi abbiamo il contesto semantico che è l’insieme degli elementi adiacenti a una parola vista dal punto di vista delle proprietà semantiche, vale a dire ciò che le parole significano. Quando le parole si combinano il significato di una influenza significato dell’altra.
Il significato di una parola non è disambiguato dagli elementi linguistici con i quali si combina ma dalla situazione comunicativa in cui l’enunciato che contiene la parola è utilizzato.
L’ambiguità è la proprietà di una forma lessicale di avere più di un significato questa proprietà può essere di due tipi principali:
- il primo tipo è l’ambiguità contrastiva cioè omonimia, è il caso di una forma lessicale che in una lingua ha due o più significati distinti e non correlati fra loro, si chiama contrastiva perché fra i due significati sono contraddittori nella loro natura quindi uno esclude l’altro.
- il secondo tipo è l’ambiguità complementare o polisemia, è il caso di una forma lessicale che ha più significati corrispondenti a manifestazioni diverse dello stesso significato di base in contesti diversi.
I significati di una parola polisemica hanno quindi una relazione più o meno evidente fra loro. La maggior parte delle parole di una lingua sono polisemiche: hanno più di un significato. Questo fatto è conforme alle proprietà della lingua di essere economiche cioè di utilizzare lo stesso materiale per più scopi. Le parole più polisemiche sono i verbi. L’alta polisemia dei verbi è legata al fatto che loro significato è incompleto e viene riempito dagli elementi coi quali formano la frase.
Nonostante la polisemia sia un fenomeno che può apparire casuale specialmente se valutato in relazione a singole parole e a lingue diverse, spostando l’attenzione dalle singole parole all’intero lessico è possibile individuare degli schemi di polisemia
Uno di essi è la metonimia: il significato di una parola si estende per contiguità concettuale a partire dall’oggetto indicato a ciò che entra in contatto con oggetti di quel tipo. La metonimia o la sineddoche sono procedimenti che portano alla formazione dei significati che vengono chiamati estesi.
Un altro procedimento che costituisce una delle risorse principali per le espansioni del significato è la metafora. La metafora è alla base della formazione dei significati che vengono chiamati figurati. Quando si applica una metafora il significato di una parola è reinterpretato per una similitudine che viene istituita fra due situazioni. A seguito di questa similitudine la parola viene usata in un contesto diverso dall’usuale nel quale acquista un nuovo significato non più letterale ma figurato.
L’ambiguità nelle parole e la polisemia sussistono sia all’interno di una stessa lingua sia tra lingue diverse. Da qui nasce la difficoltà nella traduzione. La traduzione è sempre come il dietro di un bell’arazzo, come diceva Cervantes.
La competenza traduttiva è un qualcosa su cui i teorici della traduzione si interrogano da sempre. Non si è giunti ad una vera e propria definizione ma ad una serie di teorie che ci danno l’idea di cosa essa è. Il motivo per cui i teorici non riescono ad arrivare ad una definizione condivisa è che tale competenza traduttiva viene in genere considerata come una sorta di underlying knowledge, una conoscenza di base che sottostà alla transfer (Nord)/ translational (Toury) /translator competence (Kiraly) (nemmeno la terminologia è condivisa) e che costituisce il complemento necessario delle abilità linguistiche nelle due lingue oggetto della traduzione.
Già Newmark (1989) aveva intuito l’importanza della componente (o delle componenti) non linguistica della competenza traduttiva, definendo “intelligenza” quell’underlying knowledge come qualcosa di innato, che l’esperienza può certo migliorare ma non mutare nella sostanza. Harris affermò successivamente la natura innata di tale qualità. Toury introdusse la nozione di “native translator”. Stessa linea di pensiero era quella di Vannerem e Snell-Hornby che affermano che: memoria, intelligenza, sensibilità linguistica, senso di responsabilità, capacità di pensare in maniera dinamica e creativa sono qualità che si possono alimentare nella sostanza ma non certo ricreare ex novo in un individuo.
Tuttavia, non tutti concordano con l’idea che la competenza traduttiva sia innata; in particolare: Hönig argomenta la sua posizione riprendendo la “mapping theory” di Holmes. Per Holmes vi è l’esistenza di una macrostruttura, di un multi-level process, che diventa in Hönig una “central processing unit”: grazie ad essa il testo in una traduzione viene “spostato” dal suo ambiente naturale e proiettato nella realtà mentale del traduttore, che opera a due livelli o meglio, per utilizzare la terminologia di Kiraly, in due diversi “workspaces” (controlled e uncontrolled).
La prima comprensione del testo da parte del traduttore ma così come buona parte dell’attività traduttiva ha luogo nell’ “uncontrolled workspace”ed è, quindi, difficile dar conto di essa (Think-Aloud-Protocols). Hönig poi suggerisce che i prodotti dell’attività mentale condotta dal traduttore nell’uncontrolled workspace della memoria a lungo termine sono soggetti ad un monitoring che ha luogo nel controlled workspace della memoria a breve termine. Quindi essendo la macro-strategia per lui fondamentale, Hönig attacca quindi l’idea del native translator. Infatti le strategie di problem-solving sono parte integrante di ogni traduzione. Hönig suggerisce di ribattezzare la “innate translation competence” con il nome di “transfer competence” e di utilizzare il nome “translation/translatory competence” per la competenza strategica che invece può essere acquisita.
Dal canto suo Pym afferma che è normale che servano anche conoscenze grammaticali, retorica, terminologia, computer skills, world knowledge, strategie e così via, ma la parte traduttiva non è strettamente legata solo alla lingua, è un processo di generazione e selezione, un processo di PROBLEM-SOLVING. Tradurre richiede una serie di competenze non facilmente definibili e che è possibile acquisire solo nel tempo e che vanno sempre coltivate anche quando si crede di aver raggiunto un certo grado di esperienza.
La transfer competence può essere anche acquisita e non è per forza innata, ciò perché ogni evento comunicativo è traduzione. Hönig suggerisce che il traduttore può lavorare in maniera efficace solo se ha la consapevolezza del suo ruolo sociale, culturale e comunicativo. La competenza traduttiva non è una cosa che si acquisisce una volta per tutte, ma a cui bisogna costantemente lavorare.
Non c’è niente di definitivo e ogni traduzione è diversa, non c’è una conoscenza fissa in questo campo. Non esistono traduzioni migliori o peggiori ma solo più o meno efficaci, cioè adatte allo scopo per il quale sono state richieste, al pubblico al quale sono destinate e così via. Ed è per questo che è importantissimo indirizzare le scuole verso la traduzione intralinguistica, ossia verso la capacità di riformulare testi. Tale capacità presuppone l’attivazione di procedure metacognitive di pianificazione dell’intervento richiesto che sono estremamente preziose per il lavoro del traduttore.
Il lavoro del traduttore diventa sempre più difficile se il testo è antico. Pensiamo alla Bibbia. Per il canone cattolico la Bibbia è composta di 73 libri: 46 l’Antico Testamento e 27 il Nuovo. L’Antico Testamento è scritto in ebraico, aramaico e greco, il Nuovo interamente in greco. L’Antico Testamento è stato scritto durante tutto il I millennio a. C., mentre il Nuovo nel I secolo d. C.
Si tratta di testi che presentano molti problemi linguistici e filologici, che la traduzione non può rendere. In Genesi 17, 1 è scritto: “Abramo aveva 99 anni, quando Dio apparve ad Abramo e gli disse: Io sono l’Onnipotente, cammina davanti a me e sii pio“. Il termine che al seguito della Bibbia di Lutero si suole tradurre con “pio” (tāmim) significa propriamente “completo”, “perfetto”, ma non nel senso di una perfezione morale; si riferisce piuttosto al rapporto verso Dio, al suo carattere incondizionato e indiviso. L’esigenza che qui è espressa è quella di Deuteronomio 18, 13: “Sii tutto completamente del tuo Dio”.
In Esodo 3, 1-12 c’è il racconto del roveto ardente. Mosè vede un rovento che non si consuma, quindi riceve il dono del nome di Dio. Dallo studio minuzioso della lingua di questo racconto si sono capite cose che non si notano in traduzione. Secondo l’ipotesi documentaria, i primi cinque libri della Bibbia, cioè il Pentateuco, tra cui il libro dell’Esodo, sarebbero stati scritti riunendo 4 fonti, denominate con queste sigle: E, D, J, P. Queste quattro tradizioni si riconoscono in quanto hanno dei particolari che le caratterizzano: per esempio, le prime due si riferiscono al monte di Dio con Horeb, le altre due con Sinai. Probabilmente le prime due non usano il nome Sinai in quanto richiama una divinità straniera, il dio mesopotamico Sin. Ma Gunkel arrivò a sostenere che il nucleo originario del Pentateuco non sono le 4 fonti, che pure esistono, bensì delle leggende orali. Su questa linea, il racconto del roveto ardente dimostra che il Pentateuco non è stato scritto fondendo diverse tradizioni, ma che vi era un nucleo originario il quale poi è stato riscritto da una particolare tradizione, una delle quattro che abbiamo menzionato, la quale lo ha “trasformato” secondo il proprio orientamento.
Come hanno fatto gli studiosi a capirlo? Il testo in questione sembra giocare sulla assonanza tra il nome “roveto” (in ebraico sene) e il nome Sinai. Infatti alla fine della storia, al verso 12, c’è una chiara allusione: “Va’, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato: quando avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, voi servirete Dio su questo monte”. Il segno è questo: Mosè vede il roveto (sene) ardente e, quando avrà fatto uscire il popolo dall’Egitto, essi serviranno Dio sul monte Sinai. Il testo dà per scontato il nome Sinai, ma nel racconto non compare, infatti, al verso 1, c’è l’altro nome del monte, quello di Horeb. Come mai nel racconto c’è una chiara allusione al Sinai ma per designare il monte si usa un altro nome? I filologi ipotizzano che questo racconto non nasca da una o più delle quattro tradizioni perché è inverosimile che una tradizione che non contempla il nome Sinai per non accostarlo al dio Sin, abbia poi del materiale a cui vi allude (sene/Sinai). Allora il materiale originario del Pentateuco non è costituito dalle 4 fonti citate, ma da dei racconti orali che queste fonti hanno riscritto in qualche modo. Pertanto, ci deve essere stata una leggenda orale che alludeva al Sinai mediante il sostantivo sene, e in seguito una delle tradizioni a cui abbiamo fatto riferimento, ha messo per iscritto tale racconto secondo alcuni schemi linguistici, letterari e teologici che le erano propri. È stata una tradizione che non accetta il nome Sinai, quindi è stata E oppure D. Ci sono altri indizi che fanno propendere verso la fonte E.
In Esodo 3, 14 Mosè domanda a Dio il nome e Dio risponde con queste parole ebraiche: Ehyeh asher ehyeh, “io sono (ehyeh) colui che (asher) sono (ehyeh)”. In realtà si tratta di una espressione intraducibile per via della sua ricchezza polisemica. In essa è possibile notare queste ambiguità:
- il verbo all’yiqtol può esprimere un passato oppure un presente durativo (sono solito essere) oppure un futuro;
- il verbo all’yiqtol esprime anche diverse forme di modalità: posso essere, potrei essere, devo essere, voglio essere, vorrei essere, …;
- la costruzione “io sono chi sono” può esprimere sia la indeterminatezza (sarò chiunque sarò) sia l’intensificazione (è ciò che sarò che sarò);
- la frase può essere sia una asserzione sia una promessa.
In Deuteronomio 5, 23 è scritto: “All’udire la voce che proveniva da dentro le tenebre, mentre il monte avvampava nel fuoco, vi avvicinaste a me con tutti i vostri capitribù e i vostri anziani”. Il verbo ebraico “vi avvicinaste”, wattiqerbun ‘ela, è talmente polisemico che esprime tre concetti, impossibili da rendere in italiano: un avvicinamento spaziale, cioè un movimento fisico degli israeliti; una richiesta giuridica; nel versetto 27 questo verbo comunica l’elezione carismatica di Mosè per farsi intermediario tra Dio e il popolo, quindi il verbo in questione veicola anche una sfumatura iniziatica.
In Giosuè 10, 24 c’è una immagine tipicamente orientale, si tratta di una collocazione: “Mettete i vostri piedi sul collo di quelli”. La traduzione non può rendere la pregnanza della espressione. Porre i piedi sul collo è un gesto che nell’iconografia orientale simboleggia la sottomissione e la disfatta; a differenza delle rappresentazioni antiche, qui non è il re a compiere il gesto ma i capi militari.
I filologi biblici compiono un lavoro al microscopio nello studio di questi testi antichi. La Bibbia non finisce mai di dire quello che ha da dire, quindi non si finisce mai di studiarla. Certamente questo è vero soprattutto dal punto di vista linguistico, il verbo infatti ha spesso valori ambigui e polisemici, ma anche in relazione ai realia, cioè ai dati extratestuali che forniscono sempre nuova luce ai passi biblici. In Giosuè 8, 30 si racconta che Giosuè costruì un altare a Dio sul monte ‘Ebal. Questo episodio è introdotto dalla particella “allora” (‘az) seguita da un yiqtol in una sequenza al passato: questa costruzione non dice niente in traduzione (“Allora Giosuè costruì un altare”), ma per i filologi vuol dire che l’episodio dell’altare non è originale, ma è stato una inserzione tardiva. Inoltre si è proposto di associare questo passo alla recente scoperta sul monte ‘Ebal di una rilevante struttura del Ferro I (XII a. C.), che i responsabili dello scavo hanno identificato come luogo di culto, forse un santuario regionale.
Il libro di Rut è scritto in un ebraico biblico molto limpido, per questo viene spesso letto in originale da chi si accinge a impararlo. In Rut 2, 13 Rut dice: “Ti ringrazio, signore, perché mi hai consolata”. Ma questa traduzione non rende la ricchezza dell’originale ebraico, dove vi è un yiqtol, quindi bisognerebbe tradurre “Possa trovare (ancora) grazia ai tuoi occhi”. Infatti l’uso di questo modo del verbo ebraico fa pensare a un trovar grazia rivolto al futuro. Il verbo è in prima posizione, quindi è volitivo, iussivo.
In Esdra 1, 1 si dice che Dio “spinse” il re Ciro a promulgare un decreto nel quale faceva ritornare gli ebrei nella loro patria, la Palestina, dopo l’esilio a Babilonia. Ma l’originale ebraico è letteralmente “fece alzare lo spirito di Ciro”. L’originale ha una pregnanza particolare, perché lo spirito è quello infuso da Dio in ogni uomo al momento della creazione, quindi l’espressione ebraica vuole sottolineare la signoria di Dio su quanto esiste, sulla storia e su ogni uomo in particolare.
In Isaia 19, 6 è scritto: “si svuoteranno e seccheranno i Nili di Masor”. Il Nilo era uno solo ma qui è al plurale per indicare i canali laterali e il Delta. Isaia si riferisce al mancato straripamento estivo del Nilo, un mistero anche per Erodoto: di solito il Nilo debordava durante l’estate garantendo la fertilità del terreno e la prosperità dei raccolti. Sorprende il nome māṣor per l’Egitto. La forma corrente è miṣrajim, che è un duale, per indicare Basso e Alto Egitto. Usando questa forma unica Isaia probabilmente intende dire l’unico Egitto, cioè il Basso Egitto, dove sfociava il Nilo. L’Alto Egitto era quello da dove sgorgava il Nilo, il Basso invece era il Delta, zona particolarmente fertile e che, in caso di non straripamento del fiume, ne avrebbe risentito di più.
L’ebraico biblico è una lingua semitica, mentre l’italiano è una lingua neolatina appartenente a quelle indoeuropee. Gli antichi semiti ragionavano in maniera molto diversa dalla nostra e anche la lingua ne risente. L’ebraico biblico è una lingua povera (conta solo 5750 vocaboli) e arcaica (non ha un vero sistema ipotetico, ama la paratassi). L’Antico Testamento non è un’opera immensa (conta solo 305.441 parole ebraiche e aramaiche, escludendo i 7 libri in greco).
L’ebraico biblico presenta molti giochi di parole, assonanze e allitterazioni, soprattutto in poesia, che nella traduzione non è possibile rendere. Nel cantico di Debora si suole imitare lo zoccolo dei cavalli che calpestano il terreno (Giudici 5, 22), mentre il Qoelet ironizza sul “riso dello stupido simile a un crepitio di pruni sotto una caldaia“ (7, 6), creando attraverso un gioco fonetico di sibilanti l’effetto del crepitio e del sibilo.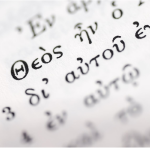
Per quanto riguarda i libri in greco dell’Antico Testamento, per alcuni di essi si pensa che il greco non sia la lingua originale, ma quella di traduzione da un originale ebraico o aramaico. Guardiamo solo al libro di Giuditta, dove nel primo capitolo è scritto che Nabucodonosor mandò messaggi a vari abitanti e anche a “quelli tra le popolazioni” (versetto 8: in greco tous en tois ethnesi) del Carmelo e di Galaad. Gli studiosi osservano che la parola “popolazioni” suona strana. In quei luoghi non vi erano altre etnie. Quindi, ipotizzando un originale ebraico, i filologi pensano che il presunto traduttore abbia sbagliato a leggere: l’originale doveva essere be-‘are (“tra le città”) e lui capì be-amme (“tra le popolazioni”). Invece chi reputa il libro di Giuditta scritto originariamente in greco, intende queste “popolazioni” come un semitismo, cioè una espressione influenzata dalle lingue semitiche parlate allora, come l’ebraico o l’aramaico: “popolazioni” sono i gentili o i pagani, come nei libri dei Maccabei e nel Nuovo Testamento.
A differenza dell’ebraico biblico, quello rabbinico o mishnico fu a lungo poco considerato. Si dovette attendere il 1812 perché Solomon Löwisohn si ponesse in un suo studio la domanda: cos’è l’ebraico mishnico? Più tardi, nel 1845, Abraham Geiger, rabbino e illuminato, compilò la prima grammatica, in due volumi, di questa forma di ebraico tardo. Lui però giunse alla conclusione che l’ebraico mishnico altro non fosse che aramaico ebraicizzato, una lingua artificiale. Studi successivi, come quelli di Segal, autore di una fondamentale grammatica dell’ebraico mishnico, hanno rovesciato questa impostazione e visto nell’ebraico mishnico una forma di lingua, se non propriamente viva (nel II sec. d. C. sarebbe stato difficile) per lo meno attivamente usata.
L’ebraico mishnico ha molte particolarità rispetto all’ebraico biblico. Presenta un incremento significativo nell’uso delle matres lectionis. Per il possesso si formano forme proclitiche o indipendenti della particella sel, “di”. Uso del suffisso –an per esprimere l’agente di una azione (gozlan, “ladro”). Il plurale maschile è spesso –in, come in aramaico. Alcuni nomi maschili prendono al plurale –ot del femminile. La forma pu’al dell’ebraico biblico è quasi del tutto scomparsa. Nella coniugazione a suffissi il hitpa’el è sostituito dal nitpa’el, che esprime un senso riflessivo-passivo. Alcuni studiosi hanno sostenuto l’esistenza di un nuf’al a fianco del nif’al. Vi sono alcuni cambiamenti minori nel significato delle forme verbali (coniugazioni derivate).
L’ebraico mishnico trae il nome dalla Mishnà, il complesso di norme, dottrine elaborate tra il II secolo a. C. e il II d. C. per applicare la Legge di Mosè contenuta nella Bibbia. Il commento alla Mishnà è detto Talmud, di cui si hanno due versioni: una palestinese e una babilonese, entrambe scritte in aramaico.
I testi cambiano a seconda dell’area concettuale di riferimento, una delle classificazioni canoniche è quella in base al dominio di appartenenza, per cui si parla di testi letterari, medici, giuridici e così via. I testi si diversificano poi assumendo caratteristiche diverse a seconda dello scopo, del contenuto e dei partecipanti all’evento comunicativo: la lingua vi assumerà di conseguenza caratteristiche stilistiche dipendenti da tutti questi fattori.
Le caratteristiche che un testo assume dipendono prevalentemente dalla motivazione che ha spinto l’autore a crearlo: il perché influenza il come. Lo scopo da assolvere determina un tipo testuale, che a sua volta si concretizza in una categoria di genere.
Quindi le tipologie testuali vengono individuate non solo in base al contenuto ma anche in base alla funzione comunicativa che assolve e sono state proposte diverse classificazione di testi. Vari autori hanno messo in correlazione le tipologie testuali con la traduzione.
Prestiamo attenzione in particolare al contributo di Reiss. La sua teoria considera il testo come unità di traduzione e non la parola o la frase. È il testo nella sua complessità e completezza che diventa unità di traduzione. Altri proponevano parole o gruppi di parole oppure unità di traduzione come unità di senso/significato e unità lessicale. Secondo Reiss a ogni tipologia testuale corrispondeva una modalità del tradurre diversa e questa modalità traduttiva in realtà è in relazione alla funzione dominante del testo di partenza. “La trasmissione della funzione dominante del Testo di partenza (TP) è il fattore determinante secondo il quale il Testo di arrivo (TA) viene giudicato”, ciò significa che la traduzione deve rendere giustizia al testo di partenza, in particolar modo alla funzione, all’ intenzionalità comunicativa dell’autore/mittente.
Reiss prende in prestito la tripartizione delle funzioni linguistiche di Bühler, quindi considera che i testi possano avere una funzione:
- informativa: che rappresenta oggetti e fatti (es. testi argomentativi o tecnico-scientifici, manuali);
- espressiva: esprime l’atteggiamento del mittente (es. testi letterari);
- conativa: tenta di attrarre il ricevente di un testo (es. testi pubblicitari, discorsi politici).
Per quanto riguarda la funzione informativa, il fulcro è trasmettere il contenuto del testo e farlo nella maniera più esplicita possibile e se non è interamente intellegibile, è necessario esplicitare i passaggi più ambigui.
La funzione espressiva ha una dimensione principalmente estetica ed è incentrata soprattutto sulla forma del testo, in questo caso la traduzione deve trasmettere la forma estetica del testo e il metodo traduttivo associato da Reiss è un metodo di tipo identificativo. Quando si traducono dei testi letterari, il metodo che deve adottare il traduttore è quello di identificarsi nell’autore, immedesimarsi nell’autore e adattarsi alla sua prospettiva, lo sforzo del traduttore è quello di individuare l’intenzionalità comunicativa del mittente, cercando di riprodurre l’intenzionalità comunicativa in modo assimilabile a quello dell’autore.
I testi operativi hanno funzione appellativa, generalmente hanno una dimensione linguistica dialogica perché si rivolgono direttamente al destinatario e la traduzione deve ottenere la reazione desiderata seguendo il metodo adattivo.
Nell’Antico Testamento gli autori dei vari libricini non usano una funzione in maniera fissa, è infatti possibile trovare testi storici (funzione informativa) ma che vengono usati per esortare (funzione conativa) e con pretese letterarie (funzione espressiva). Stesso discorso per il genere letterario in una singola funzione. Molti testi letterari della Bibbia ebraica appartengono a più generi, come i salmi, in ognuno dei quali vi è spesso sia la lode sia la supplica oppure sia la lamentazione sia la supplica.
In ogni modo la scrittura biblica ha delle peculiarità che la rendono unica. Beauchamp notava come la Legge tende a cercare un archetipo nella storia che origina la norma; il profeta attualizza il precetto divino nell’esperienza di adesso; il sapiente lo intende come un sempre dell’esperienza quotidiana. Tre generi e tre tempi diversi: prima, adesso, sempre.
Lo stesso geniale autore riconosceva in tre sezioni dell’Antico Testamento (Deuteronomio, primi 9 capitoli dei Proverbi, Isaia 40-55) un fenomeno concettuale e stilistico da lui denominato “deuterosi”, cioè un discorso che ritorna su sé stesso in maniera ridondante. Nel Deuteronomio si dice di osservare la Legge di Dio perché è la Legge; nella sezione dei Proverbi di acquistare la Sapienza perché è la Sapienza; in Isaia di osservare la Parola di Dio perché Dio parla.
Newmark mette in correlazione tipologie testuali e traduzione. È un teorico famoso perché si è occupato di formazione dei traduttori. Secondo lui i testi possono avere:
- funzione informativa
- funzione vocativa o argomentativa –
- funzione espressiva.
Ma i testi possono avere sempre un’unica funzione? Secondo Newmark no: infatti, possono avere una funzione dominante ma possono avere anche altre che nel tempo possono cambiare. Di solito le opere di narrativa hanno funzione espressiva ma possono essere anche usati per trasmettere idee e convinzioni, persuadere, argomentare. Pensiamo, oltre alla Bibbia, anche ai promessi Sposi di Manzoni, dove la storia di Renzo e Lucia non vuole solo dilettare ma anche convincere sui valori evangelici.
Un altro argomento interessante è la differenza tra generi testuali e tipologie testuali. I generi testuali sono:
- una particolare configurazione dell’atto linguistico
- una modalità espressiva, la forma che I parlanti danno ai loro testi scritti e orali
- eventi comunicativi della vita di tutti i giorni (es. esame orale, forma comunicativa che si svolge in forma dialogica e in questo senso può essere considerato un genere testuale).
Una determinata situazione comunicativa determina una tipologia testuale e questa si concretizza in un genere testuale che è più o meno standardizzato, riconoscibile all’interno di una data comunità. Talvolta tipologia testuale e genere testuale vengono usati come sinonimi e quindi confusi. Ma bisogna precisare:
- le tipologie testuali si concretizzano in forme diverse a seconda del contesto d’uso (si identificano in base alle caratteristiche formali dei testi – criteri interni – categorie universali), ovvero in base a variabili di ordine linguistico, culturale, sociale e pragmatico
- il genere invece dipende da variabili esterne, ossia a criteri riconducibili a distinzioni e classificazioni insite nella cultura della quale il testo è espressione (criteri esterni – categorie variabili in base alla cultura).
L’esame orale è un genere testuale in riferimento alla nostra cultura, invece quando i filosofi antichi insegnavano e interrogavano all’aria aperta il discorso dell’allievo non era inteso come un “esame” ma come una conversazione. L’esame orale è quindi una tipologia testuale in quanto presenta criteri interni riconducibili a un testo discorsivo e non meglio formale come il proclama di un capo di stato o le direttive di un capogabinetto.
Bibliografia
- P. Beauchamp, L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Brescia 1985;
- F. Bianchi (a cura di), Esdra Neemia. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2011;
- F. Dalla Vecchia (a cura di), Giosuè. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2010;
- F. Dalla Vecchia (a cura di), Giuditta. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2019;
- B. Di Sabato, E. Di Martino, Testi in viaggio. Incontri fra lingue e culture, attraversamento di generi e di senso, traduzione, Torino 2011;
- H. W. Hertzberg (a cura di), Giosuè, Giudici, Rut. Traduzione e commento, Brescia 2001;
- E. Jezek, Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna 2011;
- O. Kaiser (a cura di), Isaia (capitoli 13-39). Traduzione e commento, Brescia 2002;
- F. Longobardi, Le affinità del lessico, Napoli 2018;
- A. Niccacci, M, Pazzini, Il rotolo di Rut. Analisi del testo ebraico, Jerusalem 2008;
- G. Papola (a cura di), Deuteronomio. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2011;
- G. Ravasi, Antico Testamento, Milano 1991;
- A. Rofé, Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica, vol. 1 (Pentateuco e libri storici), Brescia 2011;
- A. Sàenz-Badillos, Storia della lingua ebraica, Brescia 2007;
- G. Von Rad (a cura di), Genesi. Traduzione e commento, Brescia 1978;
- V. N. Volosinov, Marxismo e filosofia del linguaggio, Bari 1976.







