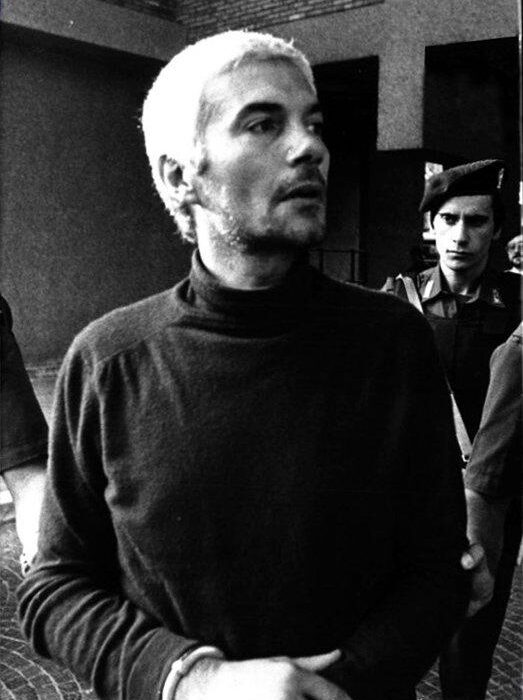Sandro Bonvissuto, nel suo Dentro (Einaudi), prova a parlare del carcere.
Ne dà una descrizione dura, cupa, quasi strangolata dal male che ci trova, dentro. Un male fisico: di pietra, di cemento. Impastato del misto di sudori che imbeve i cuscini nelle celle e costringe il protagonista ad avvolgere il proprio con la maglia per potercisi appoggiare sopra e dormire. Tra le righe del racconto c’è tutta l’asfissia di dentro.
Non c’è, però, un’intelligenza completa di questo stranissimo inferno, troppo umano e troppo sconveniente da narrare. Perché il carcere è un’imprecazione: per quanto poco di straordinario ci sia lì dentro. È la conferma che la vita è sempre quella: caos e mucchio (a parte i miracoli in cui fidava il poeta meno illuso del Novecento, Montale). Mai che ti regali una scansione netta delle cose, per cui se non ti va bene il bianco c’è il nero a consolarti, a (cor)risponderti.
La galera è semplicemente grigia. Come il mondo di fuori. Non è che se fuori è lo schifo a imporsi, dentro ci siano quelli che, opponendosi allo schifo, siano diversi, di un’altra pasta. Proprio no. Di ottimismo e pietas è bene essere parsimoniosi. L’orrore della galera non è il muro, che Bonvissuto investe di un significato fatale. Non è il tempo immobile che può volgere in minuti i tuoi pensieri, come immaginava Shakespeare nel Riccardo II. È la fauna che pullula, dentro. Il mondo di fuori che si rovescia immutato, dentro.
Uno che ha letto Jünger: «Meglio un criminale che un borghese» – se gli capita di finire dentro, cosa fa? Si dispera? Macché. Pensa subito di poter organizzare una banda. Un seminario, addirittura, di ribellione. Sbagliato. Sbagliatissimo. Povero illuso. Il detenuto, il coatto, spesso è ancora più vigliacco e piagnone del suo alter ego di fuori. Sono tutti innocenti, dentro. Tutti vittime di drammatici errori giudiziari. Scorrono fiumi di lacrime, dentro. E fioriscono, vegetazione malata, le stesse invidie cieche di fuori: di un’aula di scuola, di un asilo, di un ufficio, di una faida familiare. Lo stesso malanimo, esaltato fino al parossismo dalla promiscuità. Striscia per i corridoi, incupendoli. Rende gli stanzoni irrespirabili. I muri li abbracceresti, purché ti separassero da tutti.
Per me, la beatitudine, in galera, è la cella singola. E la vera tortura è la nuova pedagogia che impone i momenti di socializzazione. Raccontare del carcere per filo e per segno vorrebbe dire sparare alzo zero contro tutte le teoriette attuali che rifiutano di ammettere che il carattere dell’uomo è il suo destino. Lasciare da parte la beata illusione che il bene si possa insegnare, indurre, anche in assenza di predisposizione naturale. Ecco, per questo Bonvissuto non ha proprio il fegato. O l’esperienza del malvissuto.
Preferisce disegnare graziosi arabeschi gnomici, sentenziosi, che però della notte del tremendo non raccontano nemmeno il crepuscolo e subito si disfano in nulla. Come quelle fiammelle, «vaghissime», che a San Vittore erano il codice dell’amore a distanza. Tra la sezione maschile e quella femminile c’era un cortile largo. Ci si vedeva appena, sagome deformate dai capricci delle mattonelle di vetro. Ma in carcere il bisogno è tanto e l’ingegno più che acuto.
Pari a quello di Puccini quando inventò la propria opera più buia, Il tabarro. Lì, la luce del fiammifero rischiara la desolazione dello scaricatore di porto e della sua vogliosa amante; poi tradisce lei, che si consegna al dentro del tabarro del marito per essere uccisa.
Là, in galera, l’accendersi del fiammifero comunica lo sbocco sorgivo del piacere, vittoria mutilata dalla distanza, dall’assenza.
Infuocarsi, allora, non è retorica: è conio dantesco, come «imparadisare », «indiarsi», «inmillarsi ». È diventare fuoco, fuocherello, fuoco più fatuo che mai, fuoco di fiammifero, perché non c’è altro spazio dove stare, dove raccogliersi, tra i mille muri di dentro.