Gabriele d’Annunzio… Solo a pronunciare questo nome, si affollano al nostro spirito immagini, sensazioni, idee. Il poeta-soldato, anzi il poeta-eroe – come lui preferiva definirsi – non lascia nessuno indifferente. Sembra un luogo comune, ma il nome d’Annunzio fa emergere dalla nostra anima sentimenti profondi. Ed è bene subito dire che per qualche decennio, dalla fine della seconda guerra mondiale, Gabriele d’Annunzio nella nostra Italia è stato catalizzatore di denigrazioni e di sarcasmi. Egli è stato visto come un autore decadente, ammalato d’estetismo torbido e di retorica, afflitto da sentimenti esasperati d’amor patrio, esaltatore della guerra, antistorico cultore della grandezza di Roma e di Venezia. La sua impresa di Fiume è stata poi descritta sia a tinte fosche sia con i colori di un’operetta grottesca. D’Annunzio è stato visto come un provinciale, affascinato dagli ambienti dei ricchi e dei nobili. Ed è stato dipinto anche come un personaggio torbido e amorale, per le sue numerose avventure femminili. In sintesi: il personaggio d’Annunzio è stato visto come in bilico perenne tra l’eccesso e il ridicolo, tra il superuomo magniloquente e il damerino incipriato.
Tanti anni dopo, un fatto paradossale avveniva nella Repubblica fondata sul lavoro: nel vuoto creato dallo sfratto di d’Annunzio, amatore di stuoli di donne belle ed eleganti, e idolo di giovani avventurosi, si installava sugli altari un’icona sacra: Pier Paolo Pasolini, amatore anch’egli indefesso, ma non di donne dell’alta società, bensì di torvi giovani e giovinastri proletari, i cosiddetti ragazzi di vita. Pasolini è stato campione di un nuovo moralismo che vedeva nei valori della bandiera nazionale il segno di una pericolosa involuzione dello spirito. Erano i tempi in cui anche un moderato, blando patriottismo – espresso nei confronti della patria italiana e non di quella nord-vietnamita o di quella della Cina di Mao – era bollato con la paralizzante accusa di “fascismo”. Tra i tanti giudizi negativi, provenienti essenzialmente da uomini di parte, citerò i seguenti. Natalino Sapegno ha scritto : « Il posto che compete [a d’Annunzio] è piuttosto tra i minori che non tra i grandi. » Scarano Lugnani lo definisce: « L’esempio storico, forse più macroscopico del Novecento, del letterato esplicitamente organico alla classe dominante. »
Le enciclopedie straniere invece, perché aliene da faziosità di parte, riescono a darci di d’Annunzio un ritratto sintetico più giusto. Leggiamo così nell’ultima edizione dell’Encyclopedia Britannica: « Autore italiano, eroe militare, e leader politico, Gabriele d’Annunzio fu scrittore d’Italia nel tardo diciannovesimo e agli inizi del ventesimo secolo. La sua carriera colorita, le sue relazioni scandalose, la sua audacia in tempo di guerra, la sua eloquenza e le sue doti politiche di leader fanno di lui uno degli uomini più straordinari del suo tempo. » Pierre de Montera, nell’enciclopedia francese Universalis, esprime sul poeta e uomo d’armi pescarese un giudizio profondo: « I suoi detrattori potranno avere facile gioco nel rimproverargli il suo erotismo, amoralità, dilettantismo, le sue pose, gli eccessi del suo pensiero, il pericolo di concezioni che hanno fatto di lui il bardo del nazionalismo. Nondimeno, l’ampiezza della sua cultura, la diversità del suo talento, le risorse inesauribili della sua immaginazione, la potenza del suo verbo, la perfezione della sua lingua, gli assegnano un posto a parte, quello di uno scrittore eccezionale. Ha votato il suo genio al culto del bello : egli è poeta e artista, e lo è sovranamente. » Tra gli altri giudizi positivi citerò quello di Eugenio Montale. Il poeta genovese ha affermato che a d’Annunzio devono qualcosa tutti i poeti e gli scrittori contemporanei, anche quelli che ne sembrano più lontani.
A casa mia il nome Gabriele d’Annunzio, quanto più indietro io riesca ad andare, ha sempre evocato un personaggio mitico e leggendario, ma nello stesso familiare perché vicinissimo al nostro cuore. È bene che lo dica subito: io e i miei siamo originari dell’Istria, di quella terra del confine orientale che oggi non appartiene più all’Italia in conseguenza dell’esito della seconda guerra mondiale. L’Istria, Fiume e la Dalmazia sono le terre irredente che tanta parte ebbero nella vita di Gabriele d’Annunzio. Il ricordo più lontano che mi colleghi al poeta pescarese e alla sua vicenda di uomo d’armi, comandante dei legionari fiumani, è di me bambino – non avevo più di sette anni – che cantavo sul sagrato di una chiesa nel bosco di Capodimonte, a Napoli, dove vivevo, nel dopoguerra, con i genitori e la sorella in una baracca del campo profughi, lì situato. La canzone diceva, se la memoria mi è fedele : « O Fiume tu sei la più bella ! O Fiume tu sei la più forte ! Porteremo i cannoni alle porte, per difendere, per difendere la libertà. Saliremo sul monte Maggiore, sentiremo la banda suonare e se d’Annunzio ci darà il comando… » Io la cantavo, all’uscita della messa, a beneficio degli altri profughi, divertiti e forse anche un po’ commossi. Questa è una delle canzoni dei legionari fiumani, che, capitanati da d’Annunzio, marciarono su Fiume nel 1919 per rimanervi fino al 1920.
È inutile nascondere questa mia intima riconoscenza verso il nostro poeta-soldato pescarese, perché io sono rimasto fedele a quelle terre – Istria, Fiume, Zara – su cui non sventola più il tricolore italiano, e da cui più di trecentomila italiani sono dovuti venir via in seguito all’“ethnic cleansing” ai nostri danni: la pulizia etnica avvenuta nel sangue, tra episodi d’inaudita ferocia. Dicevo che, essendo rimasto io fedele a quelle terre, sono rimasto anche fedele al Comandante. E sarà per l’egoismo che la nascita ci dà piantandoci in un suolo – il suolo patrio – e ponendoci in un momento storico, e costringendoci a fedeltà che per taluni di noi sono indefettibili, io non riesco a vedere Gabriele d’Annunzio come lo hanno visto per tanti anni i suoi detrattori. Devo anche aggiungere che io ho amato ed amo non solo il d’Annunzio soldato, audace aviatore e autore dell’impresa di Fiume, ma il d’Annunzio prosatore e poeta. Il suo « Settembre andiamo… » parla al mio cuore come non lo fa nessuna altra poesia, anche perché io ho vissuto per cinque anni nella terra d’Abruzzo, da convittore, a Teramo, e quindi mi sento legato a quelle terre. Il suo romanzo « Il trionfo della morte » ha esaltato l’inquietudine della mia adolescenza. Ne ricordo ancora la chiusa : « In una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un odio supremo. E precipitarono nella morte avvinti. » Mia sorella poi ha girato con Visconti un film basato sull’Innocente. Altri elementi di comunanza, pur se lievi, con il poeta di Pescara sono numerosi. Egli risiedette per un periodo a Napoli, in Viale Elena, e si recava spesso al caffè Gambrinus. Capodimonte lo vide spesso passeggiare lungo i viali del suo romantico bosco. Io ho conosciuto tutti quei luoghi più che bene, in epoca beninteso molto posteriore alla sua. Ma la vicinanza col poeta-soldato è dovuta soprattutto al fatto che a casa mia e negli ambienti dei profughi giuliani il nome di d’Annunzio era sempre pronunciato con amore e ammirazione.
Fu un balsamo per me scoprire in un’enciclopedia – non italiana – che consultai in biblioteca, dopo poco tempo che mi trovavo qui a Montreal, emigratovi dall’Italia, che d’Annunzio era considerato oltre che un grande uomo di lettere un soldato dall’incredibile coraggio, autore di imprese di guerra straordinarie. Dopo essermi sorbito per tanti anni i pregiudizi riduttivi e denigratori di una critica italiana fortemente politicizzata a senso unico, finalmente constatavo che il volto patriottico e guerriero del Vate pescarese era riconosciuto nel suo giusto valore da chi non subiva le pesanti ipoteche del conformismo vigente nella Repubblica dei partiti. Molto prima che, in Italia, la memoria del poeta-soldato fosse oggetto di tentativi di ridicolo, vi fu chi cercò di rimettere Italiani e cultura italiana al loro posto. Al discorso con cui, il 5 maggio del 1915, sullo scoglio di Quarto, il trascinante oratore diede la spinta risolutiva all’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria (cui era legata dalla Triplice alleanza), Josef Hofmiller – giornalista-scrittore tedesco molto noto all’epoca – reagì con questo scritto : « E questi strilloni italiani credono di dover difendere la causa della cultura contro noi barbari ? Non la conosciamo forse, la loro cultura ? Piroetta qua e là vestita con sordida eleganza, scarpe lustre, capelli impomatati, profumata come una bottega di barbiere, ciondolando dal caffè al cinema, dal cinema al bar, dal bar al caffè, conosce la doccia per sentito dire, il bagno di mare come gioco di società, l’alpinismo come scampagnata irredentista, apprezza gli uccelli da canto dal punto di vista culinario, degli strumenti musicali il mandolino, della musica le romanze da operetta, della letteratura porcherie parigine dell’altro ieri, lastrica le sue strade con inverosimili monumenti equestri, e si fa rappresentare nei presunti momenti più solenni della sua storia da uno sporco avventuriero letterario, da un lurido pagliaccio il cui nome era pronunciato ancora un anno fa con sdegno e disprezzo da ogni italiano dabbene, perché il suo proprietario era stato costretto a lasciare l’Italia coperto d’insulti e di vergogna. È lui che tiene il discorso a Quarto ; il vecchio caprone bela la beatificazione della castità dei giovani, arringa dal balcone la plebe delirante, conferisce da pari a pari con Salandra e Sonnino, è ingaggiato dal teatro Costanzi per tenere un discorso di guerra ; il magnaccia è ricevuto dal re, diventa cavaliere dell’Ordine dell’Annunziata, e con ciò degno compare del re medesimo… » Nella biografia di d’Annunzio ad opera dell’inglese Gerald Griffin, a proposito dei discorsi guerrieri del Vate di Pescara si può leggere quest’altro giudizio di scherno: « Mentre lo stile fiorito dei suoi discorsi agli eserciti italiani avrebbe fatto sbalordire e sbottare a ridere i soldati inglesi, francesi o americani, si dice che abbia avuto un effetto ispirante sui combattenti italiani. »
In questo e altri giudizi negativi su d’Annunzio si avverte come un’eco del senso di ridicolo che anima il giudizio di tanti stranieri nei nostri confronti. Noi emigrati sappiamo così bene che i popoli più forti godono nel ridicolizzare quelli che le circostanze della storia hanno reso, in un dato momento, più deboli. Questi giudizi suscitano in noi emigrati un’eco ben maggiore rispetto a chi viva in Italia, perché noi emigrati abbiamo subito nella carne i pregiudizi antitaliani fatti valere da popoli più nobili, più alti, di pelle più chiara, più belli, più giusti. Questi sono riusciti a dominare l’intero pianeta, grazie anche allo schiavismo, con colonie e possedimenti, e spesso non hanno voluto riconoscerci altro ruolo se non quello di barbieri, strimpellatori, saltimbanchi, camerieri, giardinieri o mafiosi. Esagero solo un po’. La dignità nazionale, il senso dell’onore, il coraggio, e non solo quello civile – secondo l’accoppiata di termini che oggi va per la maggiore – ma anche e soprattutto quello militare, non sono cose inerti, ma aiutano a delineare il carattere di un popolo e a creare l’immagine che gli altri popoli hanno di questo. Ecco perché il sentimento di ridicolo che d’Annunzio ancora suscita in tanti Italiani rivela le carenze della nostra coscienza nazionale, incapace di catalizzarsi intorno ad una figura così autenticamente eroica, che riscatta tante prudenze, opportunismi e vigliaccherie, di cui la nostra storia è ben ricca, specie da parte di letterati in papalina e pantofole, culo e camicia con il potere. Su di un altro piano storico-militare, certamente più elevato, il ricordo della figura di Napoleone è attorniata in Francia da rispetto e venerazione.
Noi emigrati, abituati, nel passato e anche in epoche recenti, a mangiare il pane amaro della denigrazione antitaliana, possediamo una sensibilità particolare. Si sa che l’idea della patria è ampliata e nobilitata dalla perdita o dalla lontananza del suolo natale. Ecco perché con queste mie parole io so, oggi, di toccare cuori sensibili. Gli emigrati sanno che la Patria non è un’invenzione di retori, di sciovinisti, di odiatori dello straniero, ma che è una realtà dello spirito. Essi lo sanno così bene… E, se mi permettete, lo sanno ancora meglio i popoli di frontiera come quello cui noi apparteniamo: il popolo delle terre già definite irredente la cui passione di italianità si è scontrata, dopo l’esodo, in un’Italia dall’antipatriottismo trionfante, con l’amore per le bandiere altrui. La retorica è tale per chi non crede alla verità racchiusa da certe parole. La retorica nazionalista di d’Annunzio nei confronti dell’Istria, Fiume e Dalmazia fu invece l’espressione dell’animo di un uomo che tradusse nell’azione, sfidando la morte, il senso autentico delle proprie parole.
Retorica… questo male particolarmente diffuso tra gli Italiani, gente per secoli asservita allo straniero, ma che ha trovato sempre conforto nel ricordo della grandezza passata e nell’attesa di una grandezza futura. La trascorsa grandezza di Roma, il ricordo dell’Umanesimo e del Rinascimento hanno alimentato il culto tipico italiano per le frasi magniloquenti. Ma quanto umano, in fondo, questo volersi nobilitare rifacendosi alla gloria del prima, quando ci si trova a vivere in un presente assai poco glorioso. Gravi danni, oltre che dall’illusione che noi Italiani siamo gli eredi morali dei Romani, ci sono venuti dalla scarsa coscienza nazionale e dall’“elitismo” culturale con il culto del latino e l’imitazione dei classici. In d’Annunzio noi certamente troviamo il pericolo della sontuosità retorica e dell’estetismo decadente. Impossibile negarlo. Lo troviamo anche nei suoi discorsi patriottici. Ma, fatto quasi unico nella storia degli uomini di lettere aspiranti superuomini, d’Annunzio fu uno dei pochissimi che tradusse le parole in azione e che mostrò quanto vere fossero quelle parole dalla patina antica, animate da ritmi fascinosi, impreziosite da immagini sontuose, esaltanti l’eroismo. L’“Uomo d’armi” mostrò che la poesia poteva essere azione, e che il culto, in apparenza estenuato e decadente, della gloria, ricercato da lui mettendo a repentaglio la vita, aveva sostanza di sentimenti, d’azione, di verità. Egli dimostrò l’autenticità dei suoi sentimenti di amor patrio al di là di ogni dubbio attraverso le straordinarie azioni di guerra compiute da volontario nella prima guerra mondiale, con il lancio aereo di manifestini su Trieste insieme col pilota Giuseppe Miraglia (agosto 1915), il volo su Trento (settembre 1915), le incursioni su Pola (agosto 1917), l’impresa di Cattaro, la beffa di Buccari, il « folle volo » su Vienna con il lancio di manifestini propagandistici, e con numerose altre imprese che gli valsero una medaglia d’oro, non meno di cinque medaglie d’argento, una di bronzo, tre promozioni per merito di guerra…
Vi posso garantire che se si potesse insinuare solo un po’ il dubbio su queste imprese eroiche, oggi le nostre biblioteche straboccherebbero di libri tendenti a smentire la versione gloriosa dei fatti. Ma ciò non può avvenire. Anche chi si avvicina a d’Annunzio soldato con spirito dubbioso, non può non riconoscere, forse a malincuore, che il Poeta dalla vita sibaritica, conteso da maliarde, che amava i cuscini e gli spessi tappeti di dimore sontuose, accettò il sacrificio crudele delle disadorne azioni di guerra, ricercate con spirito ascetico e con abnegazione sovrumana. Forse inconsciamente d’Annunzio, attraverso la contestazione dell’ordine stabilito e l’affermazione guerriera, ricercava per sé e per l’Italia – nazione incerta perché troppo recente – una più ampia, sicura identità, mirando ad affermare, come ha scritto De Felice, « una volontà di una vita collettiva nuova ». La sua fu come un’esplorazione dei confini dell’anima nazionale. Esplorazione che purtroppo finì con il restringimento degli orizzonti nazionali, in seguito all’inglorioso esito della seconda guerra mondiale, che comportò la perdita delle terre adriatiche e operò il capovolgimento dei valori ai quali egli si era ispirato.
La forte passione nazionale, propria dei popoli che attendono il ricongiungimento con la madrepatria, d’Annunzio la constatò dal vivo, forse per la prima volta, nel viaggio che compì nelle terre irredente. Ciò avvenne nella primavera del 1902. Egli arrivò il cinque maggio a Trieste. Era la prima volta che visitava quella città. Poi, in motonave, fece il giro di tutte le coste dell’Istria. Fu a Pola, Rovigno, Pirano. Queste terre facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico. Il suo fu un pellegrinaggio. Dalle coste dell’Istria volle spingersi fino a Pisino, situata nel centro della penisola adriatica. Quelle terre, secondo me, furono per d’Annunzio una fonte diretta di ispirazione patriottica, alimentando la sua passione d’italianità. Io so di toccare tasti difficili. Non tutti potranno capire il discorso di chi usa parole che per taluni, come per me, sono carne e sangue, e che per altri possono apparire l’espressione di risonanti formule vuote. Per le popolazioni italiane di quei luoghi, invece, parole come Roma, Dante, Venezia… non erano solo parole, ma una realtà dai contorni mitico-religiosi.
« Pisino era una roccaforte – ha scritto la professoressa Nerina Feresini – ed i suoi cittadini stavano sempre sulle barricate. Avevano un patrimonio prezioso da difendere, la loro civiltà italiana insidiata. » D’Annunzio era già un autore conosciuto ed aveva già espresso il suo patriottismo, ma niente di più. Grazie a questo viaggio egli riuscì ad avere una conoscenza profonda, al livello dell’anima, di un’Italia che in Italia non esisteva. Incontrò l’Italia del sogno di riscatto e dell’amore patrio fatto di lotte quotidiane e di veri sentimenti, e non di discorsi ufficiali e di formule retoriche. Incontrò l’Italia irredenta, per usare quest’espressione che ancora una volta rivela il profondo, incolmabile divario tra chi fa di patria una semplice parola retorica e chi invece per quella parola è pronto a morire. Apro una parentesi. Anche mio padre, per designare l’epoca dell’Istria divenuta italiana ricorreva all’espressione « dopo la redenzione ». Espressione che suona oggi triste e patetica, alla luce dell’accoglienza che i profughi giuliani, lasciando la loro terra natale, ricevettero in Italia…
Gli Italiani delle terre adriatiche “dell’altra sponda”, situata all’incrocio di culture e di razze in lotta tra loro, avevano sviluppato nell’anima un desiderio d’identità nazionale ed un amore per la patria italiana che chi è nato pacificamente in Italia, e si considera tranquillamente Calabrese, Friulano, Ligure, Piemontese, non potrà mai interamente capire. Gli emigrati, invece, lo possono capire quest’amore. L’amore, nel bene e nel male, per quella realtà più ampia che la terra natale suscita, è per taluni una condanna cui non ci si può sottrarre. Noi emigrati sappiamo bene che spesso sono gli altri a ricordarci che noi siamo diversi da loro e che apparteniamo ad un altro destino nazionale. Ma vedo ancora una volta che il mio discorso si fa difficile, parlando io di sentimenti che chi proviene da quelle terre certamente capisce, ma ai quali sentimenti gli altri Italiani sono invece refrattari. Per loro, forse, dovrei parlare della mamma per poter suscitare un’immediata comprensione. Ecco, l’Italia era la mamma per la gente delle terre irredente. Una mamma lontana che si voleva vicina, sapendo quanto ci amasse. O così ci illudevamo… Mio padre mi ha raccontato che da bambino pianse lungamente quando avvenne la disfatta di Caporetto. Molti in Italia, invece, come testimoniano diverse fonti, continuarono in quei giorni a vivere come prima, fregandosene altamente di quella disfatta.
Io non voglio qui vantare quello che per molti – soprattutto in Italia – è un male per sé : l’amor patrio, che impedirebbe una più ampia e generosa solidarietà con i nostri simili al di là delle frontiere. Permettevi di dirvi che io non credo ad un internazionalismo di maniera, così diffuso in tanti abitanti della penisola, nei fatti però legati allo spaghetto al dente, al dialetto, al campanile, alla squadra di calcio e alle loro manie modaiole. Per non parlare dell’ideologia dell’odio che condannava il proprio nazionalismo, ma che esaltava quello del paese guida delle masse proletarie. Basti pensare al culto della bandiera rossa, così diffuso in Italia per tanti anni, a scapito della bandiera tricolore, vista come una pericolosa manifestazione di ipernazionalismo guerrafondaio. Torno a ripetere : l’amore per l’Italia della gente delle terre poste sotto la dominazione asburgica era un sentimento profondo, che si esprimeva in vita vissuta e non in frasi fatte grondanti retorica. Ecco perché gli scritti, i discorsi, le azioni di d’Annunzio durante la prima guerra mondiale trovarono a Trento, in Istria, a Fiume e in Dalmazia un’eco che molti non potranno oggi pienamente capire.
Permettetemi di leggervi la frase augurale che si trova nel diario di prigionia di mio nonno, costretto a combattere dal lato dell’Austria, nella prima guerra mondiale, perché suddito austriaco. Egli si trovava in Russia, prigioniero, in condizioni durissime. Eppure pensava alla sua lontana Pisino scrivendo nel suo taccuino, nel gennaio del 1916, questo pensiero augurale da cui traspare un fervore quasi religioso : « Nella speranza ed anzi la certezza che la nostra madre Italia col suo preziosissimo sangue vorrà redimerci e che al mio ritorno nella bella Pisino i miei occhi vedranno spiegata al vento sopra il castello, che da secoli attende, il tricolore nostro e così sia. » In quello stesso castello, tre lustri prima, Gabriele d’Annunzio era stato festeggiato fervidamente dalla gente di Pisino. Retorica, mi si dirà. Sì, retorica, ma dannunziana: la retorica che si sposa ai veri sentimenti e all’azione. Fabio Filzi, nato a Pisino, mia cittadina natale, salì sul patibolo a Trento nel 1916. Morì da eroe per la sua passione italiana. Anche lui fu un’espressione di questa retorica…
Mi potrebbe essere rimproverata una grave omissione se non accennassi ad un tragico capovolgimento avvenuto in molti di noi, figli delle terre irredente. Il tema meriterebbe ben altri approfondimenti. Ma per brevità mi limiterò a dire che la prima guerra mondiale, preludio alla seconda, fu un’immane tragedia che spezzò per sempre equilibri tra stati e sconvolse le identità nazionali di tanti uomini. In una lettera spedita a mio padre da un suo conterraneo, io ho letto una dolorosa analisi, fatta col senno di poi, di quella lontana guerra che segnò la distruzione dell’impero asburgico e che fece di noi dei cittadini italiani. « Ti ricordi, Mario, quanto abbiamo odiato l’Austria e Francesco Giuseppe ? Ah, se l’Austria potesse tornare… Felix Austria… » Questo è l’aspetto ancora più amaro, perché beffardo, del disfacimento del nostro mondo d’origine, del nostro esodo e della nostra dispersione in Italia e all’estero: questo dover rimpiangere il nostro nemico di allora, perché a molti di noi riesce difficile riconoscerci in un’Italia che ha aspettato mezzo secolo prima di ammettere, attraverso l’emissione di un francobollo, che vi fu un esodo, e in un’Italia in cui ci si riferisce a località come Pola e Parenzo, col nome slavo. Permettete allora al popolo che per tanti anni non è ufficialmente esistito di non tradire la memoria di d’Annunzio e di altri eroi che combatterono e anche morirono nel sogno di un’Italia più grande.
Anni dopo quel primo conflitto mondiale, un giovane padre nato nel 1907 a Trieste, ma vissuto a Pisino fino al compimento degli studi liceali, Mario Granbassi, giornalista al Piccolo di Trieste, partì volontario per la Spagna per combattere a fianco delle forze franchiste. Lasciò a Trieste la giovane sposa e i due figlioletti. Il diario che tenne nel periodo di guerra rivela la sua straordinaria elevatezza d’animo, la sua profonda umanità, e un grande coraggio che sfociò in diverse occasioni in puro eroismo. Egli era animato da una grande fede: la fede nell’Italia – l’Italia fascista. Mi rendo conto di pronunciare, oggi, un anatema. Ma non era certo un anatema per la nostra gente di confine. Per i Giuliano-Dalmati l’italianità era un valore indiscutibile, e tra italianità e fascismo per moltissimi di loro, allora, vi era semplicemente identità. Granbassi analizza nel diario i motivi profondi della sua scelta: « Ho fatto degli esami di coscienza profondi e sono ormai sicuro di non mentire a me stesso: l’intima soddisfazione di aver compiuto duramente questo mio dovere è una ricompensa che supera ogni altra. » E ancora: « La mia coscienza mi ripete: Qui [in Spagna] non sei venuto a cercare nulla che non sia ideale, perché di altro non avevi bisogno! »
Il giovane giornalista del Piccolo – nato in una straordinaria famiglia di spiriti superiori, come mi testimoniò mia madre e come ho potuto constatare io stesso attraverso la conoscenza dei suoi due fratelli, Manlio e Guido, oggi scomparsi – non tornò più nella sua amata Italia: trovò la morte in un’azione di guerra. Morì eroicamente. Morì in quella maniera che è stata consacrata da una lunga serie di film esaltanti l’eroe puro della guerra spagnola; ma – bisogna precisare – sempre l’eroe del fronte opposto. Nel manicheismo instaurato dai vincitori della seconda guerra mondiale, il suo anticomunismo gli fa oggi meritare, ipso facto, il marchio dell’errore e persino dell’obbrobrio. Quel marchio che gran parte della nostra gente si è portata appresso – nobilmente – per tanti anni.
Nel 1940 gli furono decretate alla memoria, dallo stato italiano e da quello spagnolo, le due massime ricompense al valor militare. La motivazione della medaglia d’oro italiana fu: « Comandante del plotone arditi di battaglione, si lanciava audacemente contro una munitissima posizione nemica che, con nutrito fuoco, causava forti perdite al suo battaglione, riuscendo, dopo aspro combattimento a corpo a corpo, a scacciarne l’avversario. Ferito si faceva medicare sommariamente. Ripreso il comando dei suoi arditi, si gettava ancora, con suprema audacia, nella lotta finché, investito da una raffica di mitragliatrice, cadeva colpito a morte. Prima di spirare inneggiava all’Italia, incitando i suoi uomini a continuare la lotta e a non preoccuparsi della sua persona. » Nell’agosto del ’45, per decreto di Palmiro Togliatti, allora ministro della giustizia, fu revocata la medaglia d’oro alla memoria di Mario Granbassi, e furono revocate le medaglie di altri trentuno caduti. Era quello stesso Togliatti che durante il secondo conflitto mondiale si era schierato contro gli Italiani a favore degli Jugoslavi, e che il 19 ottobre 1944 inviava a Vincenzo Bianco, rappresentante del PCI presso il Partito comunista jugoslavo, delle istruzioni in cui si legge: « Noi consideriamo come un fatto positivo, di cui dobbiamo rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire, la occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito. »
Ha commentato Ernesto Galli della Loggia nel suo libro, dal titolo quanto mai significativo, “La morte della patria”: « […] dal Partito comunista non vennero altro, a proposito del confine orientale, che indicazioni pubbliche e prese di posizione di inequivocabile contenuto ‘antitaliano’ ». Galli della Loggia specifica: « Adopero il termine ‘antitaliano’ essendo pienamente consapevole non solo del forte significato che in quanto tale esso possiede, ma anche dell’uso spesso strumentale che di esso è stato fatto dalla più faziosa propaganda anticomunista.». Anche per Togliatti la patria era meritevole di espressioni d’amore retoriche. Togliatti credeva, infatti, alla patria, ma non a quella italiana. E le espressioni che d’Annunzio rivolse all’Italia, il Migliore le tributò, nei fatti, all’Unione Sovietica, sua vera patria, nonché al mitico proletariato, a parole “liberato” e in realtà tenuto in catene dalle nuove classi dominanti, l’infausta nomenklatura.
Vi dicevo che d’Annunzio venne a Pisino, mia cittadina natale. Vi giunse il 16 maggio del 1902. Sono trascorsi, da allora, più di cent’anni. La “Famiglia pisinota” ovvero il Libero comune di Pisino che in esilio raggruppa i superstiti di quel lontano esodo dalla nostra amatissima piccola patria, scomparsa per sempre, ha permesso alla professoressa Nerina Feresini, amorosa custode di memorie per noi irrinunciabili, di pubblicare nel 1971 un volumetto che ricorda la visita del poeta pescarese a Pisino, nel lontano 16 maggio 1902, e l’impatto ch’egli ebbe sulla nostra gente. Pisino, che come tutta l’Istria faceva parte dell’Austria, era una località con una situazione politica meno tranquilla rispetto alle località costiere dell’Istria, perché lì la nostra gente conduceva una lotta più tenace di italianità. L’accoglienza che il Vate ebbe fu meravigliosa. Lo scrittore Silvio Benco scrisse così sull’“Indipendente” : « Tutte le donne, da tutte le finestre, gettavano fiori sul poeta che visitava la loro città. D’Annunzio era in Pisino l’orgoglio della stirpe, che ivi sostiene strenuamente la sua lotta, era il segno eccelso al quale le armi dei negatori d’italianità non possono giungere, era la personificazione gloriosa di una razza, alla quale gli avversari nazionali non possono contrapporre che i loro politicanti chiercuti e i loro avvocatuzzi oscuri. Pisino seppe conservare mirabilmente nel suo tripudio i limiti del vero ; non insolenti contro alcuno ; fu paga di mostrarsi qual è, di potersi mostrare qual è ad un insigne araldo del genio di nostra stirpe ; città italiana, che italianamente sente, che italianamente vive, che italianamente lotta. » Ed ancora : « Il poeta aveva ascoltato e detto parole italiane in tutte le belle città del mare, dopo aver appassionatamente amato i luminosi orizzonti e la verde campagna istriana, che gli ricordava i paesaggi dell’altra sponda ; ora il convoglio lo portò ad ascoltare e a dire parole italiane laddove si combatte ogni giorno, in ogni ora, con tutti i mezzi, con tutte le volontà valorose inchinate ai doveri umili, per conservare l’italianità dell’anima contro l’assalto d’un’anima straniera, temeraria nella sua ostinazione, fortificata dall’appoggio dei potenti, impetuosa come si conviene a una distruttrice di memorie. Quanti hanno vibrato e pianto ieri, nelle ore pomeridiane a Pisino, non lo dimenticheranno mai più ; e se d’Annunzio potrà portare in sé di tutte le città della costa un’immagine confusa d’arte, di luce e di festa cordiale, di Pisino egli deve avere una di quelle memorie che hanno avuto ad artefice una commozione intensa e che cento anni di vita non saprebbero consumare. »
Difatti, d’Annunzio mostrò di essere rimasto profondamente colpito dallo spirito della gente di Pisino. In una lettera – che scrisse da Settignano, il 17 settembre 1902, a Francesco Salata, il futuro senatore, allora redattore del Piccolo di Trieste, che aveva accompagnato d’Annunzio nel suo viaggio in Istria insieme con altre personalità del giornalismo ed esponenti dell’irredentismo giuliano – si legge : « A Pisino – ricorda ? – su quel selvaggio scoscendimento, così folto di radici vigorose ed inespugnabili, noi vediamo espandersi in tutto un popolo la più alta e la più efficace forma dell’eroismo intellettuale moderno, la lotta di cultura. Sentiamo, come un palpito fiero e concorde, il diritto della grande molteplice trasfigurante civiltà latina contro il sopruso barbarico. » A proposito di Francesco Salata, ricorderò ch’egli sposerà in seguito una pisinota, Ilda Mizzan. E ho il piacere di dirvi che qui a Montréal vive la signora Dolores Maurovich, nipote del compianto Francesco Salata, personaggio maiuscolo della Storia dell’Istria.
Anche in una lettera inedita, inviata a Trieste all’avvocato Costellos del Verdi, e divulgata nel 1997, ritroviamo il profondo amore di d’Annunzio per le terre irredente. Il Poeta scrive che « le piccole isole del mare istriano, fiorite di ginestre, mi stanno sempre davanti agli occhi, in forma di altari », e ricorda « quei giorni di vita ideale trascorsi nella nostra santa Istria » e gli amici irredentisti. Io sono convinto che d’Annunzio trovò a Pisino qualcosa ch’egli cercava e che definirà nel futuro la sua identità e alimenterà la sua azione : la passione italiana, vissuta quotidianamente come fatto profondo, autentico, fertile d’abnegazioni. Quella passione italiana che si tradurrà in sentenza di morte per tanta della nostra gente, infoibata nelle voragini carsiche spesso dopo atroci supplizi. Tra queste persone menzionerò tra i tanti un figlio di Pisino, mio zio Lino Gherbetti (Gherbetz), zio acquisito attraverso la moglie, Adalgisa Bresciani, sorella di mia madre. Lino, nel 1902, era un fanciullino. Durante quella memorabile giornata, d’Annunzio. visitò il suo asilo. Il fanciullino dai bei capelli ondulati aveva la testa reclinata sul banco. Dormiva. Il Poeta allora accarezzò delicatamente quella testa, dicendo « Che bella bambina ! » La maestra, sorridendo corresse l’illustre ospite, precisando che era un bambino. La mamma di Lino Gherbetti alluse in seguito, infinite volte, a quell’episodio, rimproverando al figlio – portato alla passione per il violino, all’amore per le donne, al vino, al gusto del rischio e dell’avventura, e dai profondi sentimenti patriottici – quella carezza. « D’Annunzio ti ha trasmesso il gusto della trasgressione, del rischio » era solita dire – probabilmente con altre parole – la povera madre al figlio già allora troppo avventuroso.
E mio zio concluse la vita terrena nell’eroismo. Fu trucidato dai partigiani di Tito, dopo che si era consegnato alle autorità allo scopo di far liberare altri civili, ingiustamente imprigionati, come si può leggere anche nel libro di Pisanò “Storia della guerra civile in Italia”. E mia zia mi raccontò che alla vigilia dell’esecuzione, che lui dava come certa, disse a lei piangente (era andata a visitarlo dove erano tenuto prigioniero): « Io morirò per l’Italia. Ma tu non devi piangere, anzi dovrai essere orgogliosa. Un giorno andrai a Roma e ti accoglieranno con un tappeto rosso, perché tuo marito ha saputo morire per la patria. » Ma a Roma mai è stato svolto ai piedi di mia zia un tappeto rosso…La frase dannunziana del tappeto rosso, che mio zio, non improbabilmente, aveva assorbito da quella lontana carezza del Vate, non troverà ammiratori o cultori nell’Italia della furbizia e dell’opportunismo. Rosso sarà il colore delle bandiere sventolanti – le uniche per tanti anni ammesse – e gli Italiani dell’Est, gli Italiani – se mi permettete – che hanno ispirato d’Annunzio e che sono stati da lui ispirati, saranno spesso etichettati come Slavi. Nuove retoriche prenderanno il posto di quelle antiche. Altre passioni trionferanno. Il letterato immaginifico sarà fatto oggetto di sarcasmi. Ma i detrattori prenderanno di mira soprattutto il d’Annunzio eroe. Per me invece è proprio l’esempio incomparabile di d’Annunzio guerriero ad ingigantire anche il poeta. È l’audacissimo combattente, nel cielo e nel mare, che rende coerente e vero il d’Annunzio letterato e poeta, Uomo nella sua totalità. Il vero eroismo, dopotutto, non è retorica.
Ha scritto un critico: « Farebbe cattiva storia lo storico che non subordinasse il d’Annunzio che contemplò ed espresse sé stesso al d’Annunzio che offrì mille volte la vita. » D’Annunzio, come è stato detto da altri « Ha saputo agire da eroe, non poetare da eroe. » Carlo Emilio Gadda, nel maggio del 1915, si rivolse in una lettera a d’Annunzio come « a colui che ha instituito e accresciuto nel nostro spirito la coscienza della vita nazionale ». Piero Buscaroli ha scritto che « Il sentimento nazionale compie in d’Annunzio l’uffizio che presso altri adempie la religione. È il solo sentimento umano che possedesse libero d’implicazioni estetiche. » L’eroismo, aggiungendosi all’estetismo e alla poesia – osservo io – permise a d’Annunzio di ottenere la completa coincidenza tra l’arte e la vita. « L’avventura di Cattaro – una vera e propria avventura di ulissidi – rimarrà tra le mie più belle ore di poesia », scrisse il Vate pescarese, rivelando la coincidenza ch’egli faceva tra l’arte e la vita. L’ansia di azione coronò in d’Annunzio l’ansia di poesia. Il vivere coronò il dire. Onore quindi al poeta, al drammaturgo e al romanziere, ma onore soprattutto al patriota, al soldato della grande guerra, al legionario fiumano così vicino al mio, al nostro cuore.
Claudio Antonelli (Canada – Montréal)


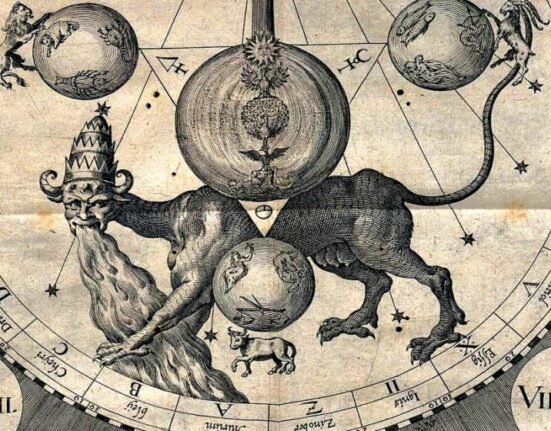





3 Comments