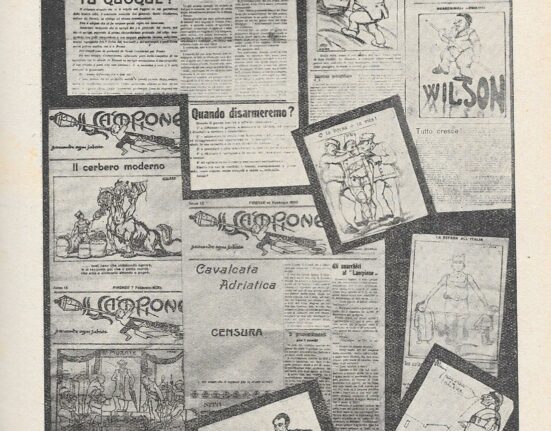Articolo N° 23.
Un secolo ci separa dall’inizio della Grande Guerra, o Prima Guerra Mondiale. Eppure il ricordo è ancora più che vivo, ma i dettagli e talune successioni di fatti non sono così immediati da ricomporre. Sia per calcolo, sia per non conoscenza approfondita degli accadimenti del passato, sovente vi sono errori in chi “racconta la Storia” e così è avvenuto in una recente trasmissione televisiva sull’impiego delle armi chimiche nella Grande Guerra del 1914 – 1918.
Nel passato anche remoto, durante taluni scontri, si sono variamente adoperate sostanze nocive e «armi non convenzionali» per sorprendere l’avversario e conseguire più agevolmente la vittoria. Le «armi avvelenate» non sono quindi un’invenzione del XX secolo, ma nel corso della Storia mai si erano impiegate armi così letali e devastanti, in quantità e varietà assolutamente mai viste prima, come durante la Grande Guerra.
Ad esempio Alessandro Lustig, già direttore del Laboratorio fisiopatologico di Firenze del Servizio Chimico Militare, nel suo lavoro in collaborazione con i dottori Ferraloro e Rovida, Effetti e cura dei gas di guerra, richiama alla memoria l’utilizzo di sostanze irritanti impiegate nel corso di alcune battaglie: «I primi composti irritanti venivano sviluppati molto semplicemente bruciando svariate sostanze come pece, catrame, grasso animale e resine, delle quali l’effetto nocivo era già praticamente conosciuto; in seguito vennero adoperate sostanze chimiche che svolgevano gas o fumi irritanti o tossici, come lo Zolfo e l’Arsenico. Pare che tali gas fossero usati dagli Spartani nella guerra del Peloponneso, davanti a Platea ed a Belium (431-404 a.C.). Anche nella Storia Romana ricorrono frequenti accenni alla guerra con sostanze fumogene irritanti, lagrimogene, asfissianti e coi gas» (Lustig A., Effetti e cura dei gas di guerra, terza edizione, Istituto Sieroterapico Milanese, Milano 1936, p. 4).

Successivamente si ha notizia di sostanze irritanti e/o tossiche e/o velenose utilizzate dai Bizantini, dagli Arabi, nel corso delle Guerre Napoleoniche, ecc. Seppure gli utilizzi di talune sostanze siano stati sporadici, queste erano ben presenti nelle menti di coloro i quali si occupavano di “arte militare”, tant’è che nel 1907 la Seconda Conferenza dell’Aia all’Articolo N° 23 delibera, nuovamente, che «Oltre alla proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato: a) di usare veleni o armi avvelenate; ecc.».
«Gas di guerra»
Sfogliando le cronache e i rapporti dell’epoca emergono varie informazioni a proposito dell’utilizzo dei cosiddetti «Gas di guerra», i quali venivano immessi nell’atmosfera mediante apposite bombole (proiettori), caricando apposite granate, proietti, ecc.
Erminio Piantanida ha pubblicato un interessante lavoro intitolato Chimica degli esplosivi e dei gas di guerra (Piantanida E., Chimica degli esplosivi e dei gas di guerra, Regia Accademia Navale, seconda edizione, Livorno 1940). In primo luogo l’autore precisa che il termine «gas asfissianti» (e così anche «gas di guerra») è improprio per gli aggressivi chimici impiegati in operazioni militari e nello specifico nel corso della Grande Guerra.
Difatti: «Colla denominazione di gas asfissianti indichiamo tutte le sostanze che, allo stato di vapori, od anche di liquidi o di solidi in sospensione sottilissima nell’aria (aerosoli), possono modificare, con la loro presenza, l’atmosfera ambiente al punto da rendervi impossibile la vita. Le sostanze che hanno tale proprietà, e che vengono usate in guerra, sono sempre (a temperatura normale) dei liquidi o dei solidi; un solo gas, vero e proprio, venne adoperato per poco tempo: il cloro. Ad ogni modo, però, per tacita convenzione, è rimasta a queste sostanze la denominazione generica e pratica di gas asfissianti. Meglio si dovrebbero chiamare sostanze aggressive o aggressivi chimici ed esse costituiscono la cosiddetta arma chimica» (Ibidem, p. 331).
Chi cominciò per primo?
La cosiddetta “storia ufficiale” afferma che i primi ad utilizzare le armi chimiche siano stati i tedeschi. Vero, se rimaniamo fedeli al pensiero, opinabile, che i gas lacrimogeni siano inoffensivi e non siano da considerarsi un’arma chimica. Ma, questo, lo si vedrà meglio soprattutto più avanti parlando della classificazione e dei vari aggressivi chimici.
In ogni caso i francesi impiegano per primi i gas lacrimogeni contro i tedeschi in azioni di guerra già nel 1914: «i francesi usarono nel 1914, nelle Argonne, delle granate che contenevano dell’etere etilbromoacetico (lacrimogeno già conosciuto dalla polizia parigina fino dal 1912) e delle granate contenenti cloroacetone; e i tedeschi, pure nel 1914 a Neuve-Chapelle, usarono certi shrapnel contenenti sale di dianisidina (lacrimogeno) e, in principio del 1915, sul fronte russo, delle granate contenenti del bromuro di xilile (lacrimogeno)» (Ibidem, p. 332).
Secondo alcuni l’impiego degli aggressivi chimici da parte tedesca è stata la risposta all’utilizzo di lacrimogeni e similari da parte dei francesi i quali, di fatto, sono stati i primi a dare il via alla guerra chimica.
Per quanto concerne l’utilizzo di un vero e proprio gas asfissiante, il cloro, Piantanida scrive: «È noto che l’uso di questi gas asfissianti è stata una innovazione della guerra mondiale 1914-1918 e che il loro impiego fu iniziato apertamente dai tedeschi alle ore 6 pomeridiane, contro una divisione francese, nel settore inglese del fronte occidentale, fra Bixcoote e Langemark. Si trattò allora di una nube di cloro prodotta (secondo i consigli di Haber) dalla emissione di 30 tonnellate di cloro liquido contenuto in bombole di ferro (1600 grandi bombole e 4130 piccole) che erano distribuite su un fronte di 6 chilometri e che furono aperte contemporaneamente mentre spirava un vento (verso il nemico) con velocità di 2-3 metri al secondo. La nube di cloro, larga 6 chilometri e profonda da 600 a 900 metri, investì i soldati francesi con effetti terribili» (Ibidem, p. 332).
A questo punto è utile riportare anche la parole di Lustig: «Quando i Tedeschi, il 22 aprile 1915 –
data memorabile nella storia militare – lanciarono nella regione di Ypres in grande stile una nube mortifera a mezzo di bombole di Cloro seminando panico e strage fra le truppe francesi di quel settore, fu quasi unanime il biasimo verso la Germania che, dando inizio a questa speciale offensiva, veniva a violare oltre che il diritto alle genti, precise convenzioni sottoscritte all’Aja, il 29 Luglio 1899 e successivamente nel 1907 (…). Comunque in seguito i Tedeschi si scagionarono dell’accusa di essere stati gli iniziatori dell’offensiva chimica, addossando ai Francesi la responsabilità dell’iniziativa stessa. Si dice infatti che l’Ufficio tedesco di informazioni segrete venne a suo tempo a conoscenza che il Maresciallo Joffre, verso la fine del 1914, disponeva già di proietti e bombe a mano carichi di Bromo e di Cloro-acetone, che furono poi usati contro le truppe tedesche nel fronte occidentale nel marzo 1915. Questo fatto – dicono i tedeschi – determinò la Germania ad iniziare senz’altro l’offensiva coi gas in grande stile, aiutata nella bisogna dalla sua poderosissima industria chimica» (Lustig A., op. cit., p. 8).

Gli aggressivi chimici.
Sulla classificazione degli aggressivi ancora Erminio Piantanida afferma: «non è possibile farne una razionale che tenga conto di tutte le proprietà di queste sostanze e perciò si sono fatte varie classificazioni particolari, ciascuna delle quali considera questi aggressivi prevalentemente secondo una certa loro proprietà» (Ibidem, p. 339).
Soggiunge che la classificazione può avvenire a seconda dell’azione che ogni sostanza determina, in prevalenza, sull’organismo umano, ma che differenti sostanze possono avere su questo effetti identici o analoghi.
Si riporta il sunto della classificazione traendolo da una recente pubblicazione (Breda M. A., Padovan G., Como 1915-1945: protezione dei Civili e rifugi antiaerei, Lo Scarabeo editrice, Milano 2014, p. 38):
– sostanze con azione prevalente sulle mucose degli occhi;
– sostanze con azione prevalente sulle vie aeree superiori, come naso e gola;
– sostanze con azione prevalente sulla composizione del sangue;
– sostanze con azione prevalente sulla pelle;
– sostanze con azione prevalente sul tessuto nervoso.
Gli aggressivi chimici impiegati in guerra si possono poi ordinare, indicativamente e per praticità di comprensione, in quattro gruppi:
1. Asfissianti o soffocanti.
2. Lacrimogeni e starnutatori.
3. Vescicatori.
4. Fumogeni o nebbiogeni.
Non tutte le sostanze chimiche di seguito elencate pare siano poi state effettivamente utilizzate nel corso dei combattimenti, ma in ogni caso erano verosimilmente presenti negli arsenali dei belligeranti. Anche in questo caso occorrerebbe effettuare una indagine specifica ed esaminare, punto per punto, lo sviluppo e l’impiego delle armi chimiche presso ogni nazione che partecipò alla Prima Guerra Mondiale per avere un quadro cronologico esatto e una conoscenza altrettanto esatta delle specifiche armi adoperate.
Asfissianti o soffocanti.
Sono sostanze che attaccano le vie respiratorie, conducendo nei casi più gravi all’asfissia, ovvero l’impedimento alla respirazione, dovuto all’avvelenamento del sangue, o alla soffocazione, oppure alla paralisi dei centri nervosi respiratori (Piantanida E., op. cit., pp. 340-357).
– Cloro. Scoperto da Scheele nel 1774, è denominato Berthollite dai francesi; ha un effetto irritante delle vie respiratorie e può condurre alla morte per asfissia da edema polmonare.
– Bromo. Ha effetti simili al cloro, come corrosione, soffocazione, irritazione agli occhi; può essere mortale.
– Fosgene. Cloruro di carbonile, è ottenuto da Davy nel 1811 a causa dell’azione della luce solare su un composto di cloro e di ossido di carbonio, da cui il suo nome che significa «generato dalla luce», con effetti più devastanti del solo cloro; è chiamato Collongite dai francesi. Vero e proprio asfissiante, conduce alla morte anche se presente nell’aria in modeste concentrazioni.
– Cloroderivati dell’etere metilcloroformico. Gas asfissianti di azione simile a quella del fosgene, sono stati tra gli aggressivi chimici più micidiali adoperati nella Grande Guerra. A seguito di vari composti si ottengono anche la Palite e la Surpalite o Superpalite, Perstoff per i tedeschi.
– Acido cianidrico. Composto scoperto da Scheele nel 1782, è la Forestite dei francesi e la Blausaüre dei tedeschi. Determina la paralisi del centro nervoso respiratorio, conducendo alla morte. I francesi lo utilizzarono mescolato ad altre sostanze e la miscela più nota è la Vincennite.
– Bromuro di cianogeno. È chiamato E-Stoff dei tedeschi; l’azione sull’organismo è analoga a quella dell’acido cianidrico, ma con azione anche irritante oltre che paralizzante.
– Cloruro di cianogeno. È chiamato Mauguinite dei francesi; l’azione sull’organismo umano è analoga a quella del bromuro di cianogeno, quindi irritante e paralizzante.
– Cloropicrina. Preparata da Stenhouse nel 1848; è l’Aquinite dei francesi e il Klop dei tedeschi. La sua azione determina irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie, nonché avvelenamento, producendo nausea e vomito; gli inglesi lo chiamano Vomiting-Gas.
– Solfato dimetilico. È il D-Stoff dei tedeschi; assai tossico, genera infiammazioni agli occhi e agli organi respiratori.
– Clorosolfonati di metile e di etile. È il C-Stoff dei tedeschi, la Villantite e la Sulvinite dei francesi. Di odore pungente, è assai volatile e irritante, ma velenoso in alte concentrazioni.
– Etere diclorometilico. Chiamato dai francesi Cici, è un composto irritante, velenoso e volatile. È usato dai tedeschi nella Grande Guerra, anche miscelato con altre sostanze.
– Etere dibromometilico. Chiamato dai francesi Bibi, è un composto moderatamente irritante, ma assai tossico. Analogamente al precedente altera il senso dell’equilibrio, tant’è che i francesi lo chiamano gas labyrinthiques.
– Cloruro di fenilcarbilammina. È il K-Stoff dei tedeschi; considerabile come lacrimogeno, è irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
Lacrimogeni e starnutatori.
In prevalenza si tratta di sostanze che hanno un’azione irritante sugli occhi e sulle mucose del naso, provocando lacrimazione, starnutazione e infiammazione. Come ricorda Piantanida: «S’intende che, a seconda della quantità assorbita, essi hanno poi anche azione che si manifesta con attacco agli organi respiratori o al sistema nervoso o al sangue, con conseguenze mortali. I lacrimogeni furono i prodotti che iniziarono, nel 1914, sia pure non ufficialmente, la guerra coi gas» (Ibidem, pp. 357-374).
– Bromuro di xilile. È il T-Stoff dei tedeschi; produce irritazione sulle mucose degli occhi.
– Bromuro di benzile. È il gas lacrimogeno Cyklite dei francesi, adoperato anche dai tedeschi; produce irritazione alle mucose degli occhi.
– Ioduro di benzile. Si tratta di un gas lacrimogeno, anche noto come Fraisinite, producente irritazione sulle mucose degli occhi.
– Cloroacetone. È l’A-Stoff dei tedeschi e la Tonite dei francesi, impiegato da questi ultimi fin dal 1914; irritante per gli occhi, può anche essere tossico in rilevanti concentrazioni.
– Bromoacetone. È il B-Stoff dei tedeschi, la Martonite dei francesi e il BA degli americani; è un lacrimogeno irritante delle mucose e degli occhi. Poteva penetrare attraverso le maschere protettive.
– Bromometiletilchetone. È il Bn-Stoff dei tedeschi e l’Homomartonite dei francesi.
– Cianuro di bromobenzile. Inventato da Reimer nel 1881, è la Camite dei francesi e il CA degli americani; ha una lunga persistenza sul terreno, è un energico irritante degli occhi e tossico ad alte concentrazioni.
– Cloroacetofenone. È il CN degli americani; di bassa tossicità, è irritante degli occhi e delle vie respiratorie.
– Arsine. Si tratta di aggressivi chimici tra cui si hanno:
Difenilcloroarsina. Preparata da Michaelis e La Coste nel 1880, in laboratorio, è l’arsina più nota usata nella Grande Guerra. Chiamata dai tedeschi Clark I e dagli americani DA, è un gas starnutatorio, lacrimogeno e irritante.
Difenilcianarsina. Per tedeschi Clark II e gli americani CDA, è utilizzata nel 1918 dai tedeschi e caricata in proiettili esplosivi distinti con la croce blu.
Etildicloroarsina. Per gli americani ED e i tedeschi Dick; questi ultimi l’hanno utilizzata, in proietti, come ausiliario al gas vescicatorio persistente (croce gialla 1) e come ausiliario agli asfissianti poco persistenti (croce verde 3).
Metildicloroarsina. Scoperta da Bayer nel 1858, è utilizzata dagli americani indicandola con MD, mentre i tedeschi la chiamarono Methyldick.
Difenilammincloroarsina o cloruro di fenarsazina. È preparata nel 1918 dall’americano Adams, seppure già nota dal 1915; gli americani la chiamano DM e gli inglesi Adamsit.
Le sostanze vescicatorie o vescicanti provocano, come effetto visibile, la comparsa di vesciche. Così spiega Piantanida: «Nella guerra mondiale, tra il 1916 e il principio del 1917, si era giunti ad una specie di equilibrio tra i mezzi di offesa e i mezzi di difesa coi gas: erano già comparsi, oltre ai lacrimogeni, gli asfissianti più terribili, ma essi erano tutti opportunamente arrestabili colle maschere antigas, specialmente ad opera del carbone attivo in esse contenuto. Il combattente era ormai regolarmente munito di maschera che gli difendeva gli occhi, il naso, la bocca (e quindi gli organi respiratori) dai gas che egli poteva incontrare sul campo. Per ottenere un progresso nella guerra chimica, si pensò allora di impiegare sostanze che agissero anche sulla pelle in modo da obbligare il nemico a proteggere tutto il corpo dei suoi soldati» (Ibidem, pp. 374-385). Si introducono quindi gli aggressivi chimici vescicanti, mescolandoli inoltre con le arsine, per garantire una penetrazione anche nelle maschere dotate di filtri a soli carboni attivi.
– Diclorodietilsolfuro. Sostanza liquida nota con il nome di Iprite o Yprite, per i tedeschi è Lost, per i francesi Ypérite e HS per gli americani; gli inglesi lo hanno chiamato Mustard-Gas, ovvero gas-mostrada, e Senf-Gas, in quanto olfattivamente ricordava l’aglio e la senape. La prima sintesi dell’iprite è ottenuta da Despretz nel 1822 ed ha effetti infiammatori, vescicatori e tossici. Viene impiegato per la prima volta dai tedeschi il 22 luglio 1917, sul Fronte Occidentale nel settore di Ypres, il quale prende il nome dall’omonima cittadina belga e da cui deriva poi la denominazione dell’aggressivo chimico.
– Clorovinildicloroarsina. È la Levisite, M-1 per gli americani e Lewisit per gli inglesi; è preparata in America da Lewis nel 1917. Con effetti simili a quelli dell’iprite, ovvero con effetti infiammatori, vescicatori e tossici, è chiamata the dew of the death, ovvero rugiada della morte.
Fumogeni o nebbiogeni.
Nel corso della Grande Guerra i belligeranti utilizzano «nebbie artificiali» tanto a terra quanto in mare per mascherane le proprie forze a fini sia offensivi, sia difensivi. Così specifica Piantanida: «La produzione di queste nebbie artificiali è affidata a diverse sostanze che prendono il nome di fumogeni o nebbiogeni e che rientrano tra le sostanze aggressive anche perché le nebbie o fumi, da esse generate, sono quasi sempre costituite da sostanze più o meno irritanti» (Ibidem, pp. 385-392).
Sostanzialmente i fumi sono prodotti da sospensioni di particelle solide, mentre le nebbie da sospensione di particelle liquide. Taluni prodotti si utilizzarono anche mescolandoli ad aggressivi chimici veri e propri, come, ad esempio, il fosgene e l’acido cianidrico.
– Fosforo. La nebbia di acido fosforico ha l’effetto è di ledere gli organi della respirazione e può essere velenosa e mortale.
– Anidride solforica. La nebbia di acido solforico è irritante per la pelle e per gli organi respiratori. – Acido clorosolfonico o cloridrina solforica. Si usa per la produzione di nebbie analoghe a quelle ottenute con l’anidride solforica.
– Tetracloruro di titanio. È l’F-Stoff dei tedeschi; la nebbia prodotta è generalmente inoffensiva.
– Tetracloruro di silicio. Si ottiene una nebbia bianca e densa, la quale non ha, generalmente, azioni irritanti sugli organi respiratori.
– Tetracloruro di stagno. Si tratta di un nebbiogeno; è usato da francesi e inglesi come solvente del fosgene, dell’acido cianidrico e della cloropicrina per tentare di far penetrare questi asfissianti attraverso le maschere non munite di filtro per le sospensioni di polveri.
– Pentacloruro di antimonio. Si tratta di un prodotto che dà notevoli effetti nebbiogeni.
– Cloruro di zinco. Date le reazioni chimiche, le nebbie che il prodotto forma vengono chiamate nebbie di zinco.
– Naftetine. Si tratta dei residui di distillazione dei petroli e danno luogo a nebbie azzurrine.
Ancora sugli aggressivi chimici.
Al fine di auspicabili e approfonditi studi sull’argomento che il presente articolo desidera sollecitare, si ritiene utile presentare anche uno stralcio della tabella pubblicata da Lustig, in cui gli aggressivi chimici sono suddivisi per raggruppamento chimico: «Tabella 1 – i più importanti gas da combattimento impiegati o studiati durante la guerra mondiale» (Lustig A., op. cit., tab. I); i “nomi di guerra” sono qui riportati in corsivo. Non tutti sono stati impiegati, come riporta la tabella e, ad esempio, per i Lewisiti è così annotato: «Preparati dagli Americani e non usati per il sopraggiungere dell’armistizio» (Ivi).
Alogeni. 1. Cloro (Bertholite); 2. Bromo.
Ossido di carbonio e derivati. 3. Ossido di carbonio; 4. Ossicloruro di carbonio (Fosgene); 5. Clorosolfuro di carbonio (tiofosgene) (Lacrimite); 6. Tetraclorosolfuro di carbonio.
Alogeno e nitroderivati degli idrocarburi. 7. Nitrocloroformio (Cloropicrina) (Klop, Aquinite); 8. Bromuro di benzile (Ciclite, Camite); 9. Ioduro di benzile; 10. Bromuro di xilile (orto-meta-para) (T. Stoff).
Composti solforati. 11. Clorosolfato di metile (C. Stoff); 12. Clorosolfato di etile; 13. Solfato dimetilico (D. Stoff, Rationite); 14. Solfuro di etile biclorurato (Solfato di dicloroetile) (Yprite, Mustard Gas, Senf-gas, Lost).
Composti arsenicali. 15. Tricloruro d’Arsenico; 16. Metildicloroarsina; 17. Etildicloroarsina; 18. Fenildicloroarsina (Sternite); 19. Difenilcloroarsina (Clark 1); 20. Difenilcianarsina (Clark 2); 21. Clorovinildicloroarsina (Lewisite 1a); 22. Diclorovinilcloroarsina (Lewisite 2a); 23. Triclorovinilarsina (Lewisite 3a); 24. Difenilamincloroarsina (Adamsite).
Aldeidi. 25. Aldeide acrilica (acroleina) (Papite).
Derivati dei chetoni. 26. Cloroacetone; 27. Bromoacetone (B. Stoff); 28. Jodoacetone; 29. Bromometiletilchetone (Bn. Stoff).
Acidi organici e derivati. 30. Cloroformiato di metile; 31. Cloroformiato di metile monoclorurato (Palite, K. Stoff, C. Stoff); 32. Cloroformiato di metile biclorurato; 33. Cloroformiato di triclorometile (difosgene) (Superpalite, Perstoff); 34. Jodoacetato d’etile.
Acido cianidrico e derivati. 35. Acido cianidrico (Vincennite); 36. Cloruro di cianogeno (Manguinit); 37. Bromuro di cianogeno; 38. Cloruro di difenilcarbilamina; 39. Cianuro di bromobenzile (Camite, Teergas).
Un’ulteriore tabella riporta i «principali composti chimici usati in guerra a scopo offensivo e difensivo», annotando che «I composti chimici proposti e studiati dai vari belligeranti durante la guerra mondiale, in rapporto alle loro proprietà aggressive utilizzabili sul campo, furono moltissimi: di questi una trentina circa furono usati e solo cinque o sei su vasta scala da tutti i belligeranti» (Ibidem, p. 31).
Se i francesi non avessero impiegato per primi, e contro i tedeschi, le granate che contenevano etere etilbromoacetico e le granate contenenti cloroacetone, la guerra chimica si sarebbe scatenata comunque?
Chi è in grado di affermarlo? Credo non sia possibile affermarlo.
In ogni caso il primo che lancia un sasso contro un suo consimile è sempre il primo che scatena la sassaiola.
Ad ogni buon conto rimango, e in ogni caso, del parere che nessuna delle nazioni belligeranti sia esente da colpe, gravi, per l’utilizzo delle armi chimiche nel corso della Grande Guerra.
La Storia ha insegnato all’essere umano che una guerra può trascinare l’essere umano stesso in percorsi terribili, assolutamente disumani.
Ritengo che allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, nonché sulla scorta di quanto la Storia nel bene e nel male ci ha insegnato, le guerre si possano sempre e comunque evitare.
Ed oggi, su questa Madre Terra, possiamo indubbiamente fare di meglio che una ennesima guerra.
Gianluca Padovan