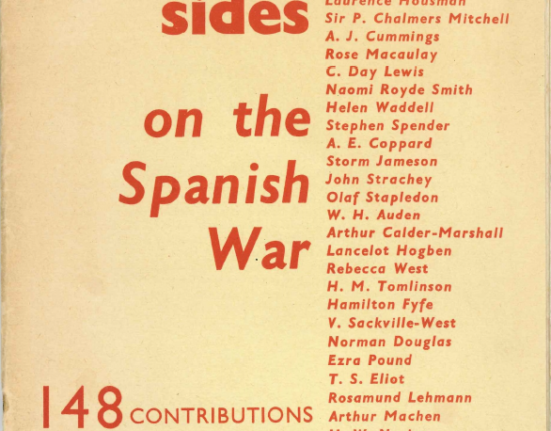al proprio dovere, era inutile e controindicato infierire più di tanto.
enti, secondo cui la Marconcini, tenuta ferma da quattro individui fu stuprata prima dal capobanda e quindi successivamente dai 36 uomini componenti la banda) sconcertò la mente del fratello e lo determinò ad una vendetta contro gli autori dell’oltraggio”