“Noi fummo i Gattopardi, i leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra”. Strane associazioni di idee si affollano nella mente sfaccendata che, per puro autolesionismo, segue lo scorrere della crisi governativa d’agosto. Capitani si rivelano caporali, vecchie e nuove volpi escono dalle tane offrendosi “al servizio del paese”. Finis Italiae, come il programma di governo di chi invoca più Europa – la malattia come terapia – e più sbarchi di immigrati. Sciacalletti e iene, secondo la straordinaria riflessione di Fabrizio Corbara principe di Salina, il nobile Gattopardo sconfitto dagli eventi. Paul Valéry ci spiegò dopo la prima guerra mondiale che anche le civiltà possono morire. Tanto più le nazioni e gli Stati, per l’indifferenza di molti e l’egemonia di iene e sciacalli. Tornano le tre streghe di Macbeth a ripeterci che brutto è il bello, e bello il brutto. Quasi nulla è come sembra.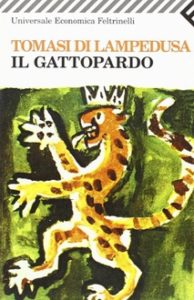
Il Gattopardo, lo splendido romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, opera unica del nobiluomo palermitano, pubblicato postumo nel 1958 un anno dopo la morte a meno di sessant’anni del suo appartato autore, è diventato il simbolo del carattere nazionale per una frase, una sola, pronunciata non dal protagonista, il principe di Salina, ma dall’amatissimo nipote Tancredi Falconeri. Dopo lo sbarco dei Mille, la vecchia società feudale siciliana andava in frantumi e il giovane rampollo, svelto a cogliere l’occasione, si schierava contro il suo rango a favore dei nuovi padroni, con la giustificazione degli opportunisti di tutte le stagioni: “se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica in quattro e quattr’otto. Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.”
Di un grande romanzo rimane al pubblico una sola frase che contraddice l’intero senso dell’opera. Gattopardesco, da allora, è l’aggettivo per i voltagabbana, gli spregiudicati svelti a infilarsi nella schiera vincente. Lontano da fuorvianti categorizzazioni, il romanzo è tutt’altro, come hanno compreso d’istinto i lettori di tutto il mondo, lasciandosi affascinare da un libro niente affatto rassicurante. Va ribaltata l’interpretazione di una sedicente intellighenzia sorpresa dall’irruzione di quel libro fuori dai suoi schemi, tesa a ridurre il Gattopardo a un seducente affresco retrò del trasformismo, anziché riconoscerlo come una sontuosa favola funeraria in cui il destino dei personaggi ha connotazioni tragiche e si consuma veloce e amaro.
Per i capibastone delle mafie culturali, il Gattopardo resta un romanzo mal sopportato da ignorare, ma è invece l’intersezione, il punto di svolta dal romanzo storico a quello psicologico, giacché il Gattopardo insegna come la storia dei fatti sia alla fine secondaria rispetto a quella dei traumi, personali e collettivi. Scritto in un periodo del secolo XX in cui riaffiorava la lode alle magnifiche sorti e progressive, Lampedusa si scagliava contro i primi presagi di quella società di consumo che distrugge con noncuranza valori, principi, passato, idee, modi di essere, intere comunità, consegnando il potere a una casta rampante, avida e ignorante, il cui unico Dio è il profitto.
Abbandoniamo gli incroci mentali suggeriti della cronaca e riflettiamo sull’ultima grande prova narrativa della nostra letteratura, un libro tra i più amati e tradotti, il primo autentico romanzo “antistorico”. Merita ripercorrere il capolavoro di Lampedusa (un predicato familiare che evoca ormai solo l’isola presa d’assalto dagli africani in arrivo) a partire dalla storia della sua pubblicazione e della manipolazione del testo, recuperato nella sua interezza da Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo e figlio adottivo dell’autore. La storia editoriale del libro è uno spaccato della tortuosa vicenda politica, morale e culturale della nostra nazione. Einaudi, Longanesi e Mondadori respinsero il manoscritto; Elio Vittorini, all’epoca dominus dell’Einaudi, fu il più netto nel rifiuto. Fu Giorgio Bassani, lo scrittore ferrarese del Giardino dei Finzi Contini a entusiasmarsi per il manoscritto recapitato da amici, pubblicandolo per Feltrinelli nel 1958.
Il successo fu immediato e il Gattopardo divenne il primo best seller italiano, nonostante il fuoco di sbarramento del PCI e degli intellettuali di servizio delle Botteghe Oscure. Il romanzo suscitò subito entusiasmi, dibattiti e polemiche. Frutto di spirito reazionario per Pasolini, Moravia, Sciascia, vinse però il premio Strega nel 1959 e fu presto tradotto in russo con il beneplacito del regime comunista, dopo una recensione favorevole di Louis Aragon, l’intellettuale comunista più influente dell’epoca. A quel punto, cambiò la strategia in Italia e un articolo commissionato da Togliatti a Giuseppe Alicata, il dirigente politico addetto ai rapporti con il mondo culturale in chiave di egemonia gramsciana, dette il via libera per un’interpretazione del libro in senso progressista, di lotta del vecchio contro il nuovo, ponendo al centro il tema della resistenza al cambiamento dei vecchi ceti di potere attraverso l’inserimento di uomini “del sistema” come Tancredi, colui per il quale tutto doveva cambiare per rimanere immobile.
Fu il cinema a decretare il successo mondiale del Gattopardo, con il celebre film di Luchino Visconti, a proposito del quale si narra di una lettera segreta del PCI per una versione cinematografica che accentuasse i caratteri decadenti del romanzo. La tesi è sostenuta da un libro, Operazione Gattopardo, pubblicato dalla stessa Feltrinelli. Secondo tale ricostruzione, il cui significativo sottotitolo è “come Visconti trasformò un libro di destra in un successo di sinistra “, il Pci scelse di cambiare strategia, appoggiando la candidatura di Luchino Visconti come regista del film. Pur di ottenere la Palma d’oro a Cannes, il regista fece sparire una dozzina di minuti, i più ideologicamente espliciti. La critica di sinistra fu in parte delusa dal risultato, ma l’operazione centrò l’obiettivo di cambiare per sempre la percezione del romanzo.
Il kolossal del 1963 entrò nella storia del cinema per lo sfarzo, la straordinaria scenografia ed ambientazione, l’indimenticabile scena del ballo, il fascino virile di Burt Lancaster, inimitabile Principe di Salina, quello ambiguo del giovane Alain Delon nel ruolo di Tancredi e la sensualità mediterranea di Claudia Cardinale, Angelica Sedara, la figlia del nuovo ricco don Calogero, che sposerà Tancredi spezzando il cuore di Concetta, una delle figlie del Principe. Strano destino quello di un libro cui si sovrappone un film fino a sostituirlo nell’immaginario comune per interessi politici, trasformato da romanzo della solitudine, della fine incombente, della sterilità dell’agire umano e quindi dell’inutilità della storia in opera calligrafica, esplicitamente decadente nella sua abbagliante bellezza, per mano di Luchino Visconti, un nobile come don Fabrizio Corbara. L’artista milanese, rampollo dei Visconti di Modrone, rappresentava perfettamente la decadenza e la fine dell’aristocrazia di sangue. Comunista, era fuoriuscito dalla storia secolare di cui era rappresentante; omosessuale, rappresentava altresì la sterilità, l’abbandono del futuro, principio della sconfitta storica della sua classe, estesa nel tempo al resto della società.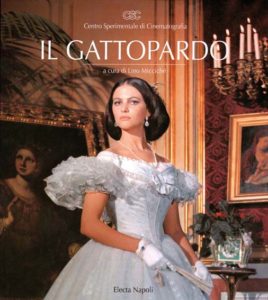
Se la storia del film è un romanzo nel romanzo, altrettanto controverso è il destino del libro, a partire dal testo, di cui fu in discussione l’autenticità sin dal 1962. La controversia sul manoscritto del 1957, che Lampedusa ricopiò personalmente, durò sino al 1969, per chiudersi solo con l’edizione curata da Gioachino Lanza Tomasi sulla base delle carte di famiglia. Un altro capitolo di un capolavoro che Bassani definì “una di quelle opere per le quali un uomo lavora o si prepara per tutta la vita”. Lanza Tomasi ricostruì un Frammento A, rimosso dall’autore e uno B, recuperato dalla vedova. Tutti questi materiali sono stati pubblicati un anno fa, nel sessantesimo anniversario dell’uscita del libro.
Spiace davvero che manipolazioni, interessi politici, editoriali, cinematografici abbiano ridotto nel tempo la forza di un grande romanzo a una semplice, per quanto elegante rappresentazione di archetipi umani, Don Fabrizio che sta perdendo il potere e Tancredi intento a raccoglierlo in qualche modo, una storia di opportunismi “gattopardeschi”. Non è davvero così e semmai il vero antagonista del Principe è Don Calogero Sedara, il nuovo sindaco di Salina, parvenu rozzo e ambizioso, la cui fortuna economica deriva prevalentemente da beni sottratti ai Salina e ai Falconeri, rappresentante della classe borghese, le iene e gli sciacalli.
L’incipit è molto significativo e, per un incrocio su cui Lampedusa avrà lungamente lavorato, ha un legame evidente con la fine del romanzo. Nel palazzo dei Salina si recita il Rosario, come ogni pomeriggio da secoli. Non può essere un Garibaldi qualunque, il vento lontano dell’”ebreuccio tedesco” Marx a cambiare le venerande abitudini della casata. “Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.” Termina con l’ultima Ave Maria la preghiera serale e lo scrittore annota un pensiero che è tra le cifre morali del romanzo: le voci “avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d’oro di parole inconsuete: amore, verginità, morte. Il cane di famiglia, Bendicò, entrava scodinzolando”. Sarà proprio lui, ignaro animale, il simbolo finale della rovina irrimediabile dei Salina, del loro mondo e della infinità vanità del tutto.
Il Principe è un leone, sì, ma di un altro tempo. Cosciente della decadenza inevitabile del suo ceto, è prigioniero dell’immobilità che considera l’essenza della Sicilia. Convinto dell’inanità degli sforzi umani, è consapevole anche della inefficacia dell’appello al passato. Per questo evita di contrastare il vento portato da Garibaldi. Il suo pessimismo pigro rammenta per contrasto quello “attivo” di un Tocqueville, rassegnato anch’egli al nuovo che incede, di cui analizza le crepe e i difetti, riconoscendo però l’inevitabilità dei processi in atto.
Don Fabrizio ha un rifugio, l’astronomia. Le stelle, almeno, si possono riconoscere, misurarne la distanza con il telescopio. Quelle “vaghe stelle dell’Orsa” rammentano al disincantato aristocratico la fragilità della condizione umana. Rifiuta anche gli onori elargiti dal nuovo potere, nella forma della nomina a senatore del nascente regno unitario. La lunga conversazione con l’inviato dei Savoia, uno dei capitoli più intensi del romanzo, è una sorta di condensato del mondo del Principe: la sua Sicilia eterna e immobile, soffocata e soffocante, sino alla fatidica abdicazione, l’invito a nominare senatore il suo contrario, il neo possidente rampante e incolto Sedara. Eppure Angelica, la figlia, sposa di Tancredi al posto di Concetta Corbara, è nipote del rozzo bracciante chiamato da tutti Peppe Mmerda. Ai gattopardi subentrano- quasi senza lotta – gli sciacalli. Cambio di scena, cala il sipario, Salina preferisce naufragare lentamente chiuso a palazzo, dialogare con le stelle in attesa della fine, che lo coglie a Palermo, in albergo, lontano dal suo feudo, dagli oggetti e dalle persone che sentiva sue, di ritorno da un infruttuoso consulto medico a Napoli, la capitale deposta.
Gli sopravvivono le tre figlie zitelle, Concetta, Carolina e Caterina. Ciascuna in forma diversa, avvizziscono tra ricordi sempre più sfumati, pratiche religiose e una collezione di reliquie che si rivela falsa, destinata a essere distrutta. E’ l’ultimo oltraggio del destino, la fine di tutto per Concetta, il cui cuore si è chiuso dopo l’abbandono di Tancredi. Romanzo dunque “antistorico”, avverso all’ottimismo teleologico e storicista. La macchina del mondo genera nuovi dolori e nuovi torti, anziché lenire i vecchi. In questo senso, si distinguono echi di Stendhal nel sentore di solitudine e morte incombente che avvolge il protagonista. La polvere del tempo si accumula su cose e persone, irrimediabilmente.
Il Gattopardo non è per nulla il romanzo del trasformismo opportunista, l’elegante scenografia a supporto del falso assioma “bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga com’è”. Nessuna continuità, nessuna sopravvivenza: quella frase diventata proverbiale è smentita da ogni pagina. Nulla resta mai com’era, ma si guasta, crolla e diventa polvere da eliminare con un panno. La memoria dei fasti familiari si ritrae, subisce amari sberleffi in una dialettica il cui perno è sempre Don Fabrizio. Spesso il centro intellettuale di un’opera letteraria è il figlio, più intelligente, più critico, più insoddisfatto della generazione precedente. E’ il caso di Edipo, Amleto, del Bazarov di Padri e figli di Turgenev. Nel Gattopardo il faro intellettuale è il padre, un paterfamilias nobile, custode della memoria di un casato e di un popolo, testimone anche della rovina. La sua vita collassa su se stessa, metafora di un mondo che si ripiega nella caduta. C’è in Don Fabrizio un’angoscia irrisolta, la narrazione analitica, persino pedante, di una morte annunciata dopo la sofferenza accettata per amor fati.
Tutto ciò si compendia nell’ultimo capitolo, successivo alla morte del Principe. Le figlie trascinano una vita svuotata, sino all’ultimo gesto simbolico di Concetta, tradita perfino dalle false reliquie per cui viveva. Lei, la superstite, ordina di gettare l’ultimo testimone del grande passato, il cane impagliato Bendicò. E’ l’excipit della storia: dal mucchietto di pelliccia esala “una nebbia di malessere” e mentre precipita la carcassa di quello che fu l’orgoglioso alano del Principe, gli occhi di vetro fissavano la donna con l’umile rimprovero delle cose che si scartano. “Pochi minuti dopo, quel che rimaneva di Bendicò venne buttato da una finestra in un angolo del cortile. Durante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante; si sarebbe potuto vedere danzare nell’aria un quadrupede dai grandi baffi e l’anteriore destro alzato che sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida.“ E’ l’atto simbolico definitivo della vittoria degli sciacalli, delle iene e delle pecore, tutti certi di essere gran cosa, anziché passanti in transito, puntini, rari nantes in gurgite vasto.
Finito il tempo dei leoni, siamo testimoni di quello dei morti viventi. Il principe di Salina ha rovesciato lo sguardo. Il cannocchiale è ora puntato dall’alto verso il basso, il Gattopardo osserva muto un mondo che non capisce. Forse la sua- la nostra – difesa contro gli sciacalli era l’immobilità: lasciar scorrere il tempo stoicamente – sopporta e astieniti – stagioni e anni, da spettatori sotto il sole implacabile. Tutto cambia, nulla rimane com’è, ogni cosa si dissolve, nostro malgrado e nonostante l’astuzia provvisoria di tutti i Tancredi, di tutti i Sedara del mondo.
Roberto Pecchioli






