“O Ascoltatore delle cesoie altisonanti,
mentre di tanto in tanto ai tosati compagni
un ariete torna belando; Suonatore di corno,
quando il cinghiale col grugno rovinando il tenero grano
infuria i nostri cacciatori; Soffio attorno ai nostri casolari,
per cacciare le muffe, e i mali delle stagioni;
bizzarro Ministro di mai descritti suoni,
che svanendo vanno sopra terre cave,
e sfioriscono tristemente per desolate lande;
temuto Violatore di misteriosi usci
che s’aprono alla conoscenza universale – guarda,
grande figlio di Driope,
i molti venuti a offrire i loro voti
con foglie attorno alla fronte!”
Abbiamo citato i versi 279-292 dell’Endimione, un poema di John Keats (Londra 1795-Roma 1821), uno degli scrittori più importanti di tutti i tempi. I quattromila versi dell’Endimione cantano il mito greco della dea Artemide che si invaghisce del bel pastorello, la quale chiede al padre Zeus di conferire a Endimione l’immortalità.
Ci siamo soffermati sulla parte iniziale, nella quale Keats compone un suggestivo inno al dio Pan, il dio pagano per eccellenza. In questa sezione si evoca l’universo sonoro, mediante l’ascoltare, le cesoie, la melodia del corno, il soffio, “i mai descritti suoni”, i voti. L’atmosfera è pregna di mistero, l’allusività dei versi sembra combaciare con i misteriosi suoni, mai descritti, che Keats sta annunciando pur sotto il velame dei simboli che intarsiano l’intero poema. Come a dire che la parola è un mistero, in quanto “a symbol of immensity”, simbolo di immensità (v. 299).
Gli albori della letteratura occidentale si ravvisano nei poemi omerici (Iliade e Odissea), che si aprono con una misteriosa figura, detta nell’Iliade theà, “dea”, la quale appare come ispiratrice di canti. È la Musa che, in questo modo, compie una fono-fania, una manifestazione attraverso il canto. La poesia occidentale nasce quindi in maniera misteriosa, infatti la parola è intrisa di mistero, quello che conferisce la divinità ispiratrice.
Anche la filosofia nasce dall’epos omerico, infatti i primi filosofi (Parmenide, Senofane, Empedocle) scrivono in esametri eroici. Nell’epos omerico, come il cantore si identifica con l’eroe declamato e poi l’eroe declamato si trasforma nell’uomo del sapere e del vedere che è il rapsodo, come ultimo stadio in Parmenide la Musa diventa Verità, la dea Aletheiē. Come a dire che anche la verità nuda e cruda, quella cioè razionale, è debitrice del mistero? Anche il logos (parola razionale) ha qualche contatto con il muthos (parola sacrale, di per sé misteriosa in quanto divina)? Probabilmente la filosofia greca antica non si stacca completamente dal mito, anche in Platone e Aristotele vi è tanto di aspetti mitici. Pertanto anche il logos ha aspetti misteriosi.
Il poema di Parmenide inizia così:
ippoi tai me ferousin, oson t’epì thumòs ikanoi,
pempon, epei m’es odon bēsan polufēmon agousai
daimonos, ē … ferei eidota fōta
“1.Le cavalle che mi portano fin dove il (mio) desiderio può giungere
2.mi guidavano, dopo che, conducendomi, mi ebbero accompagnato sulla strada ricca di canti
- della divinità che porta … l’uomo sapiente”.
L’ottativo ikanoi viene tradotto dai più avente valore iterativo, “continuano a portarmi, mi portano”, anche se alcuni vi vedono un potenziale (in Omero l’ottativo assume questo valore senza an). Le cavalle introducono continuamente Parmenide alla strada ricca di canti della dea Verità, la interlocutrice del poeta. Il genitivo daimonos si riferisce alla theà, “dea”, che compare al v.22, oppure al Sole, sul cui carro il poeta starebbe viaggiando (quest’ultima interpretazione è permessa dal richiamo successivo alle divinità solari Eliadi). Mentre il pronome relativo ē risulta (volutamente?) ambiguo: può riferirsi sia alla dea sia alla via. I tre puntini sono per un passo corrotto: KATAPANTATH. Alcuni lo correggono in: katà pant’ a t’eēi, “per tutte le cose che siano”.
L’ “uomo che sa” è in greco eidota fōta. Parmenide verrà istruito dalla dea Verità, per questo sa: quindi egli rende il suo poema intriso di mistero perché pregno di sapere divino. Alcuni danno ad eidota il valore “che vede” (in conformità al fr. 34 di Senofane) in quanto Parmenide, introdotto ai misteri nella visione della dea Verità e nell’ascolto delle sue parole, fa esperienza diretta del mistero iniziatico.
Non stupisce quindi che ai primordi la parola era riservata ai sacerdoti o comunque alla classe dominante, in quanto intrisa di sacro. Il latino carmen, che passerà a significare “poesia”, era usato all’inizio in ambito magico-sacrale. Con le “parole” era possibile interrogare un oracolo, il quale poteva rispondere con parole, spesso ambigue. Si racconta che, ai tempi in cui vi era ancora la Sibilla, un soldato doveva partire per la guerra, quindi andò a consultare l’oracolo, il quale diede questo responso: “Ibis redibis non morieris in bello”. Può essere inteso in due maniere: “ibis, redibis, non morieris in bello” (“andrai, ritornerai, non morirai in guerra”) oppure “ibis, redibis non, morieris in bello” (“andrai, non ritornerai, morirai in guerra”).
Era insomma la divinazione, ossia un procedimento con il quale si cercava di scoprire cose nascoste ricorrendo all’aiuto del mondo divino o magico, che dir si voglia, ben sapendo che nelle religioni antiche la magia era una componente essenziale.
Anticamente esistevano due tipi di divinazione: mantica diretta (divinatio naturalis, intuitiva, come quando l’officiante va in trance e il dio parla al suo posto) e mantica indiretta (divinatio artificiosa, mediante procedimenti veri e propri, e poteva essere induttiva o deduttiva). La divinatio artificiosa poteva usare un linguaggio spontaneo (omina oblativa) o provocato (omina impetrativa). In Mesopotamia si praticava quella oblativa, cioè si induceva l’oracolo a parlare spontaneamente, mediante presagi poco organizzati, molto interpretabili. Nel mondo ittita (Anatolia del II millennio a.C.) si prediligeva la impetrativa, attraverso l’uso massiccio della parola: si formulavano domande precise e si attendevano risposte precise, positive o negative. È solo in questa forma che nel mondo ittita si può parlare di “oracolo”, in ittita ariyašeššar, derivato dal verbo ariya-, “interrogare l’oracolo”.
Gli oracoli ittiti, ben formalizzati secondo procedimenti linguistici di domanda e risposta, erano questi:
- Extispicio (lettura di interiora);
- Ornitomanzia (osservazione degli uccelli);
- Lecanomanzia (sistema simbolico basato sul moto di un serpente/anguilla);
- Clinomanzia (una variante dell’extispicio);
- ḪURRI-bird Oracle (sorta di extispicio degli uccelli);
- Oniromanzia provocata (interpretazione dei sogni);
Gli studiosi ancora discutono riguardo cosa consistesse esattamente l’oracolo KIN. Il termine sumerico KIN traduceva in Mesopotamia sia l’accadico ŠIPRU, “lavoro, oracolo” che l’accadico TĒRTU, “omen”. Il termine ittita KIN aveva la valenza di ŠIPRU ed era distinto da TĒRTU, con cui si indicava l’extispicio. Il termine ittita per KIN era aniyatt-, “opera, procedimento”, dalla forma verbale anya-, “fare, operare, attuare”. Probabilmente l’oracolo KIN consisteva in questo procedimento: una maga disponeva dei simboli su una scacchiera e interrogava verbalmente la divinità, la quale si manifestava muovendo o facendo muovere le pedine così da dare un chiaro responso.
Il filosofo greco neoplatonico Proclo sosteneva l’utilità degli oracoli con queste parole: “Gli oracoli ci avvertono dei pericoli derivanti dal vivere sotto il potere del destino divenendo come coloro che, alla stregua di animali di un gregge, sono controllati dal destino stesso; in questo modo gli oracoli ci allontanano dai sensi e dai desideri materiali – infatti è a causa di questi elementi che dimentichiamo la nostra natura spirituale e divenuti semplicemente dei corpi siamo controllati secondo necessità dal destino” (Lettera all’inventore Teodoro 21).
Anticamente la parola era vista addirittura come una essenza divina, quindi un grande mistero, di cui però si intuiva la portata e l’efficacia.
Isaia 55, 10-11:
“Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme al seminatore
e pane da mangiare,
così sarà della parola
uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”.
In Isaia 45, 23 il profeta dice che la parola di Dio è irreversibile, irrevocabile. Qui il profeta amplia quanto detto in precedenza, aggiungendo che la parola di Dio genera dei frutti, come la pioggia fa germogliare il seme. Pertanto i frutti della parola di Dio sono automatici, come automatico è il processo che dalla pioggia porta al raccolto, sebbene coadiuvati dall’opera del servo del Signore, il predicatore, che estende a tutti il messaggio divino. Al v. 11 da notare che i verbi “volere” (chapetz) e “riuscire” (hifil di tzalah) riuniti insieme si leggono, oltre che in questo versetto, in Isaia 53, 10: “Riuscirà per mano sua (del servo), la volontà del Signore”. La pioggia e la neve sono abitualmente benedizioni di Dio, quindi la parola divina è quella di salvezza, la quale letteralmente non “ritorna a vuoto”, yashub ‘elay reqam, espressione usata in riferimento alla spada per descrivere il valore militare di Saul (2Samuele 1, 22). La spada è un’altra immagine frequente per descrivere la parola di Dio.
Pensiamo a Sapienza 18, 15: “La tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, come spada affilata, il tuo decreto irrevocabile”. Il termine “onnipotente” è nell’originale greco pantodunamos, e ricordiamo come la dunamis, “potenza”, è molto presente nei testi gnostici e ellenistico-giudaici. Per esempio nel Pimandro I, 32 è scritto: “riempimi di potenza”, endunamōson me (“… che io non vacilli e non venga privato della conoscenza che si confà alla nostra essenza: acconsenti e riempimi di potenza, e di questa grazia io illuminerò coloro che appartengono alla mia stirpe”). Efesini 6, 17: “Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio”. In Isaia 11, 4 le parole di punizione del Messia hanno l’efficacia di un atto di forza: “Colpirà la terra con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l’empio”. “Colpirà la terra” è in ebraico wehikkah ‘eretz; la CEI corregge “terra” (‘eretz) con “violento” (charitz), cioè “colpirà il violento”, in parallelismo con l’empio che compare dopo. Ma il testo ebraico è confermato dai manoscritti di Qumran e non è privo di senso. Il Nuovo Testamento si riappropria anche di questa immagine attribuendo alla parola di Dio e del Risorto l’efficacia tagliente di una spada. Le sentenze del giudice erano eseguite nell’antichità dalla spada. La parola di Dio ha efficacia per mezzo dello Spirito. Ebrei 4, 12: “Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore”.
È significativo che l’ebraico dabar significa sia “parola” sia “cosa”, “azione”, progetto”, grossomodo come il termine nigeriano. Salmo 33, 6-11:
“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre,
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni”.
Questo Salmo celebra la funzione cosmopoietica della parola di Dio: la sezione comincia al v. 6 (compare dabar) e finisce al v. 9 (‘mr, “parlare”, tzwh, “comandare”). Il Salmo 33 riecheggia Genesi 1, 1-3: “In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, weruah ‘Elohim merahepet ‘al pene hammaym. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu”. Tutto era informe ma lo spirito di Dio inizia la creazione, infatti dalla bocca di Dio escono queste parole: “Sia la luce!”, yehi ‘owr, e la luce venne all’esistenza. Ciò che era caos diventa, attraverso lo spirito della bocca di Dio, un kosmos, “ordine” e “mondo”, concetti espressi analogamente dal latino mundus.
Il verbo merahepet è un participio predicato, che si traduce con una forma finita. Può essere reso anche con “covava” e allora ci sarebbe l’immagine tipicamente orientale della creazione come entità che si squaderna da un uovo cosmico primordiale. Secondo un’altra interpretazione, “vento di Dio” sarebbe un superlativo ebraico per indicare un vento fortissimo, che “si agitava” (altra possibile traduzione di merahepet) sulle acque, simbolo del nulla cosmico, assieme a questo vento da uragano. Quindi, in base a tale resa, siamo ancora nel nulla, antecedente la creazione, la quale prende avvio solamente dalla parola di Dio: “Sia la luce!”
Nel Salmo 33 la parola sembra essere quasi una ipostasi, un intermediario, infatti letteralmente abbiamo “per mezzo della parola, bi-dbar … per mezzo del soffio, be-ruah”. Salmo 147, 18: “Egli invia la sua parola e li fa perire, fa soffiare il suo vento e scorre l’acqua”.
Forse il termine ebraico dabar deriva da debir, il luogo santo del Tempio di Gerusalemme. Come a dire che la parola è carica del mistero di Dio.
Sant’Ireneo di Lione diceva che la preghiera, fatta anche di parole, ha una forza tale da trasformare corpo, mente e anima dell’orante. Per i cristiani la preghiera più importante è la Santa Messa, nella quale, dapprima leggendo la parola di Dio e poi invocando lo Spirito sulle offerte che diventano veramente e realmente corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, facciamo esperienza di Gesù Risorto. Apocalisse 3, 20: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”. La seconda preghiera per importanza è il Rosario alla Beata Vergine Maria, nel quale ogni decina invita alla meditazione la parola di Dio circa i misteri di Gesù.
In greco “pregare” è euchomai, con il senso originario di “vantarsi” (elencando i meriti di fronte agli dei per ottenere qualcosa). Il verbo latino precor significa “pregare” ed è imparentato con il sanscrito pṛccha-, “domandare”, così come l’iranico pṛs-. “Pregare” è quindi “formulare una domanda” in maniera esclusivamente verbale con la preghiera, rivolta in modo speciale agli dei in vista di ottenere qualcosa che ci si aspetta da loro. In ebraico “pregare” è espresso dalla radice pll, che per Palache ha questo sviluppo: giudicare, richiedere, giudizio, supplicare, pregare.
Un detto di Maometto non raccolto nel Corano, facente parte degli Hadith, così recita: “Mentre dormite Satana fa tre nodi dietro la testa di ognuno di voi … Quando quella persona si sveglia e celebra le lodi di Dio, un nodo viene sciolto; quando fa l’abluzione, il secondo nodo viene sciolto; quando prega, tutti i nodi vengono sciolti e la mattina si alza allegra e di buon umore”.
Ibn ‘Aṭā’ Allāh, un mistico musulmano sufi, morto nel 1309, scriveva: “La preghiera è la purificazione dei cuori e il dischiudersi della porta dei misteri”. E pure: “La preghiera è il luogo del colloquio intimo e la sorgente della fedeltà. In essa si dilatano gli spazi delle coscienze e sgorgano i bagliori delle luci. Egli conosce la tua debolezza e ha diminuito il numero delle preghiere; conosce il tuo bisogno della Sua grazia e ne ha moltiplicato l’elargizione”.
Nel Corano la preghiera canonica, da fare sempre ogni giorno, è detta ṣalāt (dal siriaco ṣlōṭā prima ancora dell’avvento dell’Islam), ed è diversa da quella di richiesta (du’ā) e dalla invocazione (dhikr).
La preghiera originaria per l’Islam è quella pura, che consiste nella affermazione dell’unicità di Dio, e corrisponde alla natura originaria dell’uomo di cui essa è quasi un prolungamento. Essa forma il culto immutabile della religione originaria che è anch’essa immutabile, come precisa il Corano (30. 30): “Alza quindi il tuo volto alla vera religione, in purità di fede, Natura prima in cui Dio ha naturato gli uomini, fiṭ’rata l-lahi allatī faṭara l-nāsa ‘alayhā. Nessun mutamento patisce la Creazione di Dio, lā tabdīla likhalqi l-lahi: quella è la Religione retta, dhālika l-dīnu l-qayimu, ma i più degli uomini non sanno”.
Per gli induisti e i musulmani esoterici (sufi) la preghiera è assai importante perché si collega al suono originario, che è di natura divina. Infatti, il suono (āwāz) emana dal soffio di Allah Misericordioso (nafas al-Raḥmān) e fu manifestato al momento della creazione con il comando sonoro che la precede e la ordina. I mistici indiani chiamano questo suono sarasvatī e lo considerano la sorgente di tutti gli altri suoni, voci e vibrazioni.
Esiste per gli indiani il suono primordiale nāda, composto da tre elementi:
- Il primo è l’anāhata (non prodotto da un impatto), ovvero il suono che è sempre stato, che è ancora e che sarà. I sufi lo designano come il suono assoluto (āwāz-i muṭlaq) ed è udibile mediante certe invocazioni, ma solo dai grandi sapienti delle due comunità;
- Il secondo è āhata (prodotto da un impatto), cioè che proviene dalla collisione di due oggetti senza che si verifichi la composizione di parole;
- Il terzo è śabda, che si genera dalla composizione delle parole ed è connesso a Sarasvatī. Per questo la preghiera è assai importante in tutte e due le comunità! Da tale suono è scaturito il nome supremo (ism-i a’ẓam) dei musulmani e la sillaba OṂ degli induisti.
Il filosofo rinascimentale Marsilio Ficino riporta le opinioni degli antichi. I demoni aerei muovono nell’uomo lo spirito aereo; una volta che esso ha iniziato a vibrare si muovono anche gli umori del corpo e pertanto vengono stimolate le immagini della fantasia. Nel corpo sanguigno, stimolando più spesso il sangue e le immagini ad esso affini, si procura la voglia di vani piaceri. In quello collerico, dopo aver stimolato la bile e le immagini ad essa attinenti, si provocano l’ira e l’aggressività. In quello flemmatico, facendo aumentare la pituita e le immagini corrispondenti, si produce apatia e torpore. Infine quando nei malinconici eccitano la bile nera si infonde timore, nonché tristezza. Ficino scriveva: “Non è logico che una mente divina sia tanto ingannata e osteggiata dai sensi che a causa di demoni che hanno questo obiettivo” (Teologia platonica, Libro XVI, capitolo VII). Ebbene i platonici ritenevano, sempre a detta del grande filosofo rinascimentale, che questi demoni possono essere vinti con la filosofia e i sacrifici. Poi venne Cristo, per il quale ciò può essere realizzato mediante il digiuno e la preghiera.
Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae II-II q.83 a.2): sosteneva che la preghiera non limita la divina provvidenza: “Tre furono gli errori dell‘antichità a proposito della preghiera. Alcuni pensarono che le realtà umane non sono governate dalla provvidenza divina. Dal che segue che la preghiera, come qualsiasi culto verso Dio, sarebbe una cosa vana. E contro di essi stanno quelle parole di Malachia [3, 14]: «Avete affermato: È inutile servire Dio». – Al secondo posto troviamo l‘opinione di quanti affermavano che tutto avviene per necessità, anche nelle cose umane: sia per l‘immutabilità della provvidenza divina, sia per il determinismo degli astri, sia per la concatenazione delle cause. E anche secondo costoro è da escludersi ogni utilità della preghiera. – Il terzo errore fu l‘opinione di coloro che, pur ammettendo il governo della divina provvidenza sulle cose umane, e pur escludendo che queste avvengano per necessità, affermavano tuttavia che le disposizioni della divina provvidenza sono mutevoli, e che la loro mutazione può dipendere dalle preghiere e dalle altre funzioni del culto divino. – Ora, tutti questi errori noi li abbiamo già confutati nella Prima Parte [q. 22, aa. 2, 4; q. 23, a. 8; q. 115, a. 6; q. 116, a. 3]. Perciò l‘utilità della preghiera va difesa in modo da non imporre una necessità alle cose umane, soggette alla divina provvidenza, e d‘altra parte senza considerare mutevoli le disposizioni divine, et ideo oportet sic inducere orationis utilitatem ut neque rebus humanis, divinae providentiae subiectis, necessitatem imponamus; neque etiam divinam dispositionem mutabilem aestimemus. Per chiarire dunque la cosa si deve considerare che la divina provvidenza non dispone solo gli effetti da produrre, ma anche le cause e l‘ordine con cui devono essere prodotti. Ora tra le altre cause, per certi effetti, ci sono anche le azioni umane. Quindi è necessario che gli uomini compiano certe cose non per cambiare con i loro atti le disposizioni divine, ma per produrre alcuni determinati effetti secondo l‘ordine prestabilito da Dio. Come del resto avviene per le cause naturali. E ciò vale anche per la preghiera. Infatti noi preghiamo non allo scopo di mutare le disposizioni divine, ma per impetrare quanto Dio ha disposto che venga compiuto mediante la preghiera dei santi: cioè, come dice S. Gregorio [Dial. 1, 8], affinché gli uomini «pregando meritino di ricevere quanto Dio onnipotente fin dall‘eternità aveva disposto di donare ad essi» “.
Per i filosofi stoici romani minori Persio e Giovenale, la religione è assai importante. Infatti Persio riteneva che il vero culto deve essere spirituale. Per Giovenale gli dei sono i custodi della vita umana e i suoi supervisori quindi egli si duole che gli uomini li trascurino e vivano nel male. La riflessione di Giovenale sul rapporto tra uomini e dei si sostanzia principalmente nella Satira XIII, nella quale il poeta e filosofo divide gli uomini in due categorie: 1. quelli che non credono negli dei o che ritengono che essi non si occupano dei casi umani, come gli epicurei; 2. quelli che pensano che gli dei infliggano qualche male in questa vita per punire la colpa e ciò mitigherà il giudizio divino oppure quelli che pensano di passare inosservati agli dei o di placarli con qualche sacrificio. A tutti costoro Giovenale risponde che gli dei esistono veramente e si prendono cura degli uomini, saranno i loro giudici, quindi sorvegliano la coscienza morale e il vero culto, che non deve essere solo formale bensì sentito.
Sembra quasi di sentire le parole del profeta biblico Osea per il quale Dio preferisce l’amore rispetto al sacrificio, senza però annullare quest’ultimo (6,6: “Amore voglio e non sacrifici”). Dio ama la preghiera, ma preferisce che sia detta con il cuore. I santi testimoniano di un Dio “pazzo di amore” per il genere umano che si accontenta anche di quel poco che una creatura può dargli, come se venisse ad elemosinare dalle persone amore, preghiera, attenzioni. Basilio Magno diceva che il vero peccato sta nel non pensare Dio durante la giornata.
Quando in uno scritto si parla di ciò che Dio pensa o vuole, si fanno certamente affermazioni umane.
Dio, infatti, è per i teologi cristiani medioevali “radicaliter alter”, cioè talmente diverso dalla realtà umana che è impossibile capirlo del tutto, sviscerandone la sua essenza. Il filosofo medioplatonico romano Calcidio (IV secolo) nel suo Commento al Timeo di Platone diceva più volte che Dio è “intellegibilis”. Ma intellegibilis, come il greco noētos, non significa che si può conoscere Dio per come egli è, ma che la nozione di lui, della sua esistenza, della sua funzione, insomma tutto quello che poveramente e imperfettamente si può dire di lui, è opera dell’intelletto e non della sensazione. Infatti lo stesso Calcidio rivela che Dio è “aestimatione intellectusque melior” (cap. 176). Questa espressione si legge quasi identica in Plotino (Enneadi V, 1, 8): “Ciò che è al di là dell’intelligenza e al di là dell’essere”, to epekeina nou kai epekeina ousias.
Pertanto nulla di definitivo e perfetto si può conoscere di Dio e dei misteri cristiani, della creazione e del destino umano e delle altre creature. La teologia contemporanea è diventata una a-loghia, ammette la povertà concettuale e verbale riguardo Dio. Dio non occorre capirlo ma conoscerlo quel poco che serve per sapere che Egli vuole essere amato e pregato. Pregare Dio risponde alla virtù della giustizia.
Il filosofo greco presocratico Pitagora iniziava i suoi celebri Versi aurei così:
athanatous men prōta theous, nomōi kai diakeitai = “venera anzitutto gli dei immortali secondo la legge, e serba il giuramento”.
Quel “secondo la legge” (nomōi) probabilmente vuole indicare la tolleranza di Pitagora rispetto i vari culti praticati sulla terra. Pitagora sarebbe stato iniziato ai Misteri di più tradizioni sulla faccia della terra, quindi era riguardoso nei confronti del sentimento religioso. È un po’ come nel mondo moderno con Ramakrishna, il quale dopo essere stato induista passò a verificare la sua esperienza nelle forme dell’Islam e del cristianesimo. Bisogna pure dire che il politeismo greco romano era soltanto apparente, in quanto, sotto nomi diversi, si veneravano nei vari luoghi stessi aspetti o potenze del divino. Gli antichi, poi, quando venivano a contatto con egiziani, caldei, persiani, celti e così via, riconoscevano che i culti lì praticati erano rivolti alle stesse entità che loro adoravano con altri nomi nella propria patria.
La Madonna è la Madre di Dio, che ha dato alla luce Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Viene pregata come Arca della Nuova Alleanza. Nell’Antico Testamento dentro l’Arca dell’Alleanza erano poste le Tavole della Legge che Dio diede a Mosè. Maria lo è della Nuova Alleanza perché ha custodito nel suo grembo Cristo, che è detto da Giovanni Logos, termine greco che significa Parola, in latino Verbum. La Madonna apparsa a Kibeho in Rwanda si chiamò: Madre del Verbo. La scrittrice tedesca Gertrud von Le Fort pregava la Santissima Vergine in questo modo:
“Aiutaci, dolce Vergine Maria,
aiutaci a dire: ci sia pace
per il nostro povero mondo.
Tu che fosti salutata
dallo Spirito ella Pace,
ottieni pace per noi.
Tu che accogliesti in te
Il Verbo della pace,
ottieni pace per noi …”.
Il Vangelo di Giovanni è il quarto, ritenuto il più recente, completato non dopo il 90 d.C. Giovanni scrive il suo vangelo per i convertiti dal paganesimo, come è dimostrato dalle numerose spiegazioni di festività e usanze giudaiche. Giovanni mette in particolare rilievo i caratteri della divinità di Cristo. Egli cerca di rendere comprensibile il mistero insondabile di Gesù Cristo con un linguaggio tecnico e specifico. È il Vangelo di Giovanni a porre le basi per le profonde riflessioni teologiche dei secoli successivi sui misteri della Trinità e dell’Incarnazione.
L’incipit del quarto vangelo è questo:
en archēi ēn o Logos kai o Logos ēn pros ton theon kai theos ēn o Logos
= in principio era il Logos e il Logos era presso Dio e Dio era il Logos.
Gli esegeti di oggi ipotizzano che Giovanni abbia usato per il prologo del suo vangelo (1, 1-18) un preesistente inno al Logos, forse di matrice gnostica. Ma gli studiosi non concordano. Comunque è un dato di fatto che Giovanni usi solo qui la parola greca Logos (oltre che nel proemio di 1Giovanni). Come è un dato di fatto che, da un punto di vista di stilistica letteraria, il prologo pare fatto sia in versi e forse strofe con una certa ritmicità, assieme a materiale più prosastico (come i due incisi su Giovanni il Battista 6-8.15; il modo incerto e pesante di esprimersi del v.9; il linguaggio pleonastico di 12-13; i due versetti finali inattesi che sembrano palesemente aggiunte).
È stato scritto molto riguardo l’imperfetto greco ēn, “era”, riferito al Logos. Se ammetiamo un preesistente inno in aramaico, si tratta chiaramente di un perfetto aramaico: non sarebbe un passato ma un verbo che esprime la pienezza dell’essere, senza tempo: Cristo prima, adesso e in futuro. “Prima che Abramo fosse, Io Sono” (8, 58). Altri studiosi notano come tale imperfetto denoti la natura personale di Cristo-Logos, che come un essere umano, vero Dio e vero Uomo, era in principio prima della creazione e si trovava presso il Padre. Se accettiamo questa seconda interpretazione, la natura personale del Logos lo colloca lontano dalla speculazione sapienziale giudeo-ellenistica, da quella sul Logos dell’ebreo Filone, dalle idee gnostiche di potenze creatrici.
La preposizione greca pròs non esprime qui un movimento verso una meta, un processo vitale all’interno di Dio, ma nella koiné ha semplicemente il valore di parà, stato in luogo. Lo stesso concetto si ripropone in 17, 5 quando Cristo dice che sulla terra ricontempla la gloria che aveva “presso il Padre”: tale gloria consiste nella vicinanza a Dio, nella comunione di vita in Lui. Si tratta certamente di un linguaggio spaziale, quindi figurato, ma che vuole esprimere la strettissima comunione tra Cristo e il Padre.
Questa comunione viene espressa meglio nella terza frase: “Dio era il Logos”. “Io e il Padre siamo una cosa sola” (10, 30). La parola theos è diversa da o theos: infatti theos a principio di frase è predicato, questo vuol dire non che Logos e Padre siano identici, cioè siano la stessa cosa, nel senso che quando si parla di Logos si parla di Padre, siano insomma la stessa persona. Non si tratta dello stesso genere bensì la indicazione dell’essere comune, un qualcosa che unisce Logos e Padre, in questo senso i due sono identici. Vuol dire che la stessa divinità riguarda sia il Logos sia il Padre. Infatti, in greco di un nome senza articolo si sottolinea la qualità o essenza. Non necessariamente la frase è da tradurre “il Logos era un dio” in quanto in greco un sostantivo senza articolo non indica sempre la presenza di un articolo indeterminativo. Invece Dio Padre è indicato con l’articolo (o theos, “il Dio”) secondo l’uso greco di metterne in rilievo l’identità. Inoltre, non andrebbe tradotto nemmeno “il Logos era divino” in quanto il greco ha un aggettivo specifico per indicare “divino”, che è theios, e Giovanni espressamente non lo ha usato.
Le civiltà del passato si basavano sull’insegnamento di maestri umani mutuati da responsi divini, i veri garanti della validità di quelle parole. Non per nulla nella lingua degli antichi egizi la parola è detta medw, che si scrive con il geroglifico del bastone, come per guidare il discepolo. Nei Testi delle Piramidi, redatti sulle pareti delle tombe dei re per assisterli lungo il viaggio nel mondo dei beati, si incontra spesso la espressione DD MEDW, che si può intendere come “parole da dire”, ma DD significa anche “stabilità”, pertanto si può concludere che le parole proferite a favore del re da parte del sacerdote, su comando divino, sono le sole durevoli.
Alla metà dell’Ottocento Émile Prisse d’Avennes, un egittologo francese, riportava in Europa dai suoi scavi e dalle sue ricerche egiziane un documento eccezionale. Si trattava di un papiro lungo sette metri, risalente al 1800 a.C. circa e proveniente – a quanto pare – dalla tomba di un alto funzionario dell’antica Tebe. Oggi il papiro è custodito presso la Biblioteca Nazionale Francese.
Cosa contiene questo papiro? Nella prima parte si può leggere la fine degli “Insegnamenti per Gemnikaï”, futuro visir del faraone Snefru (IV dinastia, XXVII sec. a.C. ); poi seguono due metri di testo vuoto, cancellato già nell’antichità; quindi comincia un’opera dal titolo “Gli insegnamenti di Ptahhotep”. Anche quest’ultimo fu un visir, vissuto ai tempi del faraone Djedkara Izezi (V dinastia, XXV-XXIV sec. a.C.), e il testo riporta le sue massime indirizzate al figlio, che l’avrebbe dovuto sostituire nel ruolo di visir presso il re.
Il papiro Prisse, redatto in una elegante scrittura ieratica (la scrittura usata dagli scribi egizi per lettere, documenti amministrativi, testi letterari e altri contenuti che interessavano la corte e che non erano destinati ai monumenti, sui quali si preferiva il geroglifico), era dunque una raccolta di Insegnamenti, un genere letterario che ebbe grande fortuna nel Medio Regno. In questi scritti si immaginava che dei sapienti trasmettessero le loro conoscenze ai più giovani sotto forma di massime. È scritto in medio egiziano, considerato la fase classica della lingua. Si tratta di uno dei libri più antichi dell’umanità.
In un noto passaggio del Papiro Prisse, Ptahhotep dice che il vero sapiente è colui che ascolta gli insegnamenti degli anziani. Invece colui che non lo fa, sta nell’ignoranza. Egli non impara, è come se fosse un morto vivente perché non sa vivere. Non ha stabilità. Ecco la frase, lapidaria, di Ptahhotep: Hr m.t anx ra nb, “dicono di lui: è un morto vivente ogni giorno”.
In un altro celebre passaggio del Papiro Prisse è scritto:
aq.w=f pw xbn Dd = il suo pane è il distorcere il dire/la parola
Colui che non presta ascolto alla parola dei maestri resta nell’ignoranza, come un morto, e distorce anche gli insegnamenti. Egli non capisce le perle preziose della sapienza e travisa ogni cosa.
Il sostantivo aq.w=f significa “il suo pane”, si riferisce alla pagnotta, ma anche al guadagno, introito oppure al cibo in genere. È come se il sapiente Ptahhotep volesse comunicare che colui il quale non presta ascolto a chi ne sa più di lui, crede di essere più furbo dei maestri tanto da ricavare un guadagno dalla sua ignoranza. Ptahhotep sta stigmatizzando il presuntuoso, che oltre a non sapere presume di sé stesso.
Il verbo aq vuol dire letteralmente “entrare”, per questo il sostantivo si riferisce sia all’introito sia al cibo. Si dice del sole quando tramonta, cioè che entra nella terra (aq ra), mentre quando sorge si dice pr ra.
La parola aqw sostituisce nel tempo il lemma t per pane, che invece non sopravvive nel copto. Il termine xbn vuol dire distorcere, essere criminale. Dd è “il dire”, infinito sostantivato.
Da notare anche la costruzione in chiasmo. Inoltre l’espressione xbn Dd, interpretabile anche come “condannabile al dire, maledetto”, evoca xbn xrw, “condannato”, attestato nei Testi delle Piramidi (formula 486), antitetico al famoso mAa xrw, “giustificato”, applicato ai defunti avendo superato vittoriosamente la prova dell’ultimo giudizio.
Un altro famoso testo della letteratura egiziana è il Dialogo del disperato con la sua anima. Esso ci è giunto in un solo papiro (n. 3024 del Museo di Berlino) e data al Medio Regno. Ha forma di dialogo tra un uomo ormai stanco di vivere che si abbandona alla disperazione per via di una tragedia individuale, e la sua anima, il Ba. L’uomo vuole morire ma il suo Ba, conoscendo il dolore e l’amarezza dell’aldilà, si rifiuta di seguirlo e lo esorta all’oblio che sana gli affanni. Alle perorazioni del Ba, l’uomo fa un inno alla morte, unica consolatrice, unica sosta all’intollerabile sofferenza della vita presente.
Ebbene questo stupendo testo lirico proveniente dalle sabbie dell’antico Egitto si apre con queste parole egiziane:
jw r sksk grg Hr tA pn n nm’ n ns=sn
al fine di eliminare la menzogna su questa terra, la loro lingua non può essere parziale.
La proposizione jw r sksk grg Hr tA pn, “al fine di eliminare la menzogna su questa terra”, è una circostanziale finale. Grg è la menzogna, la falsità. Invece n nm’ n ns=sn è letteralmente “è inesistente ciò, l’essere parziale da parte della loro lingua”. Negazione (n) dell’aoristo nm’, essere parziale.
Il poeta canta che la lingua (ns), cioè la parola, non può essere parziale, cioè deve dire tutta la verità. Anticamente le parole servivano non per creare fake news ma per porre in essere insegnamenti validi, ammonimenti.
Da millenni la parola viene studiata dalle varie civiltà anche perché essa tramanda gli insegnamenti divini, quindi è estremamente importante. Le grandi tradizioni della linguistica sono quella babilonese, quella indiana, quella greco-romana, quella araba.
Nell’arte letteraria ci sarebbe un “succo”, una “essenza” (in sanscrito rasa) che può portare anche alla liberazione (mokṣa). Per Schelling nella poesia vi è l’Assoluto. Che grande mistero è la parola! I versi di una poesia con le loro immagini e la loro musicalità sono capaci di meravigliare anche a distanza di millenni.
Nella letteratura persiana le scienze della versificazione sono:
- ‘elm-e ‘aruz: prosodia
- ‘elm-e qāfiyye: rimica (kalamat qāfiyye)
- ‘elm-e badi‘: figure retoriche di suono e di forma, come il tajnis (accostamento di parole scritte in modo identico)
- ‘elm-e bayān: figure retoriche di contenuto, come l’ihām (uso di una parola dal doppio significato che crea ambiguità e magari utilizzare il significato meno comune)
- ‘elm-e ma‘āni: figura retorica rispetto alla sintassi e alla posizione della parola nel verso.
La letteratura persiana è in sostanza un tipo di produzione musulmana. In tutte le letterature musulmane la parola riveste una importanza capitale e questo è vero soprattutto per gli arabi, preislamici e islamici, per i quali la poesia è “il registro (dīwān) di queste tribù, il magazzino della loro sapienza, il luogo ove si mostrano le loro usanze (ādāb) e il ricettacolo delle loro scienze” (Abū Hilāl al-‘Askarī, m. 1005). Per questo il poeta (šā’ir) è un pilastro fondamentale nella vita del deserto: questi “presso gli arabi dell’epoca preislamica (al-ǧāhiliyya) aveva lo stesso posto che i profeti hanno presso le genti” (Abū Ḥātim al-Rāzī, m. 934).
Con l’avvento dell’Islam il ruolo del poeta nella civiltà musulmana resta sempre importante, specie se questa figura si fa portavoce del sentire religioso. Sebbene Maometto non si consideri un poeta, il Corano, scritto interamente in prosa, ricevuto da lui da parte dell’angelo Gabriele, viene considerato il Libro per eccellenza, quello che fonda la civiltà islamica e il punto di riferimento imprescindibile nei secoli a venire.
Facciamo un solo esempio della importanza della poesia presso il mondo preislamico. I beduini nomadi abitavano le tende (bayt), che erano il cuore pulsante della loro vita, tanto che venivano quasi umanizzate: la parte aperta era il viso (waǧh al-bayt). Un elemento così decisivo per la sopravvivenza di quelle antiche popolazioni dava il nome al verso della poesia: nella nota espressione bayt al-ša’r, “tenda di pelo”, abitata dai beduini, e bayt al-ši’r, “verso della poesia”, si trova la relazione tra i due elementi fondamentali della vita nel deserto.
Il lessico di una qualsiasi lingua coincide con la langue, il sistema linguistico, ed è formato da unità astratte, i lessemi, che il sistema linguistico mette a disposizione dei parlanti. Il vocabolario coincide con la parole, l’uso delle lingue, ed è formato dalle unità, i vocaboli, effettivamente usate nel discorso.
Il vocabolario è l’insieme dei vocaboli usati da un singolo parlante o da un gruppo di parlanti.
Il lessico è costituito dalla somma di questi insiemi, dall’insieme di tutti i vocabolari. A ciò si aggiunge l’insieme potenziale delle parole che non sono attestate nei discorsi, ma che potrebbero essere create tramite regole di formazione. È un numero indefinito di parole inesistenti ma possibili (come quelle formate dal prefisso iper). È un “lessico virtuale”. Il lessico è dunque un insieme aperto e infinitamente più ampio di qualsiasi vocabolario ma anche dizionario.
Il dizionario è la rappresentazione del lessico di una lingua; questa rappresentazione è sempre parziale perché deve operare una selezione che riguarda sia particolari categorie di parole (sigle), sia parole appartenenti a particolari strati del lessico (lingua scientifica).
Ciascuna unità lessicale registrata in un dizionario è chiamata lemma o entrata. L’insieme dei lemmi è il lemmario. L’operazione con cui si registra una parola come lemma è la lemmatizzazione. La lemmatizzazione riconduce le parole alla forma base che le identifica come lessemi. La forma base coincide con la forma di citazione. La lemmatizzazione non è mai un’operazione automatica, soprattutto per la presenza di omonimi (stessa forma, diverso significato). Se l’identità è solo grafica sono omografi, se è solo fonica omofoni. Un lessema omografo e omofono è detto omonimo, e diventa omonimo perfetto o assoluto se coincide anche la categoria grammaticale (esempio: piano). Per stabilire se si ha omonimia si usa un criterio etimologico: i lessemi omonimi hanno una diversa etimologia.
La lessicografia è l’attività di progettazione e realizzazione di dizionari; ha per oggetto i principi e le tecniche per registrare e descrivere i vocaboli di una lingua.
La lessicologia è il settore della linguistica dello studio generale del lessico, ossia forma, storia, significato e uso dei lessemi che formano il sistema lessicale di una lingua. Si intreccia con: morfologia, etimologia, statistica linguistica e semantica. La lessicologia è anche definita come lo studio dei rapporti semantici tra lessemi (ambito strutturalista).
La classificazione delle parole. Dalla tradizione greco-latina deriva la classificazione delle parole in parti del discorso (partes orationis). Questo inventario delle parti del discorso non è fisso, ma mutevole nel tempo e nello spazio: l’italiano ha 9 parti, divise in declinabili (nome, aggettivo, verbo, pronome e articolo) e invariabili (avverbio, preposizione, interiezione e congiunzione).
Questa classificazione si basa su due criteri: 1. Formale: distingue i lessemi che si possono declinare da quelli che non hanno flessione; 2. Semantico-concettuale: relativo al contenuto di cui le diverse classi sono portatrici (nomi = entità; verbi = azioni). La linguistica moderna ha modificato sia i criteri di categorizzazione sia l’inventario delle classi. Le parti del discorso vengono chiamate classi di parole o categorie lessicali.
Non esiste una classificazione condivisa da tutti gli studiosi, perché la classificazione delle parole presuppone una teoria della grammatica che può variare. Pertanto anche in questo la parola nel suo insieme è un mistero. Esistono molti tipi di grammatiche e non si è arrivati nemmeno alla definizione di “parola”.
Inoltre, la grammatica moderna assume che non tutte le categorie siano universali; le uniche che lo possono essere sono: nome, verbo aggettivo e preposizione (ad-posizione). Queste ultime sono anche chiamate le categorie maggiori, mentre quelle minori sono quelle che possono mancare nelle lingue (come l’articolo).
Compare anche una nuova classe, quella dei determinanti che include articoli e aggettivi/pronomi dimostrativi.
L’individuazione delle classi avviene con un criterio distribuzionale, in base alla posizione che le parole possono occupare nella frase, e un criterio formale, ossia che le parole che appartengono alla stessa classe prevedono lo stesso tipo di modificazione morfologica. Il criterio semantico è ritenuto inaffidabile: nomi come bontà indicano qualità al pari degli aggettivi.
Questo esempio mostra come sia necessario riconoscere delle sottoclassi di parole, come nelle varie specie di nomi. L’operazione con cui si distinguono in una categoria sottoclassi di parole è chiamata sottocategorizzazione.
Nella grammatica generativa la sottocategorizzazione avviene in base a due caratteristiche: 1. Intrinseche: riguardano le proprietà della parola considerata in se stessa ed espresse in forma binaria di presenza/assenza (± comune, per un nome); 2. Contestuali: riguardano la parola nella sua combinazione con le altre parole.
La (2) ha due tipi: 2.1. Sottocategorizzazione stretta: specificano con quali elementi può combinarsi una parola; 2.2. Restrizioni di selezione: specificano quali tratti intriseci devono avere le parole con cui la parola si combina. Violando (2.1) si ottengono frasi mal formate grammaticalmente; violando (2.2) frasi anomale semanticamente, ma giuste sintatticamente.
Parole piene (o parole contenuto, o autosemantiche o categorematiche): hanno un contenuto lessicale, un significato lessicale (gatto). Parole vuote (o parole funzione, o sinsemantiche, o sincategorematiche): con significato grammaticale, esprimono relazioni grammaticali (“il” gatto).
La distinzione tra parole piene e vuote coincide, in larga misura, con la distinzione tra classi aperte (infinitamente ampliabili) e classi chiuse.
I lessemi complessi sono lessemi formati da più parole (macchina da scrivere), chiamati altresì parole polirematiche. L’esistenza di questi lessemi mette in crisi sia la comune nozione di parola, sia la possibilità di tracciare una distinzione netta tra fenomeni lessicali e quelli sintattici. Le polirematiche si collocano a metà strada tra le parole (gatto) e le non parole (il mio gatto grigio). Non hanno una costruzione libera tramite regole sintattiche, e inoltre alcune volte possono essere scritte come un’unica parola. Molte polirematiche, poi, hanno un significato globale che non è ricavabile in modo composizionale dalle parole componenti. Tutto questo indica che sono una zona intermedia tra il “lessico – lessico” e la “sintassi – sintassi” e per darne conto si deve adottare una nozione graduale di parola: nel continuum che va dalla parola – parola alla non – parola si collocano le varie forme complesse che saranno tanto più parole quanto più hanno le caratteristiche della parola prototipica.
Le polirematiche esistono in ogni categoria lessicale: nomi (carta carbone), verbi (dare retta), aggettivi (alla mano), avverbi (a bruciapelo), congiunzioni (a meno che), preposizioni (a causa di), interiezioni (mamma mia). Dunque, la creazione di lessemi complessi è un normale meccanismo di estensione del lessico.
Le polirematiche si distribuiscono nei vari strati del lessico, alcune appartengono a un vocabolario comune, con una connotazione familiare o colloquiale; altre hanno una connotazione regionale, o anche letteraria, oppure sono di un vocabolario specialistico. In molti linguaggi tecnico-scientifici le polirematiche superano i lessemi semplici.
Come distinguere le polirematiche? Uno dei criteri è che ai lessemi complessi è sempre possibile assegnare la locuzione a una classe lessicale, cioè che abbia la distribuzione di un lessema. Dal punto di vista semantico, un criterio invocato è quello della non – composizionalità semantica (ma non sempre è vero: sedia a rotelle ha un significato composizionale). Spesso, anzi, una polirematica può avere sia un significato lessicale che un significato figurato, risultando polisemica (Tirare su).
Le lingue del mondo sono circa 45.000 e si raggruppano quasi sempre in famiglie linguistiche. Quelle parlate ritenute non imparentate sono dette “isolate”, come sumerico, etrusco, basco, giapponese, e per alcuni l’egiziano antico. Ma per alcune di queste lingue gli studiosi non concordano. Per dei linguisti, infatti, l’egiziano apparterrebbe alla famiglia afroasiatica, che comprende anche semitico, berbero, ciadico, e così via. Per esempio, l’egiziano j’b, “congiungere”, viene accostato all’arabo ǧaḏaba, “tirare”, cioè vi sarebbe una corrispondenza tra la /j/ dell’egiziano e la /g/ del protosemitico, come quando l’egiziano jw’, “ereditare”, viene accostato all’arabo ǧāda, “essere buono”.
Il latino fa parte della famiglia delle lingue indoeuropee, da esso deriva anche l’italiano. Già nel 1600 da Sansonetti vennero scoperte alcune curiose somiglianze fra le lingue, come il nome dei numeri. Verso la fine del 1700 vengono studiate le lingue indiane, specialmente il sanscrito, grazie al colonialismo. Il primo fu l’inglese W. Jones, che nel 1785 dimostrò l’affinità tra greco e sanscrito. I fratelli Schoegel studiarono il sanscrito, perché col romanticismo nasce il fascino per le culture orientali. Nel 1816 il tedesco Franz Bopp scrisse un libro sul sistema verbale sanscrito comparato al persiano, al latino, al greco e al germanico, fondando la linguistica comparata. Si pensa che le lingue europee, indiane e persiane abbiano una matrice comune, perché hanno delle strutture simili (sono le lingue della famiglia indoeuropea). In Europa le uniche lingue non indoeuropee sono il basco (che forse riprende lingue caucasiche), le lingue del gruppo ugro finnico (l’ungherese, l’estone e il finlandese, o finnico), il turco e alcuni idiomi parlati in Russia.
Le lingue indoeuropee si suddividono in:
- Lingue neolatine (dette così perché derivano dal latino): italiano, francese, castigliano (spagnolo), portoghese, rumeno, provenzale, catalano, sardo e ladino
- Lingue germaniche: inglese, tedesco, islandese, olandese e lingue scandinave
- Lingue celtiche
- Lingue anatoliche (ittita cuneiforme, ittita geroglifico, luvio, palaico)
- Greco (miceneo, greco arcaico, classico, ellenistico o koiné, medioevale, moderno)
- Tocario
- Albanese: proviene dalla lingua illirica
- Lingue slave: ucraino, sloveno, croato, macedone, bulgaro, russo, bielorusso, polacco, slovacco e ceco
- Lingue baltiche: lituano, antico prussiano, lettone
- Lingue arie: vedico, sanscrito, avestico, iranico. Le lingue indoarie sono idiomi indiani di origine indoeuropea che si sono evoluti in queste tappe: vedico, sanscrito, pracriti, apabhraṃsha, lingue indoarie moderne (hindi, bengalese, urdu, e così via).
L’italiano è una lingua che ha dato ai posteri poesie di altissima qualità letteraria, pensiamo solo a Dante o a Petrarca e prima ancora alla Scuola siciliana, che nella persona di Giacomo da Lentini ha creato il fortunatissimo sonetto. Tanta è stata la gloria della poesia italiana che si pensava questo: nessun poeta italiano avrebbe potuto scrivere versi mirabili se non negli schemi propri della lingua italiana.
Ma andiamo per ordine. La poesia italiana è accentata, mentre quella greca e latina si basava sulla quantità delle sillabe. La trasformazione del verso quantitativo greco-romano nel verso qualitativo italiano (cioè accentato) è stata la vittoria della poesia popolare su quella dotta. Dante scrive la Divina Commedia in endecasillabi (11 accenti) di terzine con rima incatenata. Però ci furono dei tentativi di riprodurre in italiano la poesia classica greco-latina. E furono di due tipi. Abbiamo la poesia italiana “metrica” quando si tentò di rifare i versi latini tenendo conto della quantità delle sillabe italiane, per cui nel XV secolo scrissero esametri Leon Battista Alberti, Leonardo dati, e altri. Invece abbiamo la poesia “barbara” quella che vuole riprodurre il verso classico con gli accenti e senza badare alla quantità delle sillabe.
Grossomodo tutti i tentativi furono o maldestri oppure, se pregevoli, mai paragonabili al genio di Giosuè Carducci, solo il quale dimostrò con le sue Odi barbare che anche in italiano si può scrivere una mirabile poesia classicheggiante senza ricorrere ai metri della poesia italiana e alla rima.
Il Preludio alle Odi barbare è questo (citiamo solo la prima strofa):
Odio l’usata poesia: concede
comodo al vulgo i flosci fianchi e senza
palpiti sotto i consueti amplessi
stendesi e dorme.
Carducci ricorre nel Preludio al metro saffico, quello a lui prediletto, con il quale scrisse undici saffiche barbare, cioè senza rima con strofe ciascuna di tre endecasillabi (i saffici di Orazio e di Catullo) seguiti da un quinario (adonio). Il poeta qui dice di odiare la comune poesia, accessibile a tutti e fiacca, che non desta nobili sentimenti e alti pensieri.
L’ispirazione poetica è quanto di più profondo possa capitare a uno scrittore. Non si tratta di scrivere come un cronista ma di pensare ispirato da un dio, quindi di somigliare al mondo divino. Chi compone poesia spesso viene investito da un furore sacro che i mortali poche volte conoscono. Pensiamo alle Rime di Torquato Tasso. Egli scrisse per tutta la vita le poesie liriche, facendo molte edizioni a stampa e rimaneggiandole in continuazione con numerosi ripensamenti e correzioni visibili negli autografi, e anche durante vicissitudini personali assai penose. Quelle liriche erano un chiodo fisso, egli pensava a tali poesie con interesse vivo e gusto d’ordine e insoddisfatta preoccupazione già alla vigilia della sua più felice stagione poetica, cioè alla vigilia degli anni memorabili dell’Aminta e della Liberata. E anche quando, più tardi, l’impegno parrà tutto volto al poema l’occhio non si discosterà se non fugacemente dalle rime, anzi avrà spesso un interesse rinnovato. Sino agli ultimi anni, quelli del tempo febbrile ma poeticamente esausto della Conquistata. Negli anni tardivi l’interesse alla sistemazione di tutto il materiale delle rime fece venire a Tasso il proposito di suddividerle in tre sezioni: amorose, encomiastiche e sacre. Le prime mostrano la devozione poetica al petrarchismo; le seconde, dedicate a personaggi illustri, mostrano l’ascendenza pindarica e oraziana; le terze sono più cupe, si vede che Tasso voleva esorcizzare il suo malessere con la fede e il rito. L’ispirazione poetica esprime il mistero della parola in ragione del fatto che il segno verbale trascolora dall’umano al divino, transumanando dalla terra al cielo.
Tasso era roso da un tarlo interiore. Il poeta lavorò ininterrottamente su queste liriche tanto che non poté fare come il Petrarca, il quale diede un assetto definitivo al suo Canzoniere. Invece quello del Tasso è colmo di problemi filologici: circolavano edizioni pirata, altre rime non furono pubblicate nelle edizioni ufficiali e in quelle pirata. Quindi la edizione effettivamente curata dal Tasso, la cui prima parte uscì nel 1591, la seconda nel 1593, mentre la terza fu data alle stampe dopo la morte nel 1597, senza però il consenso diretto del poeta – essa non raccoglie tutte le rime della produzione tassiana. Come non è possibile accettare per il poema la scelta del Tasso, che approvò solamente la Conquistata e non la Liberata, così non è possibile restringere alle sole rime pubblicate nella edizione tarda tutto il corpus tassiano. Produzione, quella delle rime, in cui traspare una chiarezza espressiva e concettuale che ne decretò l’immediato successo. Con una metrica impostata sulla cantabilità ma anche sulla rottura (il famoso enjambement tassiano).
Citiamo questo sonetto, uno dei più ispirati e intensi del Tasso, composto quando il poeta era in prigionia nell’Ospedale di sant’Anna, tra il 1579 e il 1581:
Vecchio ed alato dio, nato col sole
ad un parto medesmo e con le stelle,
che distruggi le cose e rinovelle
mentre per torte vie vole e rivole,
il mio cor, che languendo egro si duole
e de le cure sue spinose e felle
dopo mille argomenti una non svelle,
non ha, se non sei tu, chi più ‘l console.
Tu ne sterpa i pensieri e di giocondo
oblio spargi le piaghe, e tu disgombra
la frode onde son pieni i regi chiostri:
e tu la verità traggi dal fondo
dov’è sommersa, e senza velo od ombra,
ignuda e bella a gli occhi altrui si mostri.
Bibliografia
- M. A. Amir-Moezzi, I. Zilio-Grandi (a cura di), Dizionario del Corano, Milano 2007;
- I. ‘Aṭā’ Allāh, Sentenze e Colloquio mistico, a cura di C. Valdrè, Milano 1981;
- E. Bresciani, Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Torino 1999;
- Calcidio, Commentario al Timeo di Platone, a cura di C. Moreschini, Milano 2012;
- O. Capezio, La poesia araba preislamica, Roma 2021;
- L. Caretti, Studi sulle Rime del Tasso, Roma 1950;
- Casadei, Lessico e semantica, Roma 2003;
- d’Aquino, Somma Teologica, a cura di T. S. Centi, A. Z. Belloni, 2009;
- Dārā Šikōn, La congiunzione dei due oceani, Milano 2011;
- Di Giuseppe, La misteriosa identità della Musa e le origini della poesia europea, in F. Mercadante et alii (a cura di), Disordine e Ordine. Il fattore mimetico in politica e nella storia, Milano 2012, pp. 371-386;
- Ferrari, Commento alle Odi barbare di Giosuè Carducci, 2 voll., Bologna 1919;
- Ficino, Teologia platonica, a cura di E. Vitale, Milano 2017;
- Pitagora, I Versi d’Oro, introduzione e commento di J. Evola, Roma 2010;
- Proclo, Tria Opuscula, a cura di F. D. Paparella, Milano 2014;
- I. Ramelli (a cura di), Stoici romani minori, Milano 2008;
- Schnackenburg (a cura di), Il Vangelo di Giovanni, Parte Prima, Brescia 1973;
- Warbinek, Il sistema mantico ittita KIN, Firenze 2020.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 54 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.







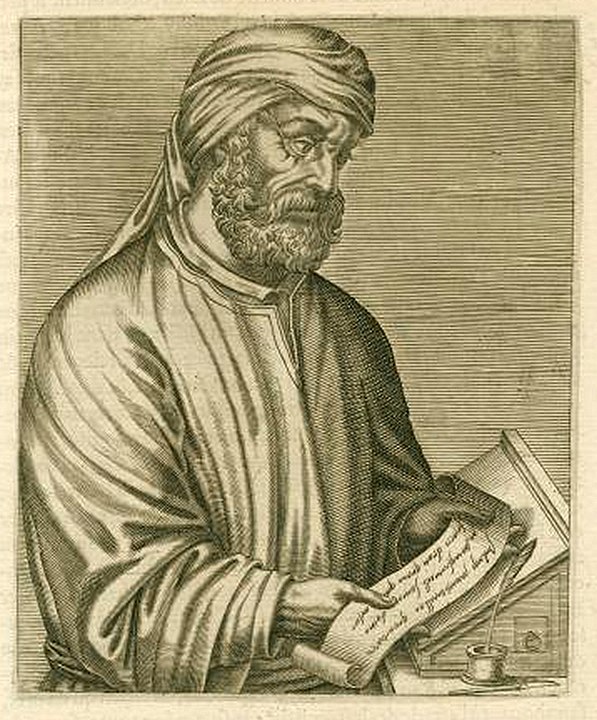
1 Comment