Il sacro era la dimensione fondamentale nel mondo antico. Non esisteva un ateismo come noi lo intendiamo: Dio era una certezza come il sole e la luna, anche vi si poteva approcciare in maniera differente. È con la Rivoluzione francese che si attua la desacralizzazione del mondo, che trova il suo compimento con il capitalismo. Nell’antica Grecia tutto era sacro, infatti non esisteva un termine proprio per “religione”: non si poteva circoscrivere il sacro in quanto esso pervadeva tutto. Ogni cittadino greco poteva compiere sacrifici e la cosa era la caratteristica segreta che ne attestava la cittadinanza. Inoltre, vi erano professionisti del sacro. I sacerdoti erano legati a una divinità e a un luogo. L’esegeta interpretava il diritto divino. Il mantis era l’interprete dei sogni, del volo degli uccelli, delle interiora. I cantori di oracoli erano ispirati da un dio e predicevano il futuro: il mantis apprende l’arte, invece il cantore di oracoli viene visitato dal dio. In quest’ultima categoria rientravano la Pizia e la Sibilla, donne spesso di umili origini che davano oracoli per il futuro.
 La Pizia prediceva un futuro che può essere cambiato, invece la Sibilla un futuro che non può essere cambiato, cioè disgrazie volute da qualche dio. Nel Libro I degli Oracoli Sibillini, vv. 1-4, è scritto che la Sibilla profetizzò cose del passato, che sono ora e che saranno nel futuro per via della empietà degli uomini. La Sibilla sta nel mondo pagano e in quello ebraico e cristiano fino al Medioevo. Nel primo parlava ispirata solitamente da Apollo, invece in quello ebraico e cristiano ispirata da YHWH, il Dio della Bibbia. Pensiamo solo alla Sibilla Cumana, ma ve ne erano molte altre. La Pizia stava a Delfi. A Delfi vi era un santuario panellenico, cioè visitato da tutta la Grecia antica, dedicato al dio Apollo. Sotto il tempio di Apollo, annesso al santuario, vi era un ipogeo nel quale stava la Pizia sopra un tripode, la quale era una donna che sentiva i messaggio del dio. Chi voleva fare una richiesta al dio, andava dalla Pizia in questo tempio. Costui faceva delle abluzioni, pagava una somma, faceva dei sacrifici. Formulava la richiesta alla Pizia, la Pizia sentiva il dio da un pozzo e dava il responso, il quale veniva trascritto dal sacerdote. Mentre la Pizia interrogava Apollo, la Sibilla ne era invasata e parlava in stato estatico.
La Pizia prediceva un futuro che può essere cambiato, invece la Sibilla un futuro che non può essere cambiato, cioè disgrazie volute da qualche dio. Nel Libro I degli Oracoli Sibillini, vv. 1-4, è scritto che la Sibilla profetizzò cose del passato, che sono ora e che saranno nel futuro per via della empietà degli uomini. La Sibilla sta nel mondo pagano e in quello ebraico e cristiano fino al Medioevo. Nel primo parlava ispirata solitamente da Apollo, invece in quello ebraico e cristiano ispirata da YHWH, il Dio della Bibbia. Pensiamo solo alla Sibilla Cumana, ma ve ne erano molte altre. La Pizia stava a Delfi. A Delfi vi era un santuario panellenico, cioè visitato da tutta la Grecia antica, dedicato al dio Apollo. Sotto il tempio di Apollo, annesso al santuario, vi era un ipogeo nel quale stava la Pizia sopra un tripode, la quale era una donna che sentiva i messaggio del dio. Chi voleva fare una richiesta al dio, andava dalla Pizia in questo tempio. Costui faceva delle abluzioni, pagava una somma, faceva dei sacrifici. Formulava la richiesta alla Pizia, la Pizia sentiva il dio da un pozzo e dava il responso, il quale veniva trascritto dal sacerdote. Mentre la Pizia interrogava Apollo, la Sibilla ne era invasata e parlava in stato estatico.
Con l’avvento del cristianesimo la società cambia. Nel mondo antico si viveva solo in questo mondo, l’oltretomba era un luogo oscuro e anche incerto. Nell’alta società era centrale la figura dell’eroe. Stando a quanto scrive Nucci, Achille esprimeva l’impulsività del giovane, invece Odisseo la riflessività dell’uomo adulto. La massima aspirazione era morire in battaglia o essere un grande atleta affinché la fama sopravvivesse tra i viventi. A questo modello si opporrà quello del martire: morire avendo raggiunto la meta della fede avrebbe spalancato le porte del paradiso. Il mondo classico non vedeva di buon occhio la povertà e l’indigenza, invece il cristianesimo proporrà la figura del povero per Dio, o quanto meno lo stile di vita per cui “è meglio avere meno bisogni che possedere più cose” (Agostino, Regola, 18). L’ispirazione dei testi sacri diviene non solo un motivo per guardarsi dalle disgrazie del futuro ma modello su cui adeguare in tutto la propria vita. L’Islam riprenderà questo concetto dall’ebraismo e dal cristianesimo.  Per questo ha fatto grande scalpore la ipotetica questione dei “versi satanici” del Corano. La leggenda narra che nella sura 53 (ai versi 19, 20 e in quello successivo, che sarebbe presente nei manoscritti più antichi del Corano ma espunto dagli ortodossi) Maometto fu ispirato non da Dio ma da Satana nel cantare la lode di tre dee pagane preislamiche, Allat, ‘Uzza, Manat, che erano sorelle di Allah, il dio pagano del pantheon arabo. I testi sacri sono la testimonianza di come le parole degli dei siano state considerate moltissimo nella storia di un dato popolo sacro. A volte ripetute per millenni, come i Veda, i testi sacri dell’induismo. Per trasmetterli invariati per moltissimo tempo sono state create delle tecniche apposite di recitazione: saṃhitapāṭha (con le modificazioni tra parole), padapāṭha (con parole isolate), le vikṛti (con gruppi di parole). La Bibbia ebraica ha precisi sistemi per la cantillazione che sono aggiunti al testo. Qualcosa di analogo succede anche per il Corano (lo studio della recitazione cantata del Corano è detto tajwid). Per molte tradizioni indiane i Veda sono la più importante rivelazione, avuta per intuizione-visione dai Rishi, anche se nessun testo si sofferma sulle modalità di questa conoscenza iniziale. L’attività creativa dei Rishi viene descritta dalla radice DHI, che indica sia il vedere sia il pensare: in questo modo i Rishi forse non creavano da soli le immagini poetiche ma “vedevano” quelle trasmesse loro dagli dei e che i comuni mortali non vedono (1).
Per questo ha fatto grande scalpore la ipotetica questione dei “versi satanici” del Corano. La leggenda narra che nella sura 53 (ai versi 19, 20 e in quello successivo, che sarebbe presente nei manoscritti più antichi del Corano ma espunto dagli ortodossi) Maometto fu ispirato non da Dio ma da Satana nel cantare la lode di tre dee pagane preislamiche, Allat, ‘Uzza, Manat, che erano sorelle di Allah, il dio pagano del pantheon arabo. I testi sacri sono la testimonianza di come le parole degli dei siano state considerate moltissimo nella storia di un dato popolo sacro. A volte ripetute per millenni, come i Veda, i testi sacri dell’induismo. Per trasmetterli invariati per moltissimo tempo sono state create delle tecniche apposite di recitazione: saṃhitapāṭha (con le modificazioni tra parole), padapāṭha (con parole isolate), le vikṛti (con gruppi di parole). La Bibbia ebraica ha precisi sistemi per la cantillazione che sono aggiunti al testo. Qualcosa di analogo succede anche per il Corano (lo studio della recitazione cantata del Corano è detto tajwid). Per molte tradizioni indiane i Veda sono la più importante rivelazione, avuta per intuizione-visione dai Rishi, anche se nessun testo si sofferma sulle modalità di questa conoscenza iniziale. L’attività creativa dei Rishi viene descritta dalla radice DHI, che indica sia il vedere sia il pensare: in questo modo i Rishi forse non creavano da soli le immagini poetiche ma “vedevano” quelle trasmesse loro dagli dei e che i comuni mortali non vedono (1).
Per altre tradizioni, la più importante rivelazione è costituita dai Puraṇa o dai testi del tantrismo. I Veda vengono elaborati con il passare del tempo, prima vengono indicati nel testo al singolare e poi al plurale (quando crescendo i testi si moltiplicarono per aggiunte successive). I testi vedici finali sono le Upaniṣad, scritte in perfetto sanscrito, mentre i Veda più antichi sono scritti in vedico, la fase più arcaica della lingua sanscrita. Le Upaniṣad sono basilari anche se vengono dopo: da esse sorge l’idea della rinascita, mentre nella fase precedente si pensava al paradiso dopo la morte. Per l’induismo e il buddhismo la parola è più di quella ordinaria: essa, infatti, può divenire un mezzo (upāya) per trasmettere la conoscenza sacra e per elevare lo spirito fino alla liberazione. Sono conosciuti anche in Occidente i mantra, che possono elevare la conoscenza, come Oṃ. Nel buddhismo esiste la śrotra vijñāna (conoscenza uditiva), una particolare contemplazione delle preghiere rituali del monastero per carpirne i segreti esoterici. In un rito indiano formato da più giorni di celebrazione la Parola sta al quarto giorno. La divinità che veicola il quarto giorno è la Parola, in sanscrito Vāc. La Parola è più delle lettere, dei simboli e delle parole: è sempre un fine da raggiungere. Le parti sono tre, e il quarto giorno è visto come il tutto che si aggiunge alle prime tre parti. Vāc per l’appunto è una sillaba formata di tre sillabe. La sillaba è trisillabica (akṣaram iti tryakṣaram), la parola vāc è una sillaba (vāg ity akṣaram). Il quarto giorno sta ai tre precedenti come la Parola sta alle tre sillabe. La Parola è l’esempio tipico del tutto che resta da aggiungere quando si sono ottenute le parti, l’anuṣṭubh (2).
La Bibbia diviene il luogo della manifestazione di Dio: è Parola di Dio. Sia perché si narra quell’avvenimento del passato sia perché è attualmente la Parola di Dio. Gli studiosi della Bibbia affermano che non si possono capire i quattro vangeli senza conoscere le feste ebraiche, che fanno spesso da sottofondo agli avvenimenti raccontati. Questo è vero soprattutto per il Quarto vangelo, quello di Giovanni. Nei capitoli 7-10 del Quarto Vangelo c’è la Festa delle Capanne. Gesù sale a Gerusalemme per questa Festa. Ai tempi di Cristo era la festa più importante per il popolo ebraico, tanto che era definita LA Festa. Il Vangelo di Giovanni è lo scritto della autorivelazione di cristo: in questa festa ha luogo una importante rivelazione del Messia. Come detto anche da Zaccaria 14, la rivelazione del Messia avverrà nella Festa delle Capanne. In questa festa è ancora oggi molto sentita dagli ebrei l’attesa messianica.Giovanni 7, 1-5: “In seguito Gesù girava per la Galilea. Non voleva infatti girare per la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Era prossima la festa dei Giudei, quella delle Capanne.  Gli dissero i suoi fratelli: ‘Parti di qua e va’ nella Giudea così che anche i tuoi discepoli vedano le opere che fai. Nessuno infatti agisce nel segreto, e cerca egli stesso di mettersi in mostra. Se tu fai queste cose, manifèstati al mondo’ “. Il verbo greco periepatei significa precisamente “girovagava” e indica che Cristo era un profeta itinerante. La festa delle Capanne era una festa di pellegrinaggio, assieme alla Pasqua e alla Pentecoste: gli ebrei dovevano recarsi con il clan familiare a Gerusalemme (i cosiddetti “fratelli”). Giovanni 7, 8: “Salite voi alla festa. Io non salgo …”. Ma ci andrà di nascosto. Gli ebrei dicono ancora oggi “salire a Gerusalemme” sia perché la città è in alto sia perché è il luogo più alto della terra, in cui vi è la Presenza di Dio. Nella Festa delle Capanne (che dura 7/8 giorni) l’ebro pio ancora oggi costruisce una tenda, nella quale deve pernottare: il tetto deve essere fatto di palmizi di modo che, all’interno della tenda, si possano vedere le stelle. La festa ricorda il popolo ebraico nel passaggio nel deserto, quando esso dormiva nelle tende e lo faceva anche Dio. In quell’accampamento la tenda più importante era la Dimora nella quale era posta l’Arca dell’Alleanza in cui scendeva Dio in una nube e accompagnava il popolo nel viaggio nel deserto. Dio si fa pellegrino tra i pellegrini umani, entra nella storia e nella sofferenza degli uomini. In questa storia si manifesta Dio e il suo Messia, che per i cattolici sono la stessa cosa. Giovanni 1, 14: “E il Verbo si fece carne e abitò tra noi e vedemmo la sua Gloria”: il verbo greco eskēnōsen significa precisamente non solo abitare ma mettere la tenda (skēnē). Cristo entra nella nostra tenda e in essa noi vediamo la sua Nube di Gloria: Egli è il Dio degli ebrei e di tutti gli uomini.
Gli dissero i suoi fratelli: ‘Parti di qua e va’ nella Giudea così che anche i tuoi discepoli vedano le opere che fai. Nessuno infatti agisce nel segreto, e cerca egli stesso di mettersi in mostra. Se tu fai queste cose, manifèstati al mondo’ “. Il verbo greco periepatei significa precisamente “girovagava” e indica che Cristo era un profeta itinerante. La festa delle Capanne era una festa di pellegrinaggio, assieme alla Pasqua e alla Pentecoste: gli ebrei dovevano recarsi con il clan familiare a Gerusalemme (i cosiddetti “fratelli”). Giovanni 7, 8: “Salite voi alla festa. Io non salgo …”. Ma ci andrà di nascosto. Gli ebrei dicono ancora oggi “salire a Gerusalemme” sia perché la città è in alto sia perché è il luogo più alto della terra, in cui vi è la Presenza di Dio. Nella Festa delle Capanne (che dura 7/8 giorni) l’ebro pio ancora oggi costruisce una tenda, nella quale deve pernottare: il tetto deve essere fatto di palmizi di modo che, all’interno della tenda, si possano vedere le stelle. La festa ricorda il popolo ebraico nel passaggio nel deserto, quando esso dormiva nelle tende e lo faceva anche Dio. In quell’accampamento la tenda più importante era la Dimora nella quale era posta l’Arca dell’Alleanza in cui scendeva Dio in una nube e accompagnava il popolo nel viaggio nel deserto. Dio si fa pellegrino tra i pellegrini umani, entra nella storia e nella sofferenza degli uomini. In questa storia si manifesta Dio e il suo Messia, che per i cattolici sono la stessa cosa. Giovanni 1, 14: “E il Verbo si fece carne e abitò tra noi e vedemmo la sua Gloria”: il verbo greco eskēnōsen significa precisamente non solo abitare ma mettere la tenda (skēnē). Cristo entra nella nostra tenda e in essa noi vediamo la sua Nube di Gloria: Egli è il Dio degli ebrei e di tutti gli uomini.
Il culto degli dei è molto antico. Secondo la nota testimonianza di Erodoto (II, 52-53) il culto agli dei risale a prima dei Greci, quando in quel territorio vi erano i Pelasgi, i quali li chiamavano semplicemente “dei” senza aggiungere altri nomi: Erodoto fa derivare il nome “dei” (in greco theoi) dalla radice del verbo greco tithemi, “porre in ordine”, perché essi avevano posto ordine all’universo. Ma, secondo Erodoto, all’opera di Omero e Esiodo risalgono la genealogia, le denominazioni, gli onori, le competenze, l’aspetto degli dei. Oggi la glottologia collega la radice del termine greco a quella indoeuropea *DHWES, “respiro”, che ha dato anche il verbo greco thuō, “sacrificare bruciando”. Dalle attestazioni sembra che in aria greca vi sia la concorrenza tra un dio Zeus e uno denominato theòs: il primo patriarcale, il secondo matrifocale; il primo elitario, il secondo più popolare. Secondo una recente etimologia, alla base del greco theòs ci sarebbe la radice indoeuropea *DHEI, “allattare”, che ha dato anche il greco theios, “zio”(3). 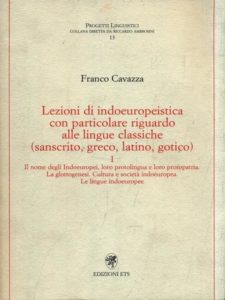 Il latino deus pare collegato alla radice indoeuropea *DEYW, legata all’idea della luce, donde anche dies, “giorno”. Il germanico Gott, god sembra associato a un’altra radice indoeuropea che veicola l’idea della bontà. Il termine nelle lingue slave deriva dalla radice indoeuropea *BHAG, “spartire”. Nelle lingue semitiche abbiamo la radice semitica che ha dato l’ebraico ‘El, ‘Elohim. Il termine arabo Allah (che non è il nome proprio di una divinità, come Zeus, ma indica il concetto generale di Dio) sarebbe derivato da quella radice con all’inizio l’articolo determinativo arabo al: Allah allora significherebbe “il dio”, Iddio. Alla base della radice semitica c’è l’idea della forza. Gli dei greci hanno a che fare con la vista: thea è “dea” in eolico (mentre in attico theos è sia maschile sia femminile) ma significa anche “visione”. Per i Greci vedere è sapere. Erano per questo detti “popolo dell’occhio”. La parola adēlon, “invisibile”, è usata dai Greci con molta parsimonia fino a Platone, in Omero compare una sola volta. I Greci aborrono l’invisibile come sinonimo di incertezza, male(4). La caratteristica degli dei omerici è quella di essere potenze e non persone, ragion per cui essi appaiono in un modo che nell’orizzonte percettivo dell’essere umano pare avere un senso coerente (quando l’eroe ferisce Afrodite, scaturisce dal corpo di lei dell’umore: Iliade V, 330-343), ma questa identità non è la sola. “Dietro la presenza degli dei aleggia sì l’immagine di splendidi esseri in forma umana, una sorta di presupposto ideale che li rende raffigurabili sulla superficie di un vaso o fa sì che il poeta possa descriverne le meravigliose apparenze; ma si è contemporaneamente ben consapevoli del fatto che il dio è altrettanto sé stesso anche quando si manifesta in forme mortali, animali, atmosferiche, o semplicemente attraverso segni e barlumi, ovvero non si manifesta affatto. Ed è proprio in questa molteplicità identitaria, nel poter essere serialmente molti, non uno solo – sé stessi e altri da sé – che risiede il privilegio divino” (5).
Il latino deus pare collegato alla radice indoeuropea *DEYW, legata all’idea della luce, donde anche dies, “giorno”. Il germanico Gott, god sembra associato a un’altra radice indoeuropea che veicola l’idea della bontà. Il termine nelle lingue slave deriva dalla radice indoeuropea *BHAG, “spartire”. Nelle lingue semitiche abbiamo la radice semitica che ha dato l’ebraico ‘El, ‘Elohim. Il termine arabo Allah (che non è il nome proprio di una divinità, come Zeus, ma indica il concetto generale di Dio) sarebbe derivato da quella radice con all’inizio l’articolo determinativo arabo al: Allah allora significherebbe “il dio”, Iddio. Alla base della radice semitica c’è l’idea della forza. Gli dei greci hanno a che fare con la vista: thea è “dea” in eolico (mentre in attico theos è sia maschile sia femminile) ma significa anche “visione”. Per i Greci vedere è sapere. Erano per questo detti “popolo dell’occhio”. La parola adēlon, “invisibile”, è usata dai Greci con molta parsimonia fino a Platone, in Omero compare una sola volta. I Greci aborrono l’invisibile come sinonimo di incertezza, male(4). La caratteristica degli dei omerici è quella di essere potenze e non persone, ragion per cui essi appaiono in un modo che nell’orizzonte percettivo dell’essere umano pare avere un senso coerente (quando l’eroe ferisce Afrodite, scaturisce dal corpo di lei dell’umore: Iliade V, 330-343), ma questa identità non è la sola. “Dietro la presenza degli dei aleggia sì l’immagine di splendidi esseri in forma umana, una sorta di presupposto ideale che li rende raffigurabili sulla superficie di un vaso o fa sì che il poeta possa descriverne le meravigliose apparenze; ma si è contemporaneamente ben consapevoli del fatto che il dio è altrettanto sé stesso anche quando si manifesta in forme mortali, animali, atmosferiche, o semplicemente attraverso segni e barlumi, ovvero non si manifesta affatto. Ed è proprio in questa molteplicità identitaria, nel poter essere serialmente molti, non uno solo – sé stessi e altri da sé – che risiede il privilegio divino” (5).
“In Omero raramente gli dei si rivolgono agli uomini in modo diretto e esplicito: la loro vera voce giunge agli orecchi umani solo in casi eccezionali. Il più delle volte, per comunicare con i mortali, gli dei scelgono modi ambigui: quando non si servono di esseri dotati di particolari capacità (maghi, vati, aruspici, poeti), o inviano, in veste di ambasciatori, divinità minori (Ossa, la ‘voce’ di Zeus; Ypnos, che compare nei sogni; Iri, la voce messaggera, che attraversa i cieli per trasmettere i messaggi divini), si presentano nelle sembianze di qualche mortale. In ogni caso decodificare i messaggi divini è sempre arduo e sempre gli uomini si sforzano in ogni modo di riuscirvi … L’uomo omerico si muove in una realtà della quale avverte tutto il mistero, è consapevole di non saper fornire spiegazioni dei fenomeni naturali, si sente esposto all’azione di forze che non padroneggia, per questo è attento a cogliere ogni segnale inquietante e pronto a attribuire la causa a un dio. Il non sapere, non capire, non poter prevedere è la prima caratteristica della condizione umana e per questo l’uomo è costantemente impegnato nello sforzo di uscire dalle tenebre nelle quali gli dei vogliono mantenerlo” (6).
Note:
1 – T. J. Elizarenkova, Il Rigveda. L’inizio della letteratura e della cultura in India, Roma 2011;
2 – C. Malamoud, Esegesi di riti. Esegesi di testi, in ID., Cuocere il mondo. Rito e pensiero nell’India antica, Milano 1994, pp. 281-299;
3 – F. Cavazza, Lezioni di indoeuropeistica, vol. 1, Pisa 2005;
4 – R. Peregalli, La corazza ricamata. I Greci e l’invisibile, Milano 2008;
5 – M. Bettini, Visibilità, invisibilità e identità degli dèi, in G. Pironti, C. Bonnet (a cura di), Gli dèi di Omero. Politeismo e poesia nella Grecia antica, Roma 2016, pp. 29-58;
6 – A. M. Storoni Piazza, Ascoltando Omero. La concezione di linguaggio dall’epica ai tragici, Roma 1999.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha dato alle stampe 32 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli.



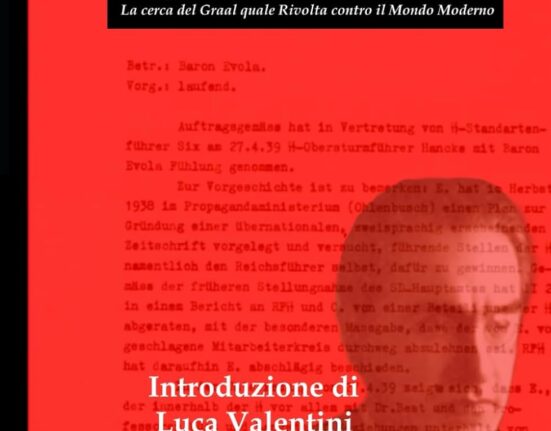




1 Comment