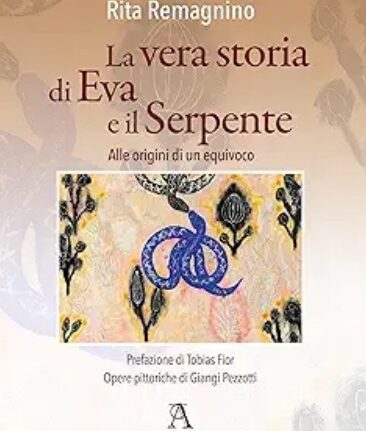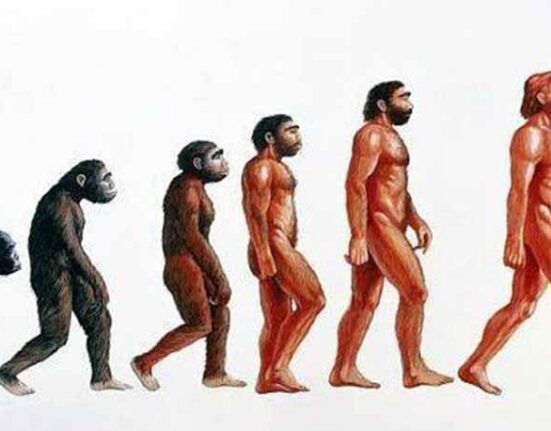Rita Remagnino
Quanti anni ha l’Uomo? E la Terra?
Un toto-cifre non sempre al sopra di ogni sospetto
Nessuno oggi è in grado di stabilire quanto manchi all’Inizio che presto succederà alla Fine della Storia, ma stando alle previsioni dei bene informati il «salto» sarebbe imminente e non tutti disporranno della forza interiore necessaria a superare il proprio tempo. Meglio portarsi avanti cercando di saperne di più sul nostro punto di partenza poiché il ricordo ancestrale che ognuno di noi si porta dentro, probabilmente stampato nel proprio DNA, andrà riaffiorando via via che ci avvicineremo al capolinea.
In modo naturale, quasi fisiologico, il risveglio della memoria implicita di catastrofi immani e desolati panorami di devastazione, tanto per fare un esempio, comincerà a fare riflettere su un quotidiano incalzato da emergenze ambientali, e a quel punto sarà di conforto sapere che altri hanno passato momenti di gran lunga peggiori, riuscendo persino a sopravvivere.
Sul nostro esordio, cioè sulla comparsa dell’uomo del Ciclo attuale nella Storia, negli ultimi secoli ne sono state dette di tutti i colori. Il primo in ordine cronologico che cominciò a dare letteralmente i numeri fu James Ussher, l’arcivescovo irlandese che nel 1654 fissò come data della Creazione umana (la Natura che ne costituiva lo scenario era considerata immutabile per iniziativa divina) la tarda serata del 22 ottobre dell’anno 4004 a.C., grosso modo intorno alle ore 18:00.
Il libro dell’alto prelato, molto letto e ammirato dai suoi contemporanei, si basava sulla cronologia della Bibbia. Dopo di lui altri cronologisti elaborarono scale temporali sulla base di dati ricavati dalle fonti bibliche, mentre gli uomini di scienza preferirono dedicarsi alla valorizzazione di evidenze empiriche, a partire da quelle fornite dai reperti fossili.
Durante tutto il XVII secolo vennero scritte intere biblioteche sull’argomento, divenuto nel frattempo di gran moda. Finché arrivò Charles Darwin, la cui teoria piacque subito ai marxisti che scoprirono in essa una formidabile «alleata scientifica» per opporsi alla visione finalistica scaturita dalle religioni. Il darwinismo accontentava degnamente anche il nuovo capitalismo liberale inglese, legittimando le scelte socio-economiche malthusiane in atto: liberato dal giogo della «legge di natura» l’uomo poteva partecipare liberamente alla «lotta per la sopravvivenza» che avrebbe fatto emergere «il più adatto», mentre i meno adatti dovevano rassegnarsi alla povertà e all’ignoranza. Non per colpa di qualcuno, bene inteso, ma perché l’uomo soggiaceva alle stesse dinamiche che regolavano il mondo animale, da cui era impossibile emanciparsi.
La teoria fu giudicata soddisfacente dalle classi dirigenti, per cui ogni critica mossa nei confronti del darwinismo da quel momento in poi venne accolta al pari di un insulto all’autorevolezza inoppugnabile della scienza, che non tardò ad assumere anche una valenza economica.
 Grazie al sostegno degli scientisti la società industriale poteva entrare a testa alta nel promettente Novecento, un secolo in cui tenne banco e fece scuola una nuova teoria che aveva come punto di riferimento il ritrovamento di alcuni scheletri «moderni» provenienti dall’Etiopia e vecchi di appena 196.000 anni. L’essere umano era nato in Africa, si disse, e da lì si era poi sparpagliato nel mondo. Un’affermazione politicamente corretta che la borghesia mercantile poteva utilizzare ad arte come forma di risarcimento morale a favore dei coloni africani sfruttati e deportati.
Grazie al sostegno degli scientisti la società industriale poteva entrare a testa alta nel promettente Novecento, un secolo in cui tenne banco e fece scuola una nuova teoria che aveva come punto di riferimento il ritrovamento di alcuni scheletri «moderni» provenienti dall’Etiopia e vecchi di appena 196.000 anni. L’essere umano era nato in Africa, si disse, e da lì si era poi sparpagliato nel mondo. Un’affermazione politicamente corretta che la borghesia mercantile poteva utilizzare ad arte come forma di risarcimento morale a favore dei coloni africani sfruttati e deportati.
Per un lungo periodo sembrò che nessuno avesse altro da aggiungere. Fino a quando l’ultimo colpo di vanga portò alla luce nelle grotte di Apidima, in Grecia, alcuni fossili di neanderthal e di sapiens risalenti a più di 210.000 anni fa e a Misliya, in Israele, reperti umani collocabili in una fascia temporale compresa tra i 177.000 e i 194.000 anni fa. Sebbene la cosa più interessante fossero le impronte umane rimaste stampate indelebilmente sulla sabbia di Trachilos, nell’isola di Creta, in quella che forse un tempo era stata una spiaggia, o il letto di un fiume asciutto.
Quell’uomo aveva dei piedi identici ai nostri, un fatto che diede non poco filo da torcere agli accademici poiché il tizio in questione era passato da quelle parti qualcosa come 5,7 milioni di anni prima, mentre, secondo la paleontologia moderna, non avrebbero dovuto esserci uomini sul pianeta in quel periodo. Al massimo, «ominidi».
La famosa Lucy indicata in precedenza come nostra prima antenata era di un paio di milioni di anni più «giovane» del passeggiatore di Trachilos, di cui si presumeva dovesse essere una discendente. Mentre le impronte dell’Ardipitechu Ramidus, rinvenute in Etiopia e datate intorno ai 4,4 milioni di anni fa, erano chiaramente le orme di una scimmia, nonostante si fosse additato questo esemplare come «diretto antenato dell’uomo».
Invece le impronte dell’abitatore di Creta, lunghe in media 21 centimetri, erano inequivocabilmente quelle di un uomo. Avevano due «bulbi» distinti tipicamente umani, uno era il calcagno e l’altro l’alluce, che lasciavano tracce globulari. L’alluce non era opponibile, le dita più piccole erano tutte parallele, e, fatto degno di nota, non mostravano di avere avuto artigli. Si trattava, insomma, di un reperto convincente nel suo complesso. Anche la datazione era attendibile, grazie all’esame dei pollini fossili imprigionati nello stesso strato di quella che fu un tempo sabbia o fango: era un uomo, non c’erano dubbi!
La nuova scoperta non solo faceva scricchiolare la teoria, o la leggenda, secondo cui la nostra specie era nata in Africa come evoluzione di scimmioidi che avrebbero adottato a poco a poco la posizione eretta, e quindi sviluppato un cervello di grandi dimensioni, ma suggeriva l’esistenza antichissima dell’uomo già «perfettamente formato» in tempi assai remoti, spingendo così gli studi fuori dalla narrativa evoluzionista.
Per non cadere in contraddizione il corpo accademico fece qualche aggiustamento, ritoccando al ribasso la datazione dell’Homo Antecessor trovato in Spagna, alla Gran Dolina, il quale era forse più giovane dell’1,2 milione di anni che gli era stato attribuito inizialmente, avendo la «dentatura di un contemporaneo». Avanti di questo passo, tra qualche anno si dirà che è la scimmia a discendere dall’Uomo, come copia più approssimata, e non viceversa. Oppure, si scoprirà che l’uomo più evoluto è quello che c’è già stato.
Se è complicato dare un’età all’uomo, figurarsi attribuire gli anni al pianeta che lo ospita. Nel Secolo dei Lumi, l’epoca degli uomini intelligenti, si osservò che le rocce in diverse parti d’Europa mostravano stratificazioni che risalivano a periodi differenti, i fossili erano presenti soltanto nelle parti di più recente formazione, che però non recavano tracce di resti umani. Questi indizi suggerivano una sola cosa: la Terra doveva essere molto più antica di quanto si era ritenuto fino a quel momento.
Appariva evidente che bisognava pensare in termini di centinaia di migliaia di anni, o addirittura di milioni di anni. Nel 1778 il naturalista francese Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, si spinse così ad ipotizzare un’età di quasi tre milioni di anni, ma non ebbe mai il coraggio di mettere la sua teoria per iscritto. Tale opinione ebbe se non altro il merito di rendere esplicito ciò che altri naturalisti sospettavano da tempo ma non osavano affermare: il nostro pianeta aveva alle spalle un profondo passato, parte del quale era stato preumano.
Ma fino a che punto la Terra, per un tempo così sterminato, era stata significativamente diversa dallo stato attuale? La vita aveva avuto una vera storia? E soprattutto: sarebbe stato possibile conoscere cosa era accaduto prima dell’arrivo dell’uomo sulla scena del mondo?
Una prima risposta arrivò da un giovane studioso di provincia, tale Georges Cuvier, il quale, applicando le sue straordinarie conoscenze di anatomia comparata allo studio dei fossili, scoprì l’esistenza di animali estinti come il mammut siberiano e il mastodonte americano, il mososauro, un enorme rettile marino, e lo pterodattilo, un rettile volante. Creature che avevano popolato «un mondo precedente» di cui poco o nulla si sapeva, spazzate via per sempre da un’improvvisa e violenta catastrofe.
Le scoperte di Cuvier diedero luogo, agli inizi dell’Ottocento, a una nuova moda: la caccia agli esemplari fossili, uno sport per ricchi eruditi in cui si distinse l’inglese Mary Anning, la quale conquistò la ribalta dell’epoca con la scoperta del teschio di un ittiosauro su una scogliera calcarea nel Dorset e, più tardi, con il rinvenimento di un fossile di plesiosauro quasi completo.
La storia della Terra, e di conseguenza della vita, erano chiaramente intrecciate e dovevano essere state scandite da eventi apocalittici che potevano spiegarne la direzione e la discontinuità. Questa teoria godette per un certo periodo di un consenso scientifico quasi unanime, finché un tale di nome Charles Lyell sfidò tale visione, sostenendo che non esisteva alcuna prova che la superficie terrestre nel passato fosse stata trasformata da improvvise catastrofi. Ogni cambiamento geologico era, anzi, il risultato di processi graduali e uniformi operanti nel corso di tempi immensamente lunghi e costanti.
Subito la comunità scientifica si divise in «catastrofisti» e «uniformisti». Ma, tutto sommato, le due posizioni non erano completamente inconciliabili. Prova ne fu il fatto che attorno alla metà del XIX secolo si arrivò a un compromesso: la Terra aveva una storia molto movimentata, governata da leggi costanti ancora attive e punteggiata di eventi catastrofici globali. Il tempo profondo del pianeta ammontava come minimo a diverse centinaia di milioni di anni o, forse, perfino a miliardi.
Proprio la durata di questo tempo tenne banco e fu oggetto di aspre dispute nella seconda metà dell’Ottocento. Ad accendere le polveri non fu un geologo, ma un fisico: William Thomson, futuro Lord Kelvin, il quale, basandosi sulle leggi della termodinamica all’epoca da poco formulate e sulle stime correnti del progressivo raffreddamento del Sole, affermò che l’età della Terra non poteva superare i cento milioni di anni.
Ma la scoperta della radioattività, dopo il 1903, fece finire in soffitta anche i rigorosi calcoli del milord. Lo studio del decadimento radioattivo di alcuni elementi, come per esempio gli isotopi dell’uranio, stabilì che l’età della Terra era di circa 4,5 miliardi di anni.
Lo scenario andò perfezionandosi nel 1915, quando il metereologo e geologo tedesco Alfred Wegener fece la cosa più semplice che si potesse fare ma a cui nessuno aveva ancora pensato: apri l’atlante e osservò attentamente il planisfero. In tutta evidenza le sponde dell’Africa e delle regioni meridionali del Sudamerica si potevano incastrare come i pezzi di un puzzle, anche se la loro coincidenza appariva perfetta solo confrontando non la linea di costa ma quella delle rispettive piattaforme continentali.
I resti fossili confermarono la teoria di Wegener evidenziando che certe specie viventi, soprattutto felci e rettili, erano distribuite un tempo esattamente nelle zone corrispondenti sulle sponde opposte dell’Atlantico meridionale. Valeva lo stesso discorso per tutta una serie di formazioni rocciose che proseguivano, di qua e di là dall’oceano, alla medesima latitudine e con un perfetto incastro. Era certo che in zone conosciute come calde e poste a sud dell’Equatore (Patagonia, Africa meridionale, Penisola Indiana, Tasmania) esistesse un tempo un clima freddo, mentre le temperature tropicali erano state di casa in regioni nordiche come le isole Spitzbergen.
C’era un’unica spiegazione convincente e simultanea di questi due fatti: le masse, ora separate, dei continenti erano originariamente ravvicinate e tutte le terre emerse, comprese quelle settentrionali, nell’insieme erano situate a Sud, prima che i continenti e gli oceani cominciassero a muoversi lentamente, scivolando come natanti galleggianti sulla superficie del mantello. Ne conseguiva che un solo continente non si era mai mosso, o quasi, dal punto in cui era nato: l’Antartide, l’ombelico del mondo, il passato e il futuro della Terra.
(2 – continua)