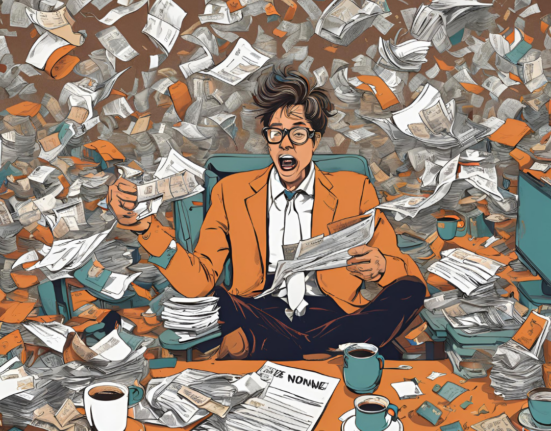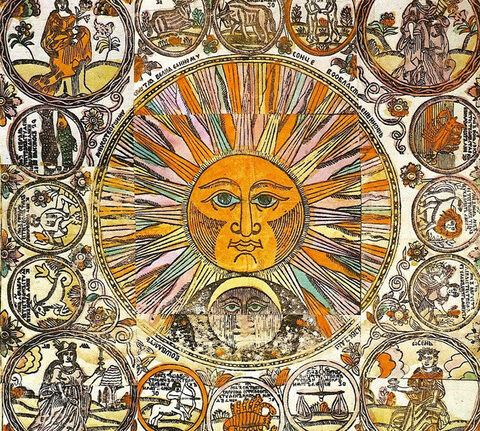Giordano Bruno non è stato solo un filosofo di grande rilievo, ma un personaggio di spessore unico, un simbolo dell’intera Rinascenza. Nelle fiamme del rogo che lo arse in Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600, stando ad un altro g
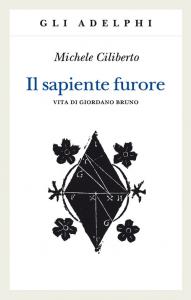 rande del pensiero italiano, Andrea Emo, si dissolse un’intera civiltà con il suo irrefrenabile slancio verso l’infinito. Di Bruno e del suo pensiero si è, nel corso dei secoli, detto tutto e il contrario di tutto. La bibliografia che lo riguarda ha riempito intere biblioteche ma, spesso, si è mostrata partigiana, in un senso o nell’altro. Si deve a Michele Ciliberto, docente della Normale di Pisa e tra i massimi esegeti della filosofia del Rinascimento, un’opera monumentale e chiarificatrice, Il sapiente furore. Vita di Giordano Bruno, nelle librerie per Adelphi (pp. 812, euro 22,00). L’autore, fin dall’incipit del volume, tende ad inquadrare la figura di Bruno all’interno del perimetro teorico del Rinascimento, non ritenendo tale età, si badi, blocco monolitico che, sic et simpliciter, avrebbe condotto illuministicamente l’umanità dall’oscuro Medioevo alla modernità. Al contrario, la Rinascenza è stata per antonomasia, come ha suggerito Cacciari, età del tragico: Giordano Bruno la incarnò esemplarmente nel percorso di vita e la testimoniò nelle opere. In esse dette nuovo vigore alla potestas dionisiaca. Ciliberto ribadisce l’intreccio profondo che lega in Bruno biografia e filosofia, chiarendo che: «la galleria delle fonti di un autore […] è importante» (p. 11), ma ancor di più lo è: «la chiave biografica in cui esse sono ripensate» (p. 11) . Nel caso del Nolano, ebbe rilevanza il ruolo «mercuriale» che egli si attribuì. Il filosofo era fermamente convito che stesse giungendo a conclusione il ciclo ebraico-cristiano e svolse la funzione di annunciatore, attraverso la «nova filosofia», del ciclo «egizio». Si sentì profeta di un Nuovo Inizio europeo.
rande del pensiero italiano, Andrea Emo, si dissolse un’intera civiltà con il suo irrefrenabile slancio verso l’infinito. Di Bruno e del suo pensiero si è, nel corso dei secoli, detto tutto e il contrario di tutto. La bibliografia che lo riguarda ha riempito intere biblioteche ma, spesso, si è mostrata partigiana, in un senso o nell’altro. Si deve a Michele Ciliberto, docente della Normale di Pisa e tra i massimi esegeti della filosofia del Rinascimento, un’opera monumentale e chiarificatrice, Il sapiente furore. Vita di Giordano Bruno, nelle librerie per Adelphi (pp. 812, euro 22,00). L’autore, fin dall’incipit del volume, tende ad inquadrare la figura di Bruno all’interno del perimetro teorico del Rinascimento, non ritenendo tale età, si badi, blocco monolitico che, sic et simpliciter, avrebbe condotto illuministicamente l’umanità dall’oscuro Medioevo alla modernità. Al contrario, la Rinascenza è stata per antonomasia, come ha suggerito Cacciari, età del tragico: Giordano Bruno la incarnò esemplarmente nel percorso di vita e la testimoniò nelle opere. In esse dette nuovo vigore alla potestas dionisiaca. Ciliberto ribadisce l’intreccio profondo che lega in Bruno biografia e filosofia, chiarendo che: «la galleria delle fonti di un autore […] è importante» (p. 11), ma ancor di più lo è: «la chiave biografica in cui esse sono ripensate» (p. 11) . Nel caso del Nolano, ebbe rilevanza il ruolo «mercuriale» che egli si attribuì. Il filosofo era fermamente convito che stesse giungendo a conclusione il ciclo ebraico-cristiano e svolse la funzione di annunciatore, attraverso la «nova filosofia», del ciclo «egizio». Si sentì profeta di un Nuovo Inizio europeo.
Tale consapevolezza accompagnò Bruno per tutta la vita, fin dall’infanzia. Egli racconta, infatti, che da infante, alla vista di un serpente fuoriuscito da una parete della sua stanza: «acuendo tutte le facoltà dell’animo, riuscì a parlare e a farsi intendere, a capire tutto quanto gli accadde intorno» (p. 26). Con questo riferimento, assieme ad altri di cui ci ha lasciato traccia nelle opere, Bruno volle far comprendere ai lettori la connessione di «memoria» e «destino mercuriale». Ciliberto, pertanto, attraversa, con dovizia di argomentazioni, discutendo una messe assai considerevole di documenti, i vari momenti della vita del Nolano, dalla nascita alla morte sul rogo, conducendo, parallelamente, l’esegesi delle opere. Lo fa in modo accattivante e, senza rinunciare al rigore accademico (il volume è arricchito da molte note di approfondimento), riesce a coinvolgere il lettore attorno alle vicende di questo personaggio teatrale. In queste pagine, vediamo Bruno seguire nel collegio napoletano di S. Domenico, con partecipata attenzione, le lezioni di dialettica del Sarnese, e privatamente, quelle di Teofilo di Vairano. In quegli anni, il giovane procedette alle letture fondamentali per definire il suo mondo spirituale, si spese sull’Ars memoriae del Ravennate e sui testi di Lullo, per non dire di Erasmo.
A Napoli gli fu intentato un processo per eresia e, per sfuggirgli, se ne andò a Roma, città nella quale ebbe altri contrasti con religiosi. Fu allora a Ginevra, dove, per ragioni strategiche, aderì alle religione riformata. Per tutta la vita Bruno ritenne le chiese riformate male peggiore della stessa Chiesa di Roma. A Parigi fu vicino agli ambienti dei Politiques di Bodin, che si battevano per un rafforzamento dello Stato, al fine di contrastare l’atomismo politico-sociale provocato dalle guerre di religione. Da ciò si evince la vicinanza del Nolano alle posizioni del Machiavelli. Il Nuovo Inizio bruniano presentava, infatti, tratti non semplicemente spirituali, ma politici. Durante gli anni inglesi si dedicò all’elaborazione della cosmologia dell’infinito su base teologica, che lo portò a superare le posizioni copernicane, occupandosi, inoltre, di ontologia. Nella polemica con i dotti oxoniensi emerse, da un lato la valorizzazione della filosofia, dall’altro la difesa orgogliosa del «primato» italiano. Ciliberto si sofferma anche sulla permanenza del filosofo in Germania, sul ritorno in Italia, a Venezia, ospite del Mocenigo e sulle diverse fasi del processo.
Ci preme soffermarci solo su alcuni plessi del pensiero del Nolano, rilevati dall’autore. Innanzitutto, la valorizzazione, nella gnoseologia bruniana, delle immagini basata sull’ontologia, vale a dire sul fatto che: «A fondamento del mondo esplicitato e sensibile […] sta […] un principio che, per la sua ricchezza, si sottrae ad ogni tentativo di espressione» (p. 544), sfugge, in definitiva, sostiene Bruno, all’approccio logocentrico. Il filosofo, in De la causa e nella Lampas, rovescia la gerarchia cosmica aristotelica: «dimostrando che una materia unica e varia può esplicarsi in forme diverse […], così da percorrere i gradi infiniti della perfezione e identificarsi in ultimo con Dio» (p. 545). La forma germina direttamente dalla «potenza della materia», intesa in senso lucreziano. Nella physis, l’azione naturale, combinandosi con quella magicamente diretta dall’uomo, può creare ordini diversi da quelli dati. La magia deve essere, si badi, condotta filosoficamente. Da qui la primazia del filosofo-mago. Da ciò consegue che per Bruno: «nascita e decadenza, apocalisse e renovatio sgorgano dal profondo della Vita universale» (p. 510). E’ quella che il pensatore definì la «Vicissitudine universale» e che legò, per certi tratti, alla concezione astrologica e per altri a quella meramente biologica. La Vicissitudine, il Circolo, può venire concepito, come negli Stoici e in Nietzsche, quale eterno ritorno dell’identico, oppure, sulla scorta di Democrito, Lucrezio e, tra i moderni, Klages, quale ritorno del simile, poiché: «la materia, la sostanza è in continuo movimento […] né è possibile riprodurre due volte la medesima figura» (p. 512). Se, quindi, il Nolano è distante da Virgilio a proposito della mitizzazione dell’Età dell’oro, gli è prossimo per quanto attiene alla visione della physis quale mixis implicante la «metasomatosi».
all’approccio logocentrico. Il filosofo, in De la causa e nella Lampas, rovescia la gerarchia cosmica aristotelica: «dimostrando che una materia unica e varia può esplicarsi in forme diverse […], così da percorrere i gradi infiniti della perfezione e identificarsi in ultimo con Dio» (p. 545). La forma germina direttamente dalla «potenza della materia», intesa in senso lucreziano. Nella physis, l’azione naturale, combinandosi con quella magicamente diretta dall’uomo, può creare ordini diversi da quelli dati. La magia deve essere, si badi, condotta filosoficamente. Da qui la primazia del filosofo-mago. Da ciò consegue che per Bruno: «nascita e decadenza, apocalisse e renovatio sgorgano dal profondo della Vita universale» (p. 510). E’ quella che il pensatore definì la «Vicissitudine universale» e che legò, per certi tratti, alla concezione astrologica e per altri a quella meramente biologica. La Vicissitudine, il Circolo, può venire concepito, come negli Stoici e in Nietzsche, quale eterno ritorno dell’identico, oppure, sulla scorta di Democrito, Lucrezio e, tra i moderni, Klages, quale ritorno del simile, poiché: «la materia, la sostanza è in continuo movimento […] né è possibile riprodurre due volte la medesima figura» (p. 512). Se, quindi, il Nolano è distante da Virgilio a proposito della mitizzazione dell’Età dell’oro, gli è prossimo per quanto attiene alla visione della physis quale mixis implicante la «metasomatosi».
L’attualità di Bruno sta in queste tesi. Ci pare, infatti, quanto mai necessario che il contributo bruniano accompagni la rinascita del logos physicós. In esso va riconosciuto il nucleo essenziale della proposta teoretica-esistenziale del filosofo. Tali posizioni, come ricordato da Schoppe, lo indussero a volgere il viso: «pieno di disprezzo» (p. 687) in altra direzione, quando sul rogo gli fu mostrato il Crocefisso. A differenza di quanto sostenuto da interpreti di formazione massonica o prossimi all’ermetismo, a tale scelta, Bruno giunse, stando a Ciliberto, a costo di un grave travaglio interiore, tra ripensamenti ed ambiguità. Tale atteggiamento, umano troppo umano, non rappresenta una diminutio del suo valore, ma arricchisce la testimonianza del «sapiente furioso».
Giovanni Sessa