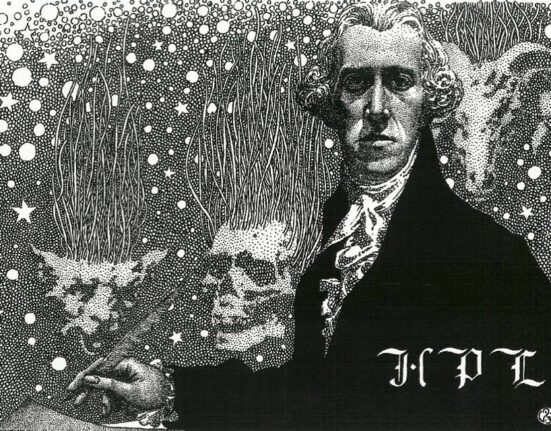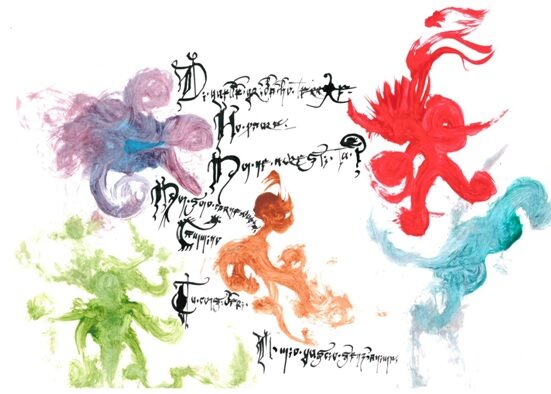Ma resta, la parola, una fragile cosa,
Che presto ammala e presto può guarire.
Se vuoi lasciar che viva la sua piccola vita,
Allora devi con leggerezza prenderla, con grazia,
Non brancicarla con rozza mano e schiacciarla:
Figurati che muore sol s’è guardata male –
Allora: informe giace, esanime
Gelida e immiserita, un piccolo cadavere,
Orribilmente straziato e deturpato
Da morte e agonia.
Una parola morta – è turpe cosa,
È un sonaglio per scheletri.
Maledetti gli odiosi mestieri,
Che uccidono parole e parolette!
(Friedrich Nietzsche, Frammenti Postumi estate-autunno 1882)
Lo spunto per questo articolo è stato il porre in ascolto le parole di alcuni grandi autori, come Quasimodo nel suo discorso tenuto in occasione del Nobel 1959. Panotticamente un cappello calzato su quel che percepiamo esser la situazione nella Cittadella delle lettere (inevitabile riservare future escursioni). La poesia è inserita in un cantuccio non risolvibile con la stessa appartenenza generica al resto, l’arte della scrittura non è solo poesia ma solo la poesia è oracolarità e vertigine. Partiamo giustappunto dal poeta siciliano, il discorso pronunciato in Svezia è un trattato ed una dichiarazione di poetica, con spunti ove soffermarsi per lungo tempo. Questa la prima differenza rintracciata, ma soprattutto vissuta in profondità nel furore, quello stesso che pugnala attraverso l’Amor del poetar ermetico (ricorda che puoi essere l’essere dell’essere/ solo che amore ti colpisca bene alle viscere):
“Lo scrittore di racconti, di romanzi, si ferma sugli uomini, li imita; consuma personaggi; il poeta, nella sua oscura sfera, con infiniti oggetti, è solo, e non sa se sia indifferenza, la sua, o speranza. Più tardi, quel volto unico si moltiplicherà, quei gesti costituiranno figure, consensi o contrasti. Questo avviene alla pubblicazione delle prime poesie, quando scoccano i previsti allarmi, perché, e occorre dirlo ancora, la nascita di un poeta che dalla corda del cerchio della casta letteraria tenta di raggiungere il centro, è sempre un pericolo per il costituito ordine culturale“.
La nascita di un poeta è sempre sinonimo di una rifondazione del linguaggio, e mentre tale iniziato al mistero oracolare si libra nel raptus e nell’atto, ode i miasmi e le pastoie di chi vorrebbe impedire l’originario, sgorgante dai pochi araldi così intesi. Il poeta è una maledizione per i cavillatori, ed è perciò che si lascia mano libera alla poesia del senso letterale (rimanendo non visitati dall’allegorico e dall’anagogico), innocua, creazione di nulla, riflesso di una frattura ultimativa tra potere creatore e fissazione alchemica-di-parola. Il vero poeta di questo post-moderno dovrà assumere su di sé lo sprezzo e collaborare con altre Torri in nome di una spinta unitiva. Dopo v’è la rivelazione ad un mondo che finge di comprenderlo:
“Strano pubblico ha ora, col quale comincia ad avere silenziosi rapporti armati: critici, professori di provincia, gente di lettere. La maggior parte di queste persone, nella giovinezza ragionevole del poeta, distruggono le metafisiche, operano sulle immagini; sono i giudici astratti: correggono, su poetiche differenziali, poesie ‘sbagliate’.”
Se la spinta è autentica, si manifesta un’implacabilità che raccoglie sempre più sospetto, via via ci si formerà il proprio registro, mentre ciò che veicola risiede in una sospensione temporale molto più dilatata di quella del letterato non-poietico. Nel poeta tutto è confitto nella carne in una scansione ad una velocità altra, nel drama della vita. Lo spostare l’accordatura d’Orfeo katà métron (secondo misura) è far discendere e agire una sola forma necessaria: la libertà assoluta dello spirito, agognata e pur depositata nel verso di un conio, come apertura e risoluzione, visita del sovrasensibile e poi dop ipostasi. Questo giuoco è tragedia (poiché al ritorno dagli stati i(n)spirativi il poeta e l’artista percepiscono meglio la propria finitudine) e ganglio inesauribile di versificazione, al contempo. Contro questa spinta v’è sia la dimensione “politica” sia la dimensione “critica”:

“Il poeta è un irregolare e non penetra nella scorza della falsa civiltà letteraria piena di torri come al tempo dei Comuni; sembra distruggere le sue forme stesse e invece le continua; dalla lirica passa all’epica per cominciare a parlare del mondo e di ciò che nel mondo si tormenta attraverso l’uomo numero e sentimento. Il poeta comincia allora a diventare un pericolo. Il politico giudica con diffidenza la libertà della cultura e per mezzo della critica conformista tenta di rendere immobile lo stesso concetto di poesia, considerando il fatto creativo al di fuori del tempo e inoperante; come se il poeta, invece di un uomo, fosse un’astrazione.”
Ora è tempo di un altro nodo cruciale, esso darebbe modo di rilanciare ad libitum questo intervento, visto che si parla dell’origine in un linguaggio, visto che l’aedo è assolutamente figlio ed epitome di un popolo, custode-alchimista-riformatore di una delle tante forme in cui il Fato fa nominare e prender vita le cose nel petto degli uomini. Sarà un caso la decadenza della poesia nell’epoca del mondialismo? Certamente no, la nuova koiné commerciale d’inglese imbastardito buono per tutti gli usi, cuoce a fuoco lento la vitalità dei rivoli con cui la lingua mantiene contatto essenziale nel destino umano. Se dalla Torre di Tubinga echeggia ancora solenne “ciò che resta lo fondano i poeti” (non saranno mai i filologi a rinnovare la lingua scritta: è un diritto che spetta ai poeti – ci ricorda sempre il Quasimodo della dissertazione al Nobel), dopo il trasporto a valle del rilancio museale heideggeriano sul tema, a guardarci intorno diremmo: quel che resta tra le macerie, hanno contribuito a scarnificarlo i vampiri psichici della cultura come svuotamento poietico, introdotto il bilanciamento democratico delle anime come supposto metro valoriale per diffondere nuove superstizioni. Così chiameremo la maggior parte dei letterati propagandati e propagandistici: vampiri che diffondono superstizione.
“Restare nella propria tradizione, evitare l’internazionalismo, è quello che fa il poeta. I letterati pensano all’Europa o al mondo in funzione di poetiche che si ripiegano su se stesse, come se la poesia fosse un “oggetto” identico su tutta la terra. Poi, a questa accettazione delle poetiche, il formalismo preferisce alcuni contenuti e ne allontana altri con violenza, ma il problema, da una parte e dall’altra della barricata, è sempre sui contenuti.”
La poesia si sviluppa come più determinato appello all’unicità sonora che s’incarna in una lingua, repetita iuvant: carme da decantare in oracolarità di una tradizione, riversata e cosparsa di rivoli plurimi, forse, ma sempre con la sorgente inerente all’ethos di una determinata comunità. I tentativi di far poesia epica in più lingue o sono accozzaglia oppure sono una reale forza sinergica (ricordiamo Pound e i suoi accostamenti plurisemantici, polialfabetici), compresa a fondo solo da un’élite. La poesia è ancorata più di ogni letteratura nella coscienza nazionale, paradigmatico quindi come essa manchi nell’hic et nunc post-moderno, annaspi, si riduca a forme di totale imbestiamento, per arrivare alla “poesia del frigo bianco dell’esistere”, come la chiamiamo: caotico rigiro abortito sui bisogni primari e sulle finte libertà del basso ventre. La poesia si mette a testa in giù per vedere il mondo, mentre in letteratura si possono compiere maggiori operazioni trasversali, su piani differenti. La letteratura può essere comparata e comparabile, la poesia è sempre una verticale o non è. La poesia come immediato, il resto della letteratua come sradicamento in nome della consorteria. In epoca di disgregazione l’aedo volge, nel migliore delle ipotesi, verso quella forma detta scontenuto: iato malvissuto tra forma e sostanza, tra espressione e contenuto. Al letterato che dà valore solo ai libri, il vero poeta deve contrapporre un sentire linfatico in ogni circostanza, anche la più umile.
“La parola del poeta, così, comincia a battere con forza sul cuore dell’uomo di ogni razza, mentre il letterato purissimo considera sé nel mondo e il poeta costretto nella provincia, con la bocca spezzata dai suoi trapezi sillabici. Il politico si serve del letterato che non ha una posizione spirituale contemporanea, ma superata almeno di due generazioni, e dell’unità della cultura fa un gioco di scomposizioni sagge e turbolente, dove il fattore religioso può spingere ancora a imprigionare l’intelligenza dell’uomo.”
Ecco un apparente ossimoro nel discorso di Quasimodo, così decifrabile: il poeta è colui che si situa per vivificare nel solco di un popolo, mentre la sua parola si sprigiona potenzialmente nel cuore d’ogni uomo, per quel sentire cosmico inalienabile (il radicamento nella propria lingua porta la scintilla come dono illuminativo, travasabile nel petto di chiunque sia radicato in una sorgente originaria); la parola del letterato è trasversale e traducibile tra i popoli ma rimane gelida rispetto alla penetrazione intuitiva. Riportiamo ancora un paio di punti salienti:
“La vera poesia non accetta i tentativi ‘missionari’ del politico, né l’intervento della critica che ha origine da una qualsiasi filosofia. Il poeta non subisce deviazioni morali o estetiche; di qui, in un certo tempo, una sua doppia solitudine nei confronti del mondo e delle milizie letterarie.”
Il poeta che opera un rinnovamento e si abbevera dei raggi di Apollo, non può esser che un solitario, guardato a vista e con sospetto, o ammantato di bizzarria. Ad ogni modo si voglia addomesticare l’insorgenza della ricerca e del gettito poietico, in conclusione è pur certo che la semina è sempre per qualche generazione posteriore e il muro dell’incomunicabilità (quello delle sovrastrutture culturali ecolaliche e parassitarie) è destinato a spezzarsi, quando gli autori alla moda che appartengono al “politico”, ai parametri spendibili in una data epoca storica, non potranno più tramare e fare resistenza (quindi ci vuole sempre o una deflagrazione o un’erosione lenta dei loro avamposti…). Essi sono i più grandi odiatori degli inviati della sacra fiamma dell’Unità (che è un sentire poetico, riversabile in sconfinamenti anche narrativi…Ma qui è altro capitolo…):
“Non è retorica, questa: in ogni nazione l’assedio silenzioso al poeta è coerente nella cronaca umana. Ma i letterati appartenenti al politico non rappresentano tutta la nazione, servono soltanto, dico “servono”, a ritardare di qualche minuto la voce del poeta dentro il mondo. Col tempo, secondo Leonardo, ‘ogni torto si dirizza’.”
Nominare le cose è evocare, così come nella poetica del Pound di ABC of Reading “caricare la parola del massimo significato possibile” è arte combinatoria , mentre nelle macerie della civiltà il linguaggio poetico è la superficie di una sclerotizzazione: se è vero che nell’epoca della somma decadenza nessuno è al posto che gli compete, si noterà come nell’approccio alla più aristocratica delle arti si avvicinino, senza farsi problemi, giocolieri che in altri tempi avrebbero raccontato le proprie barzellette da dentro una taverna. Così in tutto, ovvero la dissacrazione dei nomi: artista viene affibiato in guisa televisiva e così via. È precisamente ne Gli imperdonabili di Cristina Campo il paesaggio di desolazione odierno: “Un tempo il poeta era là per nominare le cose: come per la prima volta, ci dicevano da bambini, come nel giorno della Creazione. Oggi egli sembra là per accomiatarsi da loro, per ricordarle agli uomini, teneramente, dolorosamente, prima che siano estinte”.
Chi osa mantenere una nominazione “come per la prima volta”, è l’agente del ricordo (etimologicamente il richiamare nel cuore), il poeta in soliloquio con gli uomini spenti. Il Platone del Fedro pensava alla scrittura come “il farmaco della memoria e della sapienza”, ma se è la stessa facoltà di porre segni su un foglio a non impressionare più esperienze dello spirito, nemmeno questa prodigiosa invenzione può aiutare nella strada del ritorno alla consapevolezza. Nella strada dell’Arte dell’Io è più importante agire poeticamente in silenzio, che riversare finte poesie come collettanea di semi scaricati e privi d’ogni potere fondativo-operativo. La lotta senza quartiere del mondialismo per la perdita d’ogni identità deve inevitabilmente passare da uno svuotamento del linguaggio, i signori di ciò sono programmaticamente intenti a spezzare il filo della memoria con incessanti richiami all’in-utilità delle lingue antiche. Con esse si dovrà sempre fare i conti invece, quando si vorrà andare a comprendere cosa è tutt’ora racchiuso e sprigionante dietro gli orizzonti di senso semantici, mentre al mondialismo interessa solo veicolare il robot-uomo in comunicazioni, rapporti di mera utilizzazione dello spazio e del tempo circostanti. Il Logos congelato in operazioni di debito e credito nella società dei contratti, la parola come spettro mentale.
Stefano Eugenio Bona