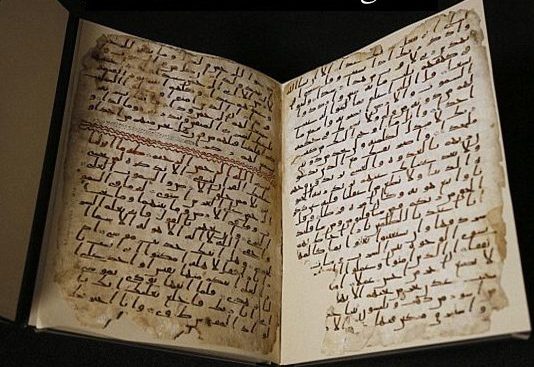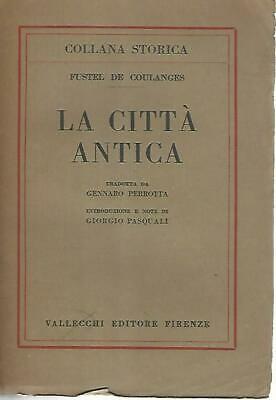Secondo il pensiero di Pietro De Francisci (1), non c’è dubbio che la saldezza delle basi dell’attività giuridica del popolo Romano è da ricercare nella persuasione della necessità di un ordine che la coscienza primitiva faceva sentire come voluta dagli dei. Il diritto è per i Romani il principale mezzo che disciplinando le attività dei singoli individui compone il popolo (multitudo) (2) in una superiore unità. Nella concezione del mondo, per il Romani non vi è moralità quando non si creda nell’esistenza di leggi e di principii superiori alla volontà dell’individuo, quando non si senta che il perfezionamento etico consiste nel richiamare il proprio spirito all’osservanza di imperativi che hanno la propria base in una realtà trascendente. Giampaolo Sabbatini, nel testo dal titolo Appunti di Preistoria del Diritto romano (3) ipotizza la provenienza dei più antichi istituti del ius quiritium all’epoca  preromana, e più precisamente in epoca di migrazione del popolo Latino da est verso ovest. In questa epoca, il diritto era costituito da consuetudini che diventavano regolamenti per l’organizzazione efficace di tipo militare. Ogni regola riguardava fondamentalmente la struttura organizzativa del popolo Stato-orda e prevedeva, ovviamente, una sanzione. Per rendere possibile il risalire degli istituti del diritto romano arcaico ad un’epoca precedente alla fondazione di Roma e allo stanziamento della stirpe latina nella vallata del Tevere, è necessario analizzare alcune istituzioni arcaiche romane, al fine di tracciare l’ipotesi di un diritto pubblico e di un diritto privato prima della Conditio Urbis. Secondo il Sabbatini, non appare difficile fondare tale ipotesi: documenti arcaici parlano infatti di una organizzazione politica preesistente alla Città – La Nazione latina (il Nomen Latinum) – (4) fornito di sue magistrature molto simili alle prische istituzioni politiche romane. Uno o due magistrati erano a capo di esse; vi era una assemblea di anziani ed un comizio di armati. Vi erano, dunque, istituzioni simili a quelle che a Roma sarebbero state rappresentate dal Re, dal Senato, dal Comizio Curiatio (5). Una fonte sulla comunanza di istituti giuridici tra il popolo latino e Roma arcaica può trovarsi nel Foedus Cassianum, il trattato di pace fra Romani e Latini dopo la battaglia del lago Regillo (per Tito Livio la guerra iniziò sotto il consolato di Tito Ebuzio Helva e Gaio Veturio Gemino Cicurino, nel 499 a.C.; Il Trattato fu stipulato nel 493 a.C. dal console romano Spurio Cassio Vecellino)[6] (6). In tale trattato si riconoscono reciprocamente validi i contratti ed i giudizi, siano essi romani, siano essi latini, indipendentemente dall’essere le parti romane, latine, o miste.
preromana, e più precisamente in epoca di migrazione del popolo Latino da est verso ovest. In questa epoca, il diritto era costituito da consuetudini che diventavano regolamenti per l’organizzazione efficace di tipo militare. Ogni regola riguardava fondamentalmente la struttura organizzativa del popolo Stato-orda e prevedeva, ovviamente, una sanzione. Per rendere possibile il risalire degli istituti del diritto romano arcaico ad un’epoca precedente alla fondazione di Roma e allo stanziamento della stirpe latina nella vallata del Tevere, è necessario analizzare alcune istituzioni arcaiche romane, al fine di tracciare l’ipotesi di un diritto pubblico e di un diritto privato prima della Conditio Urbis. Secondo il Sabbatini, non appare difficile fondare tale ipotesi: documenti arcaici parlano infatti di una organizzazione politica preesistente alla Città – La Nazione latina (il Nomen Latinum) – (4) fornito di sue magistrature molto simili alle prische istituzioni politiche romane. Uno o due magistrati erano a capo di esse; vi era una assemblea di anziani ed un comizio di armati. Vi erano, dunque, istituzioni simili a quelle che a Roma sarebbero state rappresentate dal Re, dal Senato, dal Comizio Curiatio (5). Una fonte sulla comunanza di istituti giuridici tra il popolo latino e Roma arcaica può trovarsi nel Foedus Cassianum, il trattato di pace fra Romani e Latini dopo la battaglia del lago Regillo (per Tito Livio la guerra iniziò sotto il consolato di Tito Ebuzio Helva e Gaio Veturio Gemino Cicurino, nel 499 a.C.; Il Trattato fu stipulato nel 493 a.C. dal console romano Spurio Cassio Vecellino)[6] (6). In tale trattato si riconoscono reciprocamente validi i contratti ed i giudizi, siano essi romani, siano essi latini, indipendentemente dall’essere le parti romane, latine, o miste.
Preliminarmente alla descrizione degli antichi istituti giuridici ipotizzati risalenti al tempo dello Stato-orda, appare opportuno riportare il pensiero di Pietro De Francisci in ordine allo spirito dell’antico popolo di Roma. Secondo l’Autore, tale spirito, risalente al popolo latino migrante, è caratterizzato dal concetto che la creazione di ogni forma di azione umana deve svolgersi entro un determinato ordine necessario; concezione originale di un popolo pratico e savio, che era riuscito a disciplinare le forze dell’uomo e a volgere verso uno scopo unico: la solidità e la grandezza dello Stato(7). In un ambiente come quello attraversato durante la migrazione dalla Stato-orda in cui l’esistenza è ogni giorno insidiata dai pericoli non superabili che con lo sforzo collegato di tutti, in cui la salvezza del singolo dipende soprattutto dalla comunità e dalla tutela che in essa può trovare, dove, ancora, la comunità stessa per difendere i sui componenti deve tendere le proprie energie in una lotta contro uomini e cose ostili, è necessario che si affermi il senso della comunità e si radichi nell’individuo la coscienza che lo scopo primo dell’azione è il continuo accrescimento della potenza della comunità. Ciò impone, ai fini di ordine e difesa, l’assoggettamento del singolo al medesimo comando (8). Quando si considera l’insieme delle credenze primitive, l’anima dell’antico popolo migrante è tutta imbevuta da un profondo senso del “numinoso” (9), dal sentimento cioè della presenza della divinità nelle cose, nei vari momenti della vita, nelle diverse manifestazioni di attività (10). Dalla nascita alla morte questa potenza divina accompagna l’uomo.
Tuttavia, nella religione primitiva, le divinità distinte non posseggono alcuna personalità né hanno alcuna leggenda. Si direbbe che a questo popolo antico ripugnasse attribuire a queste divinità una forma precisa ed un’esistenza individuale: essi le consideravano quali manifestazioni varie (numina) promananti da una sola ed unica potenza divina, quella del Divus Pater Jupiter, che sotto diversi aspetti si rivela misteriosamente e domina la natura (11). Tuttavia, questo senso del “numinoso” appare come l’espressione del concetto che l’ordine delle cose e dei rapporti, quindi anche l’azione e il divenire degli uomini, sono retti da una volontà superiore e trascendente in cui hanno origine le leggi che regolano le armonie della natura e le norme che reggono le relazioni umane. Conseguenza di ciò, è la convinzione che, soltanto con la conoscenza di quella volontà (e cioè dei principii che dominano il corso delle cose e degli eventi) l’uomo può raggiungere quei fini cui tende la sua attività individuale e sociale. Dalla consapevolezza che il divino è superiore all’umano e l’eterno al mutevole nasce la necessità di conformare la propria vita a quel fas, volontà divina rivelata, che è legge suprema, contro la quale è possibile reagire se non commettendo un nefas, cioè un atto riprovevole, produttivo di conseguenze funeste. Nella legge suprema pertanto va cercata la base di tutte le norme etiche. Questa convinzione della penetrazione del divino in tutta la realtà nasce la consapevolezza dell’unità del mondo e la certezza della “santità” di quella vita associata. Questo popolo migrante, così come poi faranno i cittadini di Roma, pensa che la stessa volontà divina ha stabilito la necessità della vita di gruppo; non sa concepire l’individuo astratto, l’uomo è visto come padre, figlio, fratello, componente di una familia, di una gens: né può immaginare che fuori da un gruppo, sia concesso all’uomo di vivere e di sviluppare la propria personalità intellettuale e morale. Cosi, accanto al concetto della subordinazione dell’uomo alla volontà divina, che si manifesta nel fas, si afferma l’idea della ragione divina dei vincoli che legano gli uomini fra loro: da qui l’idea del diritto considerato non già come imposizione di una forza arbitraria, ma come un riflesso della volontà divina nella coscienza degli uomini nonché la base religiosa del concetto di autorità, di gerarchia, di ordine e di giustizia.
In base a questa alleanza con il soprannaturale, il popolo migrante prima e la comunità di Roma poi, pensa di avere una posizione di privilegio rispetto agli altri popoli. Ma perché la pax deorum, presupposto della collaborazione divina, possa essere assicurata alla etnia/civitas è necessario garantirsi che quanto si sta intraprendendo sia gradito alla divinità: e necessario cioè conoscerne la volontà divina. Nasce la necessità quindi della congiunzione dell’imperium del capo/magistrato con l’auspicium, mediante una cerimonia in virtù della quale il capo/magistrato diventa depositario degli auspicia populi. Quando è assicurata la pax deorum l’uomo, svolgendo la propria attività, avrà accanto a sé come alleate le forze sovraumane che varranno a combattere tutte le altre forze umane o divine che, direttamente o indirettamente, potrebbero giovare al nemico. La divinità quindi non agisce né predeterminando il futuro né sostituendo la propria azione all’azione umana. Gli uomini devono operare ed agire nel limite delle loro possibilità: al di là di questo limite, nel campo dell’inconoscibile, nel regno delle forze ostili, soltanto la divinità può operare e sorreggere benignamente la forza dell’uomo purché venga assicurata la pax deorum. Questa fede nell’assoluta superiorità dell’uomo che operi in conformità alla volontà degli dei attribuisce alla più antica civiltà latina un suo carattere inconfondibile. Il divino e l’umano si integrano in un rapporto costante, quasi di filiazione più che di soggezione tra l’uomo e Giove Pater Genitor. è presente pertanto la convinzione dell’esistenza di una continuità nello spazio, meglio di una interdipendenza intima tra vita individuale e vita associata; è viva l’intuizione della continuità nel tempo della vita e dell’azione degli individui e della collettività/Stato, continuità assicurata dalla protezione del Genius (12) che fa discendere l’energia del padre nei figli e nei figli dei figli e dalla assistenza della divinità che garantisce con la sua collaborazione l’esistenza e la potenza della città. Per conseguire questa pax deorum è necessario che le cerimonie e gli atti propiziatori siano compiuti secondo norme rigorose, conforme al ritus (rite) e conforme al jus (juste), Di qui, sia nel campo religioso che in quello giuridico, prima confusi poi differenziati, come pure in tutta la vita pubblica e privata, il diffondersi della convinzione che ogni atto possegga una propria legge e che per conseguire i propri effetti debba rispondere a determinate forme. E’ corrente, pertanto, nello spirito di questo popolo la concezione che tutti i momenti e tutti gli atti importanti della vita devono essere accompagnati a pratiche rigorose.
Ritornando alle forme più antiche del diritto romano, Giampaolo Sabbatini, nel citato testo Appunti di Preistoria del Diritto romano, analizza la più risalente forma di condanna a morte: la sacertà criminale. In proposito, fa notare che in uno dei più antichi monumenti, il Cippo del Foro, il termine sacer si presenta strettamente legato alla sacertà criminale (13). La sacertà (lat. sacertas), secondo il diritto romano, era una sanzione a carattere giuridico-religioso inflitta a colui che determinava, con la propria condotta, un’infrazione della pax deorum; giuridicamente, comportava la perdita della protezione che la civitas garantiva ad ogni cittadino e, quindi, la possibilità per chiunque di uccidere il trasgressore. Il termine è usato sulla base del particolare significato che nella lingua latina assume l’aggettivo sacer (vale a dire “maledetto, colpito da un influsso negativo da parte degli dei”). Sacer esto (“sia maledetto”) era la formula penale con cui si consacrava qualcuno agli dei inferi. In epoca storica, colui a cui veniva inflitta la sacertà, come sancito dalle cosiddette leges sacratae, era consacrato a Giove e il suo patrimonio era consacrato a divinità plebee. La consacrazione alla divinità, però, non avveniva con le modalità del sacrificio rituale, ma era conseguita in via indiretta, garantendo l’impunità a colui che uccidesse il colpevole di un comportamento contrario alle norme vigenti (scritte e no).
La dimensione civile e sociale della religione del popolo migrante prima e romana poi fa sì che lo scelus individuale si riverberi sempre sull’intero gruppo: il singolo non ha un rapporto personale con la divinità – come accade nella religione cristiana, che è una religione di salvezza individuale – e i suoi comportamenti non sono concepibili nei termini di “peccato” del singolo, ma determinano sempre una responsabilità oggettiva della civitas.  È per questa ragione che, anche se a Roma si è affermata abbastanza presto l’idea della responsabilità personale in campo criminale, gli illeciti di natura religiosa coinvolgono l’intero gruppo, e ciò per il fatto che nel ius humanum l’individuo ha un rapporto giuridico con il gruppo di cui è parte, e dunque risponde personalmente per gli illeciti che commette contro gli altri membri o la civitas nella sua interezza, mentre nel ius divinum l’unico soggetto giuridicamente rilevante è la collettività; cosicché solo questa risponde per gli illeciti commessi dai suoi membri. Quando viene posto in essere un comportamento che provoca l’ira deorum, gli dèi si rivolgono alla comunità umana, così come accade nei rapporti tra gruppi familiari all’interno dell’ordinamento romano, oppure tra populi in quello che è stato definito il “sistema sovrannazionale” romano. Per evitare una sorta di bellum con gli dèi e per conservare la pax deorum, la città deve liberarsi della responsabilità derivante dagli atti del suo membro, e a questo fine punisce il reo con una sanzione che è realizzata nel ius humanum ma ha effetti anche nel ius divinum. La punizione a volte coincide con una messa a morte sacrificale (deo necari), altre volte con la recisione di ogni rapporto giuridico tra la comunità e il colpevole (sacratio), altre volte ancora, per illeciti meno gravi, con la caducazione di specifici diritti (impietas, intestabilitas, improbitas) – cui in età più recente si affianca o si sostituisce la nota censoria. Nel caso della sacratio, una volta che il colpevole sia stato separato dal gruppo, egli può essere ucciso impunemente da chiunque oppure può perire per l’intervento divino. Ma così come non è una pena in senso giuridico l’eventuale uccisione da parte di un privato, allo stesso modo non è una pena in senso giuridico l’eventuale rovina indotta dagli dèi: l’unica sanzione è appunto la sacratio. Non vi è dunque alcuna dazione dell’homo sacer agli dèi, né un abbandono alla loro giurisdizione, perché ogni profilo giuridicamente rilevante viene gestito dalla comunità umana, sia nei profili di ius humanum che di ius divinum (14).
È per questa ragione che, anche se a Roma si è affermata abbastanza presto l’idea della responsabilità personale in campo criminale, gli illeciti di natura religiosa coinvolgono l’intero gruppo, e ciò per il fatto che nel ius humanum l’individuo ha un rapporto giuridico con il gruppo di cui è parte, e dunque risponde personalmente per gli illeciti che commette contro gli altri membri o la civitas nella sua interezza, mentre nel ius divinum l’unico soggetto giuridicamente rilevante è la collettività; cosicché solo questa risponde per gli illeciti commessi dai suoi membri. Quando viene posto in essere un comportamento che provoca l’ira deorum, gli dèi si rivolgono alla comunità umana, così come accade nei rapporti tra gruppi familiari all’interno dell’ordinamento romano, oppure tra populi in quello che è stato definito il “sistema sovrannazionale” romano. Per evitare una sorta di bellum con gli dèi e per conservare la pax deorum, la città deve liberarsi della responsabilità derivante dagli atti del suo membro, e a questo fine punisce il reo con una sanzione che è realizzata nel ius humanum ma ha effetti anche nel ius divinum. La punizione a volte coincide con una messa a morte sacrificale (deo necari), altre volte con la recisione di ogni rapporto giuridico tra la comunità e il colpevole (sacratio), altre volte ancora, per illeciti meno gravi, con la caducazione di specifici diritti (impietas, intestabilitas, improbitas) – cui in età più recente si affianca o si sostituisce la nota censoria. Nel caso della sacratio, una volta che il colpevole sia stato separato dal gruppo, egli può essere ucciso impunemente da chiunque oppure può perire per l’intervento divino. Ma così come non è una pena in senso giuridico l’eventuale uccisione da parte di un privato, allo stesso modo non è una pena in senso giuridico l’eventuale rovina indotta dagli dèi: l’unica sanzione è appunto la sacratio. Non vi è dunque alcuna dazione dell’homo sacer agli dèi, né un abbandono alla loro giurisdizione, perché ogni profilo giuridicamente rilevante viene gestito dalla comunità umana, sia nei profili di ius humanum che di ius divinum (14).
Ritornando al testo Appunti di Preistoria del Diritto romano, l’autore afferma (pag. 26) che la sacertà criminale è uno degli istituti di origine migratoria che contribuisce ad individuare il Jus Quiritium. Soltanto trasportando l’origine di quella forma di condanna a morte nell’epoca del cammino verso l’occidente, si può avere chiara l’immagine della sua efficacia e si può comprendere la terminologia che la riguarda. In epoca storica, l’esecuzione materiale, se avviene, è un soprappiù. In epoca migratoria, nulla doveva essere fatto in più che l’inviare il reo fuori dalla compagine sociale, verso l’infinito ed ostile spazio circostante, renderlo, cioè, sacer. Nessuna azione diretta immediatamente ad uccidere doveva essere posta in atto da alcuno; allorchè il colpevole è inviato nell’Aker, egli, sebbene vivo, è ormai definitivamente separato dal popolo ed è perduto. Come affermato dal von Jhering, la sacertà criminale rispondeva pienamente ad una delle prime esigenze di un popolo anche soltanto parzialmente organizzato (15). I legami fra l’uomo sacer e la divinità ctone e chiarito dal fatto che, per l’uomo espulso dall’orda con il rito della consecratio capitis, che prevedeva le braccia legate sotto il mento, la privazione della vista mediante un cappuccio, una violenta fustigazione a sangue, non vi era possibilità di vita nello spazio circostante infestato soprattutto da lupi. Il lupo quindi diviene l’immagine del Signore ctonio; nella mitologia, il lupo è definito orcus, il signore e guardiano del regno dei morti (Cerbero).La visione ultra tombale del defunto per questo popolo è così rappresentata: il defunto doveva evitare Cerbero, pagare il traghettamento del fiume infernale per arrivare ai Campi Elisi. L’anima dei defunto, che tuttavia si credeva corporea, rimaneva in mezzo ai lupi prima di arrivare alla Terra abbandonata: i Campi Elisi (Elisi= abbandonati). Questa era l’antica terra abbandonata all’inizio delle migrazioni verso l’occidente, ricordata come terra felice in quanto immune dalle fatiche e guerre che la migrazione comportava.
Qualche caso di sacertà penale
Nei libri ab urbe condita di Tito Livio traspare la convinzione che la fides aveva costituito, insieme alla pietas, l’elemento essenziale per la legittimazione divina dell’imperium dei Romani; a suo avviso, gli dèi si erano mostrati, in ogni circostanza, più ben disposti verso coloro i quali avevano onorato la fides. La fides (16) romana è un fenomeno che trova radici antichissime preesistenti alla società romana. Essa non è solo un valore morale, è soprattutto una dottrina religiosa. Come molti altri concetti cardine dell’universo antropologico romano, anche la fides infatti ha una sua ipostasi divina; essa rappresenta un principio fondamentale e costitutivo della vita politica e sociale dell’uomo latino. Nel diritto arcaico i diversi crimini puniti con il sacer esto sembrano avere in comune la violazione della fides. In effetti la manomissione di un terminus (17), la violenza esercitata dal figlio o dalla nuora sul parens (la cosidetta verberatio parentis) (18), la frode all’interno del rapporto clientelare (19), il tentativo di restaurare la monarchia a Roma, sancita dalla lex Valeria de adfectatione regni (20), la violazione della sacrosantitas tribunicia, sancita dalla lex tribunicia prima del 494 a. C. e poi ribadita dalla lex Valeria Horatia de tribunicia potestate del 449 (21), sono tutti esempi di fides fracta, cioè di una fiducia spezzata. Dall’esame delle fonti relative a questi maleficia emerge l’idea di una fides pubblica che tutti i soggetti dello Stato-orda prima e i cives poi devono rispettare nei confronti della controparte. La fides, in effetti, è il fondamento che regola i rapporti fra gli individui, che siano rapporti già codificati dalla natura, come quelli fra padre e figli, oppure prodotti dalla cultura, come quelli che si stringono fra i membri di una stessa comunità, a livello pubblico e privato (22).  Esaminiamo in particolare alcuni casi. In merito al crimine di frode all’interno del rapporto clientelare, secondo Dionisio di Alicarnasso (23), Romolo aveva stabilito con la sacertà le violazioni della fides da parte del patrono nei confronti del cliente e viceversa (24). Mentre nel commento serviano all’Eneide la sacertà è limitata alla sola ipotesi di fraus da parte del patrono (25). Nella letteratura più antica si tendeva a considerare le due formulazioni in riferimento ad un’unica norma, per alcuni régia e per altri decemvirale, spiegando la differenza come un errore di una delle due fonti; di recente è stato postulato una duplice fase di tale istituto, la prima legata alla reciproca e paritetica necessità di mantenere intatto il rapporto tra il patrono e il cliente, la seconda nel contesto delle lotte tra i patrizi e plebei, che avrebbero condotto ad una norma più favorevole ai secondi, per cui sarebbe rimasta solo la sacertà del patrono infedele ma non l’ipotesi inversa. Altra differenza tra le due formule è che mentre nella formula di Servio è ricordata sola la dizione sacer esto, in quella di Dionisio, è nominato un dio sotterraneo: Zeus Chtonios. Questo è quindi un caso di sacertà comportante l’intervento di un dio infero. Anche in un’altra legge romulea (26) che prevedeva il divieto al marito di vendere la mogie sotto pena di sacertà, è chiamata in causa una divinità ctonia. Il significato della formula sacer esto ha avuto pertanto nei periodi storici diversi significati; all’inizio nello Stato-orda, quando il termine indicava massimamente il valore di “sia espulso dalla comunità nomade e cacciato verso l’infinito spazio circostante”, nessuna divinità personalizzata veniva specificatamente chiamata in causa ma solo divinità infere (27).
Esaminiamo in particolare alcuni casi. In merito al crimine di frode all’interno del rapporto clientelare, secondo Dionisio di Alicarnasso (23), Romolo aveva stabilito con la sacertà le violazioni della fides da parte del patrono nei confronti del cliente e viceversa (24). Mentre nel commento serviano all’Eneide la sacertà è limitata alla sola ipotesi di fraus da parte del patrono (25). Nella letteratura più antica si tendeva a considerare le due formulazioni in riferimento ad un’unica norma, per alcuni régia e per altri decemvirale, spiegando la differenza come un errore di una delle due fonti; di recente è stato postulato una duplice fase di tale istituto, la prima legata alla reciproca e paritetica necessità di mantenere intatto il rapporto tra il patrono e il cliente, la seconda nel contesto delle lotte tra i patrizi e plebei, che avrebbero condotto ad una norma più favorevole ai secondi, per cui sarebbe rimasta solo la sacertà del patrono infedele ma non l’ipotesi inversa. Altra differenza tra le due formule è che mentre nella formula di Servio è ricordata sola la dizione sacer esto, in quella di Dionisio, è nominato un dio sotterraneo: Zeus Chtonios. Questo è quindi un caso di sacertà comportante l’intervento di un dio infero. Anche in un’altra legge romulea (26) che prevedeva il divieto al marito di vendere la mogie sotto pena di sacertà, è chiamata in causa una divinità ctonia. Il significato della formula sacer esto ha avuto pertanto nei periodi storici diversi significati; all’inizio nello Stato-orda, quando il termine indicava massimamente il valore di “sia espulso dalla comunità nomade e cacciato verso l’infinito spazio circostante”, nessuna divinità personalizzata veniva specificatamente chiamata in causa ma solo divinità infere (27).
Interdictio Aquae et Ignis (28)
La interdictio aquae et ignis è il provvedimento sorto in epoca migratoria a fianco della consecratio come sostitutiva di questa: pena capitale per eccellenza, quella cioè attraverso la quale un caput (individuo) veniva escluso dalla collettività. L’acqua ed il fuoco erano i due elementi necessari alla vita delle popolazioni migratorie ed, per questo, erano beni pubblici. L’interdictio è collegata l’antichissima forma di processo penale; l’accusato, violando l’obbligo morale di comparire si ecclissava (gli obblighi morali, in epoca arcaica, erano sanciti dal mos e, quindi, inviolabili) dichiarando con ciò la propria colpevolezza. Il capo/magistrato non poteva che costatare l’avvenuta scomparsa dell’accusato e questo dava forma concreta di prova al grave sospetto di colpevolezza cui la fuga aveva dato origine. L’accusato, quindi, prevedendo la condanna, fuggiva; il capo/magistrato, per rendere la sua sorte nonostante la fuga simile a quella che sarebbe stata con la consecratio (morte per fame e sete) gli vietava l’avvicinamento al cibo e alle bevande e imponeva a chiunque il divieto di nutrirlo e di dissetarlo. Anzi, se il fuggitivo fosse giunto a tiro, chiunque poteva ucciderlo impunemente. Per ottenere lo scopo, il nome del fuggitivo doveva essere propagato in mezzo a tutti i cittadini soldato nomadi (popolo) riuniti nel comizio. Tale funzione si denominava interdictio, che significa “passare la voce”, “dire in mezzo” ad una moltitudine. Pertanto, il risultato finale che si otteneva al tempo delle migrazioni dei due istituti consecratio et interdictio era il medesimo: la morte dell’homo sacer.
Note:
1 – Pietro De Francisci, Spirito della civiltà romana, edizioni dell’Ateneo – Roma, 2° edizione, pag. 79 e ss.
2 – Livio, ab Urbe Condita, 1,8 vocata multitudine, quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, jura dédit.
3 – Giampaolo Sabbatini, Appunti di Preistoria del Diritto romano, Giappichelli, 2014
4 – A. Bernardi, Nomen Latinum (Studia Ghisleriana), Pavia. La ricerca del Berardi riguarda la sviluppo storico del Nomen Latinum, dalla prima apparizione della stirpe latina nell’VIII – VII se. A. C., alla sua scomparsa come realtà etnica dopo la guerra sociale.
5 – P. Frezza, Le costituzioni cittadine di Roma e il problema degli ordinamenti giuridici preesistenti, in Scritti Ferrini, 1947.
6 – Tito Livio, Ab Urbe condita libri, lib. II, par. 20
7 – Pietro De Francisci, citato, pag. 51 e ss.
8 – Pietro De Francisci, citato, pag. 27 e ss.
9 – Termine coniato dal teologo ted. Rudolf Otto (nella sua opera Das Heilige «Il Sacro», 1917) e da lui introdotto nella filosofia e nella storia delle religioni per indicare l’esperienza peculiare, extra-razionale, di una presenza invisibile, maestosa, potente, che ispira terrore ed attira: tale esperienza costituirebbe l’elemento essenziale del «sacro» e la fonte di ogni atteggiamento religioso dell’umanità.
10 – Tutto ciò è stato rilevato dagli studiosi della religione romana: ma soprattutto che tali caratteri siano stati definiti con molta precisione da G. Costa, La formazione storica della coscienza morale in Roma, in « Religio », vol. XI, n. 2, pp. 102-103: ma v. a. Kerènyl, Die antike Religion, ce. III, IV, VI.
11 – E’ quindi giustificato considerare questa religione primitiva come una forma di monoteismo. Solo più tardi i vari epiteti con cui questa divinità viene designata assunsero una certa autonomia: si perdette la coscienza della relazione fra il nome e la qualifica originaria: e si giunse cosi ad una personalizzazione dei diversi aspetti della divinità primitiva (Boissier, La religion romaine d’Auguste aux Antonins, 1, 1906, p. 36). La religione romana arcaica non dovette essere antropomorfica: v. a. Bouchè-Leclercq, Les Pontifes de l’ancienne Rome, p. 46.
12 – Nella religione romana, il Genio (lat. Genius, plurale Genii) è uno spirito o, più correttamente, un nume tutelare, considerato come il custode benevolo delle sorti delle famiglie ma anche dei singoli individui. Nel tentativo di chiarirne la natura ne sono state date definizioni approssimative, come “anima“, “principio vitale“, “angelo custode“.
13 – V. Pisani, Testi latini arcaici e volgari, 1960
14 – R. Fiori, La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica, in Autour de la notion de Sacer, 2018
15 – R. Von Jhering, Gli Indoeuropei prima della storia, Parigi, 1895
16 – Fiori R., Fides e Bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche in AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 3 voll., Jovene, Napoli 2008,
17 – Paolo Diacono, Pauli excerpta, s. v. Termino, p. 505 Lindsay: Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum, qui terminum exarasset, et ipsos et boves sacros esse. Dionigi di Alicarnasso, Antiquitates Romanae II, 74, 3, che riporta la stessa legge, sostiene che in questo caso il violatore sarebbe stato consacrato a Zeus Horios.
18 – Festo, s. v. Plorare, p. 260 Lindsay: Plorare, flere [inclamare] nunc significat, et cum praepositione inplorare, id est invocare: at apud antiquos plane inclamare. In regis Romuli et Tatii legibus: “si nurus . . . , <nurus> sacra divis parentum estod.” in Servi Tulli haec est: “si parentem puer verberit, ast olle plorassit paren<s>, puer divis parentum sacer esto.”
19 – Servio, Ad Aeneidem VI, 609: “aut fraus innexa clienti” ex lege XII tabularum venit, in quibus scriptum est “patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto”. Ma anche Dionigi di Alicarnasso, Antiquitates Romanae II, 10, 3.
20 – Livio II, 8, 1: Ante omnes de provocatione adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset gratae in volgus leges fuere. Alla stessa norma allude Plutarco, Publicola 12, 1.
21 – Il contenuto della lex tribunicia prima, a cui allude Festo nella voce Sacer mons, p. 424 Lindsay, è riferito da Dionigi di Alicarnasso, Antiquitates Romanae VI, 89, 3-4 e Livio, Ab Urbe condita libri II, 33, 1-3. Sulla lex Valeria Horatia de tribunicia potestate del 449, cfr. Livio, Ab Urbe condita libri III, 55.
22 – In proposito cfr. A. Valvo, “Fides”, “foedus”, “Iovem lapidem iurare”, in M. Sordi (a cura di), Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell’antichità, Vita e Pensiero, Milano 1992, pp. 115-125.
23 – Dionisio di Alicarsasso, Antiquitates Romanae II, 10, 3, (ant Rom 2.10.3: εί δέ τις έξελεγχθείν τούτων τι διαπραττόμενος ένοχος ήν τω νόμω τής προδοσίας, δν έκύρωσεν ό Ρωμύλος, τον δε άλόντα το βου- λομένω κτείνειν όσιον ήν ως θυμα του καταχθονίου Διός ).
24 – La legge, però, potrebbe essere anche di molto anteriore rispetto alla fondazione di Roma ed essere tradizionale, come quasi sempre accade allorché i romani usano la formula a Romulo, intendendo con ciò qualcosa di ancestrale (g. Sabbatini, citato)
25 – Serv., ad Aen. 6.609 aut fraus innexa clienti: ex lege XII tabularum venit, in quibus scriptum est patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto: si enim clientes quasi colentes sunt, patroniquasi patres, tandundem est clientem, quantum filium fallere. et hoc passe fieri ex Horatii dictis- carm. 2.18.26- intellegimus, qui loqueretur de avaris potentibus, ait de vicino cliente pellitur paternos in sinu furens deos. urbano tamen hoc displiciet et dicit rarumesse hoc magisque contrarium, cum magis patronos decipiant frequenter clientes. vult autem intellegi praevaricatores, qui patroni sunt clientium, quos nunc susceptos vocamus.
26 – Plut. Romolo. 22
27 – V. nota n. 11
28 – Giampaolo Sabbatini, nel citato testo Appunti di Preistoria del Diritto romano, Cap. VII (Riassunto).
Giuseppe Chiantera