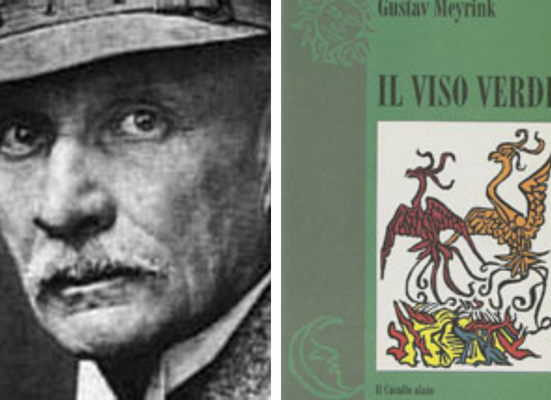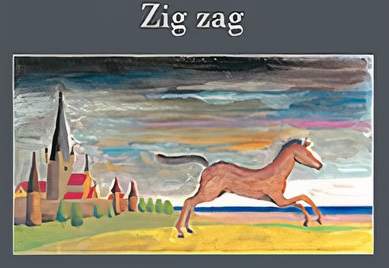Fa uno strano effetto trovarsi a rileggere Jack London quando in Italia, in Svizzera e nell’intero mondo “civilizzatotecnologico” si sta tornando a parlare di lupi. Di queste fiere creature che riemergono dai boschi. Dalle foreste. Dai sogni. Si parla di uccidere lupi che per nome portano codici buoni per un sacco dell’immondizia o una pratica da sbrigare in ufficio. Chissà come avrebbe reagito London di fronte a questi boschi del XXI secolo ripopolati e fotografati e protetti da droni e telecamere, ai custodi della Natura formato turismo, alle paure di chi non ha nemmeno il coraggio di difendersi e offendere. Avrebbe sicuramente rispettato di più questi lupi che sbucano dal bosco leggeri e silenziosi e sbranano le pecore, che fanno risuonare nella notte la loro presenza e quegli allevatori, quei contadini che si armano e aspettano il predatore, li inseguono, li cacciano, che sognano di abbeverarsi nella caccia del suo sangue piuttosto che tutti qui difensori di Animali Peluche, al riparo nelle loro città a questi avventurieri da copertina, a questi garanti di una Natura incontaminata da riprodurre in qualche presepe o documentario rimontato ad arte e trasmesso nelle ciotole familiari. Lo scontro di fierezza, di ardore, di sangue, di fauci spalancate, di armi riconcilia con il sapore della terra, della vita, della morte. London vivrebbe ancora al fianco dei lupi, dei cacciatori, degli avventurieri del ghiaccio e delle stelle, della dolcezza, dell’incommensurabile bianco che avvolge fino a togliere il respiro e scriverebbe di uomini che nel 2017 hanno bandierine al posto delle mani, appelli su qualche piattaforma crocifissa nel cervello.

E i lupi riemergono dalle foreste californiane nelle pagine de “La peste scarlatta” riproposta meritevolmente da Edizioni di Ar (traduzione e prefazione di Fabrizio Sandrelli, copertina di Curzio Vivarelli) e vengono cacciati dalla genia uscita incolume da quella peste scarlatta che ha travolto e annientato il mondo conosciuto. Uomini e donne che sopravvivono in un mondo stravolto dalla malattia che ha lasciato dietro di sè miliardi di morti e riportato indietro la lancetta del tempo agli albori della Storia. Sulla strada e nella boscaglia un vecchio portatore del fuoco della conoscenza e insieme a lui ragazzini che non conoscono parole, che imbarbariscono il linguaggio, vivono come bestie. Intorno a loro le rovine di un mondo tecnologico. Un mondo restituito infine al silenzio.
“Come si eccitano per questo progrediente mondo che striscia avanti, sempre più avanti, attaccati ai cannocchiali, cirvi a guatare microrganismi (quorum non si escludono mai, gli infimi), a suscitare espedienti per caracollare sulla naturale carcasse qualche annetto in più” (F. Freda, “In alto le forche!” )
L’umanità trapassata alle tombe dopo decenni di ritrovati scientifici, di progresso, di accumulo di capitali, di ammorbidimento ai piaceri del consumismo materiale e artistico, di propensione alla malattia, alla fine.
Una profezia uscita dalla penna dello scrittore statunitense nel 1912, scritto in un’epoca già schiava del progresso, delle fabbriche, del materialismo, coi mattatoi di Chicago a produrre carne standardizzata da scatoletta usa e getta, i nativi americani sottoterra/nelle riserve/rieducati nelle scuole del dollaro/Dio cristiano, il denaro che raccogliamo da terra e su cui si fonda l’impero totale. Il denaro. La profusione di merci. Le transazioni di denaro e sangue nei polmoni della Borsa.
Oggi la sostituzione di popoli sull’altare del Siamo tutti uguali.
Un mondo malato che nemmeno si vergogna guardandosi allo specchio perché in quel riflesso coglierebbe solo qualcosa di altrettanto vendibile, scambiabile, da garantire a tutti.
Rileggerlo oggi, 2017, questo libro ti annienta. Ti mette a nudo, per la capacità profetica di London che percepisci nelle viscere, nel cuore, sulla lingua, sul sesso. Non siamo un mondo ridotto allo stremo fisico (ci ingozziamo ogni minuto di cibo/informazioni/suoni e se muoriamo di fame lo si fa perché l’ingozzamento prevede che altra carne muoia) ma allo stremo dell’esistenza. Un mondo senza popoli se non quello dei consumatori o dei lavoratori coatti/precari/volontari/disoccupati/assisisti/schiavi, senza comunità di uomini e donne ma di congreghe mefitiche radunate intorno ai totem tecnologici e dei social network, schiave dei saldi, invecchiate sotto il peso di un consociativismo costituente, impoveriti nell’animo e nello spirito e nella carne, invasi senza nemmeno capire di esserlo, schiavi del lavoro o di redditi di sussistenza ma con la veste del padrone seduto davanti alle slot machines a giocarsi risparmi e ipotesi di nuovo arricchimento, rammolliti nei pensieri, nei nervi, pronti a non riconoscere padri e madri e a farci generare dal primo composto chimico disponibile. Una peste che scava dentro di noi e che ci iniettiamo sorridenti tutte le mattine, tutte le sere. Scompariremo. E una volta sopravvissuti ci riprodurremo nelle stesse categorie di stolti, sembra quasi ammonirci London. Le nostri radici rinascerenno marce o con possibilità di una nuova rinascita? London ci mette sull’avviso, ci prende alla gola e ci trasporta da un abisso all’altro, da un cadavere all’altro, da una città in fiamme all’orrido di uomini senza più regole, disciplina, consapevolezza di se stessi. Come se prima prendesse un martello e poi la nostra testa e cominciasse a picchiarci sopra facendoci schizzare di sangue la nostra stessa ipocrisia. E in quei ragazzini, in quei ragazzini che non vogliono più sentire quelle storie, che deridono il vecchio, le parole che pronuncia, il linguaggio a loro incomprensibile, cosa dovremmo vedere e ascoltare?
Le ripeterranno all’inifito perché forse li crediamo i progenitori, i futuri figli e nipoti dei giovani d’oggi, inquadrati, insofferenti e ribelli solo nelle pose, negli artifici chimici, nell’assuefazione sorridente ai riti quotidiani dell’imbecillimento. Ribelli nelle marche da esibire sulle magliette, nel nichilismo da X-Factor, nelle loro noiose storie di cervelli in fuga da ripetere a spron battuto nei reportage da tv verità sopra cui spalmare storie di dolorosa inutilità.
“Ce la caveremo, vero, papà?
Si. Ce la caveremo.
E non succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sì. perché noi portiamo il fuoco.”
(Cormac McCarthy, La strada).
Provate ad assaporare la forza di queste parole e guardate con ragazzini de “La peste scarlatta” con occhi rinnovati. Leggete con lingua nuova queste pagine. Fate uno sforzo. Assaporate l’ebbrezza di vivere al loro fianco la possibilità di un nuovo divenire. Di indossare le loro vesti. I loro trofei. Di cacciare. Costruire. Immaginare. Procreare. Perché forse ci si sta sbagliando, perché forse quei ragazzini, ambigui, persecutori del vecchio professore che racconta storie incomprensibili, figli inconsapevoli della tragedia, sono fiori profumati che sbocciano nell’azione, sono gemme di alberi da frutto che si assaporano nell’immediatezza, sono il presente e il futuro di una nuova genia. Di un popolo diverso. Capace di stare al mondo con nuove energie e uno spirito rinnovato. Non per sopravvivere ma per vivere. Per far sorgere il nuovo mondo in una purezza lancinante.
O forse anch’io sono un arrabbiato per partito preso: un bastiacontrario. Che spalanca le finestre dopo l’ennesima giornata disastrosa e sorride alle stelle e alla luna, calde e bianche nel cielo di una fredda sera di primavera. La neve che rischiara l’orizzonte nell’approssimarsi di una rinnovata alba.