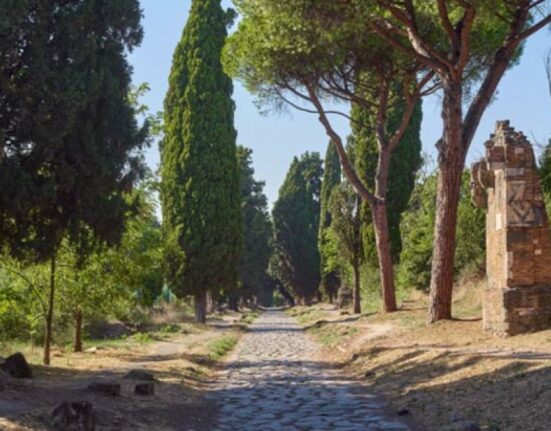Ricominciamo le nostre ricerche dal mese di settembre, anche se, posto che i miei calcoli siano esatti, questo nuovo articolo dovrebbe comparire in novembre sulle pagine di “Ereticamente”. La “forbice” fra le notizie che riporto e il momento in cui questi articoli compaiono sulle nostre pagine elettroniche, si è ridotta da quattro a due mesi, ma non so se sia il caso di rallegrarsene. Per tutta l’estate, c’è stato un notevole arretrato da smaltire accumulatosi per motivi vari, che non sto ora a rivangare, ma adesso ci troviamo di fronte un orizzonte piuttosto vuoto.
Dal momento che io ci terrei che questa serie di articoli che vorrei considerare una vera e propria rubrica, abbia una cadenza regolare sulle nostre pagine, e poiché diversi lettori di “Ereticamente” sembra vi siano affezionati e mi dispiacerebbe molto deluderli, ho adottato alcuni accorgimenti, alcuni escamotage, se volete.
Ad esempio, nella novantesima parte ho spaziato sui commenti relativi al mio ultimo libro Ma davvero veniamo dall’Africa?. Nella novantunesima ho fatto ancora peggio, infatti l’articolo è dedicato a un excursus sui pezzi che ho scritto in questi anni e sono comparsi sulle pagine di “Ereticamente” in cui ho in vario modo trattato la tematica delle origini, ma che, per un motivo o per l’altro non sono stati inclusi in Una Ahnenerbe casalinga/L’eredità degli antenati. Si tratta principalmente dei testi delle conferenze da me tenute nell’ambito del festival celtico triestino Triskell sul fenomeno megalitico nelle Isole Britanniche, nell’Europa continentale, in Italia, poiché i monumenti megalitici, spesso di millenni più antichi delle piramidi egizie e delle ziggurat mesopotamiche, sono la più chiara e convincente dimostrazione dell’antichità e della grandezza fin da tempi remoti della civiltà europea.
Dopo una novantaduesima parte “regolare”, ho dedicato la novantatreesima a esaminare il lavoro compiuto in questi anni sul gruppo facebook “MANvantara” dal nostro amico Michele Ruzzai, non soltanto per ricompensarlo in qualche modo di aver dedicato al mio libro Ma davvero veniamo dall’Africa due ampi e corposi articoli che sono certamente qualcosa di più di una recensione, ma anche per ovviare in qualche modo al fatto che le comparse di articoli di Michele su “Ereticamente” sono alquanto sporadiche proprio in ragione della sua grande meticolosità.
Tuttavia, voi capite che simili artifici non si possono usare all’infinito, e che il problema di assicurare una continuità a questa serie di articoli, rimane.
Eppure, la situazione, più che strana, è paradossale, infatti, mentre i siti, perlomeno quelli più quotati che si dedicano all’archeologia, sembrano registrare un nulla di fatto per quanto riguarda il nostro continente, altre fonti (inaspettate) ci rivelano una realtà ben diversa, al punto che si deve dire che se l’archeologia ufficiale si degnasse di prenderla in considerazione, le idee che essa ci offre sul nostro remoto passato, dovrebbero essere completamente rivoluzionate (e forse è proprio questo che si vuole evitare).
Ad esempio, il “National Geographic” ci ha segnalato la recente scoperta sotto i ghiacci della Groenlandia, di un cratere da impatto meteorico, che è stato denominato Hiawatha dal nome di una divinità dei nativi americani, e il meteorite che l’ha formato 11.000 anni fa, con le polveri che la sua caduta ha sollevato nell’atmosfera oscurando la luce solare, pare essere stato causa della mini-era glaciale nota come Dryas recente, che ha portato alla scomparsa di alcune fiorenti culture neolitiche.
Ancora, un comunicato della Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia ci ha recentemente informati di una notizia davvero sorprendente: gli scavi compiuti per l’installazione di un ascensore che porti dalla base alla sommità del colle dove si trova il castello di Udine, hanno rivelato che il colle stesso è in realtà una struttura artificiale, un mound, la più vasta struttura di questo tipo oggi nota in Europa, risalente all’Età del Bronzo.
Ma forse il contrasto maggiore con i siti ufficiali che ci parlano di questi tempi della Cina, dell’America precolombiana, delle isole del Pacifico, e soprattutto di Egitto in maniera asfissiante (senza menzionare, ovviamente i caratteri europei o nettamente nordici presentati dalle mummie faraoniche), ma riguardo al nostro continente, sembra abbiano poco o nulla da segnalare, è rappresentato da un sito come “L’arazzo del tempo” che, ricordiamo, si avvale di un ricercatore “fuori dagli schemi” come Felice Vinci.
Tanto per cominciare, “L’arazzo del tempo” ci ha parlato dell’insediamento neolitico di Deltaserrserne che è stato scoperto all’estremità settentrionale della Groenlandia, uno dei luoghi oggi più gelidi, primi di risorse, meno propizi alla vita umana che esistano sul nostro pianeta. Questo può significare solo che decine di migliaia di anni fa, quando le regioni oggi temperate erano strette dalla morsa della glaciazione, quelle artiche erano invece abitabili, godevano di un clima ben più mite, guarda un po’, proprio come ci hanno raccontato i maestri della tradizione, da Tilak in poi.
Più vicino a noi, nell’area balcanica, un paio di articoli segnalano i siti di Lepenski Vir e Yunasite, che sono i resti delle città più antiche del mondo, di un buon millennio più antiche della mediorientale Gerico a cui l’archeologia ufficiale attribuisce tale primato.
Sempre nel cuore dell’Europa, tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Germania meridionale, la fotografia aerea avrebbe evidenziato i resti di qualcosa come 150 edifici costruiti tra il 4.800 e il 4.600 avanti Cristo, le tracce della più antica civiltà europea e forse mondiale.
Non parliamo della scoperta avvenuta in Sardegna del frammento di una ruota dentata che avrebbe fatto parte di un congegno simile al famoso meccanismo di Antikythera, solo tecnicamente più avanzato più antico di tre secoli, che ci dà l’idea che certe conoscenze, più che accumularsi, siano andate perdute nel corso dei secoli.
E limitiamoci ora a un fuggevole accenno alle ultime uscite in libreria di Felice Vinci di cui vi ho parlato la volta scorsa, I segreti di Omero nel Baltico, che a dieci anni dall’ultima edizione di Omero nel baltico fa il punto sulle nuove scoperte nell’area baltico-scandinava, e Il meteorite iperboreo, scritto assieme a Susy Blady e Karl Kello. Può essere che la lavorazione del ferro e l’Età del Ferro siano state innescate dalla caduta di un meteorite ferroso nell’isola estone di Saarema.
Insomma, come si vede, c’è materiale più che sufficiente per pensare che lo strano, recente silenzio dell’archeologia ufficiale sul passato europeo rifletta non la mancanza di cose su cui lavorare, ma una vera e propria scelta ideologica. Forse si vuole evitare di risvegliare negli Europei il senso dell’antichità e della grandezza della loro civiltà.
Ma vediamo ora, per quanto risicato possa essere, quel che passa il convento in questo periodo.
 Cominciamo da “Ancient Origins” che ultimamente sembra dedicare grande spazio alla mitologia greca. Abbiamo appunto un post intitolato proprio Mitologia greca, che, dopo una breve introduzione, presenta i link a tutti gli articoli che, nel corso del tempo la pubblicazione ha dedicato all’argomento, e sono davvero tanti.
Cominciamo da “Ancient Origins” che ultimamente sembra dedicare grande spazio alla mitologia greca. Abbiamo appunto un post intitolato proprio Mitologia greca, che, dopo una breve introduzione, presenta i link a tutti gli articoli che, nel corso del tempo la pubblicazione ha dedicato all’argomento, e sono davvero tanti.
C’è però un appunto che non è possibile fare a meno di fare. Tra i miti “greci” così elencati, troviamo anche la leggenda di Romolo e Remo. “Mito greco”? Nemmeno per sogno, non soltanto è latino, ma si tratta proprio del mito fondante della romanità.
Una svista? Speriamo che sia così. Però bisogna anche ricordare ciò che vi ho segnalato nell’ottantanovesima parte, ossia che parlando della rinascita del paganesimo in Europa, “Ancient Origins” ha menzionato tutti tranne la comunità gentile romana.
“Ancient Origins” è irlandese, e dalla gente dell’Isola di Smeraldo non ci aspettiamo la stessa insopportabile spocchia degli Inglesi, ma sarebbe bene che avessero chiaro in testa che la storia dell’Europa, senza tenere in considerazione l’Italia, non si può fare se non in maniera distorta e mutila.
Fra gli articoli dedicati ai miti greci, alcune aggiunte recenti, un articolo di Robbie Mitchell dell’11 settembre dedicato a una divinità poco conosciuta, Nyx, la dea primordiale della notte. Quasi a fare da contraltare, il 14 settembre invece Alicia McDermott ci parla di Helios, il dio del sole. Il 28 agosto Lex Leigh ci parla degli inferi nella mitologia greca, una concezione che era spesso la base per rituali negromantici. Il 27 agosto Molly Dodenswell ci parla di Crono, il dio titano padre di Zeus. Secondo l’autrice sarebbe avvenuta fin dai primordi di questo mito una confusione tra questa figura e “il Padre Tempo”, favorita dall’omofonia (chronos è tempo in greco), ma in realtà il ruolo di dio del tempo non gli è attribuito da nessuna delle cosmogonie che conosciamo.
Aggiungo al riguardo una piccola chiosa: tale confusione è stata certamente aumentata dai latini che hanno fuso la figura del padre esiliato di Zeus con Saturno, in origine un antico dio dell’agricoltura (Sator in latino significa seminatore).
Parliamo di un articolo di Aleksa Vuckovich dell’8 settembre che ci parla di una leggenda basca, quella del Basajaun. Questa creatura, il cui nome significa “signore dei boschi”, è descritta come un umanoide di grandi dimensioni, robusto e villoso. Uomo selvatico o versione europea dello yeti?
La Vuckovich presenta un’ipotesi suggestiva: noi sappiamo che i Baschi sono una popolazione pre-indoeuropea fra le più antiche che popolano il nostro continente, stanziata nelle sue sedi attuali fin dal paleolitico. La leggenda del Basajaun non potrebbe essere il ricordo dell’incontro avvenuto allora con genti molto primitive appena oltre o ancora al disotto della soglia dell’umanità, neanderthaliani o altro?
Riprendiamo il discorso sulla mitologia greca e in particolare sul mito di Crono-Saturno. Ultimamente mi è capitato di fare un viaggio nella mia materna Toscana, e qui ho avuto l’occasione di visitare il castello di Poppi (Arezzo). Il castello, appartenuto ai conti Guidi, diede rifugio ai ghibellini sconfitti nella battaglia di Campaldino, battaglia a cui partecipò Dante Alighieri, e più tardi, quando la parte bianca fu costretta all’esilio da Firenze, ospitò lo stesso Dante.
Al bookshop del castello ho notato e subito acquistato un libro, Prodigi e misteri in terra di Arezzo di Fabrizia Fabbroni. Molte delle leggende che questo libro ha raccolto, hanno un interesse locale (anche se trattandosi di una terra dalle origini etrusche, visto che la mitologia etrusca è ancora oggi assai poco conosciuta, ci aspettano diverse sorprese), ad esempio quella dell’uomo selvatico di Monterchi (ma questo tema dell’uomo selvatico ricorre dalla mitologia basca al ciclo arturiano fino allo yeti dell’Himalaya), ma forse più interessante di tutte è la prima storia che si rifà precisamente al mito di Crono-Saturno.
Secondo la narrazione tradizionale, il dio sconfitto dal figlio Zeus si sarebbe rifugiato nell’Italia centrale. Lazio, Latium, deriverebbe da latere, nascondersi, perché qui appunto il dio si sarebbe nascosto per sottrarsi allo sguardo di Zeus, ma la Fabbroni accredita la versione della leggenda secondo la quale il dio si sarebbe nascosto nella terra fra i due fiumi che un tempo sarebbero nati da una sorgente unica, finché gli eventi sismici non le hanno separate, vale a dire la terra fra i due fiumi Tevere e Arno, che è marginalmente Lazio ma soprattutto Etruria.
Passiamo a esaminare quello che ha da offrire di questi tempi ArcheoMedia, e qui ci imbattiamo subito in una sorpresa, infatti questo sito che si dedica di solito all’archeologia italiana, ultimamente sembra spaziare su uno scenario più ampio, europeo e non solo europeo, quasi a voler compensare la strana mancanza d’interesse per il nostro passato ultimamente dimostrata dai siti maggiori (a parte l’attenzione che, abbiamo potuto rilevare “Ancient Origins” ha dimostrato alla mitologia greca).
Un articolo di Angelo Petrone dell’8 settembre ci informa che in Ucraina, precisamente nel sito di Bilsk poco distante dal villaggio omonimo, sono stati ritrovati i resti di un’abitazione dell’Età del Bronzo ampia circa 64 metri quadrati, assieme ad alcune punte di freccia però più recenti, di epoca scitica. Quest’ultimo ritrovamento è particolarmente importante perché, essendo stati gli Sciti un popolo nomade, fuori dalle necropoli, ben poche sono le tracce che costoro hanno lasciato dietro di sé.
Un articolo del 12 settembre di Andrea Marsanich ci racconta che nella penisola dalmata di Sabbioncello, oggi Croazia, sul locale castelliere sono state trovate le inequivocabili tracce di un assedio. Esso risalirebbe alla campagna militare condotta nel 35-33 a. C. da Ottaviano, allora non ancora Augusto, contro gli Istri.
Un altro articolo, sempre del 12 settembre, questa volta di Michele Zazzi, ci parla della situla di Plikasna. La situla, che prende il nome dal proprietario, nome che è inciso su di essa, è un vaso d’argento placcato d’oro, ed è uno dei capolavori dell’oreficeria etrusca, oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Secondo Zazzi, essa rivela influssi greci e orientali, ed è una dimostrazione di come gli Etruschi fossero un popolo aperto sempre a nuove esperienze e pronto a recepire influssi culturali.
Carne al fuoco, come si vede, ce n’è tanta, e questo rende francamente inaccettabile il fatto che almeno una parte del mondo archeologico sembra voler ignorare o nascondere come polvere sotto il tappeto il nostro passato. Che sia l’ennesima forma di quel “Cancel culture” cui dobbiamo opporci con tutte le nostre forze?
NOTA: Nell’illustrazione, Nyx, dea greca della notte, dall’articolo di Robbie Mitchell su “Ancient Origins”.