Jean Servier (1918-2000) può essere considerato, per utilizzare un’espressione coniata da Prezzolini in riferimento alla propria esperienza intellettuale oltre che anagrafica, un «figlio del secolo» XX. Un secolo drammatico in cui si è mostrata a chiare lettre la marcia trionfale delle idee moderne e, a partire dagli anni Settanta, l’affermarsi della società liquida. Con tali contingenze storiche e speculative, Servier ha intrattenuto un lungo, serrato e critico confronto. Egli ha legato il suo nome a ricerche etnologiche ed antropologiche relative alla popolazioni berbere del Nord Africa. Qui, del resto, era nato: più precisamente a Constantine, in Algeria. Chiuse i suoi giorni, dopo una vita intensa e appassionata, spesa al servizio della Tradizione e della cultura, a Saint Christol, in Francia. A ricordarlo
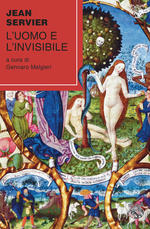 è Gennaro Malgieri, curatore della nuova edizione dell’opera più nota ed importante dello studioso, L’uomo e l’invisibile, da poco nelle librerie per Iduna Edizioni (per ordini: associazione.iduna@gmail.com, pp. 435, euro 28,00). Il volume è impreziosito da una suggestiva appendice fotografica. La traduzione del libro è di Giovanni Cantoni e ad Agostino Sanfratello, esponenti del cattolicesimo tradizionalista. Cantoni, scomparso nel gennaio scorso, è ricordato da Malgieri nel saggio introduttivo, quale insigne rappresentante: «della Controrivoluzione italiana nella seconda metà del Ventesimo secolo» (p. VI). Questo scritto apparve per la prima volta in Italia nel 1967 per le edizione Borla di Alfredo Cattabiani, nella collana diretta da Del Noce e Zolla, ma dopo quasi un sessantennio mantiene il suo straordinario vigore argomentativo e la sua attualità. E’, in qualche modo, la sintesi dei diversi interessi culturali dell’autore. Servier, docente presso le Università di Montpellier e di Aix-en-Provence, fondò con l’antropologo Gilbert Duran, postosi in sequela del mondo ideale e del metodo inaugurato da Marcel Griaule, la: «corrente della socio-etnologia dell’immaginario» (p. VII). A Griaule, Servier riconobbe il merito di aver colto, tra i primi, il valore delle culture che avevano seguito una strada di sviluppo altra da quella utilitarista dei popoli occidentali moderni, una via: «che si dirige verso l’invisibile e non verso la conquista della materia» (p. VII). Questa condivisione di vedute con Griaule, nel pensatore francese era motivata dall’ interesse per la magia e l’esoterismo. Le ampie competenze conseguite in tali ambiti, sono testimoniate dal suo, Dizionario critico dell’esoterismo, pubblicazione profetica che ebbe vasta circolazione nel mondo accademico transalpino.
è Gennaro Malgieri, curatore della nuova edizione dell’opera più nota ed importante dello studioso, L’uomo e l’invisibile, da poco nelle librerie per Iduna Edizioni (per ordini: associazione.iduna@gmail.com, pp. 435, euro 28,00). Il volume è impreziosito da una suggestiva appendice fotografica. La traduzione del libro è di Giovanni Cantoni e ad Agostino Sanfratello, esponenti del cattolicesimo tradizionalista. Cantoni, scomparso nel gennaio scorso, è ricordato da Malgieri nel saggio introduttivo, quale insigne rappresentante: «della Controrivoluzione italiana nella seconda metà del Ventesimo secolo» (p. VI). Questo scritto apparve per la prima volta in Italia nel 1967 per le edizione Borla di Alfredo Cattabiani, nella collana diretta da Del Noce e Zolla, ma dopo quasi un sessantennio mantiene il suo straordinario vigore argomentativo e la sua attualità. E’, in qualche modo, la sintesi dei diversi interessi culturali dell’autore. Servier, docente presso le Università di Montpellier e di Aix-en-Provence, fondò con l’antropologo Gilbert Duran, postosi in sequela del mondo ideale e del metodo inaugurato da Marcel Griaule, la: «corrente della socio-etnologia dell’immaginario» (p. VII). A Griaule, Servier riconobbe il merito di aver colto, tra i primi, il valore delle culture che avevano seguito una strada di sviluppo altra da quella utilitarista dei popoli occidentali moderni, una via: «che si dirige verso l’invisibile e non verso la conquista della materia» (p. VII). Questa condivisione di vedute con Griaule, nel pensatore francese era motivata dall’ interesse per la magia e l’esoterismo. Le ampie competenze conseguite in tali ambiti, sono testimoniate dal suo, Dizionario critico dell’esoterismo, pubblicazione profetica che ebbe vasta circolazione nel mondo accademico transalpino.
Lo studioso, inoltre, nelle pagine di Storia dell’Utopia, perseguì la destrutturazione delle false certezze dell’utopismo, muovendo da Platone e giungendo al pensiero contemporaneo. Tutto il suo impegno, lo rileva Malgieri, fu motivato dalla certezza che: «cultura, questo patrimonio ereditato, comporta non soltanto delle conoscenze, un ideale sociale […] ma una ragione per vivere. Difendere la cultura è difendere la nostra civiltà» (p. VII-VII). In Servier, tale intransigente difesa, lo si evince dalla Introduzione al volume, era diretta a sfatare gli errori e le devianze che animano la vita dei nostri contemporanei, in particolare le idee di progresso e di evoluzione della specie. Con forza egli sostiene: «Osservazioni recenti, studi condotti in tutti i campi, rimettono in questione l’evoluzionismo e la nozione di progresso […] una menzogna che rigetta senza fine nell’avvenire la soluzione dei nostri problemi e della nostra angoscia» (p. 7). Ai suoi occhi la scienza ufficiale andava ridotta, alla metà del secolo scorso, mentre tutti ne tessevano le lodi incondizionate, ad un insieme di ipotesi non definitivamente corroborate, fondate, il più delle volte, su atti di fede. Soleva ripetere: «Darwin ha parlato degli “occhiali affumicati del teologo” […] ma quali occhiali di tenebra stanno sul naso degli evoluzionisti» (p. 9).
La civiltà doveva essere difesa dalle confusioni moderne, attraverso il riconoscimento delle differenze culturali di uomini e popoli. Ciò implicava, tra le altre cose, l’accettazione della percezione dell’inconoscibile da parte di quanti lo avvertono in modalità diversa da quella propria dell’uomo civilizzato. Contrapposte alla «civilizzazione» moderna e quantitativa, stanno le civiltà tradizionali: «In esse il termine “spirituale” […] occupa il suo posto vero di causa efficiente, di motivazione sempre presente nella condotta umana» (p. I). I popoli legati alla Tradizione, a causa della pervasività spirituale esercitata nei loro confronti dalla civilizzazione moderna, vengono considerati dal senso comune dei reietti e la loro visione del mondo rigettata. In cosa di fatto consiste il riferimento primario delle civiltà tradizionali? Servier, al riguardo, fornisce una risposta inequivocabile: l’invisibile. Egli attribuiva a tale termine il valore di ciò che all’uomo: «si impone naturalmente e […] rientra nelle sue ordinarie, elementari, prioritarie conoscenze» (p. VIII). A dire di Servier, e su questo non lo seguiamo, l’invisibile sarebbe altro dal sacro, in quanto quest’ultimo potrebbe essere costruito dall’uomo. In ogni caso la dimensione invisibile costituirebbe la vera «patria» degli umani. Vero, certo, ma alla sola condizione che l’invisibile sia pensato come inverato nel visibile e non, come radicalmente altro da esso.
Per tale ragione, e Servier ne ha piena contezza, l’invisibile non può avere: «l’indeterminatezza di un concetto metafisico, è una realtà» (p. IX). In tale contesto ideale, il culto dei morti non si riduce a semplice rammemorazione del trapassato, ma rappresenta la forma più verace del ricongiungimento con la realtà intelligibile. Insomma, Servier come Bachofen è fermamente convito che la casa in cui l’uomo «abita poeticamente» il mondo, non sia rappresentata dalla sua abituale residenza, ma dal sepolcro. L’invisibile come realtà che «si mostra in evidenza» é ben testimoniata nel capitolo, I cavalli degli angeli. Nelle sue pagine il pensatore, dopo aver condotto per mano il lettore nella decifrazione di culti e riti di popolazioni di ogni latitudine, si confronta con lo sciamanesimo dei popoli dell’estremo Nord. Le durissime pratiche iniziatiche cui il potenziale sciamano si sottopone, sono le medesime vissute dai mistici di altre tradizioni. In esse, il prescelto supera la paura, l’ostilità ambientale e: «cerca l’invisibile di là dalla fame e dal freddo» (p. 154). Lo sperimenta e lo incarna, rispettando un certo numero di proibizioni esistenziali. Lo sciamano, quindi: «sa di essere come una coppa che talvolta lo spirito di Dio riempie, rendendolo capace allora di intercedere per il gruppo umano di cui è responsabile» (p. 157). In questa affermazione emerge il meglio del libro: la necessità dell’uomo d’oggi di recuperare il rapporto con l’invisibile, ma anche il limite dell’approccio mistico-passivo al sacro che ha caratterizzato l’autore di queste pagine.
Giovanni Sessa


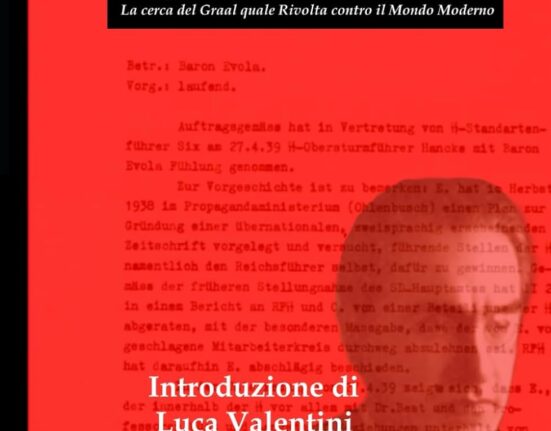
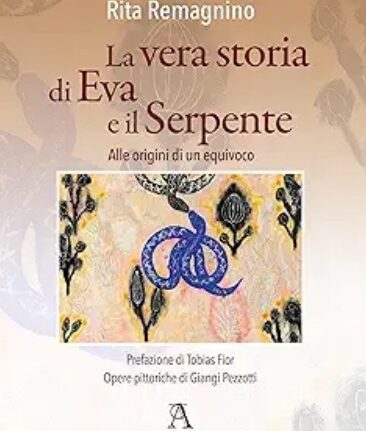

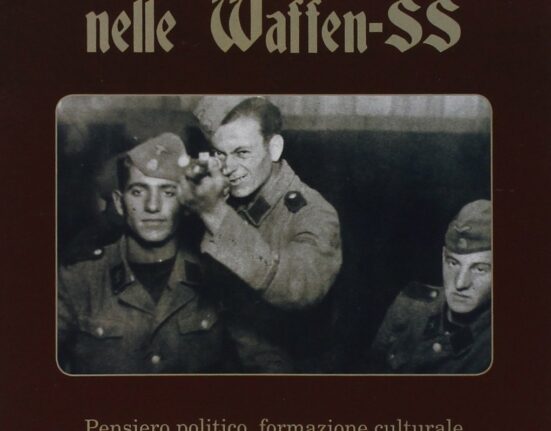
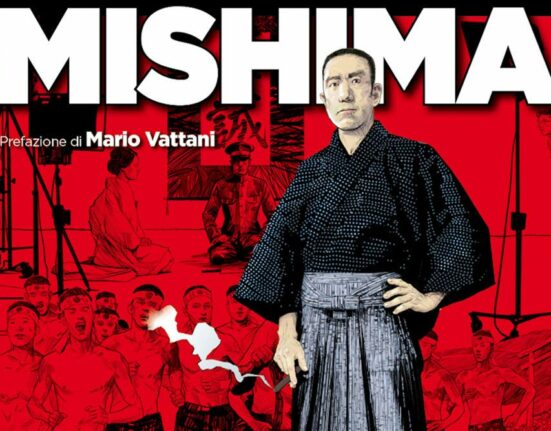

1 Comment