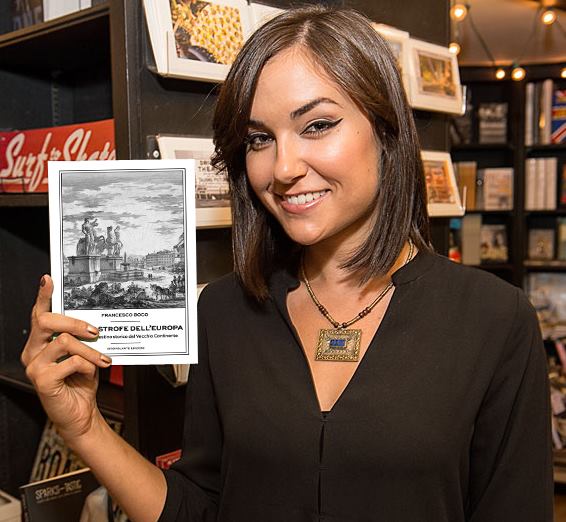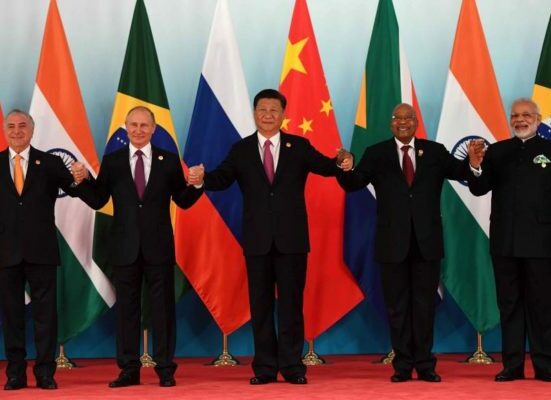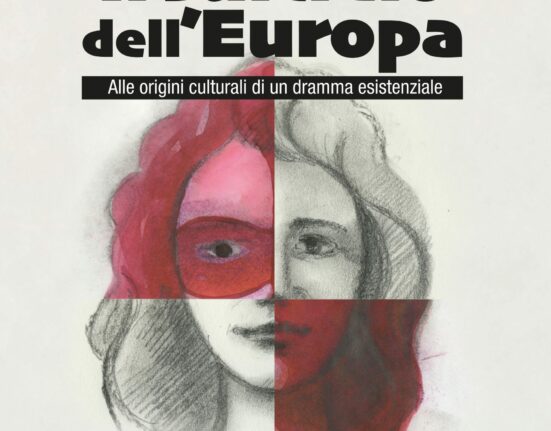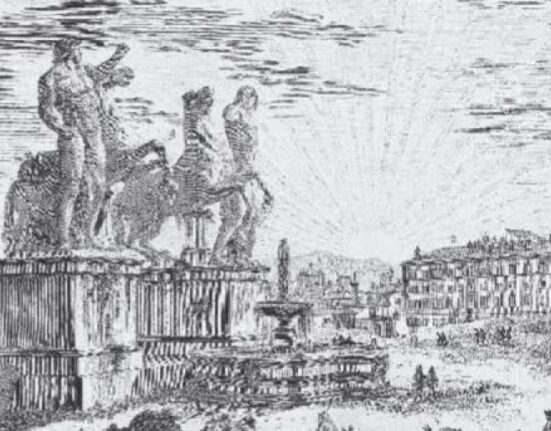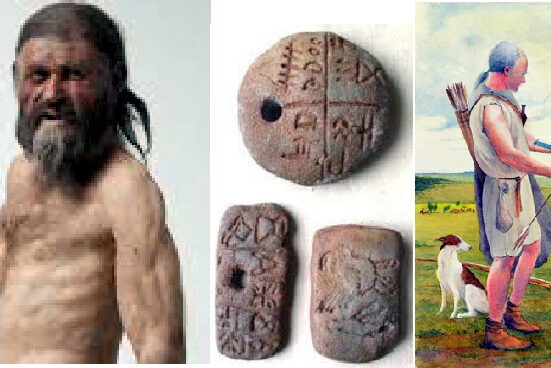Il nuovo libro di Francesco Boco, La catastrofe dell’Europa. Saggio sul destino storico del Vecchio Continente (Idrovolante edizioni, 20€, con postfazione di Stefano Vaj, disponibile in tutti i principali shop online), è un lavoro di filosofia della storia che comprende ampi elementi di ontologia e filosofia politica. Come si capisce fin dal titolo, l’autore ha voluto problematizzare il destino della civiltà europea, tentando però un passo ad oggi non ancora compiuto, quello cioè di dare forma a un sistema filosofico coerente e compatto, che tenga assieme autori e concetti noti ma raramente uniti in una struttura concettuale d’insieme. L’avvio del lungo saggio, che può essere considerato diviso in due parti, una preparatoria e una parte propositiva, chiarisce quali saranno i termini della trattazione. Prendendo in esame autori come Spengler, Evola, Blaga, Hegel e Huntington, Boco definisce in primo luogo cosa si debba intendere con il termine civiltà. Con evidente richiamo alla filosofia di Martin Heidegger egli la considera la più vasta espressione storica dell’esserci di un popolo. L’essere, inteso qui come potenza trascendente che comunica attraverso il mito e il simbolo, si fa dunque storia agendo tramite gli uomini. E l’uomo, quando agisce all’interno di una collettività o comunità, opera sempre in senso politico. Ecco quindi che il formarsi di una civiltà significa il prendere forma di un vasto insieme di uomini, il loro darsi una definizione all’interno del mondo.
Le civiltà decadono, ma l’approccio dell’autore a questo tema ormai noto non è di semplice ripetizione di schemi già efficacemente delineati da altri, quanto piuttosto di dare una visione del disfacimento delle civiltà alla luce della concezione della storia dello storico francese Braudel e dello storico identitario Venner. Il riferimento è quindi alla storia intesa come lunga durata, una temporalità non più considerata semplicemente lineare o cicilica, in ultimo segmentaria e in sé conclusa, ma come un continuum all’interno del quale, per dirla con Toynbee, si fanno largo delle sfide epocali. Boco infatti tenta di ridefinire la comprensione della crisi della civiltà (nello specifico quella europea) approfondendo lo sguardo in quelli che sono gli aspetti antropologici e culturali, e giungendo così alla conclusione che con decadenza si debba considerare un periodo più o meno lungo ma non necessariamente irreversibile e che va sempre riconsiderato in prospettiva della storia passata e anche, soprattutto, di un progetto futuro. Qui si incardina la critica mossa dall’autore a quello che considera il vero peso gravante sulle spalle della civiltà europea. L’Europa non riesce ad essere se stessa e non trova gli assi attorno a cui coagulare la sua forza perché si lascia distrarre e allontanare dal suo Essere autentico dalla visione del mondo occidentalista. Con la sconfitta bellica del 1945 è avvenuta una vittoria sul piano culturale che ha imposto una concezione economicistica, anti-conflittuale, individualista e cosmopolitica che si esprime in filosofia ad esempio negli scritti del filosofo tedesco Habermas o in certe teorie di fine della storia fatte proprie da Kojeve, Bataille e in ultimo Francis Fukuyama.
Contro questa visione che punterebbe ad esaurire il destino storico mondiale, ma in verità solo quello europeo, nell’indistinto dell’a-storico, Boco dà avvio alla sezione del testo più interessante e propositiva. Citando Nietzsche, Heidegger, Vico, Machiavelli e soprattutto Giorgio Locchi, l’autore rinsalda i legami con un pensiero filosofico vivido e ancora da esplorare appieno. La concezione del tempo è fondamentale per l’autocomprensione di un popolo, di una civiltà, ed è qui che s’inserisce la necessità di comprendere il tempo come una sfera, cioè nella sua tridimensionalità. È in questa ottica che, seguendo Heidegger e Locchi, per l’autore diventa possibile rispondere attivamente alla chiamata dell’Essere dando piena realizzazione storica al destino della propria civiltà.
La tradizione e la memoria culturale svolgono allora un ruolo centrale perché sono espressione di un qualcosa di più profondo che può sempre essere riattivato per rimettere in moto la storia. Se la storia è aperta, è cioè lo spazio del possibile, essa risponde a una legge profonda che è quella del divenire, della differenza e, in ultimo, quella del conflitto eracliteo, che sembra aprire e chiudere tutto il libro.
Attraverso una efficace trattazione che affronta problematiche antropologiche, ecologiche, estetiche si arriva dunque alla parte finale dell’opera in cui l’autore prende in considerazione le prospettive storiche future. La più interessante è quella che qui viene chiamata Imperativo interstellare, alludendo ai progetti in corso di espansione della civiltà su altri pianeti. Quello che sarà della civiltà europea, della sua storia, della sua cultura e dei suoi popoli, dipenderà da decisioni epocali non più rinviabili. La sfida è aperta.
Mario Tondelli