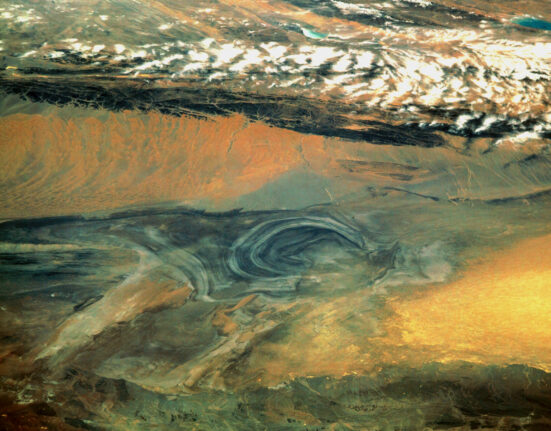Periodicamente si torna a discutere di «destra». La grande assente, qualcuno dice, dallo scenario politico contemporaneo. In Italia, essa sembra essersi inabissata, non si sa bene in quali profondità marine, dopo il disonorevole liquefarsi dell’astro berlusconiano (che non ha mai brillato di luce propria), e dei suoi satelliti «Fare Futuristi». Va rilevato, per inciso, che assieme alla «destra» è svanita nei meandri della società liquida, quella che un tempo è stata la «sinistra». Ragionare della rinascita dell’una e/o dell’altra ci pare, nell’orizzonte politico segnato dalla crisi indiscutibile della democrazia liberale, a cui va addebitata la nascita della dicotomia destra-sinistra, niente più che parlare del nulla. Infatti, come rilevato da molti analisti, tra essi Alain de Benoist, lo spartiacque politico nella realtà contemporanea è quello che divide inclusi ed esclusi, non solo in termini economici, dal sistema liberal-capitalista. Tale divisione è trascritta perfettamente, in tutto il mondo occidentale, dai risultati elettorali: da essi si evince che i primi trovano rappresentanza negli schieramenti di sistema, mentre gli esclusi, sempre più numerosi, trovano accoglienza in movimenti populisti.
Ciò può piacere o non piacere, ma è un dato di fatto. Crediamo non piaccia a Filippo Rossi, collaboratore de Il fatto quotidiano e già caporedattore de L’Italia settimanale.  Traiamo tale convinzione dalla lettura della sua ultima fatica letteraria, Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra, di recente apparso nel catalogo delle edizioni Marsilio (pp. 190, euro 12,00). Libro indubbiamente interessante, per di più ben scritto. L’autore presenta in modo coinvolgente una serie di argomentazioni atte a costruire una «buona destra», totalmente altra nel tratto esistenziale, oltre che sotto il profilo culturale e politico, dalla «destra del cattiverio» (la definizione è di Pierluigi Battista) presente su piazza, rappresentata da Lega e Fratelli d’Italia, nonché dai loro leader. Sappia il lettore che condividiamo molte delle analisi di Rossi, ma non i due assunti di fondo che le sostengono: vale a dire il guardare al modello della democrazia liberale (sia pur riformata) e il voler far piazza pulita di ciò che esiste a «destra».
Traiamo tale convinzione dalla lettura della sua ultima fatica letteraria, Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra, di recente apparso nel catalogo delle edizioni Marsilio (pp. 190, euro 12,00). Libro indubbiamente interessante, per di più ben scritto. L’autore presenta in modo coinvolgente una serie di argomentazioni atte a costruire una «buona destra», totalmente altra nel tratto esistenziale, oltre che sotto il profilo culturale e politico, dalla «destra del cattiverio» (la definizione è di Pierluigi Battista) presente su piazza, rappresentata da Lega e Fratelli d’Italia, nonché dai loro leader. Sappia il lettore che condividiamo molte delle analisi di Rossi, ma non i due assunti di fondo che le sostengono: vale a dire il guardare al modello della democrazia liberale (sia pur riformata) e il voler far piazza pulita di ciò che esiste a «destra».
Non si può non condividere l’idea che una forza politica che voglia svolgere una funzione di direzione pubblica, non possa limitarsi, sic et simpliciter, a contestare il progetto degli avversari, ma debba elaborare una sua autonoma e ben individuabile progettualità, che le consenta di governare, non semplicemente di gestire, la complessità della società moderna. Non basta dire no, contrapporsi in modo rancoroso a scelte che non si condividono (dall’immigrazione, alla famiglia, ai diritti), in nome della paura suscitata dall’insecuritas indotta dal fallimento del progetto illuminista. L’odio non è stato mai in grado di armonizzare alcun corpo sociale, mentre il politico accorto dovrebbe, con sagacia, esercitare l’opera demiurgica di tessitura delle differenze nella comunità in cui opera, stante la lezione di Platone. «Destra», infatti, dovrebbe innanzitutto significare difesa dell’élite spirituale. Essere elitari, ricorda Rossi con Goethe: «significa essere rispettosi: rispettosi del divino, della natura, degli altri esseri umani» (p. 27). Quindi, non bisognerebbe, a «destra», mai dimenticare, la vocazione aristocratica, come insegnò Evola, neppure di fronte al fallimento delle classi dirigenti politiche degli ultimi decenni. La pulsione rabbiosa non basta, ne conveniamo, essa va metabolizzata, «cavalcata» come la tigre evoliana.
L’élite, ricorda Rossi, deve essere «gentile», vale a dire animata da nobiltà, deve porsi al servizio della comunità: avvezza alle buone maniere, deve incarnare le virtù, e tra esse, l’onestà. Infatti: «La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile» (p. 44), come scrisse Corrado Alvaro. Oggi viviamo in una simile degradata condizione. E’ necessario recuperare alla politica la capacità di volare alto, perché quando essa: «costruisce il futuro, ha sempre qualcosa di sacro. Si chiama civiltà. Si chiama tradizione» (p. 57). Il politico di vaglia deve liberarsi di ciò che Marc Augé ha definito «il dominio» del presente, per tornare a pensare in grande, quale «architetto» della cosa pubblica. In tale azione, il primato deve essere accordato alla tutela della natura e alla produzione della bellezza: «Se destra significa patriottismo, tradizione, identità nazionale, la destra italiana dovrebbe avere come obiettivo principe quello di proteggere la grande bellezza italiana» (p.75). Nel 1309, negli Statuti di Siena la bellezza veniva esperita come momento imprescindibile del bene comune. Pertanto, bisogna aver contezza che la polis non è un dato, qualcosa di acquisito una volta per tutte, ma la si costruisce ogni giorno. Grande politica è porre in forma il mondo.
In questo senso non basta, oggi, affermare il rifiuto dell’Europa dei mercanti, bisogna tornare a pensare l’Impero federato d’Europa come nuovo motore propulsore della storia, riponendo al centro delle istanze politiche il tema della decisione quale atto eroico e creativo. Per far ciò, bisogna andare oltre, lasciarsi alle spalle le gabbie dogmatico-ideologiche ed ascoltare il ritmo pulsante della vita. Esso è centrato sulle disuguaglianze, che vanno declinate, non in termini meramente negativi, ma positivamente. Sostanzialmente, la proposta di Rossi mira a creare una democrazia aristocratica: «una democrazia liberale in grado di formare e scegliere i migliori attraverso un fondamentale mix tra buona scuola e buone regole» (p. 35). Il problema sta tutto qui! La democrazia liberale, da tempo, si è andata trasformando in governance, in regime che espropria la sovranità popolare in nome dell’expertise tecnocratica e delle oligarchie finanziarie trans-nazionali. Il filosofo Andrea Emo lo aveva compreso fin dagli dell’immediato secondo dopoguerra, e definì «epidemica», in senso etimologico greco, la democrazia liberale: le sue classi dirigenti si «pongono sopra» il popolo, limitandone gli spazi di partecipazione politica attiva ed espropiandone la sovranità.
I populismi, sono, in termini politici, come ricordava recentemente Veneziani, una mera pulsione, ma una pulsione legittima, l’unica forma di espressione politica dei popoli. Pertanto, non ci si può sbarazzare di essa, è necessario rettificarla, far si che la pulsione si trasformi in visione. Questo il compita che spetta all’élite culturale. La democrazia liberale, sia pure emendata in senso aristocratico, resta tale, liberale. Disconosce ogni forma di limes. Al contrario, il confine dà contezza della propria identità e consente di comprendere quella altrui. De Benoist lo scrisse anni fa, la reale alternativa alla democrazia liberale va individuata nella democrazia organica. In essa ogni popolo partecipa al proprio destino, guardando alla Tradizione come meta possibile e non semplicemente come passato irrecuperabile.
Giovanni Sessa