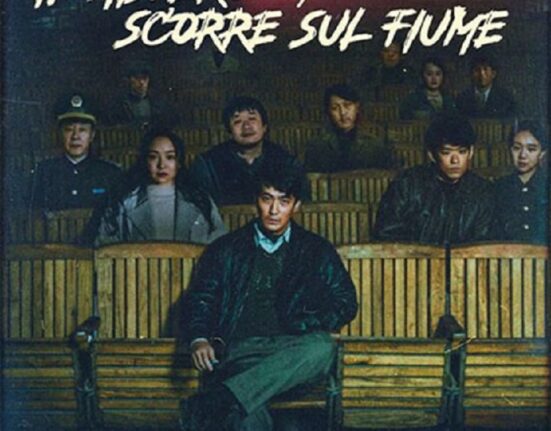“Non riesco mai a lavorare bene con ciò che è mediocre,
non mi trovo mai a mio agio nell’ordinario, nel quotidiano.
Alfred Hitchcock
Dobbiamo ritornare nel passato“.
Scottie Ferguson
(James Stewart)
Vi sono coincidenze surreali tra il film di Alfred Hitchcock Vertigo-La donna che visse due volte, e alcuni episodi di vita di chi scrive. La vertigine menzionata in latino nel titoloè in primo luogo l’acrofobia di John “Scottie” Ferguson (James Stewart): non so perché, fin da bambino ne soffro anch’io. Il film uscì nel 1958: le cifre di questo anno sommate danno 23, il mio giorno di nascita.
 Quando vidi Vertigo la prima volta,da bambino, il numero civico del “mio” condominio era il 26: gli anni di Madeleine Elster (Kim Novak), e della sua antenata ispanica Carlotta Valdès quando si suicidò cento anni prima. I due protagonisti si conoscono quando Madeleine tenta di annegare(come Carlotta) lasciandosi cadere nella baia di San Francisco e, salvata da Scottie, gli racconta che anche da bambina era caduta in mare, scivolando da una barca. Cominciata l’università, strinsi amicizia con una ragazza dell’Alessandrino somigliante a Kim Novak–aveva anchela K nel nome– ma con gli occhi scuri e un mare di capelli ricci nerissimi,come un’altra donna che visse due volte: lady Ligeia di Edgar Allan Poe. Era bellissima, semplice e simpatica, ma anche sfuggente come Madeleine, il passo lento e leggero, le improvvise stanchezze,le mani pallide e gelide da revenante («mano fredda, cuore caldo!», mi rispondeva con la sua R francese e un’enfasi scherzosa),e a volte mancava alle lezioni in modo del tutto imprevedibile. Nell’ultimo mese dell’anno accademico non la vidi più: sembrava svanita nel nulla, e io ne soffrii non poco. Una mattina, dopo tre giorni di assenza imprevedibile, raccontò che, pur essendo in salute, il suo ragazzo (che voleva accompagnarla a prendere il treno per Torino)l’aveva trovata svenuta da mezz’ora sul pavimento del bagno – anche lei caduta in un luogo “acquatico” -e aggiunse: «Quando ero piccola mi era successa la stessa cosa».
Quando vidi Vertigo la prima volta,da bambino, il numero civico del “mio” condominio era il 26: gli anni di Madeleine Elster (Kim Novak), e della sua antenata ispanica Carlotta Valdès quando si suicidò cento anni prima. I due protagonisti si conoscono quando Madeleine tenta di annegare(come Carlotta) lasciandosi cadere nella baia di San Francisco e, salvata da Scottie, gli racconta che anche da bambina era caduta in mare, scivolando da una barca. Cominciata l’università, strinsi amicizia con una ragazza dell’Alessandrino somigliante a Kim Novak–aveva anchela K nel nome– ma con gli occhi scuri e un mare di capelli ricci nerissimi,come un’altra donna che visse due volte: lady Ligeia di Edgar Allan Poe. Era bellissima, semplice e simpatica, ma anche sfuggente come Madeleine, il passo lento e leggero, le improvvise stanchezze,le mani pallide e gelide da revenante («mano fredda, cuore caldo!», mi rispondeva con la sua R francese e un’enfasi scherzosa),e a volte mancava alle lezioni in modo del tutto imprevedibile. Nell’ultimo mese dell’anno accademico non la vidi più: sembrava svanita nel nulla, e io ne soffrii non poco. Una mattina, dopo tre giorni di assenza imprevedibile, raccontò che, pur essendo in salute, il suo ragazzo (che voleva accompagnarla a prendere il treno per Torino)l’aveva trovata svenuta da mezz’ora sul pavimento del bagno – anche lei caduta in un luogo “acquatico” -e aggiunse: «Quando ero piccola mi era successa la stessa cosa».
Vertigo è un film che consente diverse interpretazioni: psicoanalitiche, filosofiche, persino femministe, nonostante si dicesse che Hitchcockf osse un misogino. Il marito di Madeleine incarica Scottie di pedinare sua moglie, che soffre d’improvvise assenze mentali e crisi depressive, vaga per la città come una sonnambula di giorno e forse potrebbe suicidarsi. Scottie deve guardare quindi in avanti, verso il futuro eventuale di un’altra persona; Madeleine invece guarda all’indietro, verso il proprio passato, si crede Carlotta Valdès reincarnata. Correlativo oggettivo del passato è il museo d’arte di San Francisco – in realtà si tratta del Palazzo della Legion d’Onore –dove Madeleine siede in contemplazione del grande e inquietante ritratto di Carlotta, con un bouquet di fiori simile a quello tra le mani dell’antenata, e sente di dover riviverne il destino tragico. Il quadro, opera di John Millard Ferren (1905-1970),statunitense espressionista-astrattista(i suoi dipinti ricordano i Joan Mirò e i Nicola De Maria), ebbe un destino anch’esso inquietante: dopo essere stato rimosso dal Palazzo della Legion d’Onore, scomparve fino a oggi. Così anche Scottie si ritrova ad andare all’indietro, verso il passato: il movimento diventa curvo, centripeto, si avvolge su se stesso come i capelli a chignon di Carlotta e di Madeleine, come un labirinto o un vortice (elemento che Hitchcock replicherà in Psycho, con l’acqua insanguinata nello scarico della doccia)che cattura l’investigatore e lo spettatore. L’atmosfera surreale e straniante prevale sulla vicenda giallo-poliziesca: soltanto nel secondo tempo, dopo la caduta mortale di Madeleine dal campanile del convento di San Juan Batista, si scopre che tutto ciò nasconde un inganno e un omicidio. Gli ambienti principali dell’azione (il museo, il cimitero, il ponte, il mare, il bosco di sequoie, il convento) sono realtà molto più antiche della contea di San Francisco e della scoperta dell’America; sono luoghi simbolici molto più significativi dei saloon western,dei casinò e dei grattacieli, rimandano a tempi lunghissimi e a dimensioni ultraterrene: il Golden Gate Bridge diventa allusione al trapasso, come le guglie o i vascelli all’orizzonte nei dipinti di Caspar David Friedrich, e l’altra riva (la collinosa Contea di Marin) metafora dell’aldilà. Ugualmente, gli elementi che – grazie anche agli zoom calibrati della telecamera -focalizzano e inquietano l’attenzione (il ritratto, lo chignon, i fiori, il medaglione d’oro con incastonato un rubino, indossato da Carlotta ed ereditato da Madeleine) hanno significati antichi, profondi e indipendenti dalla“civiltà” tecnologico-consumistica nata negli USA. Sono eredità significanti, concentrati di verità umane: l’eros, la bellezza, l’amore, la paura,la morte, l’aldilà, il tempo, la memoria.«In La donna che visse due volte c’è il ritorno del passato che assale il nostro presente e minaccia il nostro futuro» (1), perché smaschera il presente come mistificazione della realtà, come contesto insufficiente allo spirito umano.
La coppia protagonista è «romantica» nel senso autentico del romanticismo, e non in quello ironico, irridente, e in definitiva scettico che gran parte della nostra società superficiale gli ha affibbiato. Scottie è «un uomo emotivo» (2)- aggettivo che oggi è talvolta sinonimo,sottinteso e presuntuoso, di «ipersensibile patologico»– turbato dalla donna affascinante: «Non è un caso il fatto che la sensazione di vertigine si presenti sempre in presenza [della] donna» (3). Altrochè i fischianti da gradino del bar, gli stupratori e i «femminicidi». Madeleine è dolente e melanconica, ma non lacrimosa; sembra quasi in contatto con l’aldilà, ma allo stesso tempo soffre l’acuta nostalgia di una vita perduta :la sua, perché lei “è” Carlotta. Distante dall’ordinario, talvolta posseduta da tristi fantasie o da arcane reminiscenze, Madeleine ci fa ammettere l’insufficienza estetica e sentimentale di alcuni modelli di «donna moderna» e di chi vi si conforma. C’è da chiedersi se il suo nome sia stato scelto a caso da Pierre Boileau e Thomas Narcejac, autori del romanzo D’entre les morts (in italiano, La donna che visse due volte)al quale Hitchcock s’ispirò per il film: una madeleine famosa nella letteratura francese è quella della Strada di Swann di Marcel Proust (4), che non è una donna, è un pasticcino, ma è anch’essa al centro di un ritorno nel passato, quello che scatta nella memoria del Narratore quando la assaggia bagnata nel tè. D’entre les mortssi svolge in Francia negli anni 1940-44, equi Madeleine (l’unico personaggio il cui nome non cambia nel film) è bruna di capelli; il ritratto della sua bisnonna (che qui è Pauline Lagerlac) è un quadro più piccolo, sulla mensola del camino in casa sua; l’età di entrambe è 25 anni e non 26; il gioiello ereditato non è un collier d’oro ma una collana d’ambra. Il tailleur grigio indossato da Madeleine non fu «scelto apposta per il suo colore spento, in netto contrasto con la capigliatura biondissima», dalla «leggendaria costumista» (5) Edith Head: anche nel romanzo lei è vestita- e poi ri-vestita dopo la “morte”, quando si rivela Renée Sourange – soprattutto così.
ma non lacrimosa; sembra quasi in contatto con l’aldilà, ma allo stesso tempo soffre l’acuta nostalgia di una vita perduta :la sua, perché lei “è” Carlotta. Distante dall’ordinario, talvolta posseduta da tristi fantasie o da arcane reminiscenze, Madeleine ci fa ammettere l’insufficienza estetica e sentimentale di alcuni modelli di «donna moderna» e di chi vi si conforma. C’è da chiedersi se il suo nome sia stato scelto a caso da Pierre Boileau e Thomas Narcejac, autori del romanzo D’entre les morts (in italiano, La donna che visse due volte)al quale Hitchcock s’ispirò per il film: una madeleine famosa nella letteratura francese è quella della Strada di Swann di Marcel Proust (4), che non è una donna, è un pasticcino, ma è anch’essa al centro di un ritorno nel passato, quello che scatta nella memoria del Narratore quando la assaggia bagnata nel tè. D’entre les mortssi svolge in Francia negli anni 1940-44, equi Madeleine (l’unico personaggio il cui nome non cambia nel film) è bruna di capelli; il ritratto della sua bisnonna (che qui è Pauline Lagerlac) è un quadro più piccolo, sulla mensola del camino in casa sua; l’età di entrambe è 25 anni e non 26; il gioiello ereditato non è un collier d’oro ma una collana d’ambra. Il tailleur grigio indossato da Madeleine non fu «scelto apposta per il suo colore spento, in netto contrasto con la capigliatura biondissima», dalla «leggendaria costumista» (5) Edith Head: anche nel romanzo lei è vestita- e poi ri-vestita dopo la “morte”, quando si rivela Renée Sourange – soprattutto così.
Se la visita al ritratto e alla tomba di Carlotta rappresentano la ricerca solitaria del passato individuale, la successiva passeggiata nel Parco delle Sequoie (il Big Basin Redwoods State Park, in California) simboleggia la ricerca condivisa del passato collettivo. Le sequoie hanno il fusto rossiccio: il colore del tè in cui “entra” la madeleine di Proust; sono gigantesche, sempreverdi ed estremamente longeve (vivono anche quattromila anni). Nel bosco millenario, la coppia sembra farsi minuscola, come nei dipinti di Friedrich, edè come se risalisse indietro nel tempo fino a entrare in un ambiente oltremondano, sacro, dove il tempo è sospeso:«La Natura è un tempio di vive colonne» (6). Madeleine si sofferma sul “calendario” dei cerchî interni di un esemplare antico oltre mille anni:«Qui io sono nata… e qui sono morta. Fu soltanto un momento, per te… neanche lo notasti», mormora all’albero, mentre il suo dito guantato sfiora un cerchio della metà dell’Ottocento. Malattia mentale (forse), ma anche sentimento della brevitate vitae espresso come in una poesia di Francisco De Quevedo odi Emily Dickinson. Scottie tenta di allontanarla dalla sua ossessione, le chiede perché abbia tentato di affogarsi, ma lei si retrae, è assalita dall’angoscia. Tutto ciò somiglia a una seduta psicoanalitica nella natura anziché nello studio dello specialista, a un ritorno al tempo dilatato dell’infanzia, a una ricerca delle cause delle angosce umane ancestrali. Un olio su tela di Edvard Munch (che conosceva bene l’angoscia), La voce (1893), presenta una donna vestita di bianco e con i capelli raccolti, sola e pensosa, in un bosco di altissimi pini al tramonto del Sole; ricorda abbastanza la scena di Madeleine nel Parco e potrebbe esserne stato un modello. Dipinto e film ci ricordano che il pathos, la memoria e il pensiero sul ruolo dell’Uomo nel cosmo necessitano di ambienti ben diversi dai «non-luoghi» (7) di plastica e metallizzati della postmodernità.
Perciò l’interpretazione “necrofila” di Vertigo, basata quasi esclusivamente su una dichiarazione dello stesso Hitchcock – «Quest’uomo vuole andare a letto con una morta, si tratta di necrofilia»(8) -è parziale e sbrigativa. È vero che il «maestro del brivido» introduce va nei suoi film elementi sulle deviazioni psicologiche e sessuali, ma ciò non consente di liquidare l’intero film come «un film sul sesso distorto», «morboso», «che corre il rischio di esibire un eroe necrofilo, un’eroina perversa, un regista guardone» e addirittura «una trama che non ha né capo né coda». (9) Quest’ultimo giudizio è puramente da Bastian Contrario: non sfugge a nessunoil fatto che la vicenda sia volutamente costruita sulla duplicità, sulla ripetizione, sul ritorno: due volte Scottie in preda alle vertigini di fronte a qualcuno che cade nel vuoto (prima il collega poliziotto dal terrazzo, poi Madeleine dal campanile), due volte il dipinto (il ritratto di Carlotta e l’autoritratto di Midge Wood, la fidanzata «troppo materna» (10) di Scottie, nei panni di Carlotta), due volte lo chignon e il bouquet di fiori di Carlotta e di Madeleine, i 26 anni di entrambe, due volte la caduta dal campanile (prima Madeleine, poi Judy Barton nei panni di Madeleine), due volte il ciondolo prezioso (quello di Madeleine e quello di Judy, che è lo stesso e fa intuire a Scottie l’inganno di cui è vittima: «Non si conservano mai i ricordi di un delitto!»).
va nei suoi film elementi sulle deviazioni psicologiche e sessuali, ma ciò non consente di liquidare l’intero film come «un film sul sesso distorto», «morboso», «che corre il rischio di esibire un eroe necrofilo, un’eroina perversa, un regista guardone» e addirittura «una trama che non ha né capo né coda». (9) Quest’ultimo giudizio è puramente da Bastian Contrario: non sfugge a nessunoil fatto che la vicenda sia volutamente costruita sulla duplicità, sulla ripetizione, sul ritorno: due volte Scottie in preda alle vertigini di fronte a qualcuno che cade nel vuoto (prima il collega poliziotto dal terrazzo, poi Madeleine dal campanile), due volte il dipinto (il ritratto di Carlotta e l’autoritratto di Midge Wood, la fidanzata «troppo materna» (10) di Scottie, nei panni di Carlotta), due volte lo chignon e il bouquet di fiori di Carlotta e di Madeleine, i 26 anni di entrambe, due volte la caduta dal campanile (prima Madeleine, poi Judy Barton nei panni di Madeleine), due volte il ciondolo prezioso (quello di Madeleine e quello di Judy, che è lo stesso e fa intuire a Scottie l’inganno di cui è vittima: «Non si conservano mai i ricordi di un delitto!»).
La donna che visse due volte è quindi sì «una fiaba nera, una cupa filastrocca di paura e di morte» (11), ma anche un film che «non risponde più esattamente alle attese del pubblico» e rammenta verità perenni anche mediante «scelte figurative astratte che rimandano […] alla lezione delle avanguardie espressioniste e surrealiste» (12). Scelte esplicitate nel dissolversi del bouquet di fiori, nei flash colorati e nelle geometrie disorientanti che accompagnano la caduta vertiginosa di Scottie nel suo allucinante incubo notturno, che lo perseguita, non a caso, dopo la scomparsa di Madeleine, la donna dal fascino d’altri tempi e soprattutto d’altre dimensioni, l’unica per la quale si possano affrontare le altezze, le vertigini e il vuoto – cioè i rischi e le proprie paure – perché in leisi scorge qualcosa di metafisico.
Note:
1 – Maurizio Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, Torino 2009, p. 110.
2 – François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, Parma 1977, p. 204.
3 – Laura Righi, La vertigine del doppio. Vertigo tra fantasmi e simboli, appunti dal corso di Laurea specialistica in Cinema, Televisione e Produzione multimediale dell’Università di Bologna,A.A. 2007/2008 (prof. Guglielmo Pescatore),da www.tesionline.it/.
4 – Primo romanzo della Ricerca del tempo perduto.
5 – Dieci cose che non sapevate sulla Donna che visse due volte, da www.film.it/.
6 – Charles Baudelaire, Corrispondenze(nei Fiori del male).
7 – Definizione dell’antropologo Marc Augé.
8 – Truffaut, op. cit., p. 203.
9 – Giorgio Gosetti, Alfred Hitchcock, Milano 1996, pp. 126-127.
10 – Del Ministro, op. cit., pp. 37, 76, 95.
11 – Gosetti, op. cit., p. 127.
12 – Giorgio Simonelli, Invito al cinema di Alfred Hitchcock, Milano 1996, pp. 65-66.
Piervittorio Formichetti