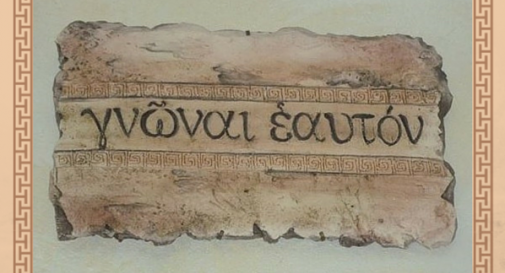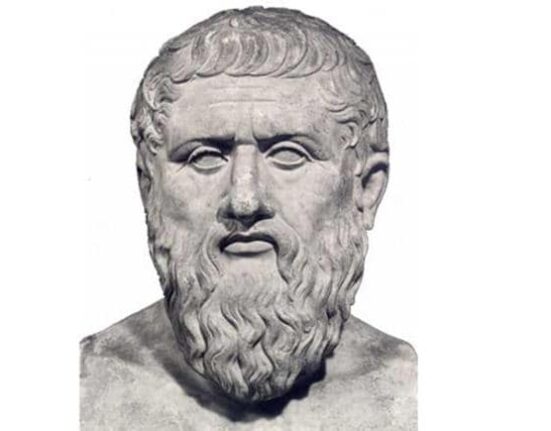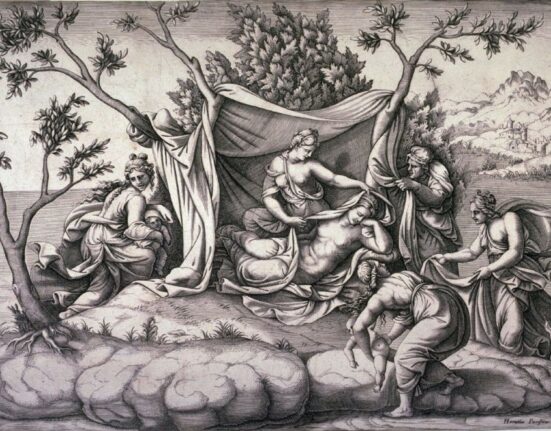Le procedure essenziali dei riti iniziatici, per i quali la morte di un uomo vecchio e la rina- scita di un uomo nuovo sono attuati, e le condizioni di accesso ai penetralia (1), sono simili in tutto il mondo. Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum (cap. XVIII), trattando di questi temi (2), ci ricorda che vi sono risposte corrette alle domande corrette (habent enim propria signa propria responsa), e che la risposta corretta (proprium responsum) è data dall’iniziando (homo moriturus) proprio come la prova del suo diritto d’essere ammesso (ut possit admitti). Un esempio tipico di tale signum e delle risposte errate e corrette può essere citato dalla Jaiminîya Upaniṣad Brāhmaṇa, III.14.1-5. Quando il defunto raggiunge la Porta-del-Sole è posta la do- manda: “Chi sei tu?” (3). Se risponde col proprio nome o con un nome di famiglia (4) è trascinato via dai fattori del tempo. Dovrebbe rispondere: “Chi io sono (è) la Luce (che) tu (sei) (ko’ham asmi suvas tvam). Come tale sono venuto a te, la Luce celeste”. Egli (Prajāpati, il Sole) risponde: “Chi tu sei, quello stesso sono Io; chi Io sono, quello stesso sei tu. Entra”. Di numerosi paralleli che si potrebbero citare, forse il più notevole è il mito di Rūmī dell’uomo che bussò alla porta del suo amico e gli fu chiesto “Chi sei tu?”. Rispose: “Io”. “Vattene”, rispose l’amico. Dopo un anno di separazione e di tribolazione tornò e bussò di nuovo, e alla stessa domanda rispose: “Ecco tu sei alla porta”, al che ricevette la risposta: “Poiché tu sei io, entra, Oh me stesso” (5).
Ora non vi può essere alcun dubbio che l’ingresso al tempio d’Apollo a Delfi fosse letteralmente una Porta del Sole, un passaggio nella casa o tempio del Sole. L’inscrizione sul frontone, “Conosci te stesso” (γνῶθι σεαυτόν) esige una conoscenza della risposta alla domanda: “Chi sei tu?” (6) e si può dire, nel linguaggio velato dei misteri, richiede questa stessa domanda. L’ingiunzione, come dice Plutarco (7), è rivolta dal Dio a tutti coloro che L’avvicinano; e la famosa “E” egli ritiene sia la loro risposta corretta. Se allora, come pure suggerisce, “E” significa EI, e se prendiamo dalle sue varie interpretazioni i significati (1) il Sole (Apollo) e (2) “tu sei”, e supponiamo che entrambi questi significati siano contenuti in quella sillaba enigmatica, abbiamo il signum, “Chi sei tu (alla porta)?” e il responsum, “Il Sole (che) tu sei (sono Io)”. È certo che nessun’altra vera risposta potrebbe essere data da qualcuno “qualificato per entrare in comunione con il Sole” (8) .
Note:
1 – La parte più recondita, segreta e nascosta;
2 – Per Giulio Firmico Materno, nato a Siracusa all’inizio del IV secolo, scrittore romano in lingua latina, vedere G. van der Leeuw, The ΣΥΜΒΟΛΑ in Firmicus Maternus, in Egyptian Religion, I (1933);
3 – In inglese arcaico nell’originale: “Who art thou?”, come pure alcuni dialoghi successivi;
4 – “I nomi sono impedimenti” (Aitareya Āraṇyaka, II.1.6). Dio non ha un nome proprio o di famiglia (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III.8.8), né mai diventa qualcuno (Kaṭha Upaniṣad, II.18), e ne consegue che non vi può essere ritorno a Dio, né deificatio (per la quale, secondo le parole di Cusa, una ablatio omnis alteritatis et diversitatis è indispensabile) per chiunque sia ancora qualcuno. L’iniziato è senza nome, non è se stesso ma Agni (Kauṣītaki Brāhmaṇa, VII.2.3), cfr. Galati, 2,20, “vivo autem jam non ego, sed Christus in me” (vivo, però non più io, ma Cristo in me). Dio è un Mare, “nostra pace: ella è quel mare, al qual tutto si move” (Paradiso, III.85-86) e, come i nomi dei fiumi si perdono nel mare, così sono per- duti i nostri nomi e sembianze quando Lo raggiungiamo (Anguttara-Nikâya, IV.198, Praśna Upaniṣad, VI.5). “Also sich wandelt der tropfe in daz mer” (Così si mutano gocciolando nel mare) (Meister Eckhart, F. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des Vierzehnten Jahrhunderts, Leipzig, G.J. Göschen, 1857, p. 314), cfr.;
5 – Rūmī, Mathnawī, I.3056-3065; cfr. Cantico dei Cantici, 1,8, “Si ignoras te, egredere” (Se non lo sai, o bellissima);
6 – Che l’iscrizione effettivamente ponga questa domanda è esplicito in Senofonte, Memorabilia, IV.2.24, dove Socrate chiede a Eutidemo: “Hai fatto attenzione, e cercato di considerare chi eri?” (ὄστις εἴης);
7 – Moralia, 384D ss. (“La ‘E’ di Delfi”). Similmente in Platone (Carmide, 164D) si suppone che l’ingiunzione “Conosci te stesso” non sia “una raccomandazione”, ma “il saluto di Dio (πρόσρησις) a coloro che entrano”, e che le parole sono pronunciate dal Dio a coloro che stanno entrando nel suo tempio, “diversamente da come gli uomini si esprimono” e “molto enigmaticamente” (αἰνιγματωδέστερον); vale a dire, “non in doctis humanæ sapientiæ verbis, sed in doctrina Spiritus” (non con insegnamenti di sapienza umana, ma con insegnamenti dello Spirito) (I Corinzi, 2,13).
Le parole “Conosci te stesso” sono “enigmatiche”, a quanto pare, solo perché possono essere prese a riferimento della conoscenza di una delle due anime o sé dell’uomo, la fisica e mortale o l’incorporea e immortale, così spesso trattate da Platone e nella filosofia Vedica. In Senofonte, Memorabilia, IV.2.24 (cfr III.9.6), Socrate parla di “auto-conoscenza”, come la conoscenza dei propri poteri e limiti [cfr. Filone d’Alessandria, De specialibus legibus, I,44 e Plutarco, Moralia, 394C]; ma questo in una conversazione con un uomo presuntuoso che pensa già di conoscere da sé “chi” egli sia, di nome “Eutidemo”. Ma in Alcibiade, I.130E ss., Socrate dice che “chi ordina, ‘Conosci te stesso’, ci invita a conoscere l’anima”, e continua a dire che chi conosce solo ciò che è del corpo “conosce le cose che sono sue ma non se stesso” (τὰ αὑτοῦ ἀλλ’ οὐχ αὑτὸν); cfr. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, I.5.15. In parallelo a queste distinzioni si può citato lo scherno di Plutarco verso chi non riesce a distinguere Apollo dal Sole (Moralia, 393D, 400CD), passaggi che richiamano Leggi, 898D, in cui Platone dice che “quel corpo di Helios è visto da tutti, la sua anima da nessuno”, e anche Atharva Veda, X.8.14: “Tutti gli uomini Lo vedono (il Sole), non tutti sanno con la mente”;
8 – Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I.6.1.
∗ A.K. Coomaraswamy, The “E” at Delphi, in Review of Religion, VI (1941), 18-19; ripresa in Cooma- raswamy. 2: Selected papers. Methaphysics, a cura di R. Lypsey, Princeton University Press, Princeton, 1978.
(in collaborazione con la Rivista di Studi Tradizionali Lettera e Spirito)