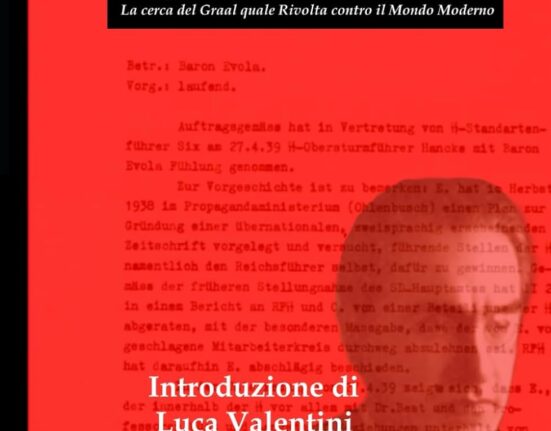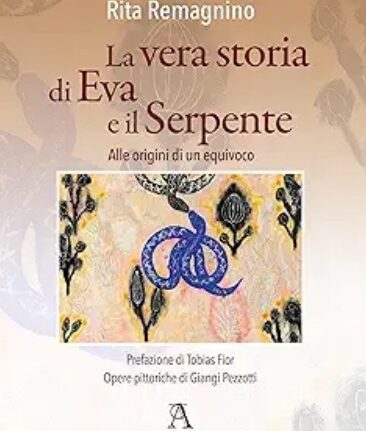Maggio 1949. Ciro Poggiali, giornalista e scrittore italiano, si cimenta in un reportage vecchio stile sul «reggimento civile e il travaglio psicologico di un popolo in guerra», il popolo tedesco.
Maggio 2020. A distanza di settantuno anni, per caso il testo approda sulla mia scrivania. Quella guerra si è conclusa, nel modo che tutti conosciamo – ne è passata di acqua sotto i ponti; quella visione sembra superata, cancellata, spazzata via da un nuovo ordine di cose; quegli uomini sono morti, sepolti insieme ai loro valori.
Ebbene, a che pro leggere o rileggere un’opera siffatta?
Una caratteristica peculiare dei testi editi (o ristampati) dalle Edizioni di Ar è l’intemporalità.
Il volume figura, tra suoi pari, in una collana che da sola potrebbe segnare la cifra dell’intera casa editrice: ‘Gli inattuali’.
Ed è certo profondamente inattuale questo Autore, Ciro Poggiali, che non può nemmeno vantare una pagina Wikipedia a lui dedicata, né un lemma nella Treccani: nessuno, pare, lo ha ritenuto degno di menzione. Eppure, una menzione, questi la meriterebbe ben più di molti personaggi tanto in voga, che, sacrificando preziosi alberi, riempiono risme su risme di cellulosa con le loro inezie.
Corrispondente speciale per il Corriere della Sera, la testimonianza più nota del Poggiali sono i suoi diari dall’Abissinia, in cui annota i fatti di Addis Abeba del ’37.
Per il nazismo non mostra alcuna simpatia e, ad ogni chiosa di capitolo, ricorda al pubblico (e a se stesso) di essere antinazista, con un breve monito moralistico, come impone la migliore tradizione favolistica da Esopo in poi. Non è pertanto da considerarsi, questo, un testo apologetico sul regime nazionalsocialista. Tutt’altro.

Il titolo originale, Il Crepuscolo degli Dei, fornisce già un primo orientamento, quantomeno sulle intenzioni dell’Autore, sul suo orientamento. Il nuovo titolo – K.! La risorgiva di Sparta. Nazismo e società civile in tempo di guerra – è, invece, una scelta delle Edizioni di Ar. Poggiali non menziona mai Sparta, non fa alcun riferimento diretto ai Lacedemoni, né alla Laconia, né al Peloponneso. Le similitudini sono tutte a carico del Lettore, sono palesi seppure non esplicitate: non doveva essere negli intendimenti dell’Autore (rin)tracciar somiglianze e filiazioni…
Diciamo pure che egli si è trovato innanzi qualcosa che non ha neanche dovuto cercare.
La nuova intestazione prende forma – oltre che nell’ermetico preambolo editoriale – man mano che si procede con la lettura, e un lettore ben equipaggiato non avrà bisogno di arrivare a pagina 207 – «Alle donne […] fu rilasciata una tessera di riconoscimento personale con impressa la lettera K (Krieg: guerra)» – per avvedersene, né alla fine dell’opera. Qui è condensata l’essenza della ‘doricità’ germanica, tramite l’appiglio, contingente, alla solidità dell’armamentario fornito ai soldati, alla perfezione dell’abbigliamento militare e della marcia, all’ampiezza dei criteri di reclutamento, alla partecipazione di tutta la popolazione – compresa quella civile, comprese, quindi, anche le donne e i bambini, ciascuno a suo modo – alla Guerra: Pòlemos era “padre di tutte le cose”, già prima di essere ribattezzato Krieg dai Germani.
Poggiali, allora, riesce a parlare di guerra prendendola sempre alla larga, occupandosi per l’appunto della società civile – in tempi belligeranti, scilicet – producendo un’istantanea perfetta della Germania in guerra. O meglio: della Germania e basta, ché la guerra è come ovvia, scontata.
Dato originariamente alle stampe nel 1949 per Edizioni Europee, il testo è quasi contemporaneo agli eventi analizzati, è una straordinaria fotografia dell’epoca, persino nella grafica: la ristampa anastatica, del 2011, ci restituisce il carattere tipografico dell’opera originale, cosicché ne risulti un’immersione completa negli anni Quaranta, godibile a maggior ragione da chi ha il gusto del vetusto. Salta immediatamente all’occhio la differenza nello stile, rispetto al canone odierno. Con l’avvento del nuovo secolo, la lingua, e la scrittura in particolare – anche quella professionale, giornalistica e letteraria – si scarnisce fino alla mortificazione, si sfigura: un giornalista italiano di quei tempi, in fondo neanche così lontani, poteva ancora adoprare una sintassi autenticamente italica, con asindeto e ipotassi, senso della punteggiatura, lessico ampio, per nulla contaminato, invaso, colonizzato selvaggiamente da anglismi per la quasi totalità superflui, inutili, dannosi, che affliggono l’uso contemporaneo.
Un luogo comune impone che, come il vino buono deve decantare per rendere al meglio le proprie qualità organolettiche, così l’evento storico di una certa portata abbisogna di tempo per essere analizzato, assimilato, riconsegnato alla storia, solo dopo che sia intervenuto il necessario distacco emotivo. Paradossalmente, invece, a quel tempo, subito dopo la guerra e la capitolazione tedesca, un cronista poteva permettersi un’analisi lucida e una disamina quanto più possibile oggettiva – seppur non del tutto imparziale, com’è ovvio – di personaggi, regimi, popoli, fatti, pensieri, senza essere demonizzato, e senza che una rappresentazione passasse per una apologia.
Apologia. Di per sé sarebbe una bellissima parola: penso all’apologia per antonomasia, quella di Socrate. Tuttavia, oggi, l'(ab)uso giuridico e (pseudo)politico ne ha determinato un vertiginoso scadimento anche nell’uso corrente. E si badi, la recente equiparazione del comunismo al nazionalsocialismo nel cattivometro della UE non è una vittoria, non è una conquista, non è una consolazione per nessuno: “è una cagata pazzesca!” – per dirla alla Fantozzi.
A Poggiali, nel ’49, è concesso di riferire candidamente su «i negri di una tribù del bacino centrale del Congo» e di tessere le lodi della «razza germanica», senza che nessuno gridi allo scandalo: il politicamente corretto non esisteva ancora.
E pur fortemente critico, è altrettanto lucido sulla questione dell’antigiudaismo – non essendo ancora calata la cappa del tabù sull’argomento – spingendosi fino a confutare la vulgata sulla fabbricazione del sapone, evidentemente già allora in circolazione.
Neanche può definirsi, questo, un libro sul nazismo: piuttosto un libro sulla Germania.
Poggiali doveva conoscerla bene, la Germania, e doveva amarla, è palese; e sembra soffrire nel vederla ridotta in macerie dopo la guerra. Così come, pur animato dallo spirito più oggettivo che gli riesca, stimando grandemente i tedeschi, partecipa, con grande empatia, del loro dolore nell’ora della disfatta.
Il nostro autore è senza ombra di dubbio un abile narratore, e tuttavia, se anche alcuni suoi incipit risultano estremamente letterari e poetici, è pur sempre un cronista, e la sua opera una ricognizione, un racconto, non un romanzo. Egli descrive doviziosamente, con l’occhio dell’osservatore attento e scrupoloso, il carattere dei Germani. Più lo si legge, più ci si addentra in un trattato antropologico del tipo tedesco: gustoso, godibilissimo, specie laddove la scrittura si fa più caustica, quasi derisoria. Dotato inoltre di una buona dose di autoironia, Poggiali riesce a guardare se stesso – l’Italia – con gli occhi dei tedeschi: ne risulta uno spaccato perfetto ed azzeccatissimo del divario culturale tra i due tipi antropologici, l’italico e il germanico. Emergono, chiare, definite, le differenze di indole e di costume, tra l’Italia e la Germania, e potrebbero essere, le sue, osservazioni valide tutt’oggi.
Un eccellente esempio è offerto dalla cosiddetta ‘questione femminile’: chi pensi – sono in molti, troppi, tanto tra i simpatizzanti quanto tra i detrattori – che nella Germania di Hitler le donne dovessero solamente stare a casa a far figli, si sbaglia, non sa di cosa parla.
Il lavoro era un cavallo di battaglia di Hitler, forse più gettonato di quello razziale: erano tantissime le madri lavoratrici tedesche a quel tempo, Poggiali riferisce una tal quantità e qualità di diritti (oggi diremmo privilegi) delle gestanti, impensabili, perfino surreali per i canoni (italiani) attuali. La condizione femminile complessiva di allora era, in sostanza, migliore della nostra di oggi. E ciò, più che motivo di vanto per gli apologeti del Reich, dovrebbe esser occasione di vergogna per chiunque, in particolare per i ‘progressisti’ nostrani.
Si diceva del lavoro: forza e bellezza. Ecco l’anima socialista delle Germania del Reich.
Ed ecco il «canone fondamentale dell’etica sociale tedesca». Tutti dovevano lavorare, e tutti dovevano esser posti nelle migliori condizioni per farlo.
Una massiccia, autarchica politica agricola, mirava al ritorno alla “vecchia madre terra”.
«Gli storici del Reich s’erano industriati a dimostrare che il decadimento dei due Imperi […] fosse avvenuto perché essi non avevano saputo erigere il loro edificio su basi rurali». La risposta di Hitler fu: «La Germania del futuro sarà uno Stato di agricoltori, od essa perirà».
Non era da meno la cura per l’ambiente: i tedeschi a quel tempo potevano già vantare la raccolta differenziata e il riciclo pressoché totale e generalizzato dei rifiuti, consuetudini oggi considerate unità di misura del progresso civile e ambientale.
Oggi, la politica agricola italiana e il nostro rapporto con la “vecchia madre terra”, si riducono a una “sanatoria di migranti”; mentre il non plus ultra dell’ecologismo si risolve nei capricci di una minor…enne scandinava. Non occorre aggiungere altro, se non stendere il consueto velo pietoso.
Qualcos’altro, invece, possiamo dire dei teutonici im Krieg, così come ce li mostra il Poggiali. «Zoofili» li definisce – oggi diremmo “animalisti”: a parte un sentimento di benevolenza, innato e sviscerale nei confronti del mondo animale, era «connaturale» ai tedeschi anche il senso del rispetto per le bestie, pure quelle selvatiche, e la convivenza della specie umana con tutte le altre, nel complesso piuttosto armoniosa.