Nell’estate del 1978 trascorsi a Bamyan tutto il mese di agosto e la prima decade di settembre. Lassù ero arrivata in compagnia di due italiani, un tedesco e due americani con i quali condividevo il noleggio di un pullmino scalcagnato comprensivo di guida/autista. Partendo da Kabul avevamo imboccato la Strada del Nord e superato Sharikar, prima di dirigerci verso ovest e attraversare la meravigliosa vallata del Panjdin, in direzione Ghorband, dove si aprivano le porte dell’Hindu Kush. Per noi ragazzi occidentali appena usciti dal liceo e cresciuti nel benessere era come viaggiare a bordo di una macchina del tempo programmata sul Medioevo. Incantati guardavamo il sole scintillare sulle rocce di quel mondo brado composto da piste polverose e pietrose, passi incredibili a 3.500 metri di altitudine, fiumi prosciugati col letto ingombro di ciottoli, villaggi appollaiati in alto che guardavano in giù, fortezze diroccate all’ombra delle quali passavano carovane misteriose che seguivano strade invisibili. Quando ripenso a quelle rotte assetate e spoglie mi sento ancora la polvere nelle ossa. Giunti a Bamyan avevamo trovato alloggio al Caravan Hotel per la modica cifra di 10 afgani al giorno. La camera da letto, se così si poteva chiamare, era uno stanzone con due tavolini bassi per il tè e sei charpoys, i tappeti in fibra di juta fissati su montanti di legno sui quali stanchi morti avevamo immediatamente disteso i nostri sacchi a pelo. Nessuna traccia di cuscini e lenzuola, ma la cosiddetta «generazione Erasmus» affetta da cosmopolitismo compulsivo e finanziata dall’industria del divertimento a quei tempi non era ancora nata, e noi eravamo dei giovanissimi viaggiatori di poche pretese desiderosi di conoscere altri mondi. Trascorrevamo le giornate esplorando la regione che circondava la città rossa, straordinariamente selvaggia, e camminando in valli argillose che avevano il colore del sangue. Talvolta ci arrampicavamo su per una montagna che arrivava a 4.000 metri di altitudine, e una volta in cima stavamo seduti per ore a guardare in silenzio il deserto assoluto. Per rinfrescarci facevamo il bagno nelle acque turchesi del lago di Band-i-Amir, nuotavamo in mezzo alle sue cascate, tra le sue scogliere vertiginose, meravigliandoci davanti agli alberi pietrificati.
Sulle nostre semplici attività quotidiane vegliavano i giganteschi buddha scavati nella montagna, vestigia della passata grandezza di Bamyan, che già nel II secolo d.C. fu un crocevia culturale straordinario, meta quasi obbligata di greci, cinesi, persiani, indiani e uomini curiosi in cerca di avventura. Il custode della montagna sacra, un uomo di mezza età a cui piaceva parlare, ci aveva preso in simpatia e un giorno ci invitò a pranzo a casa sua. Niente di straordinario: uova strapazzate, tè, riso con verdure piccanti, chapati e frittelle al miele. Le donne di famiglia, che mangiavano nella stanza accanto, ci vennero presentate solo a fine pasto, quando non c’era più il rischio che gli stranieri maschi assistessero allo scabroso spettacolo delle loro labbra in movimento. Non nascondo di avere pianto davanti alla televisione, nel marzo del 2001, quando i talebani fecero esplodere i due giganti di pietra che anni prima mi avevano concesso con tanta grazia la loro saggia benevolenza. Non solo se n’era andato in pochi minuti un atomo del mio microscopico passaggio esistenziale sulla Terra ma, cosa ben più grave, un pezzo importante della storia dell’umanità non c’era più. Sparito per sempre. Un manipolo di fanatici gli aveva sparato addosso con carri armati e lanciarazzi avvisando il mondo che i due buddha, uno alto 53 metri e l’altro 35, erano solo l’inizio della loro opera di distruzione e ricostruzione. Pochi mesi dopo, infatti, toccò alle Torri Gemelle di New York. Un caso?
A seguire vi fu una corsa di eventi a rotta di collo. Le primavere arabe, la Libia, la Siria, il Medioriente, l’Africa Centrale, il Sudamerica. Una guerra dietro l’altra mentre l’Europa stava a guardare. Sospesa tra un malinteso senso del dovere nei confronti dell’alleato atlantico e l’istinto di ragionevolezza che le suggeriva di prendere il largo. Ancora siamo lì con il piede in due scarpe, come ha appena dimostrato la clemenza con cui abbiamo accolto la dichiarazione scombinata del presidente Usa, il peggiore di sempre, che in mondovisione ha detto agli afghani che d’ora in avanti dovranno cavarsela da soli perché all’America questa guerra «non interessa più».
 E via, mezzi e soldati tutti quanti in Iraq! Cosa ne è stato delle nobili promesse occidentali di «costruire una nazione democratica, combattere il terrorismo, proteggere i diritti delle donne»? Questi argomenti sono stati tolti dall’ordine del giorno con il consenso dell’Europa, o a sua insaputa? Se lo zio Sam vuole perdere la faccia su scala planetaria, mettendo in campo una politica schizofrenica che non si capisce bene dove vada a parare, è proprio necessario che la Vecchia Europa segua il suo declino? Come osservò anni fa Henry Kissinger, gli Stati Uniti non hanno alleati permanenti ma solo interessi economici da difendere. Del resto la slealtà americana era nota fin dalla caduta di Saigon, nel 1975, e in tempi più recenti l’abbiamo vista all’opera in Siria, quando i combattenti curdi sono stati consegnati nelle mani dei Turchi dalla sera alla mattina. Una sorte analoga è toccata all’Ucraina, ai Paesi Baltici e ad altri ingenui spalleggiatori di quella che un tempo è stata (ma non è più) la prima potenza mondiale. L’Afghanistan è solo l’ultimo tassello di una serie di disavventure belliche finite in modo grottesco e dimostra con brutale chiarezza che la politica estera di Washington mira unicamente ad interessi corporativi. Le lobby hanno la precedenza mentre le vite di chi capita nel tritacarne del Pentagono, siano essi stranieri o americani, non contano niente. Perennemente sospesa, l’Europa tentenna. Nonostante la «presa di Kabul» da parte dei talebani spalleggiati dal Pakistan non abbia ridicolizzato solo la Casa Bianca e il suo inquilino ma sia stato uno smacco senza precedenti per l’Occidente intero. Mi chiedo cosa aspettiamo noi Europei a tornare alla Storia, alla nostra Storia, emancipandoci dalla subalternità atlantica. Quale momento migliore di questo, ora che il progetto americano di accerchiamento geopolitico della Russia e dell’Eurasia in generale è andato in fumo e un’altra storia deve essere scritta … Se i talebani, secondo i calcoli statunitensi, avrebbero dovuto metterci 90 giorni ad espugnare Kabul e invece hanno risolto la faccenda in una settimana, vuol dire che avevano l’appoggio del popolo afghano, che probabilmente non vedeva l’ora che le truppe straniere alzassero i tacchi e se ne andassero fuori dalle scatole.
E via, mezzi e soldati tutti quanti in Iraq! Cosa ne è stato delle nobili promesse occidentali di «costruire una nazione democratica, combattere il terrorismo, proteggere i diritti delle donne»? Questi argomenti sono stati tolti dall’ordine del giorno con il consenso dell’Europa, o a sua insaputa? Se lo zio Sam vuole perdere la faccia su scala planetaria, mettendo in campo una politica schizofrenica che non si capisce bene dove vada a parare, è proprio necessario che la Vecchia Europa segua il suo declino? Come osservò anni fa Henry Kissinger, gli Stati Uniti non hanno alleati permanenti ma solo interessi economici da difendere. Del resto la slealtà americana era nota fin dalla caduta di Saigon, nel 1975, e in tempi più recenti l’abbiamo vista all’opera in Siria, quando i combattenti curdi sono stati consegnati nelle mani dei Turchi dalla sera alla mattina. Una sorte analoga è toccata all’Ucraina, ai Paesi Baltici e ad altri ingenui spalleggiatori di quella che un tempo è stata (ma non è più) la prima potenza mondiale. L’Afghanistan è solo l’ultimo tassello di una serie di disavventure belliche finite in modo grottesco e dimostra con brutale chiarezza che la politica estera di Washington mira unicamente ad interessi corporativi. Le lobby hanno la precedenza mentre le vite di chi capita nel tritacarne del Pentagono, siano essi stranieri o americani, non contano niente. Perennemente sospesa, l’Europa tentenna. Nonostante la «presa di Kabul» da parte dei talebani spalleggiati dal Pakistan non abbia ridicolizzato solo la Casa Bianca e il suo inquilino ma sia stato uno smacco senza precedenti per l’Occidente intero. Mi chiedo cosa aspettiamo noi Europei a tornare alla Storia, alla nostra Storia, emancipandoci dalla subalternità atlantica. Quale momento migliore di questo, ora che il progetto americano di accerchiamento geopolitico della Russia e dell’Eurasia in generale è andato in fumo e un’altra storia deve essere scritta … Se i talebani, secondo i calcoli statunitensi, avrebbero dovuto metterci 90 giorni ad espugnare Kabul e invece hanno risolto la faccenda in una settimana, vuol dire che avevano l’appoggio del popolo afghano, che probabilmente non vedeva l’ora che le truppe straniere alzassero i tacchi e se ne andassero fuori dalle scatole.
Forse la maggioranza della popolazione afghana non starà dalla parte dei talebani, ma di sicuro non sta neanche dalla parte degli occidentali che negli ultimi decenni hanno utilizzato su larga scala armi all’uranio impoverito e «bombe non convenzionali» meno potenti degli ordigni nucleari ma con un potere distruttivo molto elevato, senza contare tutte le operazioni effettuate a scopo intimidatorio sulle popolazioni locali. Alcuni non si spiegano come abbiano fatto i guerriglieri afghani a resistere tutto questo tempo nonostante la schiacciante disparità di forze. L’elefante e il topolino. Nel mio piccolo non ho mai avuto dubbi, avendo constatato nel corso degli anni, sia durante l’invasione russa sia sotto quella americana, la fermezza con cui le genti afghane si sono sempre difese, appellandosi al sacrosanto principio di autodeterminazione dei popoli. Un valore a cui l’Europa ha rinunciato troppo in fretta.
Nella prima metà dell’Ottocento le tribù pashtun e tagike avevano già mandato a monte il «grande gioco» (così lo definì Rudyard Kipling) di Londra e Mosca che si disputavano il controllo delle vie commerciali per l’Asia. Ma evidentemente quella memorabile catastrofe coloniale non ci ha insegnato niente, tant’è vero che abbiamo voluto riprovarci. Il motivo? Troppo attento alle dinamiche dell’economia e della finanza, il mondo occidentale ignora sistematicamente la Storia. Altrimenti saprebbe le etnie che abitano quegli altipiani (l’Islam è arrivato in tempi relativamente recenti) sono le eredi spirituali, culturali e biologiche degli Sciti, la più brillante civiltà delle steppe manifestatasi tra il Dnjepr e il Don, nella Russia meridionale, intorno al 1.800 a.C. Non stiamo parlando di militari al soldo di un esercito statale ma di società guerriere dedite all’uso delle armi e all’allevamento dei cavalli da svariati millenni. Gli Sciti di un tempo si riconoscevano a distanza dagli ampi mantelli variopinti (un chiaro simbolo sciamanico) in cui erano avvolti mentre gli afghani convertiti all’Islam hanno dovuto ripiegare sui colori scuri, ma l’indole è sempre la stessa.
Un guerriero tradizionale sarà sempre moralmente superiore a un mercenario occidentale, ciò a prescindere dalle apparecchiature tecnologiche in dotazione. Ecco perché negli ultimi anni solo i combattenti mediorientali sono stati visti arrendersi con la bandiera bianca in una mano e il Corano nell’altra. Con cosa si sarebbe arreso un soldato occidentale? Quale simbolo «religioso» avrebbe potuto ostentare? Patente e libretto? Carta d’identità e codice fiscale? Passaporto Verde, vaccinato o non vaccinato? Tutte queste cose insieme? Come ciascuno di noi i nostri giovani soldati sono ossessionati dall’horror vacui, hanno il terrore di scomparire, mentre un guerriero tradizionale se ne frega della morte, che anzi ricerca. Eppure non è passato un secolo da quando il filosofo combattente, o combattente filosofo, Ernst Jünger paragonò la «pace» alla superficie fredda di un’anima morta: “solo chi è forte tiene il proprio mondo in pugno: il debole è destinato a farlo evaporare nel caos.” A suo modo di vedere non c’era nulla di più sacro di un essere umano combattente, dei tramonti rossi che accompagnavano la battaglia, dei canti primaverili dei soldati risvegliati dal sonno di una non-vita per vivere e combattere. L’essere umano deve essere sempre all’altezza del proprio destino, sotto qualsiasi forma, persino quella mortale.
Certe posizioni radicali oggigiorno non sono più condivisibili? Sono d’accordo, a patto però che si accetti il rifiuto di altre culture di prendere la nostra come esempio. Dopo guerre, guerre e poi ancora guerre, è arrivato il momento di dire la verità: il modello di vita «occidentale» non è gradito altrove, perciò smettiamola una buona volta di fare i missionari e impariamo la lezione. Per dirla tutta hanno stancato anche noi i pensieri unici, le globalizzazioni, gli universalismi e i liberismi, completi di annessi e connessi. Non si capisce dunque per quale motivo dovrebbero piacere a qualcun altro. Quest’ultima cocente sconfitta morale, oltre che economico-strategica, non potrebbe essere un’occasione per riflettere? Se non ora, quando?
Tutto al momento appare ancora incerto e fare previsioni sarebbe azzardato, ma a parole i talebani di seconda e terza generazione dicono di essere cambiati, e noi li aspettiamo alla prova dei fatti. Staremo a vedere. In questi anni i guerriglieri afghani hanno impedito agli americani con le loro incessanti azioni di disturbo di accedere ai vasti giacimenti di cobalto, litio, oro, rame e «terre rare» (REE). La linfa della tecnologia si trova nel cuore dell’Eurasia, e precisamente in Afghanistan. Tale divieto, probabilmente, è derivato dal fatto che agli occhi degli afghani non c’è niente di più odioso dell’”american way of life”. Un male da estirpare alla radice, a loro modo di vedere le cose. Tutto lascia supporre tuttavia che i Cinesi e i Russi riceveranno un trattamento migliore. E l’Europa, in tutto ciò, dove si colloca? Dipende da noi, naturalmente. Ma partiamo con il piede sbagliato se speriamo di lavarci la coscienza distribuendo qualche lasciapassare completo di assegno famigliare a poche centinaia di famiglie afghane. Così, tutto può tornare come prima.
Nel 2008 sono riemerse dalla rupe di Bamyan le parti di un terzo buddha, sdraiato e dormiente. Già mille anni fa un viaggiatore ne aveva parlato. Simbolicamente il buddha nascosto dovrebbe rappresentare l’uomo (del futuro?) pronto per il Nirvana. Le sue dimensioni coprirebbero la metà di un campo di calcio. Ma stavolta, per prevenire vandalismi e saccheggi, gli archeologi hanno saggiamente deciso di lasciarlo lì dov’è. Finché la pancia della montagna lo custodisce, assieme a centinaia di altri manufatti, è al sicuro. Verranno tempi migliori.
Questo atto di resistenza culturale sottolinea la speranza di una rinascita possibile. Non solo per gli afghani, ma per noi tutti. Se dunque il termine “indo-europeo” (di nostra invenzione) attribuito alla cultura di un intero continente ha ancora un senso, allora possiede un significato anche la denominazione geografica “Eurasia”. Il che vuol dire che in una prospettiva di «pacificazione» allargata non si potrà andare avanti a criminalizzarsi a vicenda. Su questa strada tortuosa un punto di dialogo andrà trovato, pur conservando ognuno le proprie specificità.
Rita Remagnino




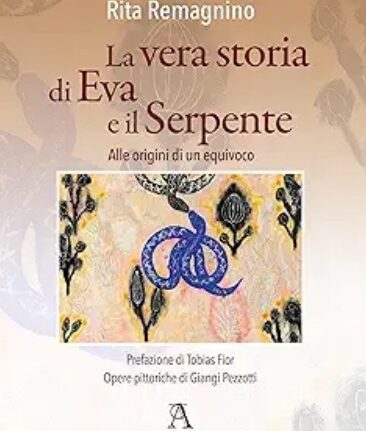


8 Comments