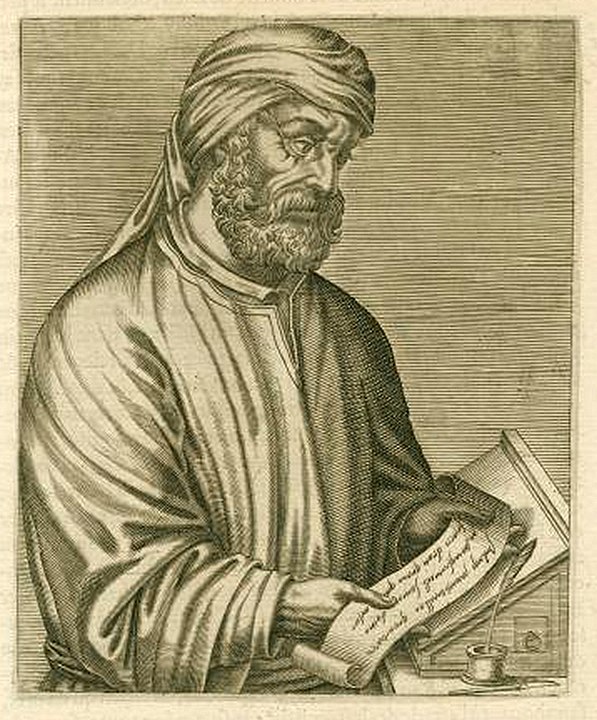Il problema dell’umanità poggia su una confusione tra i piani. Esiste il livello che nessuno può conoscere, quella magia che regge tutto, il Brahman nirguṇa, il non quantificabile (1), che tutto pervade di sé ma che sfugge a ogni categorizzazione concettuale e discorsiva. Esiste poi il livello originato dal primo, quello della causa razionalizzabile che determina le cose del mondo, il Brahman saguṇa, il Logos, la ragione ultima di tutte le cose, quantificabile e all’origine del piano della manifestazione (sottile e fisico). Platone presenta una distinzione simile: l’Uno-Bene è il primo, mentre il Mondo delle Idee è il secondo. L’Uno è il principio assoluto che nessuno conosce ma tutto pervade, detto in altri termini è il livello metafisico, l’essere inteso in termini assoluti da Parmenide. Invece il Mondo delle Idee è l’essere comunemente inteso, il livello ontologico. Cosa ha fatto Aristotele? Aristotele ha scambiato i termini tradendo l’insegnamento originale di Platone: Aristotele ha confuso i due livelli, per questo dice che la filosofia prima è la scienza della causa. Egli ha dato razionalità anche all’Assoluto. Plotino riprenderà Platone: il primo livello è l’Uno, il secondo livello è il Nous. Detto in termini pratici, la vita è un mistero, poggia su quegli orientamenti archetipici che annullano il caso ma sono relegati nella incomprensibilità dell’inconscio.  Quando noi cerchiamo di capire razionalmente la vita, cerchiamo la causa razionale, ma la vita in sé stessa non è inquadrabile nella ragione discorsiva. Facciamo come Aristotele: fondiamo i due livelli. La vita non va capita, razionalizzata, alla maniera di Freud, che cercava la causa, ma va armonizzata in noi. Va accettata in una comprensione profonda, al di là di una mera razionalità. Mettiamo che ci innamoriamo. Non dobbiamo cercare le spiegazioni, come fa Alberoni nei suoi saggi, ma dobbiamo capire la lezione intuitiva che quell’evento ci procura. Cioè il cambiamento. L’amore è un dono divino incomprensibile, che ci guida lungo una via, porta alla trasformazione. Noi nasciamo dall’utero di una madre, ma dobbiamo rinascere attraverso l’amore del partner o di Dio.
Quando noi cerchiamo di capire razionalmente la vita, cerchiamo la causa razionale, ma la vita in sé stessa non è inquadrabile nella ragione discorsiva. Facciamo come Aristotele: fondiamo i due livelli. La vita non va capita, razionalizzata, alla maniera di Freud, che cercava la causa, ma va armonizzata in noi. Va accettata in una comprensione profonda, al di là di una mera razionalità. Mettiamo che ci innamoriamo. Non dobbiamo cercare le spiegazioni, come fa Alberoni nei suoi saggi, ma dobbiamo capire la lezione intuitiva che quell’evento ci procura. Cioè il cambiamento. L’amore è un dono divino incomprensibile, che ci guida lungo una via, porta alla trasformazione. Noi nasciamo dall’utero di una madre, ma dobbiamo rinascere attraverso l’amore del partner o di Dio.
È vero che noi siamo il risultato di una storia passata, ove risiedono le nostre radici, per cui dobbiamo stare attenti a non ferire la nostra nostalgia (Borgna), cioè a non cancellarla, perché l’atteggiamento nostalgico rivolto al passato indica un legame con noi stessi e ci strappa da un presente o un futuro inautentici senza la nostra vera anima. Tuttavia l’uomo è come un bruco, ha bisogno di un periodo depressivo nel quale si rinchiude nel suo bozzolo per prepararsi alla rinascita, divenendo autenticamente sé stesso nello splendore delle energie rinnovate. Questa parabola psicologica trova molte eco in numerose festività, racconti e miti del passato: non pensiamo solo alla croce di Cristo che precede la resurrezione gloriosa, ma anche alla rinascita di molte divinità pagane dopo una morte ingloriosa (da Marduk a Odino), per non parlare di momenti goliardici (festività dionisiache nell’antica Grecia, saturnali nell’antica Roma) che esprimevano un temporaneo emergere del caos che preparava il rinnovarsi dell’ordine, cui fece seguito il Carnevale nella società cristiana (2). Nelle antiche iniziazioni era possibile raggiungere la luce della realizzazione suprema solo dopo le durissime prove, come quelle subìte da Amenofi IV quando andò nel regno dei morti. La violenza iniziatica aveva molti scopi, tra cui quello di staccare il prescelto dai limiti del mondo materiale e innalzarlo alla perfezione della luce. Nel Buddhismo mahayana c’era il concetto della liberazione delle creature, anche attraverso la morte sacrificale. In questo senso, il sacrificio umano non avrebbe nulla o quasi di sinistro: sarebbe un altissimo atto di amore, per cui la divinità chiama il sacerdote a liberare la cosiddetta vittima dalla vita, causa di sofferenza indicibile. Sempre in India, certe scuole riconoscevano addirittura l’auto-sacrificio: la prima virtù dell’illuminato, dana, la donazione, richiama il sacrificio vedico, per l’appunto dana. Non per nulla, era considerato un grande atto di liberazione dall’egoismo auto-mutilarsi a favore del bisognoso. È insomma l’ideale antichissimo del: per aspera ad astra. Certamente non ogni violenza o trasgressione ha un fine nobile, per esempio, sempre in India, alcune sette tantriche praticavano loscamente il rovesciamento completo dei precetti buddhisti, come quello di astenersi dall’uccidere creature. L’avverbio “loscamente” può intendersi in due maniere. Però prima bisogna fare un discorso più generale. La Via della Mano Destra è un percorso realizzativo finalizzato a servire principi spirituali consolidati dalla tradizione: per il cristianesimo c’è l’obiettivo della resurrezione, per l’induismo quello della liberazione (mokṣa), per altri della unione al divino (la Fenice sarebbe il simbolo della reintegrazione della propria natura con quella divina: il mitico uccello avrebbe origini egiziane e sarebbe l’anima del dio supremo Ra). Tutto questo deve avvenire nell’ossequio a una divinità ben precisa. Invece la Via della Mano Sinistra punta ad un altro obiettivo finale: l’adepto dovrà trasformarsi lui stesso in un dio, creatore di mondi. Quest’ultimo tipo di adepto, affrancandosi dal potere spirituale tradizionale, non accetta le comuni norme morali e spirituali. Punterà invece a compiere azioni contro il sistema per affermare la propria individualità fino alla trasformazione in una divinità. A questo punto atteggiamenti come quelli di alcune sette del tantrismo, che ribaltano le norme comunemente accettate, possono avere due spiegazioni: la trasgressione viene vista di più come male da compiere per rifuggire il bene tradizionale e quindi il sistema (satanismo occultista) oppure di più come male da compiere per affermare la propria individualità e libertà (satanismo razionalista). Alla fine si tratta della stessa cosa perché chi aderisce al sistema è servitore di una divinità, che detta le regole, e non è una divinità lui stesso.
La Via della Mano Destra risponde a un archetipo inconscio antichissimo che vede nella figura superiore, di potere (come un dio o un re o un padre), la funzione di dare la vita. È significativo che il latino pater, “padre”, derivi da una radice indoeuropea che significa “proteggere” e “nutrire”, funzioni entrambe necessarie alla sopravvivenza. Tale radice indoeuropea, con il senso di “padre”, si ritrova anche nell’ittita (attas) o nel gotico (Attila, grande capo barbaro, che parlava una lingua turcofona, ha il nome che in gotico significa “piccolo padre”: -ila è un suffisso diminutivo e atta vuol dire “padre”) o nel turco (Atatürk significa “padre dei turchi”). È significativo che in ittita il re viene detto ha̭ššuš, dalla radice ittita hašš-, “procreare”. Gli dei egiziani erano spesso raffigurati assieme alla croce ansata, ankh, simbolo della vita. Quindi la divinità viene vista come necessaria alla sopravvivenza in vita e anche dopo la morte. Invece la Via della Mano Sinistra risponde a un archetipo specularmente opposto, quello della individualità e della libertà: essere il dio di sé stessi, in questo e nell’altro mondo. È significativo che il latino liber, “libero”, condivide la radice con parole come libidine: chi è libero decide da solo cosa fare, non è costretto dalle regole morali accettate dai più.  La riflessione cabalistica attribuisce la prima Via all’Albero della Vita, la seconda all’Albero della Morte. Le dieci Sephirot sono emanazioni di Dio che formano l’Albero della Vita. A queste corrispondono dieci Sephirot Avverse (dette anche Qliphot) che formano l’Albero della Morte, la controparte del primo albero. In sostanza, l’aspetto spirituale inerente la Via della Mano Destra è l’Albero della Vita, a cui si contrappone l’aspetto materiale della Via della Mano Sinistra rappresentato dall’Albero della Morte. Per esempio, la Sephirah della Conoscenza si esprime spiritualmente per il servizio di Dio (conoscere Dio per glorificarlo), a questa si contrappone la Sephirah Avversa della Conoscenza che si esprime materialmente per raggiungere i propri scopi (dominio degli altri e superbia). La Via della Mano Destra sarebbe più concentrata su preghiera, perdono, amore, carità, invece la Via della Mano Sinistra su meditazione, respirazione, droghe, manipolazione degli altri, violenza. Gli esoteristi ricordano che chi segue la prima Via può perdersi e cominciare a seguire la seconda, e viceversa. Entro la prima Via c’è chi segue la Sephirah della Vittoria, caratterizzata da emozioni forti: amore verso Dio e gli altri. Ma è possibile che, seguendo la tensione emotiva, il candidato inizi a ribellarsi alle regole divine per seguire istinti nefasti che lo portano verso la materia. Sempre entro la Via della Mano Destra, c’è chi segue la Sephirah della Severità, caratterizzata da grande forza di volontà per perfezionarsi. Ma è possibile che, seguendo la tensione della durezza, il candidato inizi a odiare e a fare violenza agli altri.
La riflessione cabalistica attribuisce la prima Via all’Albero della Vita, la seconda all’Albero della Morte. Le dieci Sephirot sono emanazioni di Dio che formano l’Albero della Vita. A queste corrispondono dieci Sephirot Avverse (dette anche Qliphot) che formano l’Albero della Morte, la controparte del primo albero. In sostanza, l’aspetto spirituale inerente la Via della Mano Destra è l’Albero della Vita, a cui si contrappone l’aspetto materiale della Via della Mano Sinistra rappresentato dall’Albero della Morte. Per esempio, la Sephirah della Conoscenza si esprime spiritualmente per il servizio di Dio (conoscere Dio per glorificarlo), a questa si contrappone la Sephirah Avversa della Conoscenza che si esprime materialmente per raggiungere i propri scopi (dominio degli altri e superbia). La Via della Mano Destra sarebbe più concentrata su preghiera, perdono, amore, carità, invece la Via della Mano Sinistra su meditazione, respirazione, droghe, manipolazione degli altri, violenza. Gli esoteristi ricordano che chi segue la prima Via può perdersi e cominciare a seguire la seconda, e viceversa. Entro la prima Via c’è chi segue la Sephirah della Vittoria, caratterizzata da emozioni forti: amore verso Dio e gli altri. Ma è possibile che, seguendo la tensione emotiva, il candidato inizi a ribellarsi alle regole divine per seguire istinti nefasti che lo portano verso la materia. Sempre entro la Via della Mano Destra, c’è chi segue la Sephirah della Severità, caratterizzata da grande forza di volontà per perfezionarsi. Ma è possibile che, seguendo la tensione della durezza, il candidato inizi a odiare e a fare violenza agli altri.
Le due Vie e i due Alberi non sono rispettivamente Bene e Male in quanto la salvezza finale sarebbe la conclusione di entrambe le Vie, ma mediante strumenti diversi. È che non esiste una sola natura umana: ci sono uomini spirituali e uomini materiali. I primi sono adatti per la Via della Mano Destra, i secondi per la Via della Mano Sinistra. Secondo la letteratura esoterica, gli adepti della Via della Mano Destra, essendo ai vertici del potere manifesto, come la religione, insinuerebbero alla massa l’idea che la salvezza si ottenga solo mediante la loro Via e la grazia di Dio. Ma si tratterebbe della più colossale menzogna della storia architettata appositamente per attirare fedeli. La verità sarebbe un’altra: sarebbe contenuta nell’Anello del Nibelungo di Wagner. Il Walhalla è il paradiso promesso dalle religioni accettate dal potere costituito, ma non è altro che un inganno per imprigionare le anime e tenerle alla mercé di divinità inferiori che si spacciano per benefattori dell’umanità mediante la mortificazione della natura specifica di ciascuna anima e quindi la assoluta negazione della verità. Tra la schiavitù orchestrata da un dio e il libero sviluppo realizzativo della propria anima, sarebbe meglio scegliere il secondo. In base ad un’altra visuale, noi apparteniamo a un Grande Essere, che chiamiamo Dio, il quale ha la necessità di evolversi. L’uomo, nella sua identità più profonda, è collegato mediante l’anima immortale a Dio. A questo punto noi, essendo particelle di Dio, vivremmo questa vita per evolverci. Pertanto lo sbocco finale sarebbe per tutti la salvezza perché l’inferno, in qualità di assenza di Dio, sarebbe inconcepibile. Anche la sofferenza in sé non esisterebbe: noi, essendo Dio, saremmo totalmente gioiosi ma non ce ne accorgeremmo per via di dinamiche energetiche collegate a tale evoluzione divina.
Sarebbe questo il segreto della “gioia pasquale” di cui parlano soprattutto le chiese orientali: una gioia basata sui segni della croce. Uno dei primi problemi teologici che dovette affrontare la chiesa primitiva, soprattutto quella efesina, fu l’incarnazione di Cristo. Sotto l’influsso dello gnosticismo, alcuni pensavano a una incarnazione simbolica. Ma la tradizione giovannea (3) volle nettamente chiarire che Cristo venne veramente nella carne. 1Giovanni 4, 2: “Da questo conoscete lo spirito di Dio: ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto nella carne, en sarkì elēluthota, è da Dio”. E la carne si associa inevitabilmente alla sofferenza. Tuttavia, nonostante questa presa di posizione contro le correnti spiritualistiche, nel Vangelo di Giovanni si connette indelebilmente la passione e la croce di Cristo ai segni della regalità divina. Come a dire che Cristo è veramente Dio solo nella sofferenza. Vengono in mente le parole di Isaia 51, 1: coloro che cercano “giustizia” (che nel linguaggio biblico significa “salvezza”) devono guardare alla roccia da cui sono stati tagliati, ‘el tsur chutsabetem. Applicando queste parole nel cristianesimo, possiamo dire che bisogna guardare all’amore di Dio che ha scelto la propria dimora nella carne, con tutti i suoi limiti. La tradizione giovannea insiste nell’uso della espressione “comandamento” (in greco biblico entolē), anziché il plurale “comandamenti”, per sottolineare che, sull’esempio dell’amore di Cristo, il comandamento più importante, vera sostanza della fede cristiana, è quello dell’amore. Ma per Cristo dire “amore” non significa altro che dire “croce”. E, secondo la visione cristiana, quella pace (in ebraico shalom) portata dal Messia, prosperità e gioia assieme, non può non fondarsi sulla sua sofferenza. 1Pietro 2, 24: “Dalle sue piaghe siete stati guariti”, ou tōi mōlōpi iathēte. Ambrogio parlava della chiesa come della Casta Meretrix, “prostituta pura”: essa ha una vocazione rivolta a tutti gli uomini, quella di purificarli dai loro peccati. E, secondo i Padri della Chiesa, ciò avviene grazie a quel sangue e acqua che sgorgano dal costato trafitto di Cristo (Vangelo di Giovanni 19, 34: “… e ne uscì sùbito sangue e acqua”, kai exēlthen euthus aima kai udōr).
Secondo una visione ancora più estrema, tutto ciò che è materiale (spazio, tempo, causa, sofferenza, divenire, cambiamento sarebbe illusorio. Per questo Gauḓapāda (Māṋḓūkyakārikā Upanis̭ad II. 32) così scriveva: na nirodho na cotpattirna baddho na ca sādhakaḥ – na mumukṣurna vai mukta ityeṣā paramārthatā, “Questa è la suprema verità: non vi è né nascita né vi è cessazione di essere, né aspirante alla liberazione né liberato, né alcuno che sia in schiavitù”.
La Filosofia Perenne (4) distingue nell’uomo una parte mortale (corpo e anima psichica) e una parte immortale (anima immortale). Pensiamo alle due anime di Platone, alla nefeš e alla rūaḥ degli ebrei, alla nafs e al rūḥ dei musulmani, all’anima e all’anima dell’anima di Filone, al Faraone e al suo Ka degli antichi egiziani, al Saggio Esteriore e al Saggio Interiore dei cinesi, all’Uomo Esteriore e all’Uomo Interiore del cristianesimo, al Sé (ātman) e al Sé immortale del sé (asyāmṛta ātmā) del Vedānta. Pensiamo anche alla psiche cosciente e all’inconscio collettivo della psicologia moderna (5). L’inconscio collettivo ci invia molti segnali sincronici per indicarci che il nuovo ci sta aspettando, che la via dell’armonia con il mondo deve essere attuata in tutti i modi. Ma questo “demone” socratico interiore, immagine dell’inconscio collettivo, che ci guida lungo lo sviluppo delle nostre potenzialità, non persegue un progetto razionale, inquadrabile in schemi geometrici: il numinoso che ci abita, essendo incosciente, non parla il linguaggio della razionalità cosciente. Infatti si esprime per segni. Il fine ultimo del nostro esistere non è un programma aziendale con entrate e uscite, ma un continuo saltare nel vuoto per ottenere un appagamento totalizzante che la ragione discorsiva non può esprimere né nei mezzi né negli scopi. Per questo, di contro alle parole razionali dei filosofi che indicano con certezza (“cosa è?”, Socrate insegnava a chiedersi), il linguaggio del “demone” allude solamente. La via del “demone” non va capita, ma va sentita, che è cosa ben diversa. Le Upaniṣad serbano quattro detti ormai divenuti celebri, definiti mahāvākya:
1. Aham brahmāsmi, “Io sono il Brahman”;
2. Tat tvam asi, “Quello sei tu”;
3. Prajñānam brahma, “Brahman è pura sapienza”;
4. Ayam ātmā brahma, “Questo atman è Brahman”.
Tutta la Realtà Vera (Brahman nirguṇa) forma una Unità Assoluta: in sanscrito si dice che “soltanto con l’intuizione lo si può conoscere (perché) in Quello non vi è nessuna molteplicità”, manasaivānudraṣṭavyam neha nānā ‘sti kimcana (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 4. IV. 19). Ogni diversità e differenziazione è una illusione, in sanscrito māyā.  Questo sostantivo ha molti significati: si usa quando gli dei cambiano sembianza, quando l’universo cambia aspetto (per esempio nell’alternarsi del giorno e della notte), oppure per veicolare un concetto assai difficile secondo il quale l’Assoluto fa cambiare la natura in un processo ciclico senza fine. Ma già nella letteratura vedica più antica māyā indica sia illusione/inganno/falsità sia sapienza suprema. Come a dire che la sapienza suprema è riconoscere l’illusorietà del mondo materiale? Aristotele sosteneva che i principi primi non possono essere dimostrati. Essi vanno accettati perché sono certezze dimostrate da sole dall’esperienza con la convalida dell’intelletto. Ma sta qui tutto il limite di questo discorso, che viola apertamente l’insegnamento platonico: se i sensi sono fallaci, la certezza data da essi è una pura illusione. Entro la tradizione sapienziale occidentale posteriore il mondo è stato visto come un teatro, nel senso che il mondo fenomenico altro non è che una illusione. È interessante osservare come in arabo la parola tamthil, con cui si indica il teatro, ha il senso proprio di “raffigurazione” o “immagine”. Secondo Kaṋāda esiste una realtà oggettiva: ogni cosa ha dravya, una “sostanza”, che si manifesta in modalità statica (guṇa) e dinamica (karma). Tuttavia la Māṋḓūkya Upanis̭ad insiste sula natura illusoria di tutto il mondo materiale. Nell’importante commento di Gauḓapāda (Māṋḓūkyakārikā Upanis̭ad II. 15) si legge: avyaktā eva ye ‘ntastu sphuṭā eva ca ye bahiḥ – kalpitā eva te sarve viśeṣastvindriyāntare, “sia gli (oggetti) all’interno, che non sono manifesti, sia quelli all’esterno che sono oggettivati, sono solo rappresentazioni mentali; la sola qualificazione distintiva si ha dai differenti organi dei sensi”. Le Scritture indiane (cfr. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 5. V. 3) insegnano che la Realtà Vera (satyam) è rappresentata da un nome segreto, ahar, dalla radice HAN, “distruggere”, e HA, “distaccarsi”: chi scopre intuitivamente ciò, distrugge l’errore della non conoscenza (avidya) e si distacca dall’illusione della dualità (dvaita). La logica razionale si basa invece sulla contrapposizione di concetti: possiamo pensare il bene solo se pensiamo anche il male. Da ciò deriva che la ragione discorsiva non può assolutamente squarciare il velo del Mistero. Proprio perché pensa o parla, l’uomo non può esprimere la verità. Ma può amarla assecondando ragioni del cuore che la mente non conosce, come scriveva Pascal. Da qui il grande valore della conoscenza vera. La conoscenza vera non è discorsiva, bensì una profonda intuizione del nesso che lega tutte le cose vere. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.V.16 rivela che tre sono i mondi:
Questo sostantivo ha molti significati: si usa quando gli dei cambiano sembianza, quando l’universo cambia aspetto (per esempio nell’alternarsi del giorno e della notte), oppure per veicolare un concetto assai difficile secondo il quale l’Assoluto fa cambiare la natura in un processo ciclico senza fine. Ma già nella letteratura vedica più antica māyā indica sia illusione/inganno/falsità sia sapienza suprema. Come a dire che la sapienza suprema è riconoscere l’illusorietà del mondo materiale? Aristotele sosteneva che i principi primi non possono essere dimostrati. Essi vanno accettati perché sono certezze dimostrate da sole dall’esperienza con la convalida dell’intelletto. Ma sta qui tutto il limite di questo discorso, che viola apertamente l’insegnamento platonico: se i sensi sono fallaci, la certezza data da essi è una pura illusione. Entro la tradizione sapienziale occidentale posteriore il mondo è stato visto come un teatro, nel senso che il mondo fenomenico altro non è che una illusione. È interessante osservare come in arabo la parola tamthil, con cui si indica il teatro, ha il senso proprio di “raffigurazione” o “immagine”. Secondo Kaṋāda esiste una realtà oggettiva: ogni cosa ha dravya, una “sostanza”, che si manifesta in modalità statica (guṇa) e dinamica (karma). Tuttavia la Māṋḓūkya Upanis̭ad insiste sula natura illusoria di tutto il mondo materiale. Nell’importante commento di Gauḓapāda (Māṋḓūkyakārikā Upanis̭ad II. 15) si legge: avyaktā eva ye ‘ntastu sphuṭā eva ca ye bahiḥ – kalpitā eva te sarve viśeṣastvindriyāntare, “sia gli (oggetti) all’interno, che non sono manifesti, sia quelli all’esterno che sono oggettivati, sono solo rappresentazioni mentali; la sola qualificazione distintiva si ha dai differenti organi dei sensi”. Le Scritture indiane (cfr. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 5. V. 3) insegnano che la Realtà Vera (satyam) è rappresentata da un nome segreto, ahar, dalla radice HAN, “distruggere”, e HA, “distaccarsi”: chi scopre intuitivamente ciò, distrugge l’errore della non conoscenza (avidya) e si distacca dall’illusione della dualità (dvaita). La logica razionale si basa invece sulla contrapposizione di concetti: possiamo pensare il bene solo se pensiamo anche il male. Da ciò deriva che la ragione discorsiva non può assolutamente squarciare il velo del Mistero. Proprio perché pensa o parla, l’uomo non può esprimere la verità. Ma può amarla assecondando ragioni del cuore che la mente non conosce, come scriveva Pascal. Da qui il grande valore della conoscenza vera. La conoscenza vera non è discorsiva, bensì una profonda intuizione del nesso che lega tutte le cose vere. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.V.16 rivela che tre sono i mondi:
1. Quello degli uomini lo si ottiene con la progenie;
2. Quello dei padri con il rito;
3. Quello degli dei, il più elevato, con la conoscenza (6).
A questo punto esistono due parole: quella che esprime la conoscenza falsa, razionale e poi quella assoluta, che è la prima manifestazione dell’Assoluto. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 4. I. 2 si spinge a dire che la parola è il Brahman stesso. Nell’epoca vedica la parola era considerata in senso assoluto perché coincidente con la realtà, invece nel periodo post-vedico la parola divenne quotidiana, relativa, profana, poiché lasciò la connessione perfetta tra significante e significato. Non solo, ma buona parte della filosofia occidentale vede nel linguaggio quotidiano, che sarebbe malato, il più grande problema per la speculazione filosofica. Bisogna correggere innanzitutto la parola di tutti i giorni. Russell notava, ad esempio, la forte ambiguità del verbo essere, che può dire con la stessa forma due cose diversissime. “Socrate è un uomo” indica una predicazione (unione di soggetto e verbo), invece “Socrate è umano” indica una identità. Confondendo questi due livelli logici, si incorre in grandissimi errori filosofici (7). Il problema è estremamente rilevante. Schleiermacher in una lezione del 1832 diceva che “quando il pensare e la connessione dei pensieri sono in entrambi gli interlocutori (cioè: chi parla e chi ascolta) una sola e identica cosa, allora, a parità di lingua, la comprensione va da sé”, das Verstehen von selbst (8). Ma se, a causa delle ambiguità della lingua, chi parla dice una cosa e chi ascolta ne intende un’altra, un po’ come accade in Ionesco, il problema principale della filosofia non sta tanto nella logica ma nell’espressione linguistica. La parola quotidiana ha quattro livelli (Appayya Dīkṣita, Ratnatrayaparīkṣā, vv. 72-86):
1. Voce Sottile (sūkṣmā vāc): intuizione preconcettuale presente in tutte le creature;
2. Voce Veggente (paśyantī vāc): la parola non è ancora espressa, ma si trova in uno stato aurorale nel quale la Voce Sottile è unita all’oggetto indeterminato;
3. Voce Mezzana (madhyamā vāc): inizia la vera espressione dell’oggetto, ma solo nel pensiero interno;
4. Voce Corporea (vaikharī vāc): la parola diviene un suono articolato.
Per il Karma Mīmāṃsā di Jaimini e tutta la riflessione successiva entro tale importante scuola filosofica indiana, il mondo intero è nato da un suono originario, ma che continua a persistere, costituendo l’essenza del mondo e il nesso tra mondo spirituale e mondo materiale. Ora i Veda, come espressione sonora dell’essenza (sat) del mondo, sono eterni, non solo una rivelazione. Dato che nei Veda vi sono le formule per il sacrificio, solo l’aderenza a queste formule rituali permette di eseguire correttamente il sacrificio, cosa che, vista l’importanza di tale parola assoluta, garantisce l’armonia universale (9). Ṛg-Veda X, 71, 4 rivela che c’è una parola che chi ha la vista non vede e chi ha l’udito non ode. Eraclito (B 1 DK) diceva che esiste una parola (Logos) della quale “gli uomini sono incapaci di comprensione”, axunetoi ginontai anthrōpoi: prima di averla sentita e dopo averla sentita. “Anche se tutte le cose avvengono secondo questo Logos, essi si mostrano inesperti, quando si cimentano in parole e in azioni”, peirōmenoi kai epeōn kai ergōn toioutōn. La parola assoluta non è comprensibile mediante la razionalità discorsiva, bensì mediante l’intuizione profonda. Secondo una valida interpretazione del pensiero di Eraclito, il Logos non è quel principio razionale che regge tutto, tributario della spiegazione cristiana posteriore, bensì, come anche Heidegger sosteneva sulla scorta del tedesco legen-liegen, quella apertura intuitiva nei confronti del Tutto. È stata da molte parti scardinata l’idea che la filosofia greca sia nata come tentativo di affermare la razionalità contro il mito. Nietzsche la faceva derivare dai misteri dionisiaci, forse i più lontani dall’idea moderna di razionalità. Più precisamente riguardo a Eraclito, Macchioro e Guthrie hanno sostenuto che fosse un orfico: l’orfismo era una tradizione misterica molto antica e in voga. Burkert pensava a un Eraclito appartenente alla religione e filosofia orientale. Somigliana e West hanno visto Eraclito entro l’ambito delle tradizioni indiane e iraniche (10).
Aristotele diceva che la filosofia greca è nata da: thauma. Di solito si traduce questo vocabolo greco con “meraviglia”. Allora Aristotele avrebbe voluto dire che la filosofia nasce dal senso di ammirazione per ciò che ci circonda: il filosofo coglie la meraviglia del mondo e inizia a interrogarsi razionalmente su di esso. Ma, stando a una traduzione filologicamente più rigorosa, il sostantivo greco significa invece “terrore”. Allora forse Aristotele voleva dire che il filosofo, consapevole della condizione drammatica dell’uomo nell’universo, inizia a chiedersi il perché della sua sofferenza. In questo senso la speculazione filosofica sul reale non deriva in nessun modo da un afflato razionale, ma tutt’altro: dallo sgomento che l’uomo prova di fronte alla irrazionalità della sua sofferenza, inizia a cercare delle risposte. Nell’antica Grecia l’esperienza del divino era ambigua. Innanzitutto, la religione non era un settore specifico del vivere, per cui, come oggi, c’è il mondo laico, poi quello politico, poi quello religioso, e così via. Invece tutto era considerato sacrale, per cui la religione ufficiale era amministrata da funzionari statali.  Entro questo sfondo pan-religioso, l’antico uomo greco sperimentava il divino o come meraviglioso o come terribile. La prima esperienza era veicolata dal sostantivo theòs, che indicava quando la categoria dell’insolito entrava a far parte del mondo visibile e razionale finendo per apparire meravigliosa. La seconda esperienza era veicolata dal sostantivo daimōn: indicava quando la categoria dell’insolito restava nascosta ai sensi esterni, rimanendo quindi non conciliante, non rappresentabile, interna, irrazionale, pertanto paurosamente terribile. Quando Aristotele parlava del thauma non si sarebbe riferito al theòs ma al daimōn. Per l’uomo greco il divino, secondo entrambe le accezioni, non era tanto qualcosa di personale, come oggi, per cui Dio è un essere cosciente, ma si confondeva con gli eventi del mondo. La divinità era essenzialmente qualcosa che accade nel mondo: un fenomeno, un evento, una emozione, un sentimento. Detto in altri termini, lo spasimo pauroso che il filosofo avvertiva di fronte al dramma della condizione umana era quella divinità che presiedeva alla speculazione filosofica. La falsa conoscenza è egoistica, è frutto dell’Io intriso di desiderio. Fino a quando l’uomo è attaccato a questo mondo con il desiderio, dopo la morte, ritorna qui e continua il ciclo delle vite. Solo chi ha spento il desiderio, non si reincarna più, ma si risolve nel Brahman, ottenendo la suprema liberazione dal ciclo doloroso delle vite (cfr. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 4. IV. 6).
Entro questo sfondo pan-religioso, l’antico uomo greco sperimentava il divino o come meraviglioso o come terribile. La prima esperienza era veicolata dal sostantivo theòs, che indicava quando la categoria dell’insolito entrava a far parte del mondo visibile e razionale finendo per apparire meravigliosa. La seconda esperienza era veicolata dal sostantivo daimōn: indicava quando la categoria dell’insolito restava nascosta ai sensi esterni, rimanendo quindi non conciliante, non rappresentabile, interna, irrazionale, pertanto paurosamente terribile. Quando Aristotele parlava del thauma non si sarebbe riferito al theòs ma al daimōn. Per l’uomo greco il divino, secondo entrambe le accezioni, non era tanto qualcosa di personale, come oggi, per cui Dio è un essere cosciente, ma si confondeva con gli eventi del mondo. La divinità era essenzialmente qualcosa che accade nel mondo: un fenomeno, un evento, una emozione, un sentimento. Detto in altri termini, lo spasimo pauroso che il filosofo avvertiva di fronte al dramma della condizione umana era quella divinità che presiedeva alla speculazione filosofica. La falsa conoscenza è egoistica, è frutto dell’Io intriso di desiderio. Fino a quando l’uomo è attaccato a questo mondo con il desiderio, dopo la morte, ritorna qui e continua il ciclo delle vite. Solo chi ha spento il desiderio, non si reincarna più, ma si risolve nel Brahman, ottenendo la suprema liberazione dal ciclo doloroso delle vite (cfr. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 4. IV. 6).
In questa esistenza la persona, secondo l’induismo, produce dei meriti o dei demeriti: è il karma positivo e il karma negativo. I meriti ci dirigono verso la meta della realizzazione, i demeriti si ripropongono in una vita futura, quindi ci fanno reincarnare. Lo scopo della successiva reincarnazione è imparare quelle lezioni che non abbiamo imparato durante la vita precedente. Il karma negativo si ripropone in un’altra vita per insegnarci delle lezioni. È il concetto del karma non risolto. Per esempio, una persona che è stata egoista (centrata sul desiderio colpevole rivolto verso di sé), avrà nella vita successiva delle esperienze relazionali negative per imparare il valore dell’amore disinteressato. Brahmasūtra III. 1. 8: kṛtātyaye ‘nuśayavān dṛṣṭa smṛtibhyām yathetam anevam ca, “all’esaurimento di ciò che è stato fatto (in vita), (secondo) la rivelazione, l’anima ritorna (sospinta) dal residuo del karma (non risolto) lungo quella via dalla quale se ne andò (da questo mondo), o in modo differente”. La tradizione indiana dice che gli elementi che producono karma negativo sono delle malattie dell’ego:
1. Kāma: desiderio;
2. Krodha: odio e violenza;
3. Moha: attaccamento;
4. Lobha: cupidigia;
5. Mada: orgoglio;
6. Mātsarya: invidia.
Invece la vera conoscenza, essendo intuizione e quindi un abbraccio nei confronti del Tutto, è in definitiva il contrario dell’egoismo: è puro amore come distacco dai limiti egoici. Per questo la massima realizzazione degli esseri avviluppati nella manifestazione illusoria sta nel distacco da sé e nella proiezione verso il mondo e gli altri. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 5. II. rivela che il Creatore dà a tutti la sillaba sanscrita DA:
1. Per gli dei essa significa dama, “autocontrollo” per operare il bene verso tutti;
2. Per gli uomini essa significa datta, “donare”;
3. Per gli asura essa significa daya, “compassione”.
L’amore disinteressato è una suprema legge della realtà. L’uomo inizia a decadere da sé stesso quando comincia a allontanarsi dalle leggi di fuoco inscritte nel proprio cuore. Le nostre intuizioni profonde sanno quando sbagliamo, anche se l’errore ha spesso un fascino terribile. In cinese l’amore, ài, è espresso da un carattere che unisce il segno del respirare e quello dell’amico: l’amore disinteressato è fonte stessa della propria vita. Non per nulla, il sostantivo cinese bàn, “compagno”, è indicato dal segno stilizzato per uomo e da quello per dire la metà: i giusti atteggiamenti verso gli altri costituiscono parte del nostro stesso essere autentico (11). Per il buddhismo le componenti dell’amore disinteressato sono stati mentali non ordinari detti Brahmavihāra:
1. Mettā: gentilezza;
2. Karuṋā: compassione;
3. Muditā: gioia per ilo benessere degli altri;
4. Upekkhā: equità.
Il primo errore è perdersi nella illusione anziché attingere con gli occhi dell’anima la Realtà Vera. In altre parole significa non ascoltare la voce della coscienza, la quale ci indica sempre la via da seguire, anche se non vogliamo ammetterlo. Il monito rivolto all’iniziato di seguire la legge universale era indicato simbolicamente dalla triade capitolina: secondo una interpretazione, infatti, Giove è tale legge, Minerva l’intelletto scevro da errori che permette di intendere tale legge, Giunone l’amore verso di essa. La via della liberazione dall’illusione sta nell’imparare a giudicare rettamente ciò che ci circonda, scindendo da questo la forma illusoria dalla Verità che vi alberga. Per Kalipa la liberazione si realizza mediante quella conoscenza suprema che sa separare la natura (prakr̭ti) dallo spirito (purus̭a). Tutti noi siamo felici quando amiamo e ci innamoriamo, diventiamo tristi quando finisce una relazione. È un fenomeno dell’anima che sta sotto gli occhi di tutti. Ma non vogliamo ammetterlo e ci perdiamo nell’egoismo più cieco, dal culto della materia fino ad arrivare al tradimento del partner. L’amore svela come l’uomo sia parte del Tutto: amando sentiamo in profondità che gli altri non sono cosa separata da noi. Pensiamo al mito dell’androgine. Secondo una teoria, la parola “amore” deriverebbe dalla lettera A (prima dell’alfabeto e quindi simbolo di unità) e dal sostantivo egiziano mer, “amore, affetto, attrazione”. Pertanto l’amore sarebbe quella forza che ci unisce agli altri. Non per nulla, gli antichi egiziani chiamavano le piramidi mer per indicare che esse uniscono cielo e terra. Come sosteneva Jung, l’illuminazione non è una esperienza soprannaturale, ma un riconoscimento del reale. È un saper vedere senza schemi mentali precostituiti. Le persone credono più alla loro razionalità che al loro stesso vedere. Poiché la mente è limitata e condizionata, gli occhi vedono solo una parte della realtà. Il vedere è la capacità di eliminare l’illusione. La società attuale ci dà input che frenano l’azione. A scuola impariamo intellettualisticamente tante cose che alla fine non servono per la vita, perché per vivere bene non dobbiamo pensare astrattamente ma comprendere in profondità il senso delle cose. Staccandoci dalla azione, il troppo intellettualismo, le informazioni esagerate che non danno vera conoscenza, il bombardamento mediatico ci staccano dal mondo vero facendoci fermare all’illusione e, perciò, ci staccano dalla realizzazione. “La conoscenza non coincide con la padronanza filosofica e scientifica del pensiero, o l’accumulo di informazioni corrette intorno alla vita, ma con la stabilizzazione di livelli di coscienza illuminati, attraverso una costante disciplina e apertura interiore. Noi Occidentali dobbiamo rivolgere lo sguardo ai Misteri Eleusini, alle iniziazioni orfiche, e a quei pensatori che Platone definiva sophoí, ovvero Sapienti, e che hanno nome Eraclito, Empedocle, Parmenide, Pitagora, ma anche ai grandi maestri della conoscenza tragica (“patendo conoscere”), Eschilo, Sofocle, Euripide, per non citare che i maggiori tra i Greci. Guardare alle radici della nostra cultura significa anche guardare alla Sapienza d’Oriente, perché anche di essa (oltre che dello sciamanesimo iperboreo e della spiritualità egiziana, persiana e mesopotamica) era pervasa la Sapienza di Pitagora, Eraclito, Parmenide, Empedocle, Democrito e Platone” (12).
La verità è che l’uomo si realizza quando, intuendo in profondità la Realtà Vera, diventa sempre più parte del Tutto. Tutto l’essere dell’uomo deve partecipare attivamente al perfezionamento del Tutto. Per il noachismo ogni uomo ha come fine ultimo quello del perfezionamento (tikkun) del mondo attraverso una attività particolare. Uomo (microcosmo) e Mondo (macrocosmo) sono inscindibilmente uniti, per questo, sempre secondo il noachismo, quando il mondo meriterebbe di essere distrutto, compare un arcobaleno, segno che Dio non lo elimina per via del patto fatto con gli ebrei: però, se c’è un giusto, non compare mai un arcobaleno per via dei suoi meriti nei confronti del mondo intero.
Platone, Leggi, X: “… chi si occupa del tutto in vista della salvezza e della virtù dell’insieme ha ordinato tutte le cose in modo che ogni più piccola parte di esse, nei limiti del possibile, subisca e operi ciò che le spetta. A ciascuna di queste parti sono state preposte delle guide che presiedono anche la più piccola cosa ch’essa subisce e compie, e fanno in modo che tutto si realizzi perfettamente sino all’ultima divisione. Anche tu, o misero, sei una piccola frazione di queste parti che mira continuamente e tende al tutto, anche se infinitamente piccola, e proprio a tal proposito, ti sfugge il fatto che ogni genesi avviene in funzione di quello, e cioè perché nella vita del tutto vi sia un’essenza di felicità, e quel tutto non si è generato in funzione di te, ma tu in funzione di quello. Ogni medico, infatti, ed ogni esperto artigiano realizza ogni sua opera in funzione del tutto, e tendendo al miglior bene comune, realizza la parte in funzione del tutto, e non il tutto in funzione della parte: tu sei turbato perché ignori che ciò che ti accade ed è ottimo per il tutto lo è anche per te, in virtù di quella proprietà che deriva dalla comune origine. E poiché l’anima è sempre unita ora a quel corpo, ora a quell’altro, e quindi subisce ogni sorta di mutamento a causa sua o di un’altra anima, non resta altra opera all’ordinatore se non quella di collocare il costume migliore nel luogo migliore, e quello peggiore nel luogo peggiore, secondo ciò che è conveniente a ciascuno, perché ciascuno abbia il destino che gli spetta”. Pensiero, emozione e azione nel mondo devono essere una cosa sola. È nello schizofrenico che avvengono dissociazioni così potenti per cui questi elementi viaggiano su binari separati. Oppure nella persona non realizzata, schiava di un mondo illusorio che crede di penetrare solo con la razionalità senza coglierlo effettivamente con il cuore né raggiungerlo adeguatamente con la azione. Anche dal punto di vista somatico, la emozione prepara innanzitutto l’azione. Gli stati corporei viscerali sono monitorati e gestiti dalle stesse strutture cerebrali preposte poi alle emozioni e alla coscienza: ipotalamo, area tegmentale ventrale, nuclei para brachiali, grigio periacqueduttale, nuclei del rafe, locus coeruleus, formazione reticolare ascendente. Non solo, ma le parti del cervello che regolano l’omeostasi fisiologica creano una mappa del funzionamento viscerale, la quale è contigua con le aree che creano la mappa muscolo-scheletrica, cioè lo schema corporeo. Le neuroscienze ipotizzano che la contiguità di queste due mappe spieghi perché le emozioni preparino all’azione.
Note:
1 – Le Scritture indiane vi alludono con le parole neti neti (= na+iti), “non è questo, non è questo”;
2 – I riferimenti letterari sono pressoché infiniti. Pensiamo anche al Shāh-nāma di Firdusi, l’epopea nazionale dell’Iran, in cui la formazione dell’eroe segue lo schema classico: “Con questo sogno profetico di una nuova grande età ha inizio un lungo periodo di prove per l’eroe predestinato”, in G. de Santillana, H. von Dechend, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Milano 1983;
3 – Gli studiosi ritengono che il Vangelo di Giovanni abbia un nucleo che si fonda sulla testimonianza dell’apostolo, ma che poi sia stato elaborato entro la cosiddetta tradizione giovannea: una scuola cristiana che faceva capo alla sua dottrina. Per quanto riguarda le tre lettere di Giovanni, gli studiosi pensano che non siano direttamente dell’apostolo, ma siano state composte entro questa tradizione. In 3Giovanni 10 c’è la testimonianza che Diòtrefe sparla dell’autore della lettera: vista la grande importanza rivestita dagli apostoli, è impensabile che qualcuno si schierasse apertamente contro Giovanni, ma è possibile che questo atteggiamento potesse verificarsi per un suo discepolo;
4 – A. Huxley, La Filosofia Perenne, Milano 1995: “Philosophia Perennis: la definizione fu coniata da Leibniz ma la cosa in sé è universale e al di fuori del tempo. È una metafisica che riconosce una Realtà divina consustanziale al mondo delle cose, delle vite e delle menti; è una psicologia che scopre nell’anima qualcosa di simile alla Realtà divina o addirittura di identico ad essa … Si possono trovare rudimenti di questa Filosofia Perenne nelle dottrine tradizionali dei popoli primitivi in ogni regione del mondo, mentre nelle sue forme compiutamente sviluppate essa trova posto in ognuna delle religioni più elevate”;
5 – A. K. Coomaraswamy, Il significato della morte, in ID., La tenebra divina. Saggi di metafisica, Milano 2017, pp. 467-470;
6 – Eraclito (B 112 DK): sōphronein aretē meghistē, “la vera sapienza è la virtù più grande”;
7 – A. Moro, Breve storia del verbo essere, Milano 2010;
8 – F. D. E. Schleiermacher, Ermeneutica, Milano 2015;
9 – J. Ries, Alla ricerca di Dio. La via dell’antropologia religiosa, vol. 1, Milano 2009: “In Iran, nella tradizione zurvanita, ogni fenomeno terrestre corrisponde a una realtà celeste. Anche le città hanno il loro archetipo celeste: è il caso di Ninive, Assur, Gerusalemme. Questa idea del doppio cosmico si ritrova in alcune pratiche dell’India vedica, in particolare nel sacrificio, che conferisce forza ed efficacia con la messa in concordanza con un archetipo”;
10 – G. Lampis, Logos. Il frammento 50 di Eraclito, in Atopon, 1/2020;
11 – A. Cianci, Il libro dei caratteri cinesi, Novara 2009;
12 – A. Tonelli, Attraverso oltre. Della conoscenza, della solidarietà, dell’azione, Bergamo 2019.
Marco Calzoli,
è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha dato alle stampe 29 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane. Ha pubblicato anche molti articoli.