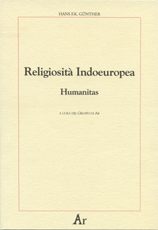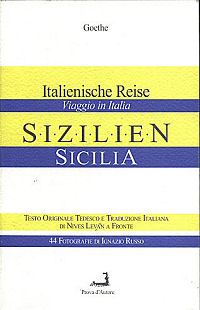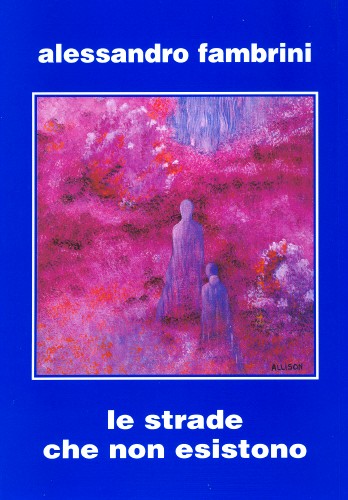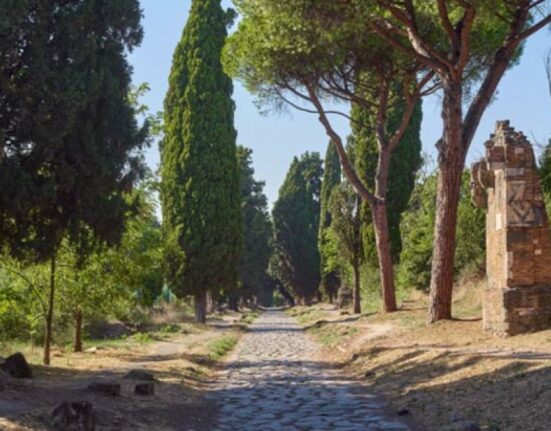di Fabio Calabrese
Adriano Romualdi è stato uno dei più competenti e lucidi intellettuali dei nostri ambienti. Se un destino cinico e baro non ce l’avesse strappato fin troppo precocemente, sono certo che sarebbe potuto diventare un Maestro nel senso più alto del termine, e in ogni senso per tutti noi.
Una delle cose più interessanti e “dense” che ci ha lasciato, è probabilmente l’introduzione a “Religiosità indoeuropea” di Hanns F. K. Guenther nella versione pubblicata dalle edizioni di AR, un vero e proprio saggio che ben meriterebbe di essere editato come pubblicazione indipendente.
In questa ampia introduzione-saggio c’è un’osservazione che mi fece riflettere parecchio quando lessi questo scritto per la prima volta decenni or sono, e che mi dà da pensare anche adesso. Secondo Romualdi, l’Europa è percorsa da una duplice tensione, la “nostalgia del sud” e la “nostalgia del nord.
La prima è probabilmente la più facile da capire. Per genti settentrionali che vivono al di sopra dell’arco alpino, “il sud” rappresenta l’inevitabile attrattiva di un clima più mite e di una natura più rigogliosa, ma naturalmente non c’è solo questo: c’è l’attrattiva delle tracce di grandi civiltà del passato: le testimonianze della civiltà greca, romana, di quella dell’Italia rinascimentale. Sulle orme di Goethe e del suo “Italienische Reise”, il viaggio in Italia per i rampolli delle famiglie centroeuropee benestanti dell’età romantica fra settecento e ottocento era considerato una parte essenziale del “grand tour” che si riteneva indispensabile alla loro educazione.
C’è probabilmente anche dell’altro. Anni fa mi capitò di vedere un reportage televisivo sull’isola greca di Santorini che è una sorta di Pompei ellenica. Qui in età minoica una violenta eruzione vulcanica, come a Pompei, distrusse un fiorente abitato ma ne conservò i resti tramandandoli “congelati nel tempo” alla posterità. Ancora oggi l’antica Santorini è stata riportata alla luce solo in minima parte.
La cosa interessante però, era che la troupe venuta a girare il documentario intervistò una signora tedesca sposata ad un greco che abitava lì. Fu chiesto alla signora, che era nativa di Amburgo, come aveva potuto adattarsi a vivere in un piccolo centro che durante la stagione invernale, quando non venivano turisti, si riduceva a essere abitato da non più di qualche centinaio di persone.
“E perché no?”, rispose la donna, “Quando esco per strada, conosco tutti quelli che incontro, è come essere tutti una grande famiglia”.
Indubbiamente, per chi è abituato alle grandi conurbazioni dell’Europa centrale, riscoprire un altro modo, un altro ritmo più naturale del vivere, può essere un altro motivo di fascino. Mi è venuto da pensare che noi stessi, se riteniamo la grande città coi suoi ritmi frenetici, l’assenza di tranquillità, l’interagire principalmente con una folla di estranei sconosciuti magari dalle fisionomie multietniche, un modo “normale” o addirittura gradevole di vivere, significa che ci siamo americanizzati ben oltre quel che avevamo immaginato.
Ora, è senz’altro vero che le grandi conurbazioni si trovano soprattutto nell’angolo nord-occidentale del nostro continente tra Benelux e Renania, mentre l’Europa mediterranea presenta ancora angoli di natura relativamente incontaminata (che però tra inquinamento, cementificazione, incendi boschivi di origine dolosa, pare si sia ansiosi di distruggere), ma qui la contrapposizione nord-sud c’entra poco, è in gioco piuttosto l’antitesi fra la modernità e i suoi
modi e ritmi di vita frenetici, e ambienti più tradizionali che hanno ancora conservato una dimensione e una possibilità di vivere a misura umana.
modi e ritmi di vita frenetici, e ambienti più tradizionali che hanno ancora conservato una dimensione e una possibilità di vivere a misura umana.
La nostalgia del nord è una cosa diversa, qualcosa che sembra toccare soprattutto certi ambienti intellettuali, tuttavia la sua presenza è del pari innegabile. Non è strano che il fascino del nord si riveli soprattutto agli appassionati e agli autori di letteratura fantastica; ne sono un esempio due critici fra i più quotati del fantastico italiano, Luigi De Anna e Massimo Berruti che hanno scelto la Scandinavia come loro terra d’elezione. De Anna, ad esempio, è docente da molti anni all’università di Turku, Finlandia.
Anche per chi non ha compiuto la scelta radicale di trasferirsi a quelle latitudini, l’interesse per il mondo nordico di una parte della nostra letteratura, è tuttavia evidente, ne è un esempio un romanzo che anni fa per qualche tempo è stato un piccolo best seller, opera di un autore fin allora sconosciuto, “L’ultimo dei Vostiachi” di Diego Marani, un romanzo che narra la vicenda dell’ultimo superstite di un immaginario popolo ugrofinnico scampato ai campi di concentramento staliniani, ultimo custode di un linguaggio la cui conoscenza potrebbe svelare alcuni misteri della linguistica ugrofinnica e indoeuropea, che si trova a essere conteso tra vari linguisti e glottologi in un congresso scientifico dal sapore surreale (dove Marani mette bene in luce quanto poco oggettiva e quanto intessuta di interessi personali, rivalità e gelosie sia la ricerca scientifica).
Un racconto lungo che mette bene in luce un singolare amore per le bianche solitudini del nord, è anche l’opera di un autore prettamente fantastico quale Alessandro Fambrini, “Le strade che non esistono”, che narra la storia di un giovane docente italiano partito per l’Islanda sulle tracce di un’amica misteriosamente scomparsa. Il mondo di ghiacci eterni solcato da piste enigmatiche, “strade che non esistono” esercita un fascino strano e irresistibile, al punto che il protagonista è sul punto, forse, di essere inghiottito dallo stesso abisso nel quale è scomparsa la sua amica. Un merito di questa storia è anche quello di metterci in contatto con una realtà che da noi si preferisce ignorare: il paganesimo scandinavo sopravvissuto in Islanda a secoli di persecuzione e che oggi ha finalmente ottenuto un riconoscimento ufficiale.
Quanti ritengono che il paganesimo sia stato completamente sradicato dall’Europa e che, in conseguenza di ciò, qualsiasi rifarsi alle tradizioni più antiche del nostro continente sia qualcosa di artificioso e nullo, beh, sono nettamente in errore. Fambrini è opportunamente ambiguo: sono i sacerdoti di un’antica religione ad apparire a un certo punto sulla scena, o è una manifestazione degli stessi dei?
Il racconto è stato pubblicato dalla Perseo Libri diversi anni fa in un’antologia dallo stesso titolo. Un altro bel racconto, “Perimeni”, che in greco moderno significa “lui attende”, ci mostra la polarità opposta, mediterranea. In un’isola greca apparentemente tranquilla avviene una serie di eventi inesplicabili. L’isola e i suoi abitanti sono in realtà posseduti da un’entità estremamente simile alle divinità del pantheon mostruoso creato da H. P. Lovecraft.
L’enorme difetto dell’antologia, è che gli altri racconti non sono assolutamente all’altezza di questi due, scritti come riempitivi e per giustificare la collocazione del libro in una collana di fantascienza, genere per il quale Fambrini non è assolutamente tagliato.
Parlando di fantascienza, si potrebbe ricordare pure un racconto del più importante autore fantascientifico italiano scomparso qualche anno fa, “Lettera dalla Norvegia” di Lino Aldani.
Io non so quanto possa essere fondata da un punto di vista scientifico, ma certamente è una testimonianza di un legame che si avverte con il mondo nordico, anche l’ipotesi avanzata da Felice Vinci in Omero nel Baltico. Secondo questa ipotesi, gli avvenimenti che sarebbero alla base dei canti poi raccolti nell’Iliade e nell’Odissea si sarebbero verificati prima della discesa degli Achei nel Mediterraneo, quando ancora erano insediati nelle terre settentrionali in cui avrebbero avuto origine, poi, una volta giunti nella Penisola ellenica, costoro avrebbero adattato le antiche narrazioni al nuovo ambiente. Vinci, a supporto della sua tesi fa un puntuale confronto della toponomastica omerica con l’ambientazione mediterranea e quella baltica, e quest’ultima in effetti sembra corrispondere meglio; cita poi ad esempio il fatto che Omero descrive una battaglia che sarebbe durata un’intera notte: cosa impossibile nell’ambiente mediterraneo, ma possibilissima in quello settentrionale dove, durante l’estate artica il sole non scende mai al disotto dell’orizzonte. Il problema di questa suggestiva ipotesi è la mancanza del supporto di prove archeologiche.
Il fatto rilevante è che tutte queste persone, in genere, non dimostrano di condividere i nostri orientamenti politici. Nei nostri ambienti, l’attrazione verso il nord si manifesta in maniera forse più epidermica, con il riferimento a nomi come “Thule” o all’uso della simbologia runica, ma ci sono pure da noi in
Italia ambienti che si rifanno all’odinismo o all’asatru (“fedeltà verso di Asi”), al punto che è legittimo porsi la domanda: da dove viene questa attrazione che ci fa puntare verso il nord come gli aghi magnetici delle bussole?
Italia ambienti che si rifanno all’odinismo o all’asatru (“fedeltà verso di Asi”), al punto che è legittimo porsi la domanda: da dove viene questa attrazione che ci fa puntare verso il nord come gli aghi magnetici delle bussole?
L’Italia ha avuto nei quindici secoli che separano la scomparsa dell’impero romano dalla sua rinascita come stato nazionale unitario, momenti in cui ha manifestato un’eccellenza difficilmente eguagliabile e di fatto ineguagliata in campo letterario e artistico: si pensi a quel monumento alla civiltà comunale che è l’opera di Dante Alighieri, alla grandezza dell’umanesimo e del rinascimento, ma in campo politico ha avuto una storia perlopiù penosa di divisioni, lotte fratricide e invasioni nel corso delle quali a un dominatore straniero ne subentrava un altro. Fra le poche figure che si staccano da questo sfondo ben poco esaltante, forse l’unica, è rappresentata da un uomo “nordico” di padre tedesco e madre normanna, che sembrò per un momento sul punto di ridarci quella dimensione di stato nazionale venuta a mancare per un così vasto arco di secoli, Federico II di Svevia, ammirato dai suoi stessi nemici e chiamato “stupor mundi”, stupore del mondo, e la cui memoria è ancora oggi oggetto di una vera e propria venerazione. Questa spiegazione tuttavia non può che essere molto parziale.
Per coloro che hanno più robusti appetiti intellettuali, può senza dubbio entrarci il fatto che ancora oggi la storia antica in particolare dell’Europa settentrionale è molto, molto misconosciuta. E’ un tema che ho affrontato altre volte, ma sul quale vale la pena di ritornare: la storia accademica, quella che viene insegnata nelle scuole dalle elementari alle università è una falsificazione, magari non deliberata ma assolutamente reale, che dipende dal peso che hanno ancora oggi il cristianesimo e la bibbia nella cultura cosiddetta “occidentale”: si suppone che la civiltà umana sia nata in Medio Oriente, guarda caso negli stessi luoghi in cui è stata scritta la bibbia, e che da qui si sarebbe poi estesa passando dai Mesopotamici agli Egizi, ai Fenici, agli Ebrei (of course), ai Persiani, infine – buoni ultimi – a Greci e Romani poco prima del declinare dell’età antica. Sebbene si ammetta che l’Europa mediterranea possa avere – in ragione degli influssi mediorientali – goduto di una certa civiltà in età antica, il settentrione del nostro continente viene retrocesso a un’animalesca barbarie. La simpatia, l’attrazione che sentiamo verso il Nord trarrebbe origine dalla solidarietà che si nutre istintivamente verso chi è vittima di un’ingiustizia.
In anni recenti sono emerse prove decisive che questa concezione, che è ancora quella che si insegna nelle scuole ai nostri ragazzi, è del tutto falsa. Parliamo ad esempio delle sepolture che sono state esumate nei pressi del celebre sito neolitico britannico di Stonehenge; in particolare di due: il cosiddetto arciere di Amesbury e, una scoperta del 2005, quella del “ragazzo con la collana di ambra”.
La tomba dell’ “arciere” che ha rivelato uno dei più ricchi corredi funerari preistorici conosciuti fra cui un gran numero di punte di freccia, da cui il soprannome, ha restituito i resti di un uomo di mezza età affetto da una zoppia e da un’infezione alla mascella conseguenza di un ascesso dentario. Il corredo funebre è tipico della cultura della ceramica a nastro diffusa dalla Penisola iberica all’arco alpino. L’uomo proveniva dalle Alpi, cosa che è stata dimostrata dall’analisi dello smalto dentario: nello smalto, infatti, rimangono tracce di isotopi di ossigeno e di stronzio che derivano dalla frutta e dalla verdura masticate nel corso della vita, e ogni località ha la sua “firma” caratteristica.
Ancora più sorprendente si è rivelato il “ragazzo con la collana di ambra”: era giovanissimo, di non più di quindici anni, proveniva dal Mediterraneo, mentre la collana che aveva al collo è composta di ambra nordica proveniente dal Baltico. Data la giovane età, si ritiene che non potesse aver compiuto da solo un viaggio così lungo, ma facesse parte di un gruppo familiare di turisti o di pellegrini (considerato il valore sacrale che indubbiamente Stonehenge aveva nella preistoria e nell’antichità), e doveva essere membro di una famiglia benestante, considerato il notevole valore della collana di ambra.
Quasi all’improvviso, ci si disegna davanti agli occhi un’immagine dell’Europa antica molto diversa da quella riportata nei libri di storia: un’Europa molto più civile di quel che ci hanno raccontato, dove le merci e le persone si spostavano viaggiando su grandi distanze, e non isolati avventurieri, ma interi gruppi familiari.
Se dalle Isole Britanniche ci spostiamo alla Germania il quadro di fondo non cambia. Nei pressi di Wevelsburg troviamo Externsteine, un complesso megalitico paragonabile a Stonehenge anche se (ovviamente) molto meno noto. Nelle vicinanze di Externsteine sorge il castello di Wevelsburg dalla caratteristica e unica pianta triangolare, che fu scelto da Heinrich Himmler come “casa madre” dell’ordine delle SS: si tratta indubbiamente di un luogo carico di potenti e “magiche” suggestioni, a cui il comandante delle SS era notoriamente sensibile.
La scoperta forse più significativa, però è avvenuta in tempi recenti, si tratta del cosiddetto disco di Nebra; un disco di bronzo (per dare un’idea delle sue dimensioni, si può ricordare che prima che fosse riconosciuto come un manufatto preistorico, fu usato da un contadino come copertura di un pozzo) che riporta una serie di simboli astronomici allineati che, opportunamente posizionato permette di determinare i solstizi, gli equinozi e forse le eclissi. Se Stonehenge è stato definito, sempre in ragione degli allineamenti astronomici, un computer preistorico, allora il disco di Nebra si può considerare un PC portatile della preistoria.
Non sono questioni accademiche: occorre respingere l’idea che esista una “civiltà occidentale” basata interamente su di una antico libro orientale: l’Europa non aveva bisogno di essere civil
izzata dal Medio Oriente perché era già civile. Esiste la civiltà europea, e quel che si trova oltre Atlantico ci è non meno estraneo di ciò che si trova oltre gli Urali.
izzata dal Medio Oriente perché era già civile. Esiste la civiltà europea, e quel che si trova oltre Atlantico ci è non meno estraneo di ciò che si trova oltre gli Urali.
Tutto ciò, però non risponde se non in maniera molto parziale alla domanda sul perché proviamo questa attrazione verso il nord, perché cerchiamo istintivamente la luce del nord. Io avanzerei un’ulteriore ipotesi: perché vi riconosciamo istintivamente una patria ancestrale perduta. Noi siamo indoeuropei dunque in una qualche misura iperborei.
Che l’origine degli Indoeuropei sia da ricercare in un’ancestrale sede iperborea, artica, questa tesi è stata sostenuta fra le due guerre mondiali dallo studioso tedesco Hermann Wirth. Dopo il 1945, come moltissime altre cose, è caduta in desuetudine; non ne è stata dimostrata la falsità, è stata pure essa sconfitta assieme all’orizzonte intellettuale di cui fa parte, sui campi di battaglia. In tempi recenti essa è stata ripresa da un coraggioso intellettuale anticonformista, il nostro Silvano Lorenzoni nei due libri “Involuzione, il selvaggio come decaduto” e “Mondo aurorale”; oltre al fatto che elementi in questo senso si possono dedurre dalla prefazione a “Religiosità indoeuropea” di Romualdi.
Questa concezione – salta subito agli occhi la domanda – non stride con la tesi che oggi sembra andare per la maggiore, dell’origine africana dell’ “homo sapiens”? (a parte il fatto che quest’ultima è ben lontana dall’essere definitivamente provata, e pare suggerita più che da prove scientifiche, dalla volontà di farci digerire con le buone l’immigrazione).
Ebbene, se ci pensiamo attentamente, le cose non stanno precisamente così. Ammettiamo in via d’ipotesi l’origine africana della nostra specie; a un certo punto deve essersi verificata una frattura, una separazione fra due gruppi: coloro che migrarono lasciando il continente africano forse attraverso l’istmo di Suez, forse per qualche altra via in cerca di nuove terre, erano i più intraprendenti, i più avventurosi, i più intelligenti, ma la storia naturalmente era solo all’inizio, perché nuovi ambienti più difficili imponevano via via nuove sfide per la sopravvivenza, mentre quelli rimasti in Africa potevano continuare a crogiolarsi in uno stile di vita che tutto sommato non differiva poi moltissimo da quello degli antropoidi da cui si era distaccato il ceppo umano.
Soprattutto per coloro che si spinsero nell’ambiente inclemente del nord dovette valere la spietata legge dell’adattati o muori: le difficoltà forgiarono un nuovo tipo di uomo, in uno col fenomeno per il quale la necessità di assorbire una quantità di radiazione solare sufficiente a evitare il rachitismo doveva portare a epidermidi sempre più chiare. Adattarsi a un ambiente più duro e povero di risorse non significava soltanto sviluppare la resistenza e diventare un cacciatore più abile, ma sviluppare la cura della prole e la socialità, mentre la necessità di conservare risorse per i momenti di crisi favoriva lo sviluppo della preveggenza, la capacità di pensare a lungo termine. Il difficile ambiente nordico forgiò l’uomo europeo che da qui armato di un cervello migliore, di una struttura sociale più complessa, ridiscese poi a conquistare il continente dando origine alle prime grandi civiltà, mentre in Asia il ceppo mongolo diede luogo a uno sviluppo parallelo, cosa che invece nell’Africa “nera” non si verificò affatto e, fino al colonialismo, non fu mai superata la fase dell’organizzazione tribale.
Le popolazioni europee presentano oggi una notevole varietà, sia per l’adattamento a condizioni locali, sia per la mescolanza con altre popolazioni pre-indoeuropee che abitavano le zone dove esse si insediarono definitivamente, ci sono certamente delle differenze tra uno svedese e un siciliano, ma c’è sempre una linea di sangue nordico per quanto sottile che le congiunge tutte. Quando questo legame di sangue s’interrompe, faceva notare Romualdi, noi non ci troviamo più di fronte a un siciliano o a un andaluso ma a un arabo, non ci troviamo più di fronte a un russo ma a un mongolo.
Fascino dell’Alto Nord apparentemente inesplicabile? Nostalgia di una patria ancestrale. Come indoeuropei, siamo tutti un po’ iperborei, e ciò che abbiamo razionalmente dimenticato parla ancora potentemente al nostro inconscio.
Oggi viviamo nell’era della globalizzazione, del mondialismo in cui si prepara l’universale meticciato da parte di coloro che vogliono far sparire popoli, etnie e culture in una massa umana indifferenziata pronta a essere il gregge manipolabile e intercambiabile dei loro servitori, ma io ho fede che alla fine questo sporco gioco da apprendisti stregoni scoppierà loro in mano e in faccia.
Quanto meno, costoro sottovalutano enormemente quanto le nostre radici siano forti, antiche, profonde.